1. PREMESSA
Molti termini e concetti di uso quotidiano – in particolare quando si parla di guerre e conflitti – come ha già scritto Giampietro Gobo (qui e qui) «hanno in comune lo stesso problema: prima di rispondere (aprir bocca) bisognerebbe definire con chiarezza che cosa si intende». Il diritto di autodifesa è certamente uno di questi.
L’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite rappresenta una delle disposizioni più dibattute del diritto internazionale contemporaneo. Esso riconosce il diritto naturale degli Stati all’autodifesa in caso di attacco armato, configurandosi come eccezione al divieto generale dell’uso della forza sancito dall’art. 2(4). La tensione tra sicurezza nazionale e legalità internazionale ha alimentato un dibattito giuridico e politico che si è intensificato alla luce di recenti crisi, come quelle in Ucraina e nella Striscia di Gaza.
2. STRUTTURA E FUNZIONE DELL’ARTICOLO 51
Il testo dell’articolo 51 recita: «Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva nel caso in cui abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fino a che il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionali.»
Questa clausola assume la funzione di deroga condizionata al divieto dell’uso della forza. La sua applicazione è subordinata a tre criteri fondamentali:
- Attacco armato effettivo come presupposto giuridico;
- Temporalità dell’autodifesa, limitata all’intervento del Consiglio di Sicurezza;
- Rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e notifica.
Tali condizioni sono state progressivamente consolidate nella giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia (CIG), in particolare nella sentenza Nicaragua vs. Stati Uniti (1986).
3. LEGITTIMITÀ DELL’AUTODIFESA: CHI DECIDE?
Nel sistema internazionale manca un’autorità centralizzata con competenza vincolante ex ante sull’uso della forza. Le valutazioni di legittimità si articolano su tre livelli:
- il livello del Consiglio di Sicurezza ONU: è formalmente deputato a qualificare atti di aggressione (art. 39), ma è spesso paralizzato dal veto dei membri permanenti;
- quello della Corte Internazionale di Giustizia: la CIG ha delineato i confini normativi dell’articolo 51, ribadendo la necessità di un attacco armato, la proporzionalità della risposta e l’obbligo di notifica. Tuttavia, la sua giurisdizione è volontaria;
- quello delle Soft law e delle valutazioni politiche: si tratta di risoluzioni non vincolanti, dichiarazioni di ONG e organismi regionali contribuiscono alla costruzione di una legittimità percepita, sebbene priva di effetti giuridici diretti.
4. CRITERI INTERPRETATIVI: IMMEDIATEZZA, PROPORZIONALITÀ E PREVENZIONE
Immediatezza: La reazione armata deve seguire l’attacco senza ritardi ingiustificati, per evitare la degenerazione in rappresaglia. Tuttavia, la prassi mostra una crescente flessibilità temporale.
Proporzionalità: La risposta deve essere calibrata rispetto alla minaccia, non necessariamente simmetrica nei mezzi. Il principio è soggetto a interpretazioni divergenti e spesso politicizzate.
Autodifesa Preventiva: La teoria dell’autodifesa anticipata, fondata sul caso *Caroline* (1837), richiede una minaccia “istantanea, travolgente, senza scelta di mezzi e senza tempo per la deliberazione”. Dopo l’11 settembre, gli Stati Uniti hanno ampliato il concetto di “imminenza”, giustificando interventi contro minacce latenti (es. Iraq 2003). La comunità internazionale, tuttavia, non ha accolto unanimemente questa estensione, e la CIG continua a rigettare l’autodifesa contro minacce potenziali.
5. DUE CASI SOTTO AGLI OCCHI DI TUTTI
Ucraina (2022): l’invasione russa è stata giustificata da Mosca come intervento protettivo per la popolazione del Donbass. L’Ucraina ha notificato l’attivazione dell’articolo 51 il giorno stesso. La comunità internazionale ha riconosciuto l’esistenza di un attacco armato, legittimando le forme di autodifesa collettiva. Tuttavia, permangono dubbi sulla proporzionalità delle risposte militari.
Israele e Hamas (2023): l’attacco di Hamas del 7 ottobre ha causato oltre 1.200 vittime civili. Israele ha reagito invocando il diritto all’autodifesa. La risposta militare, estesa e con elevato impatto sulla popolazione civile, ha sollevato interrogativi sulla proporzionalità e sul rispetto del diritto internazionale umanitario. Il caso evidenzia le difficoltà interpretative dell’articolo 51 in contesti di conflitto asimmetrico e urbano.
5. CONCLUSIONI
L’articolo 51 rimane un pilastro del sistema di sicurezza collettiva, ma la sua applicazione è segnata da ambiguità normative e da una forte politicizzazione. In particolare:
- le valutazioni di legittimità sono condizionate da equilibri geopolitici;
- i criteri giuridici sono suscettibili di estensioni ad hoc;
- la teoria dell’autodifesa preventiva rischia di erodere il principio del divieto dell’uso della forza.
Sarebbe auspicabile un dibattito accademico, politico e diplomatico che, pur riconoscendo le esigenze di sicurezza, riaffermi la centralità del diritto positivo e la necessità di un controllo multilaterale sull’uso della forza.
Autore
-
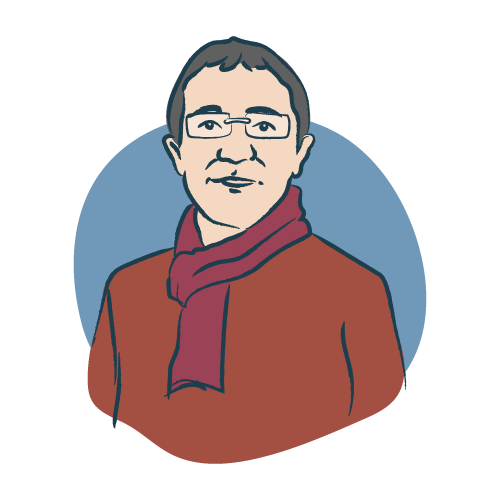
Ingegnere elettronico, manager in una multinazionale, matematico e scrittore. Cerca l’intelligenza nell’intelligenza artificiale. E forse la trova: o tutto è intelligenza oppure niente lo è.
Leggi tutti gli articoli
