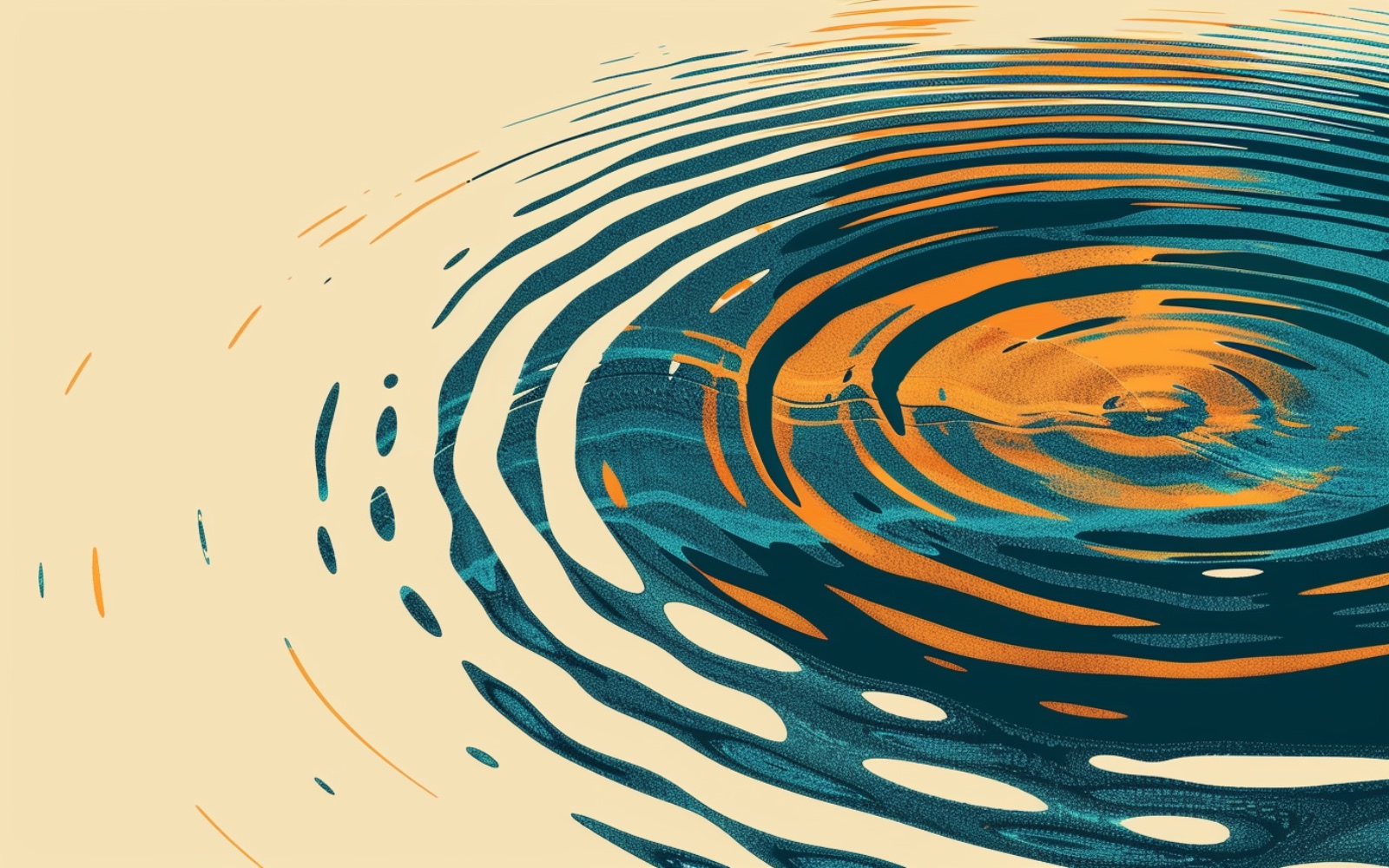Antropologia dell’IA - Stereotipi, discriminazioni di genere e razzismi
Da un twitter divenuto virale nel 2019 si è venuti a conoscenza del fatto che Goldman Sachs, una delle più importanti banche d’investimento del mondo, aveva escluso una potenziale cliente dall’accesso a una prestigiosa ed esclusiva Apple card in base a una profilazione erronea e discriminatoria. Il fatto si è saputo perché l’autore del twitter, un danese sviluppatore di software, è il marito della persona a cui era stata negata la card, che lui invece aveva ottenuto pur guadagnando meno di lei. In sostanza, la donna per ragioni opache e non trasparenti era stata considerata non idonea per quel determinato prodotto.
Discriminazioni di genere
Se non ci fosse stato quel twitter non si sarebbe saputo nulla di tutto ciò, ovvero di una sistematica e silenziosa discriminazione di genere. La vicenda rappresenta una plastica esemplificazione della nota metafora del cosiddetto “soffitto di cristallo”: la possibilità che una donna ha di poter scalare il potere o di avere pari opportunità di carriera è spesso preclusa da una sorta di soffitto trasparente, che costituisce una barriera invisibile eppure potente e limitante. Per ragioni imperscrutabili, non esplicitate chiaramente e senza la possibilità di entrare nel merito, gli algoritmi rischiano di attuare politiche discriminatorie, che si supponeva dovessero appartenere al passato e non alle tecnologie del futuro. La rappresentazione, l’interpretazione e la codificazione degli esseri umani attraverso dataset di training e le modalità con cui i sistemi tecnologici raccolgono, etichettano e utilizzano questi materiali sono aspetti decisamente cruciali nel riprodurre stereotipi, pregiudizi, forme di discriminazione di genere o razziale. I bias trovano sempre una strada per inserirsi nel sistema, o meglio in un certo senso i bias fanno parte del sistema. A questo proposito, è noto che fino al 2015 Amazon reclutasse i suoi futuri dipendenti tramite un sistema che si era “allenato” sui curricula, in genere di uomini, ricevuti nei dieci anni precedenti. I modelli avevano quindi imparato a raccomandare gli uomini, autoalimentando e amplificando le disuguaglianze di genere dietro la facciata di una supposta neutralità tecnica. Tanto per fare un esempio, il curriculum di un aspirante dipendente di Amazon veniva scartato se al suo interno conteneva la parola “donna”, perché il sistema aveva imparato a gestire di dati così (Dastin 2018).
Il razzismo dell’IA
L’IA produce e riflette le relazioni sociali, una determinata visione del mondo e, inevitabilmente, i rapporti economici e di potere, visto il notevole capitale in termini finanziari che occorre per investire in essa. Basti pensare che i sistemi di riconoscimento facciale, che contribuiscono fortemente a etichettare la realtà e gli umani, derivano dai primi tentativi sperimentali della Cia e dell’FBI negli anni Sessanta, passando per i database basati sulle immagini dei carcerati, per arrivare all'epoca attuale, dove i principali sistemi di questo tipo sono alimentati da volti e scatti liberamente messi in circolazione sui social (Crawford 2021:105-135). Ovviamente l'accresciuta complessità tecnologica e il suo considerevole impatto sociale hanno fatto emergere anche i tratti più controversi dell’IA, a cominciare dai pregiudizi automaticamente inseriti nei dataset utilizzati per nutrire l'intelligenza artificiale. Si pensi al fatto che c’è stato un lungo dibattito sul riconoscimento facciale, in cui si è visto che è più difficile distinguere i neri, proprio perché i dataset di training si fondano prevalentemente su materiale fotografico di bianchi, raccolto e categorizzato soprattutto da bianchi.
Le differenze razziali, culturali e di genere sono elementi che non si limitano ad affiancarsi o a sommarsi uno sull’altro, ma interagiscono producendo nuove e incomparabili forme di segregazione e di assoggettamento, che si stratificano su vecchi e consumati stereotipi e discriminazioni. A questo riguardo, sui media ha molto circolato la storia di un’afroamericana che non riusciva ad avere il mutuo per acquistare una casa e non si capiva perché, visto che aveva un buon lavoro in una università americana; finché non è apparso chiaro che ciò dipendeva dal quartiere afroamericano in cui abitava e dal suo essere afroamericana (Glantz, Martinez, 2018). In pratica, l’IA acuiva le asimmetrie già esistenti riguardo i singoli gruppi umani a partire dalla loro supposta affidabilità in termini creditizi. Limitando le chance di un futuro migliore si perpetua e “naturalizza” un razzismo esistente e conclamato seppure mai apertamente dichiarato.
Secondo la scienziata esperta in intelligenza artificiale Timnit Gebru e la studiosa di linguistica computazionale Emily Bender un gigante come Google riafferma e ratifica continuamente le disuguaglianze. Ad esempio, il suo programma di riconoscimento facciale è meno accurato nell’identificare le donne e le persone di colore (Hao 2020). Gli algoritmi, concepiti a partire da tecnologie innovative, possono convalidare forme di razzismo istituzionalizzato. Addirittura in uno studio dell’Università del Maryland è stato riscontrato che in alcuni software di riconoscimento facciale le emozioni negative vengono maggiormente attribuite ai neri piuttosto che ai bianchi (Crawford, 2021:197).
Il contesto socio-culturale dell’IA
Lo sviluppo esponenziale dell’IA ha in qualche maniera obbligato a ragionare su determinati aspetti, come quelli per così dire più umani delle machine learning. Gli stereotipi, le forme di discriminazione e di razzismo infatti vengono automaticamente appresi e inseriti nei dataset, ma questi ovviamente erano e sono già presenti in internet e nella realtà quotidiana al di là della IA. Per cui bisogna tornare a monte, appunto. Di cosa si nutre l’IA? Chi costruisce l’intelligenza artificiale? Perché è ovvio che non si tratta di semplicemente di correggere errori una volta che emergono, come il caso dei curricula di Amazon o della Apple card di Goldman Sachs. Le immagini inserite nei dataset basati sulla visione artificiale per il riconoscimento degli oggetti, nel categorizzare i generi si ritrovano a organizzare, etichettare ad esempio foto in cui gli uomini sono spesso stati fotografati outdoor presi in qualche attività sportiva e con oggetti relativi allo sport e le donne prevalentemente in cucina con qualche utensile relativo al cucinare (Wang, A., Liu, A., Zhang, R., Kleiman, A., Kim, L., Zhao, D.,Shirai, I. Narayanan, A. Russakovsky, O., 2021: 9). Questo dato è di per sé rilevante e in qualche modo va analizzato perché i bias sono già incapsulati nel sistema.
Fei-Fei Li, un’esperta di visione artificiale che si occupa anche di debiasing, come ridurre i bias che i dataset tendono ad inglobare, afferma che le conseguenze della attuale situazione sono “dataset non sufficientemente diversificati, compreso quello di ImageNet [a cui la stessa Li ha lavorato, n.d.a.], esacerbate da algoritmi testati male e decisioni discutibili. Quando internet presenta un’immagine prevalentemente bianca, occidentale e spesso maschile della vita quotidiana, ci resta una tecnologia che fatica a dare un senso a tutti gli altri” (Li, 2024: 253). I dataset riflettono anche una concezione del mondo fortemente ancorata a quella di coloro che ci lavorano.
È interessante sapere che, secondo il Guardian, nel team di Sam Altman il 75% dei dipendenti di OpenAI è uomo (Kassova, 2023). E la domanda che inevitabilmente sorge è: quali sono le conseguenze di una IA sviluppata senza la piena partecipazione delle donne, delle minoranze e di Paesi non occidentali? Perché allo stato attuale è ovvio che la loro mancanza di rappresentanza nel settore tech ha come conseguenza che gli algoritmi funzionano male con coloro che non sono bianchi e maschi.
L’IA e il marchio del capitalismo
Le altre domande altrettanto cruciali sono: per chi è fatta l’IA? Chi possiede i dataset e che uso ne fa? E qua ovviamente entra in gioco anche la democrazia sulla trasparenza e l’etica della non discriminazione. Uno degli elementi chiave riguardo i dati è che sono presi senza contesto e senza consenso. Nick Couldry e Ulises Mejias (2022) fanno un interessante parallelismo tra epoca coloniale e società attuale. Se nell’epoca del colonialismo, il potere agiva in maniera estrattiva, ovvero i colonizzatori spoliavano i paesi colonizzati di materie prime preziose e di forza lavoro (tramite lo schiavismo), i corrispettivi contemporanei per profitto estraggono dati senza chiedere il consenso ai legittimi possessori, come nel caso di Midjourney che, come recentemente emerso in una class action promossa da alcuni artisti americani, ha utilizzato le opere di 16.000 artisti senza chiedere il consenso e aggirando il copyright. I maggiori giganti tecnologici sono costantemente e voracemente in cerca di enormi quantità di dati per alimentare e allenare i sistemi di intelligenza artificiale (Metz, C., Kang, C., Frenkel, S., Thompson, S.A., Grant, N., 2024). Internet è stato concepito da coloro che operano nel settore dell’IA come una sorta di risorsa naturale, disponibile da cui si possono estrarre dati a piacimento. Il colonialismo dei dati è un ordine sociale emergente basato su un nuovo tentativo di impadronirsi delle risorse del mondo a beneficio di alcune élite, come era avvenuto in passato con il “classico” colonialismo. C’è una continuità profonda nei metodi di acquisizione, negli atteggiamenti mentali, nelle forme di esclusione e di preservazione del potere. È incredibile come ciò sia a volte incastonato in qualche biografia emblematica: Elon Musk, ad esempio, ha un padre che è stato proprietario di una miniera di smeraldi in Zambia. In famiglia la forma di colonizzazione si è solo evoluta con i tempi e con le tecnologie, ma il marchio è lo stesso.
L’intelligenza artificiale, come un tempo il colonialismo, genera valore in modo iniquo e asimmetrico, impattando negativamente su molte persone, non importa se le definiamo in termini di razza, classe o genere, o tramite l’intersezione di tutte queste categorie.
E renderla più inclusiva non sarà una battaglia facile.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Crawford, K. (2021), Né intelligente né artificiale: il lato oscuro della IA, Il Mulino, Bologna.
Couldry, N., Mejias, U.A. (2022), il prezzo della connessione: Come i dati colonizzano la nostra vita e se ne appropriano per fare soldi, Il Mulino, Bologna.
Dastin, J. (2018), “Amazon Scraps Secret AI Recruiting Tool That Showed Bias against Women”, in Reuters, October 11.
Glantz, A., Martinez of Reveal, E. (2018), “Kept out: How Banks Block People of Color from Homeownership, APnews, February 15.
Hao, K. (2020), “We Read the Paper That Forced Timnit Gebru Out of Google. Here’s What It Says”, in MIT Technology Review, December 4.
Kassova, L. (2023) “Where are All the ‘Godmothers’ of AI? Women’s Voices are not being Heard”, The Guardian, November 25.
Li, F.F, (2024), Tutti i mondi che vedo, Luiss University Press, Roma.
Metz, C., Kang, C., Frenkel, S., Thompson, S.A., Grant, N. (2024), “How Tech Giants Cuts Corners to Harvest Data for A.I.”, The New York Times, April 6.
Telford, T. (2019), “Apple Card algorithm sparks gender bias allegations against Goldman Sachs”, Washington Post, November 11.
Wang, A., Liu, A., Zhang, R., Kleiman, A., Kim, L., Zhao, D., Shirai, I. Narayanan, A. Russakovsky, O., (2021,“A Tool for Misuring and Mitigating Bias in Visual Dataset”, arXiv: 2004.07999v4 [cs.CV] 23 Jul 2021.
Un pensiero per coloro che periscono di certezza
Alla lunga, diventa piuttosto insostenibile vagare con il solo scopo di diffondere opinioni nate altrove. Per questo, inizio con un’ammissione di colpevolezza, forse più d’una.
Prima ammissione: questa risposta, pensata in origine come contraltare all’articolo di Matteo Donolato sul caso del sovraesteso femminile, è stata riscritta più volte di quanto mi piacerebbe ammettere. Al punto che mi ero convinto che valesse la pena scrivere un collage che comprendesse tutte le versioni precedenti. Sarebbe stata un’opzione molto democratica e molto moderna, sufficientemente paritaria. C’era tutto, pro e contro, e tutti nati in seno ad una stessa persona, che poi sarei io…
Seconda ammissione, corollario della prima: devo confessare di essere stato sballottato a fasi alterne dall’una all’altra parte della staccionata, e con altrettanta momentanea convinzione, con fretta e foga, ho interpretato il burattino degli uni e degli altri, di chi ci sta e di chi non ci sta. Ed ogni volta bisognava analizzare, e poi giudicare e condannare o perdonare. Arrivavo alla fine, e quel minimo di non-so-bene-cosa mi faceva scrivere, ad ogni conclusione, «che idiota!».
Dunque, ricomincio. C’è il fatto, lo strano caso del sovraesteso femminile: l’Università di Trento decide di andare per la via della provocazione, ogni professione indicata al maschile nei documenti d’Ateneo diverrà femminile, dunque sovraesteso. Ogni presidente è ora presidenta, ogni studente può diventare studentessa - the sky is the limit!
A dirla tutta, non nasce interamente come “caso”, lo diventa. Ci sono due rami della questione. Da una parte, mediaticamente, la divisione si forma sulla capacità divisiva dell’atto stesso, dall’altra questo stesso effetto di polarizzazione fomenta, in un fenomeno di feedback, l’amplificarsi della questione. Ecco, all’orizzonte, il «caso mediatico», il cui intimo meccanismo reclama la polarizzazione come elemento necessario per la sua riuscita, anzi, per la sua stessa esistenza.
Se tutto va a buon fine, da qualche parte si imbandisce un panel televisivo saggiamente strutturato per raccogliere il peso della provocazione e semplificare il tutto in una disputa tra contendenti. L’amplificazione iniziale funziona come una disseminazione ad alta velocità, «bisogna che se ne parli». Diversamente, lo scontro mediatico raccoglie i frutti con una sorta di sistema ad imbuto per generare categorie altamente digeribili. Rallenta il tempo, si distilla una suddivisione semplice delle parti contendenti: chi sta di qua e chi sta di là. È tutto propedeutico al nutrimento dell’ascoltatore. Due opinioni opposte l’una all’altra, ma sufficientemente chiarificate, possono essere distribuite al popolo, che a sua volta produrrà ancora una volta un effetto a cascata verso il basso. Così, la buona novella circola per il mondo, molto più semplice e strutturata di prima, e ciascun talk show si ripete in ogni bar che offra da bere del bianchino alle dieci del mattino, o qualche spritz all’happy hour.
Ma stai di qua o stai di là?
Se non hai deciso una parte, allora cosa parli a fare?!
Innanzitutto, pazienza… e dubbio che, a intenderlo propriamente, dovrebbe essere il metodo per sviare da questo inferno. Se dico «propriamente», è perché la polisemia di dubbio rischia di generare - ahimè - un ulteriore dubbio, dunque riformulo.
In un primo senso, dubitare contraddistingue un modo dell’intelligenza di procedere in avanti: dubito tra questa e quell’opzione. Nei limiti del possibile, possiamo chiamarlo un fatto di «problem solving». Quando dubito se sia meglio andare a destra o a sinistra, non dubito della mia inclinazione a giungere alla destinazione che mi sono precedentemente prefissato.
Dall’altra parte, con «dubbio» potremmo intendere ciò che da Henri Bergson in poi chiamiamo «l’inversione del normale corso di pensiero»: andare indietro, piuttosto che in avanti. Non consiste nel dubitare di quale opzione favorire - cosa scegliere dal menu o quale strada sia più favorevole al raggiungimento della meta -, ma piuttosto dubitare del modo nel quale le opzioni sono poste - sarà il menù giusto? Perché vado dove vado?
Non è più un’operazione dell’intelligenza dettata dal superamento di un ostacolo, ma più propriamente un atto del pensiero e della riflessione e…del dubbio.
A proposito di questo metodo, quando l’autore del Saggio sui dati immediati della coscienza (1889) ripropone il classico paradosso di Achille e la tartaruga, la contrapposizione tra spazio e tempo è sviscerata nel medesimo modo: non bisogna partire dalla dicotomia tra spazio e tempo come problema già formato, ma piuttosto risalire fino alla formulazione della questione. Primo lato della questione: siamo sicuri che spazio e tempo vadano posti come sono posti? Secondo lato della questione: perché, ed è una domanda a cui è altrettanto fondamentale rispondere, la dicotomia è stata posta proprio in questi termini?
È un modo di procedere che contraddistingue tutta l’opera bergsoniana: è necessario risalire la catena delle false contrapposizioni, curandosi di dar ragione del perché, in primo luogo, quella falsa dicotomia è venuta ad essere. In Materia e memoria la dicotomia tra idealismo e realismo è denunciata come errore già nelle pagine introduttive, mentre ne L’evoluzione creatrice sono poste in questione le (false) dicotomie tra ordine e caos, finalismo e meccanicismo, e molto altro ancora. Pur con qualche postilla, si può affermare che quello del filosofo francese è un metodo generale del pensiero.
Dunque, nel nostro caso si tratta non soltanto di osservare con scrupolo le opzioni che l’opinione pubblica ci propina, ma di saggiare le modalità stesse di questa produzione di schieramenti e, ultimo ma non ultimo, riflettere sulle ragioni per cui il dubbio che procede a “ritroso” parrebbe, almeno ad un primo e fugace sguardo, essere così sistematicamente avversato.
Perché da ambo le parti c’è una certa fretta, tanto di coloro che con fermezza reclamano la condanna repentina, quanto degli altri che gioirebbero sentendo annunciare che ciò che ieri era provocazione, oggi diventa legge e imposizione; ed ambo le parti sfruttano il “dubbio” solo nel suo senso “semplice”, ossia nel riproporre, piuttosto incessantemente, dei dubbi da risolvere rapidamente tra alternative già determinate: vai di qua o vai di là?
Possibile aver così poca cura di ciò che ci circonda da altalenare tra l’immediato rifiuto del nuovo o la condanna di ciò che è stato, con l’ottusa fiducia che ciò che sarà, per ciò stesso, sarà meglio? Anche l’altalena tra il «nuovo» e il «già stato», direbbe Bergson, è una falsa alternativa.
D’altra parte, nel suo secondo significato il dubbio rivela - almeno potenzialmente - l’inganno delle opzioni, scoprendosi come l’atto stesso di contrapposizione alla fretta delle parti. In virtù di ciò, non è un primariamente un meccanismo deduttivo per risolvere l’incertezza tra le opzioni, ma un metodo di retrocessione per porre sotto esame la creazione stessa del campo di alternative che ci sono proposte.
Se dovessi ipotizzare dove ci porterebbe questa ricerca, in primis si rivolgerebbe con sospetto verso la foga che contraddistingue questi schieramenti della domenica, che il giorno prima ci sono, il giorno dopo spariscono a favore di qualcos’altro. Bisognerebbe indagare psichicamente questa famelica necessità di applaudire e ripudiare, in quello che a tutti gli effetti sembrerebbe una continua fioritura di micro-identificazioni “alla giornata”, il cui funzionamento necessita la ripetizione ininterrotta di nuove approvazioni, così come richiede la brevità temporale di ogni nuova “battaglia”.
In ciò, si rivelerebbe al fondo degli attuali movimenti pseudo rivoluzionari, di cui “la provocazione del sovraesteso” fa parte, la loro ingenuità: a foga e certezza rispondono con foga e certezza, a iper-legiferazione rispondono con altrettanta iper-legiferazione, di conseguenza sono interamente determinati - oso dire prodotti - dal sistema stesso che credono di fronteggiare.
Di conseguenza, tra coloro che ci fanno ballare tra l’innegoziabilità di ciò che è sacro e la rinegoziazione di ogni cosa, la nostra attenzione dovrebbe vertere non tanto sulla valutazione di quale alternativa preferire, ma sulla presentazione stessa di questa alternativa, e delle ragioni storiche e culturali che forzano questo ristretto menù contro i nostri occhi, limitandoci la vista. Scoveremmo, come ho già scritto, il loro modo comune, l’intenzione manifesta di passare per la via dell’iper-legiferazione, che - in aggiunta o parallelamente - non passa più per i soli canali statali o sovrastatali, ma opera con un taglio trasversale tramite sistemi che mimano, ovunque, i tribunali: “giudizio-sulla-rete”, “cancel-culture” e “bolle mediatiche”, sono pienamente in linea con la definizione di questo percorso iperbolico della codificazione.
Scoveremmo tra coloro che difendono a spada tratta una lingua - come se questa fosse nata in seno alla mente brillante di un solo ed eroico legiferatore patriottico - e coloro che professano la possibilità di rinegoziare ogni parola - come se la lingua rinascesse nuova e candida ad ogni mattina - il comune desiderio di agire su vasta scala ad una micro-codificazione della lingua, fin nelle sue più intime fibre, al fine di direzionare le fibre sociali che stanno per essa… almeno in teoria.
Tra i movimenti rivoluzionari della lingua, e i moti controrivoluzionari della cultura, scoveremmo il timore comune di perdere il controllo di ciò che varia - di quel «che varia davvero, nonostante ogni previsione o premonizione» - benché l’una parte se ne dichiari fallacemente a favore, e l’altra esplicitamente contraria.
Una rettrice uomo salverà il mondo?
Il 28 marzo scorso il Consiglio di Amministrazione dell’università di Trento ha deciso per l’uso del femminile sovraesteso in tutti i suoi documenti ufficiali. Ovvero, per esempio, il rettore e il presidente diventano la rettrice e la presidente, anche se si tratta di uomini.
A seguito di questa decisione il rettore Flavio Deflorian diventa la rettrice Flavio Deflorian, il quale (o la quale?) ha così commentato il suo nuovo status: “Leggendolo mi sono sentito escluso. Così ho capito il senso della decisione”.
Il comunicato ufficiale recita: “È il primo caso di atto redatto in questo modo all’Università di Trento. Dall’adozione nel 2017 delle guida sul linguaggio rispettoso delle differenze, prosegue l’impegno dell’Ateneo per la costruzione di un’università più inclusiva”.
L’obiettivo di costruire un’università sempre più inclusiva è senz’altro condivisibile e, d’altro canto, il tema dell’inclusività è diventato uno dei temi più sensibili in tutte le università del mondo occidentale. Nel frattempo io faccio una certa fatica a capire perché nelle università non sia altrettanto popolare, che so, il tema dello sfruttamento dei bambini nelle miniere di litio africane per estrarre il raro minerale indispensabile per far funzionare i nostri pc e le nostre auto pulite… ma vabbè, sto divagando.
Torniamo al punto, naturalmente questa iniziativa ha fatto discutere sui giornali e sui social (ma per quel che ho visto, avrei immaginato un dibattito più caldo e serrato, segno forse che l’iniziativa di UniTrento non è stata presa molto sul serio?). Naturalmente molte voci a favore, provenienti soprattutto dalle aree culturali riconducibili ai movimenti come quello delle transfemministe e, a rimorchio, dai partiti di sinistra; qualche voce scettica, anche a sinistra, e non poche voci ironiche o sarcastiche, non necessariamente provenienti solo da visioni socio politiche di destra o reazionarie.
A questo punto però credo che ci siano due domande da farsi, la prima: una iniziativa di questo tipo ha una funzione di reale utilità nella lotta alle diseguaglianze di genere nella società? E la seconda: è per forza necessario dividersi per schieramenti ideologici (e partitici) su un tema come questo?
Provo a rispondere, a puro titolo personale, a entrambe le questioni. Senza girarci troppo attorno, credo che iniziative come questa non servano assolutamente a nulla per la causa dell’inclusione e, anzi, siano controproducenti. Già, perché ai reazionari con mentalità patriarcale (e chi decide se uno è reazionario con mentalità patriarcale?) un’iniziativa a come questa non solo NON li farà riflettere, ma servirà ad aumentare la loro convinzione di essere “in un mondo di pazzi” dal quale difendersi arroccandosi sulle proprie rassicuranti posizioni.
Poi però serve a poco (o a nulla) anche con le persone di mentalità aperta e consapevoli. Perché costoro sanno bene che esistono problemi reali, di contenuto, e scrivere rettrice di un uomo non risolve nulla dei problemi reali. E, quindi, quando leggo la dichiarazione della rettrice / rettore, che dice di essersi sentito escluso e di aver (finalmente!) capito (il non detto è “il dramma dell’esclusione femminile e fluida”), mi viene da ridere. Per cui, professoressa Flavio & C., se lei ha bisogno di questa cosa per capire che ci sono ancora da colmare dei gap di genere, siamo messi male male…
In realtà farei un torto all’intelligenza della rettrice / rettore a pensare che solo attraverso questa iniziativa lei / lui abbia preso coscienza esistenziale delle disuguaglianze di genere. Così a me questa iniziativa di UniTrento non sembra neppure una provocazione per sensibilizzare. Mi sembra, invece, solo un atto di piaggeria verso le frange estreme della cosiddetta cultura woke che, detto en passant, nulla hanno a che spartire col concetto di inclusività. Peggio ancora.
Ma qui c’è un altro punto, qualcuno effettivamente cerca un dialogo e un confronto su questi temi? A qualcuno interessa parlare di contenuti, di situazioni concrete? Francamente vedo sempre più intransigenza da una parte e dall’altra e sempre meno voglia di capire le ragioni altrui, e questo vale per tutti i temi di confronto del vivere comune nelle nostre società. Vengo poi alla seconda domanda. È proprio necessario creare delle contrapposizioni ideologiche?
Parrebbe di sì. Uno sport diffusissimo nel mondo intero, da sempre, è quello di dividersi in fazioni. A prescindere, in parte o anche completamente, dai contenuti. Contrapposizioni tra fazioni che spesso sfociano nella categorizzazione e demonizzazione del pensiero altrui e, infine, in odio reciproco; odio di appartenenza, di bandiera, che non è una bella cosa e che sa tanto di disagio psicologico.
Il problema è rompere questa spirale e spostare la discussione dal “packaging” al contenuto.
Non saranno delle rettrici uomini a riuscire in questo.
Perturbare l’universale - Un sasso lanciato nello stagno
Il rapporto tra genere e istituzioni è problematico fin dalle origini, poiché le istituzioni stesse sono le prime ad aver contribuito, spesso in maniera determinante, alla produzione e riproduzione del sessismo. In particolare, le istituzioni hanno agito in due modi: attraverso la discriminazione di alcuni gruppi, a partire dalle donne, fino a omosessuali, transessuali, intersessuali, etc., evidenziandone le particolarità; oppure esse hanno agito nel senso opposto, invisibilizzando gli stessi gruppi attraverso l’uso di un neutro universale. Per questo chiedersi quale possa essere il ruolo del linguaggio delle istituzioni nella sovversione del binarismo di genere è una domanda complessa e sfaccettata.
Già nel 1986, Alma Sabatini, una linguista femminista, su segnalazione della Commissione Nazionale Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha scritto un testo per dare indicazioni per attenuare il sessismo della lingua italiana. A seguito di un’indagine sulla terminologia usata nel linguaggio istituzionale, nei libri di testo e nei mass media, Sabatini sottolineò la prevalenza del genere maschile, usato in italiano anche con doppia valenza (il cosiddetto maschile neutro) che annulla la presenza del soggetto femminile dai discorsi. Ha sottolineato il mancato utilizzo di termini istituzionali e di potere declinati al femminile (ministra, assessora, sindaca) e il prestigio concesso a un termine maschile, ma non al corrispettivo femminile. Sabatini afferma che: “La premessa teorica alla base di questo lavoro è che la lingua non solo riflette la società che la parla, ma ne influenza e limita anche il pensiero, l'immaginazione e lo sviluppo sociale e culturale”.
Le fondamentali riflessioni di Sabatini, e le sue raccomandazioni, hanno evidenziato l’assenza delle donne dal linguaggio della scena pubblica, ma allo stesso tempo hanno mostrato come criticare l’universale maschile non significhi uscire dal binarismo di genere. La struttura della lingua italiana, infatti, richiede una costante esplicitazione del genere a cui si appartiene, arrivando ad attribuirlo anche alle cose inanimate. Inoltre, per esprimere questa appartenenza di genere, in italiano è possibile riferirsi solo al maschile o al femminile, poiché non esiste un genere neutro che possa essere utilizzato. Negli ultimi anni, molti movimenti sociali che si definiscono queer hanno cercato di mettere in discussione questo binarismo imposto attraverso l’uso di asterisco, @ o -u come desinenze non sessuate. In questo senso i movimenti parlano di “queerizzare” la lingua italiana. Ciò significa pensare al modo in cui la lingua può essere forgiata dall’interno per opporsi, seguendo le indicazioni della linguistica queer[1], alle idee essenzialiste, naturalizzate ed egemoniche su genere e sessualità. Queste sperimentazioni, però, non trovano spazio negli ambiti istituzionali, nei quali sono ancora percepite come elementi di disordine[2]. Una forma di resistenza linguistica che proviene dai movimenti politici, da un uso situato e perturbante della lingua e dalla possibilità di utilizzare il linguaggio contro se stesso.
Allo stesso tempo, è importante notare come, nella tradizione del femminismo italiano della cosiddetta seconda ondata, il rapporto con la legge è spesso stato problematico ed è stato messo in discussione in molti modi. Come reso evidente riflessione del Collettivo della Libreria Femminista di Milano Non credere di avere dei diritti (1987), l’inclusione delle donne nell’attuale sistema giuridico è considerata un rischio: in questo senso era . In questo testo su giustizia e diritto si sostenevano alcune tesi: il diritto è concepibile solo come traducibilità e fonte dell’esistenza sociale; la giustizia può andare oltre il diritto attraverso la formula del giudizio politico sull’ingiustizia; fare giustizia significa praticare, ciascuna nel luogo in cui si trova, un’idea di mondo giusto fondata innanzitutto sulla valorizzazione dell’esperienza e sulla trama delle relazioni umane. Come sottolinea Tamar Pitch: “una caratteristica comune dell’approccio femminista è la messa in discussione della definizione positiva del diritto e della tradizione più rigida del positivismo giuridico, producendo norme e ragionando su norme al di fuori del perimetro della legge [...]. Questo non solo perché il femminismo costituisce ‘punto di vista esterno’, [...] ma perché ragiona sulle norme in vista della possibile produzione di regole giuste” (Pitch T., I diritti fondamentali: differenze culturali, disuguaglianze sociali, differenza sessuale, Giappichelli, 2004, p. 62).
Con queste premesse è possibile capire perché le teorie femministe guardino in maniera ambivalente i regolamenti, che allo stesso tempo esprimono le norme ma possono essere anche terreno della loro risignificazione, anche a partire dal linguaggio. In particolare da un linguaggio, come l’italiano, che non solo propone un rigido binarismo di genere, ma che riproduce costantemente l’egemonia maschile e la maschilità egemonica: “la maschilità egemone […] garantisce (o si presume garantisca) la posizione dominante degli uomini e la subordinazione delle donne. […] Il segno distintivo dell’egemonia è, infatti, l’autorità reclamata e ottenuta, più che la violenza diretta” (Raewyn W. C. Connell, Masculinities, Polity Press, 1995, p. 69) ed è pertanto quell’insieme di comportamenti, abitudini, modi di vita e di azione che riproducono il dominio senza bisogno di agire forme di coercizione. La maschilità egemone non è un tipo di carattere fisso, sempre e ovunque lo stesso, bensì si tratta della “maschilità che occupa una posizione egemone in una struttura data di relazioni di genere, una posizione che è sempre possibile contestare” (Cit., p. 76), anche da parte degli stessi maschi.
La teoria della maschilità egemone si basa sul pensiero di Antonio Gramsci e sul suo uso del concetto egemonia, il processo grazie al quale le classi dominanti ottengono un potere epistemico di definizione della cornice di significato entro la quale la realtà viene letta. Gramsci sottolinea come le classi dominanti mantengano la propria posizione di privilegio non solo attraverso l’azione diretta di un dominio, ma anche attraverso la creazione di modelli culturali tramite che possano creare consenso nelle classi subordinate rispetto alla legittimità e l’inevitabilità della posizione di privilegio della classe dominante stessa.
E le donne si trovano a occupare la posizione subalterna, a potersi esprimere solo con le parole e l’immaginario maschile, anche quando parlano di loro stesse. E i termini maschili e le desinenze maschili vengono presentate come neutre e in quanto tali universali e incontestabili. Proprio per questo, anche attraverso l’analisi del linguaggio, “possiamo […] ripensare la mascolinità egemonica come contesto pervasivo, superando la semplice distinzione tra soggettività egemoni e marginali o subalterne. Insomma intendere una più generale egemonia della e non nella maschilità, leggendo criticamente i riferimenti simbolici che strutturano, in forme diverse, tutte le maschilità” (Ciccone S., Maschi in crisi, Rosenberg & Sellier, 2019, p. 119).
Parlare di sé al maschile (come quando io, da donna, scrivo “eravamo tutti d’accordo") o riconoscersi in un appellativo al maschile (come quando le studenti rispondono al “buongiorno a tutti” di chi entra in aula), svela come l’essere donna sia una condizione straniante, in cui si è oggetto dei discorsi senza poterne diventare soggetto. Le donne imparano a pensarsi, in qualche modo, attraverso lo sguardo e le parole maschili e poi lavorano per differenza, per scarto rispetto a quello che vivono, in un processo che sovverte le traiettorie usuali del riconoscimento: non si tratta, infatti, di scoprire qualcosa, ma di smantellare qualcosa di già detto, di già riconosciuto.
Seguendo Teresa de Lauretis potremmo dire, così, che “il femminismo […] scoprì l’inesistenza della donna: il paradosso di essere allo stesso tempo catturate e assenti nei discorsi, sempre parlate ma inascoltate, e nell’impossibilità di esprimersi, mostrate come uno spettacolo eppure non rappresentate o irrappresentabili […], un essere la cui esistenza e la cui specificità sono simultaneamente affermate e rifiutate, negate e controllate” (de Lauretis T., Eccentric Subjects, in Ead. Figures of Resistance (1990), University of Illinois Press, 2007, p. 151). Questa inesistenza della donna diventa il motore per non poter fare a meno di interrogarsi costantemente su cosa voglia dire donna e “la ragione per cui non possiamo farne a meno è che, per le donne, il paradosso della donna non è un’illusione o un’apparente contraddizione, ma una realtà” (Cit., p. 154). Donna, quindi, sarebbe il prodotto di un’esclusione, di un’alterità che si mostra in maniera lampante nel linguaggio che utilizziamo.
In tutta la storia dei femminismi, non a caso, le donne si sono appropriate del lessico politico degli esclusi, dall’uguaglianza della Rivoluzione Francese all’emancipazione sindacale, per risignificarlo e svelarne la parzialità. Quando Olympe de Gouges scrive la Dichiarazione della donna e della cittadina nel 1792 non fa altro che questo: perturbare la rivendicazione dei diritti dell’uomo mostrando come quella stessa pretesa di universalità escluda le donne. Sostituire la parola donna alla parola uomo negli articoli della Dichiarazione, quindi, non è un gesto puramente semantico – come non lo sono mai le sovversioni linguistiche femministe, lesbiche, gay e transfemministe –, ma si tratta uno spaesamento che permette di cogliere i dispositivi di inclusione ed esclusione che sottendono alla politica. De Gouges lascia quasi invariato il testo della Dichiarazione, sostituendo donna e cittadina tutte le volte che compare uomo e cittadino, ma modifica in maniera sostanziale l’articolo dedicato alla libertà di opinione, che nella sua formulazione recita:
la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei più preziosi diritti della donna, poiché tale libertà assicura la legittimità dei padri nei confronti dei figli. Ogni cittadina può quindi affermare liberamente: sono madre di un figlio che vi appartiene, senza che un barbaro pregiudizio la costringa a dissimulare la verità
(Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791; trad. it., Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, Il Melangolo, 2007, pp. 21-22).
De Gouges lega così la libertà di opinione alla possibilità di mettere in discussione uno dei cardini dell’ordine patriarcale: l’indissolubile legame tra paternità e matrimonio. Un gesto che sovverte l’ordine familiare, basato sull’idea della centralità del matrimonio come baluardo della legittimità della prole e strutturato attraverso il predominio maschile. E in questo modo, a partire da una condizione apparentemente privata come la maternità, mette in crisi quell’ordine politico fondato proprio sull’ordine domestico.
De Gouges svela anche l’impostura di una volontà generale che si esprime in una universalità che in realtà è maschile. Inoltre, riformulando l’articolo IV, pone in relazione libertà e giustizia, definendola come l’azione di restituire tutto quello che appartiene ad altri: poiché le donne non hanno mai posseduto nulla, possono così riappropriarsi di tutto quello che è loro. Emerge, così, un ideale di uguaglianza che cerca di tutelare anche la differenza[3], chiedendo un’inclusione nello spazio pubblico che non cancelli una storia differente, fatta si sopraffazione e ingiustizia, ma anche di resistenza.
In questo senso utilizzare un femminile sovraesteso permette un inciampo nel pensiero e nel linguaggio che può spingerci a riflettere sulle modalità di costruire l’universalità e i soggetti come omogenei, intercambiabili. Il disagio che gli uomini possono provare nel sentirsi inclusi in un tutte o nel trovarsi descritti come le docenti può essere produttivo non tanto per fondare una nuova norma, ma per perturbare quelle già esistenti e per provare a modificare la percezione delle cariche, dei ruoli di potere ma anche della pretesa universalità del maschile sottolineando le esclusioni che provoca. Il campo del linguaggio, in questo senso, è un campo di battaglia su cui vale la pena scendere e che sicuramente vale la pena osservare, anche per dare spazio ad altre narrazioni e ad altre possibili strutture, senza dimenticare, però, gli effetti materiali trasformativi che può produrre e che dovrebbero essere prodotti.
[1] La linguistica queer è una definizione data da Heiko Motschenbacher a quella branca della linguistica che, ispirandosi alle teorizzazioni sul queer, analizza criticamente le nozioni essenzialiste, egemoniche e naturalizzate su genere e sessualità. Si veda M. Heiko, Taking Queer Linguistics further: sociolinguistics and critical heteronormativity research, International Journal of the Sociology of Language, 212, 2011, pp. 149-179.
[2] Cfr. M. Baldo, Frocie, femminelle, terrone, polentone e favolosità varie. Quando il queer è di casa, online, 2017, http://www.queeritalia.com/blog/2017/5/13/frocie-femminelle-terrone-polentone-e-favolosit-varie-quando-il-queer-di-casa1 e I. Marotta e S. Monaco, Un linguaggio più inclusivo? Rischi e asterischi nella lingua italiana, Gender/sexuality/Italy, 3, 2016.
[3] Cfr. Martina Reuter, Equality and Difference in Olympe de Gouges’ Les droits de la femme. A La Reine, Australasian Philosophical Review, 3, 4, 2019, pp. 403-12.
Linguaggio di genere – Il caso del femminile sovraesteso
1.
L’Università di Trento ha recentemente redatto il nuovo Regolamento generale di Ateneo in un modo che, a prima vista, può sembrare curioso: ha indicato tutte le professioni con i termini al femminile, a prescindere dal genere delle persone che ricoprono le varie cariche.
Le parole del rettore stesso, riferendosi alla bozza del testo, sono emblematiche: «leggere tutto il documento […] mi ha colpito. Come uomo mi sono sentito escluso. Questo mi ha fatto molto riflettere sulla sensazione che possono avere le donne quotidianamente quando non si vedono rappresentate nei documenti ufficiali».
L’Ateneo si è avvalso del femminile sovraesteso in luogo del modello standard, cioè il maschile sovraesteso (o non marcato). Questa è una forma espressiva che conosciamo bene, in quanto la usiamo in ogni contesto, pubblico o privato; per esempio, quando salutiamo dando il buongiorno a tutti, quando dichiariamo che siamo arrivati in un luogo, oppure quando specifichiamo di uscire con amici, pur in presenza, in tutti questi casi, anche di persone di genere non maschile.
Per far scattare il maschile sovraesteso, è sufficiente che in un gruppo ci sia almeno un soggetto di genere maschile, a prescindere dal genere di tutte le persone appartenenti al gruppo stesso e, inoltre, senza considerare le eventuali statistiche: anche se la percentuale di uomini dovesse essere nettamente inferiore rispetto alle altre identità, da prassi verrebbe comunque usato il maschile.
La questione non è di poco conto. Infatti, «il problema secondo chi se ne occupa è che alla prevalenza del maschile sul femminile nel linguaggio corrisponda anche una prevalenza nel pensiero, e che quindi continuare a usare il maschile sovraesteso […] sia di fatto un modo per perpetrare un modo di pensare in cui le donne sono sistematicamente subordinate agli uomini».
Alla luce di tutte queste considerazioni, proviamo ad approfondire la tematica.
2.
La scelta linguistica dell’Università di Trento mi piace. Molto. Aiuta a fare chiarezza su come il linguaggio non sia qualcosa di neutro, in quanto riflette la società nella quale viene costruito, ereditandone gli errori e le distorsioni. In effetti, «la lingua parlata da una comunità è uno specchio della realtà in cui si vive; in questo specchio si rendono evidenti anche quelle situazioni ancora da migliorare che non sono solo negli elementi della lingua, ma anche della comunità stessa dei parlanti» (Lorenzo Gasparrini, Non sono sessista, ma… Il sessismo nel linguaggio contemporaneo, Roma, Edizioni Tlon, 2019, p. 48).
Il linguaggio è, a volte, sottovalutato e, pertanto, non se ne coglie la fondamentale importanza per la costruzione del mondo che ci circonda; infatti, esso può contribuire a creare una ben specifica narrazione e, di contro, ne va a oscurare altre.
Facciamo dunque attenzione a quello che diciamo: usare una determinata parola piuttosto che un’altra chiama in causa un mondo piuttosto che un altro; così facendo, viene coinvolta anche la rete di significati che tale mondo porta necessariamente con sé. Quindi, il linguaggio non solo non è neutro, ma non è neanche isolato.
Il maschile sovraesteso, come tutto il linguaggio, rappresenta un modello di società, una presa di posizione; tuttavia, questo modello non l’abbiamo scelto ma ci è stato imposto. Come? Per esempio, attraverso l’abitudine, che «scambiamo per naturalezza, ovvietà, inoffensività e leggerezza» (cit., p. 75). Infatti, usando costantemente termini declinati al maschile per riferirci a una pluralità mista di persone, abbiamo sviluppato l’idea che il maschile sia l’opzione “giusta” e, pertanto, non abbiamo ritenuto che potesse avere delle criticità. Eppure, esso esprime solo una delle alternative possibili, rappresenta semplicemente quella standardizzata. Ma standard non sempre significa corretto.
Il maschile sovraesteso è quindi uno dei (tanti) modi di cui la società si avvale per sopravvivere, generazione dopo generazione; occultando le sue scelte fa in modo che diventino le nostre scelte, e siamo tutti felici. Al maschile, però. Infatti, così facendo, non vengono prese in considerazione altre narrazioni, verso le quali tale scelta non è adeguata. Esistono allora persone di serie A e persone di serie B?
Attenzione, non sviliamo la questione affermando che c’è “ben altro”, ma chiediamoci: se un certo tipo di parole venissero usate verso di me, cosa proverei? Facciamo un esempio: se io fossi un uomo privilegiato e, in una conferenza, il relatore salutasse il pubblico esordendo con “buongiorno a tutte”, come mi sentirei? Ecco, magari quella stessa sensazione la provano – o l’hanno sempre provata – altre persone.
Allora, valutiamo bene se alcune parole possano farci sentire a disagio, mettendoci poi nei panni di altri individui; il mondo che abbiamo sempre abitato potrebbe sembrarci molto diverso, se osservato con altri occhi.
È necessario, pertanto, ripensare (anche) come ci esprimiamo, in modo da includere altre narrazioni rispetto a quella standard; non dimentichiamo che «la nostra natura è quella di scopritori di differenze» (cit., p. 22). La scelta dell'Università di Trento, paradossale solo in apparenza, indica una direzione che mi sembra corretta.
Come ogni costruzione sociale, anche il linguaggio si può problematizzare e rinegoziare; può essere decostruito e, con esso, si possono decostruire le narrazioni, i mondi, che porta con sé. Può dunque evolvere. Tutto parte sempre da noi, con le nostre domande e le nostre scelte; se comprendiamo la contingenza delle influenze che abbiamo intorno, arriveremo ad abitudini più consapevoli e, inoltre, avremo maggior cura e riguardo nei confronti di altre persone.
E, lo ripeto, non sono affatto questioni di poco conto.
Papa Francesco e l'Ideologia Gender - Uno scivolone etico e politico?
Papa Francesco si è recentemente scagliato contro la cosiddetta “ideologia gender”, apostrofandola come «il pericolo più brutto del nostro tempo». A suo dire, essa abolisce le differenze e «rende tutto uguale», dichiarando inoltre, in modo lapidario, che «cancellare la differenza è cancellare l’umanità».
Ma che cos’è il gender? E poi, cos’è tale “ideologia gender”?
Gender e sesso biologico
In prima approssimazione e a grandi linee, è possibile intendere il genere (in inglese “gender”), come «orientamento psicosessuale che l’individuo acquisisce su basi culturali»; pertanto, esso è una costruzione sociale che investe, e condiziona, i nostri corpi, le nostre identità e le nostre vite.
Il genere è quel dispositivo che viene attivato a partire dal nostro sesso anatomico e ci indirizza verso i ruoli che la società ha già preparato per noi. Infatti, «mentre il termine sesso viene […] usato per indicare la dimensione biologica dell’essere donna o uomo, [genere] implica la variabilità delle interpretazioni che culture, tra loro diverse, hanno costruito a partire dal dato di partenza biologico». Pertanto, sesso e genere sono distinti: anatomico-biologico il primo, culturale-sociale il secondo.
Prendiamo, come esempio, i sessi femminile e maschile. La società impone a donne e uomini di conformarsi a quello che si ritiene essere il modo “naturale” di esser femmine e il modo “naturale” di esser maschi; l’assegnazione alla nascita dell’uno o dell’altro sesso, dunque, indirizza da subito verso un genere definito.
La costruzione sociale è decisamente pervasiva; è facile pensare subito a temi e oggetti destinati a un pubblico femminile e i relativi equivalenti che, invece, sono indirizzati a un pubblico maschile, con rigide distinzioni e confini che non devono essere superati per non incappare nella discriminazione, nell’esclusione sociale, nel giudizio negativo. Infatti, ha una connotazione di genere un numero considerevole delle cose con cui entriamo in contatto ogni giorno, sia concrete che astratte: capi d’abbigliamento, accessori, giocattoli, interventi sul corpo, desideri, professioni ecc.
Tuttavia, affrontare il tema del genere in modo critico è una via che può permettere la decostruzione dei condizionamenti sociali, in quanto porta a riflettere sui rapporti che distinguono tra femminile e maschile, aprendo così a diverse narrazioni e a maggiori libertà individuali.
Infatti, «il [genere] si inscrive in un più ampio ripensamento dei temi legati all’identità, al soggetto, alla sessualità, alla corporeità, che si coniugano con possibilità di espressione e trasformazione, in rapporto critico e innovativo con categorie che tendono a fissarsi e ad assumere forza regolativa e normativa». Non dimentichiamo che le costruzioni sociali sono rinegoziabili.
Dunque, sembra chiaro che il genere è un dispositivo costruito in parte dai condizionamenti sociali e in parte dalle scelte e dalle storie personali, [1] con tutte le possibilità che ne derivano.
LA COSIDDETTA "IDEOLOGIA GENDER"
L’oggetto dell’invettiva papale, l’Ideologia Gender, è, in realtà, un concetto-ombrello nato verso la fine degli anni ’90 nell’ambiente cristiano cattolico conservatore statunitense, e precisamente ad opera del “Family Research Council, una lobby familiarista cattolica statunitense, attivista dell’Opus Dei, e vicina ai Narth (Associazione nazionale per la ricerca e terapia dell’omosessualità) cioè ai sostenitori delle terapie riparative per l’omosessualità”.
Perché questi gruppi di cattolici conservatori hanno “inventato” questo concetto-ombrello?
Il fine – abbastanza evidente nella prima pubblicazione, “The Gender Agenda: Redifining Equality” di Anne O’Leary – è quello di comprendere sotto lo stesso termine e contrastare l’ampio spettro di pensieri e pratiche di quegli anni, pensieri e pratiche che non rientravano nelle posizioni cristiano-cattoliche più tradizionaliste; in questo spettro troviamo, secondo gli estensori della “Gender Agenda”, chi “si occupa del controllo della popolazione; i libertari della sessualità; gli attivisti dei diritti dei gay; i promotori multiculturali del political correct; la componente estremista degli ambientalisti; i neo-marxisti/progressisti; i decostruzionisti/postmodernisti.”
Una crociata “contro”, insomma, in cui la componente di contrasto verso delle pratiche di tolleranza e di normalizzazione sociale degli orientamenti sessuali e di genere “non tradizionali” è solo una piccola parte.
L’Ideologia Gender sembra, quindi, non esistere se non nelle intenzioni di chi non ne fa parte.
Sembra essere un altro argomento fantoccio, creato per sostenere teoreticamente un’operazione di rafforzamento di confini molto ampi, tra il tradizionale e “l’altro”, di esclusione di ciò che è “strano”.
Sotto questo concetto-ombrello, però, si riparano dalla pioggia delle posizioni “strane” anche, nell’ordine:
- i vertici della dottrina cristiano-cattolica, il Consiglio Pontificio pubblica un corposo testo, il “Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche” (2003), che studia e critica la fantasmatica “Teoria del Genere”;
- alcune frange dell’associazionismo cattolico;
- il cardinale Ratzinger;
- militanti conservatori e associazioni familiariste cattoliche come «Manif pour Tous-Italia», «Sentinelle in piedi», «Hommen-Italy»;
- il Forum delle Associazioni familiari [2] e un’ampia serie di soggetti tradizionalisti.
Dall’altra parte, sono invece seri e ampi studi sociologici, psicologici e medici sul genere, sulla sessualità e sulla relazione tra persona e orientamenti comportamentali, affettivi e sessuali.
LA POSIZIONE DI PAPA FRANCESCO
Ora, sull’affermazione di Jorge Mario Bergoglio, è opportuno fare delle puntualizzazioni preliminari:
- Bergoglio parla nella veste di Papa, massima autorità della Chiesa Cattolica;
- il contesto in cui parla è quello del Convegno Internazionale "Uomo-Donna immagine di Dio. Per una antropologia delle vocazioni" promosso dal Centro di Ricerca e Antropologia delle Vocazioni (CRAV); [3]
- la famiglia tradizionale uomo-donna-figli è, secondo la dottrina cristiano-cattolica, un pilastro, la cellula fondamentale della società. [4]
Non credo, quindi che ci si possa scandalizzare se il Papa difende questo elemento, storicamente alla base della dottrina della religione di cui è massima autorità.
Né, tantomeno, credo che si possa criticarlo se lo fa di fronte ad una platea di cattolici che si appresta a riflettere sul ruolo dei cristiani cattolici nella società contemporanea, sulla vocazione e sulle relazioni che i cristiani e la chiesa devono intrattenere con posizioni “altre”, diverse e variegate, non allineate all’ortodossia dottrinale.
Ancora meno, credo, che si possa lamentare una discrasia, una contraddizione, tra queste affermazioni e le recenti aperture nei confronti delle relazioni affettive e delle coppie “in situazioni irregolari e di coppie dello stesso sesso”: il mondo cattolico è ampio, complesso, poliedrico e ci vuole un ombrello molto grande per contenerlo tutto.
Quello che sembra fare Bergoglio, con quelle parole e in quel contesto, è un’operazione – me lo si passi – di marketing affiliativo, di legittimazione della propria autorità di fronte ai partecipanti al convegno, richiamandosi alle posizioni dottrinali tradizionali. Posizioni da cui ritengo normale, direi quasi opportuno, che una organizzazione inizi per pensare il confronto con la diversità.
Insomma, il papa Francesco fa il suo mestiere e lo fa, mi pare, abbastanza bene.
Stupiscono, però, due fatti, che sembrano veri e propri scivoloni di Bergoglio:
- L’uso del concetto dell’Ideologia Gender che, seppur strumentale all’operazione di auto-legittimazione, ha esposto il capo della chiesa cattolica ad ampie critiche da parte dei media e di tutti coloro che ne conoscono genesi e storia: Bergoglio, di fatto, ha attaccato un prodotto della chiesa, il cui referente empirico è fumoso;
- Il secondo scivolone, a mio avviso moralmente più grave, è il comparativo di maggioranza associato all’Ideologia Gender: “il pericolo più brutto del nostro tempo”; riesce difficile pensare che il fantasma delle minacce alla famiglia tradizionale siano, in questo momento, più pericolose e più brutte – ad esempio - della strage di famiglie israeliane compiuta da terroristi nei cosiddetti territori occupati il 7 ottobre del 2023 e il successivo massacro di dimensioni spropositate di altre famiglie, palestinesi questa volta, ancora in corso, nella striscia di Gaza.
NOTE
1 Nel parlare di scelte individuali, assumo una posizione neutrale rispetto alla questione che vede contrapposti il libero arbitrio e il determinismo materialista, con tutte le posizioni e sfumature intermedie. In questa posizione, pertanto, mi disinteresso temporaneamente della genesi della scelta e ne osservo solo il risultato.
2 Il quale ha diffuso via internet un «vademecum strumenti di autodifesa dalla teoria del gender per genitori con figli da 0 a 18 anni».
3 L’obiettivo del convegno è di discutere apertamente della vocazione al sacerdozio cristiano, della “trasmissione del patrimonio culturale e spirituale dei cristiani richiede ai credenti di tutto il mondo di riposizionarsi di fronte a un ambiente che è diventato estraneo, indifferente o addirittura ostile, anche nei Paesi tradizionalmente cattolici”. “Dobbiamo pensare in altri termini al futuro del cristianesimo, in un contesto che si aspetta che i cristiani trovino un nuovo paradigma per testimoniare la loro identità”. Obiettivo e scopo del Simposio a cui parteciperanno specialisti internazionali di Sacra Scrittura, filosofia e teologia, scienze umane e pedagogia, è “offrire una visione aggiornata dell’antropologia cristiana in un’epoca di pluralismo e dialogo tra le culture, per sostenere il significato della vita come vocazione” (Cardinale Ouellet, vedi qui).
4 «La Famiglia è costituita dall'unione indissolubile tra un uomo e una donna, aperti al dono della vita. Questa istituzione ha il suo fondamento nel disegno di Dio, ovvero nella legge naturale e perciò precede qualsiasi riconoscimento da parte della pubblica autorità. Per questo è considerata la "cellula fondamentale della società"», recita Cathopedia, l’enciclopedia cattolica.
Giocattoli di genere - Psicologia e influenza sociale
La psicologia, la filosofia e la sociologia hanno documentato come i giocattoli per l’infanzia siano portatori di modelli sociali legati al genere. In questa sede, ci concentreremo prevalentemente sul gioco in età infantile, cercando di esaminare non solo come esso trasmetta stereotipi di genere già in questa fase della vita, ma anche come sia un momento molto importante nei processi di sviluppo per bambini e bambine.
Innanzitutto, cos’è il gioco? La Treccani lo definisce così: “esercizio singolo o collettivo a cui si dedicano bambini o adulti, per passatempo, svago, ricreazione, o con lo scopo di sviluppare l’ingegno o le forze fisiche”[1]. Se diamo a questa definizione generica una sfumatura, funzionale allo scopo di questo post, potremmo aggiungere che il gioco non è un’entità statica ma si modifica, mutando i propri contenuti e la loro fruizione, al variare dei contesti (socioculturali, anagrafici ecc.).
Andiamo ad approfondire il discorso esaminando alcune riflessioni psicologiche sul fenomeno del gioco:
- Secondo H. Spencer (1820-1903), attraverso il gioco si bruciano le energie che si dovrebbero consumare nella lotta per la sopravvivenza; lotta che gli esseri umani non attuano più, in quanto “evoluti”. C’è dunque un patrimonio energetico che non si sfrutta più, ma che deve essere scaricato «in modo istintivo»[2]; il suo sfogo è individuato nell’attività ludica, grazie alla quale «il bambino sprigiona l’eccesso di energia psichica accumulata»[3].
- La “teoria catartica” di S. Freud (1856-1939) e A. Adler (1870-1937) afferma che «il gioco avrebbe la funzione di liberare l’individuo da tendenze o istinti incompatibili con le esigenze della vita sociale»[4]. Inoltre, lo stesso Freud «per primo ha posto in evidenza la funzione del gioco come manifestazione simbolica di disturbi profondi, di un conflitto psichico inconscio che richiede risoluzione»[5].
- Winnicott (1896-1971) «ha studiato lo sviluppo del bambino e le diverse fasi che lo contraddistinguono a partire dal grado di dipendenza del bambino dalla figura di accudimento. Egli ha sottolineato come il gioco permetta al bambino di prendere consapevolezza di sé stesso e, attraverso la creatività, di imparare a conoscersi»[6].
Per quanto riguarda le teorie dello sviluppo, citiamo:
- Per K. Groos (1861-1946), il gioco è un bisogno innato che ha valore di esercizio preparatorio alla vita adulta (spesso, infatti, i bambini si divertono a imitare il comportamento dei “grandi”). Pertanto, «con il gioco, […] il bambino acquisisce abilità e schemi mentali man mano più complessi che risultano indispensabili per condurre una vita autonoma»[7].
- Vygotskij (1896-1934) ritiene che il gioco abbia una funzione fondamentale per lo sviluppo del bambino su più livelli (cognitivo, emotivo e sociale)[8]. Egli evidenzia, inoltre, «come nel passaggio dall’infanzia alla fanciullezza il gioco rappresenti per il bambino un utile strumento per la gestione dell’emotività ansiogena e per la realizzazione di desideri insoddisfatti, mentre si sta relazionando con difficili compiti evolutivi, quali la differenziazione e il distacco dalla figura materna, la scoperta del Sé, la dilazione dei propri desideri»[9].
- Secondo J. Piaget (1896-1980), il gioco ha «la funzione di palestra di sviluppo, di esercitazione attiva e interattiva con l’ambiente, in grado di apportare competenze e abilità all’individuo in stretta correlazione con lo sviluppo neurobiologico e cognitivo del medesimo»[10]. In breve: «il giocare muta nella sua forma con il crescere del fanciullo»[11]; rimarcando così «una corrispondenza diretta tra gioco e sviluppo mentale del bambino»[12]. La teoria di questo autore prevede dunque degli stadi, secondo cui «il bambino matura superando una serie di tappe»[13].
Dal punto di vista sociale, infine, riportiamo:
- Fröbel (1782-1852) ritiene che il gioco sia lo strumento grazie al quale il bambino si relaziona sia col mondo esterno, sia con gli altri individui[14].
- Huizinga (1872-1945) «ha considerato il gioco come il fondamento della cultura e della vita umana organizzata in società»[15]; per questo autore, l’essere umano «è soprattutto Homo ludens più che sapiens»[16].
- Caillois (1913-1978) distingue quattro categorie:
- «Giochi di competizione (agon): tutte le gare in generale»[17], fisiche e mentali;
- «Giochi di fortuna (alea): dove il fattore primario è il caso»[18] (lotterie, scommesse, gioco dei dadi, “testa o croce” ecc);
- «I giochi incentrati sulla finzione e il mimetismo»[19], definiti «di simulacro (mimicry)»[20], nei quali si imita qualcun altro (rientrano in questa categoria, per esempio, anche i giochi dove i bambini emulano le attività degli adulti);
- «Giochi di vertigine (ilinx)»[21], dove vengono sfidati il pericolo e le leggi fisiche come, per esempio, gli sport estremi.
------------
Questa carrellata di teorie e di pensatori permette di capire come il gioco sia un’attività complessa, dalle infinite finalità e sfaccettature, e che sia un’occupazione decisamente più “seria” di quanto saremmo portati a pensare a prima vista. Essa coinvolge numerose abilità, impegnandoci sotto diversi punti di vista. Non a caso, «la principale caratteristica delle ricerche psicologiche degli ultimi decenni del 20° sec. è la rinuncia a una spiegazione unitaria ed esaustiva del significato psicologico del gioco»[22]; pertanto, «viene riconosciuta l’esistenza di forme distinte di gioco: ciascuna di esse assolverebbe diverse funzioni psicologiche, utili alla crescita fisica e psichica dell’individuo, oltre che all’adattamento e alla sopravvivenza della specie»[23]. Ricordiamo, inoltre, che i giochi di gruppo e i giochi sociali permettono relazioni interpersonali e stimolano attività condivise, ma possono creare ruoli e gerarchie; ed è proprio su questi concetti (ruoli e gerarchie) che ci dobbiamo soffermare per proseguire nell’esposizione.
Esaminiamo ora la nostra società, approfondendo il tema dei giocattoli e analizzando le imposizioni sociali che essi trasmettono a bambini e bambine, con particolare riferimento al genere.
Sotto un punto di vista evoluzionistico anche il genere sessuale e le caratteristiche temperamentali svolgono un ruolo discriminante a livello dell’evoluzione e della sperimentazione ludica, creando differenze tra maschi e femmine evidenti già dall’età infantile: i maschi sono infatti più orientati ad attività aggressive, competitive, realizzate singolarmente e basate sul movimento, sulla scoperta, sull’azione e la sperimentazione concreta, mentre le bambine appaiono propense a giochi realizzati in gruppo e fondati sull’accudimento, l’immaginazione, la cooperazione; tale differenza sembra generalmente dovuta ad una serie di influenze ambientali/esperienziali che rendono le femmine soggette ad un’educazione più improntata al controllo emotivo e alla bassa competizione rispetto al corrispondente maschile.[24]
Il discorso che ora dobbiamo affrontare prende le mosse dalla consapevolezza che i giocattoli sono (anche) uno strumento di controllo e conformismo sociale, costruiti per trasmettere (nonché conservare) modelli, ruoli e gerarchie fin dall’infanzia. Infatti, «è chiaro che anche i giocattoli sono fruitori di stereotipi di genere, intesi come rappresentazioni semplificate e riduzionistiche della realtà, socio-culturalmente condivise, che attribuiscono determinate caratteristiche agli uomini, alle donne e ai rapporti tra loro»[25]. Finalmente ci siamo: anche i giocattoli sono fautori di binarismo di genere! (Per intenderci: «si definisce binarismo di genere quella rigida distinzione tra maschile e femminile, uomo e donna, da cui deriva una altrettanto rigida aspettativa su quali debbano essere i comportamenti, gli atteggiamenti, l'aspetto, l'abbigliamento, i compiti di uomini e donne, chi debbano amare»[26]).
------------
Come si applicano le osservazioni e le analisi compiute fino a questo punto con uno sguardo su possibili sviluppi futuri?
Iniziamo parlando di “COFACE Families Europe”. Esso è un network che lavora per garantire pari opportunità e benefici a tutte le famiglie; co-fondato dall’Unione Europea, tra i suoi valori fondanti troviamo, per esempio, la non-discriminazione (il riconoscere tutte le forme di famiglia), il rispetto dei diritti umani e l’inclusione sociale. Vediamo adesso uno studio che ha coinvolto questa organizzazione:
"Con COFACE Families Europe lo scorso dicembre 2015 abbiamo lanciato una campagna sui social media, chiedendo a genitori e a chiunque volesse partecipare di inviarci foto di giocattoli e pubblicità, che mostrassero esempi positivi o stereotipi. La campagna, con l’hashtag #ToysAndDiversity ha avuto un buon successo e abbiamo deciso di andare più a fondo, con uno studio che ci facesse avere un’immagine più chiara di cosa ci fosse in Europa.
I primi anni della vita di un bambino sono fondamentali per il suo sviluppo e il gioco e i giocattoli contribuiscono a formare la personalità e gli interessi del bambino, influenzando così anche le scelte che farà nel suo futuro. Abbiamo quindi deciso, per cominciare, e per avere materiale abbastanza omogeneo, di guardare i cataloghi di giocattoli in diversi paesi europei. Con l’aiuto delle ONG che sono membri [sic] della rete di COFACE, con l’esperienza della campagna inglese “Let Toys Be Toys” e con il supporto scientifico di due professoresse universitarie, abbiamo raccolto i cataloghi e creato un questionario, composto da oltre 200 domande) che ci servisse per analizzarli."
Un anno dopo, ecco i risultati.
"Abbiamo analizzato le immagini di 3125 bambini in 32 cataloghi di 9 paesi: Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Gran Bretagna.
- 12 cataloghi erano divisi in sezioni “per maschi” e “per femmine”. 20 cataloghi non avevano questa divisione formale ma le sezioni e i giocattoli per maschio/femmina erano facilmente individuabili con il colore delle pagine (rosa e colori pastello per le bambine, colori più scuri e marcati per i bambini), dall’associazione di giocattoli nella stessa pagina (bambole e peluche per le femmine, treni e dinosauri per i maschi).
- i maschi erano almeno due terzi dei bambini presenti in 5 sezioni (su 13 in cui era diviso il nostro questionario): videogames (67%), costruzioni [sic] (69%), droni (72%), macchine e mezzi di trasporto (74%), guerra e armi (88%). Le femmine erano più di due terzi del totale solo in due sezioni: attività di cura, bambole (87%) e prodotti di bellezza (94,5%). Nelle altre sezioni, sebbene i numeri siano più bilanciati, si possono vedere delle grandi differenze guardando con quali giochi sono rappresentati i maschi e le femmine all’interno della stessa sezione (es. nella sezione “animali” i maschi giocano con dei dinosauri, le femmine coi peluche).
- La sezione dei costumi e maschere è particolarmente interessante: nei cataloghi divisi tra […] maschi/femmine, la sezione per maschi aveva costumi per supereroi, personaggi di film e cartoni animati e professioni, come dottore, pompiere, poliziotto…, la sezione per femmine aveva un numero ridotto di personaggi dei cartoni e professioni e un altissimo numero di principesse. Nei cataloghi formalmente non divisi, maschi e femmine apparivano vestiti, in pagine diverse, con lo stesso tipo di vestiti proposti nei cataloghi con categorie separate. Due proposte quindi completamente diverse. Ma se scegliamo noi per loro, proponendo solo una parte delle maschere e dei costumi disponibili, non stiamo influenzando le loro scelte? Non stiamo già dicendo come “è normale” che si immaginino?
[…]
- Sui 3125 bambini, 2908 sono stati identificati come bianchi, 120 neri, 59 di famiglie miste, 31 asiatici, 7 medio-orientali. Su 3125 bambini, nessuno aveva disabilità visibili." [27]
COFACE Families Europe si è impegnata, nel tempo, a promuovere campagne di sensibilizzazione sugli stereotipi trasmessi nei giocattoli rivolgendosi a diversi settori chiave, con lo scopo di sottolineare quanto sia importante che bambini e bambine decidano liberamente con cosa giocare, che non vengano limitati nel loro divertimento da imposizioni e pregiudizi[28].
------------
Esaminiamo adesso altri casi, che mostrano come (forse) le cose stiano cambiando:
- Il 25 settembre 2019, l’azienda di giocattoli Mattel lancia sul mercato una nuova bambola “gender free”, descritta come «né maschio né femmina» e «libera di essere come vuole, senza etichette»; l’idea alla base di questo prodotto è quella di pensare un mondo più inclusivo, che oltrepassi i vecchi stereotipi. Infatti, si può creare un numero elevato di bambole, grazie alle molteplici possibilità di personalizzazione (il colore della pelle, i capelli, gli indumenti ecc.), nonché a una corporatura definita “neutra”, permettendo così a bambini e bambine di liberare la propria fantasia[29].
- In Francia, nel 2019, una spiacevole consapevolezza ha portato a dei cambiamenti importanti. Infatti, «la mancanza di rappresentazione femminile scoraggerebbe le bambine nel perseguire una carriera nei campi delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)»[30]; tra i responsabili di questo problema sono stati individuati anche i messaggi trasmessi dai giocattoli per l’infanzia, i quali possono portare a cattiva comunicazione, ponendo il focus su una ristretta narrazione del mondo: «molto spesso, infatti, le bambine vengono associate a cucine, bambole, casette, che rimandano all’ambiente domestico, come a dire che da adulte saranno madri e donne di casa, al contrario dei maschietti, più di frequente raffigurati davanti a un microscopio»[31]. Così, il cambio di rotta: «l’accordo per una rappresentazione nel mondo del giocattolo più equilibrata è stato firmato dal governo francese, dalla Federazione Francese dei produttori di giocattoli e dalle associazioni di settore»[32]; uno statuto, quindi, che dovrebbe abbattere gli stereotipi di genere. Infatti, «i giocattoli legati alla scienza e alla tecnologia prodotti d’ora in avanti dovranno […] includere le ragazze e, che bella novità, i giochi legati alla sfera domestica dovranno includere anche i maschietti»[33]. Infine, sottolineiamo che «le nuove linee guida punteranno […] a spostare le attenzioni dei giocattolai verso il potenziale dei bambini e ciò che amano»[34].
- Nel 2021, dopo aver commissionato un sondaggio internazionale, la Lego annuncia che eliminerà gli stereotipi di genere dai suoi giocattoli. È emerso, infatti, che «mentre le bambine sono sicure di sé e pronte a giocare anche con le confezioni di mattoncini pensate per i maschi, il 71% dei bambini intervistati ha confessato di temere di essere presi in giro qualora avessero utilizzato scatole descritte come “giocattoli per ragazze”»; l’articolo riporta, inoltre, che questa è «una paura […] condivisa se non più accentuata nei genitori». La Lego, insieme al togliere le etichette di genere sui suoi giocattoli, ha diviso i giochi per “passione”.[35]
------------
È giunto il momento di tirare le conclusioni. Lo scopo di questo articolo è di esporre il delicato tema dei giocattoli per l’infanzia, cercando di mostrare il grande potere che tali strumenti hanno nella creazione di un conformismo collettivo, che ci influenza fin da piccoli. Per esporre le mie riflessioni in modo efficace, ho voluto iniziare con un’analisi del fenomeno “gioco”, in modo da falsificare i miti che lo vogliono vedere solo come un momento di svago fine a sé stesso; successivamente, ho voluto studiare la società in cui ci muoviamo. Come ho cercato di mostrare, le influenze sociali sono ovunque, immateriali e silenziose, ma ci plasmano in ogni momento della nostra vita dicendoci, per esempio, cosa pensare, dove andare, chi vedere ecc. E’ il prezzo da pagare per vivere in una società ordinata e non caotica. Tuttavia, voler comprendere questi schemi intorno a noi è il primo passo per una maggiore consapevolezza, grazie alla quale si può fendere il velo che avvolge la superficie delle cose, scavando più in profondità e accedendo così a un mondo completamente nuovo, invisibile e sotterraneo. È fondamentale, infatti, imparare a riflettere e a decostruire i modelli sociali, guardare la realtà con occhio attento e critico, non pensare che sia tutto immutabile, ma capire che la linea di demarcazione può essere rinegoziata e spostata «sempre un po’ più in là...» (per citare una raccolta di storie di Corto Maltese). I giocattoli, per tornare a noi, sono dunque uno dei tanti modi con cui siamo bombardati da influenze e scelte che (forse) in realtà non ci appartengono, tra l’altro in un periodo della nostra vita davvero importante: avere (o non avere) determinati stimoli in età infantile può plasmare gli adulti che saremo. Se è vero che il giocare prepara i piccoli alla vita “da grandi”, è innegabile che molti giocattoli in commercio assolvono a questa funzione, ma al costo di incanalare bambini e bambine nei ruoli che la società ha costruito per loro e per la loro vita futura, stabilendo che tipo di adulti saranno e discriminando chiunque non si conformi a questa collocazione. I giocattoli, pertanto, aprono un’interessante finestra sulla nostra stessa realtà sociale, sul mondo in cui viviamo, con tutti i suoi stereotipi da individuare (sono ben nascosti), esaminare, comprendere e, lo ripeto, decostruire.
Note e Bibliografia
[1] gioco nell'Enciclopedia Treccani
[2] https://www.studenti.it/gioco-in-pedagogia-come-strumento-educativo.html
[3] gioco nell'Enciclopedia Treccani
[4] gioco nell'Enciclopedia Treccani
[5] Gioco: le funzioni evolutive e la sua importanza nello sviluppo del bambino (stateofmind.it)
[6] Il gioco in pedagogia come strumento educativo | Studenti.it
[7] Il gioco in pedagogia come strumento educativo | Studenti.it
[8] Il gioco in pedagogia come strumento educativo | Studenti.it
[9] Gioco: le funzioni evolutive e la sua importanza nello sviluppo del bambino (stateofmind.it)
[10] Gioco: le funzioni evolutive e la sua importanza nello sviluppo del bambino (stateofmind.it)
[11] Il gioco in pedagogia come strumento educativo | Studenti.it
[12] gioco in "Dizionario di Medicina" (treccani.it)
[13] Il gioco in pedagogia come strumento educativo | Studenti.it
[14] Il gioco in pedagogia come strumento educativo | Studenti.it
[15] Il gioco in pedagogia come strumento educativo | Studenti.it
[16] gioco in "Dizionario di Medicina" (treccani.it) (corsivi in origine)
[17] gioco in "Dizionario di Medicina" (treccani.it) (corsivo in origine)
[18] gioco in "Dizionario di Medicina" (treccani.it) (corsivo in origine)
[19] Il gioco in pedagogia come strumento educativo | Studenti.it
[20] gioco in "Dizionario di Medicina" (treccani.it) (corsivo in origine)
[21] gioco in "Dizionario di Medicina" (treccani.it) (corsivo in origine)
[22] gioco nell'Enciclopedia Treccani
[23] gioco nell'Enciclopedia Treccani
[24] Gioco: le funzioni evolutive e la sua importanza nello sviluppo del bambino (stateofmind.it)
[25] Sinapsi - Spiderman non è una principessa e non è rosa... eppure ad Emma piace! Gli stereotipi di genere nei giocattoli (unina.it)
[26] Sinapsi - Binarismo di genere: fin dove possono spingersi le sue conseguenze? (unina.it)
[27] Stereotipi di genere: l'educazione inizia dai giocattoli - Netural Family-Attività per bambini a Matera e proposte innovative per famiglie felici.
[28] #ToysAndDiversity | COFACE Families Europe (coface-eu.org)
[29] Le informazioni e le citazioni qui riportate provengono da: Barbie, arriva la bambola "gender free": "Libera da ogni etichetta perché i bambini sono contrari agli stereotipi" - Il Fatto Quotidiano
[30] Stereotipi di genere nei giocattoli: la Francia dice no (tomshw.it)
[31] In Francia firmata carta con i produttori di giocattoli contro gli stereotipi di genere - greenMe
[32] Stereotipi di genere nei giocattoli: la Francia dice no (tomshw.it)
[33] In Francia firmata carta con i produttori di giocattoli contro gli stereotipi di genere - greenMe
[34] Stereotipi di genere nei giocattoli: la Francia dice no (tomshw.it)
[35] Le informazioni e le citazioni qui riportate provengono da: La Lego annuncia, niente più etichette di genere sui giocattoli - Notizie - Ansa.it