Nell’articolo precedente abbiamo provato a dare un’idea di cosa sia il progetto del Deposito Nazionale delle scorie radioattive e della situazione di stallo in cui versa – in questo momento – tra una legge approvata nel 2011 e l’apparente cambiamento di piani enunciato dal Ministro dell’Ambiente meno di un mese fa.
Abbiamo anche accennato che il processo di identificazione della località dove costruire il Deposito1 doveva passare attraverso la Consultazione Pubblica, un iter che prevede la discussione pubblica, con «tutti i soggetti interessati alla realizzazione e all’esercizio del deposito, inclusi i comuni in cui potrebbero essere localizzati, le regioni coinvolte, le associazioni ambientaliste e i cittadini residenti nelle aree interessate».
OBIETTIVI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA
Nel disegno delineato da Sogin, la Consultazione Pubblica aveva tre obiettivi:
- il primo, di ampio respiro, era spiegare a tutti gli stakeholder coinvolti cos’è il Deposito, perché è necessario farlo, come viene fatto e perché non comporta rischi significativi per l’ambiente e la popolazione;
- il secondo obiettivo era arrivare alla Carta Nazionale delle Aree Idonee per la costruzione del deposito escludendo quelle 2 che – sulla base delle considerazioni fatte dagli interessati – presentano delle criticità ancora non considerate;
- il terzo, il più importante di tutti, era stimolare la candidatura di alcune delle Aree giudicate Idonee a luogo in cui costruire il Deposito.
COME SI FA LA CONSULTAZIONE POPOLARE
La Consultazione Popolare è costituita da un ciclo – chiamato Seminario Nazionale – di 10 sessioni: 2 plenarie di apertura e di chiusura dei lavori, una nazionale e una sessione per ciascuna delle 7 Regioni 3 in cui si trovano il 67 siti potenzialmente idonei.
Le sessioni e le relative discussioni sono tenute in video conferenza 4 e trasmesse in streaming in tempo reale, può partecipare chiunque, istituzioni, associazioni, privati cittadini.
La struttura delle sessioni, ripetuta quasi identicamente per ogni regione, è in forma di dialogo contradditorio, con:
- la componente promotrice del Progetto, costituita da Sogin, ISIN 5, Nucleco 6, le Università direttamente coinvolte nel progetto o nei Seminari;
- le parti portatici di interessi potenzialmente contrari o di richieste di chiarimento, come le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Arpa 7, i rappresentanti degli agricoltori, le associazioni ambientaliste.
Il colloquio procede secondo uno schema di narrazione, obiezioni, risposte alle obiezioni, conclusione istituzionale; all’interno del confronto è prevista una sessione di domande fatte dai partecipanti – inclusi i cittadini – e di relative risposte da parte del responsabile del progetto: l’Ing. Chiaravalli di Sogin.
Ogni sessione è seguita da una sintesi e da una formalizzazione dei risultati.
A titolo di esempio, ecco il programma della Sessione dedicata a Basilicata e Puglia:
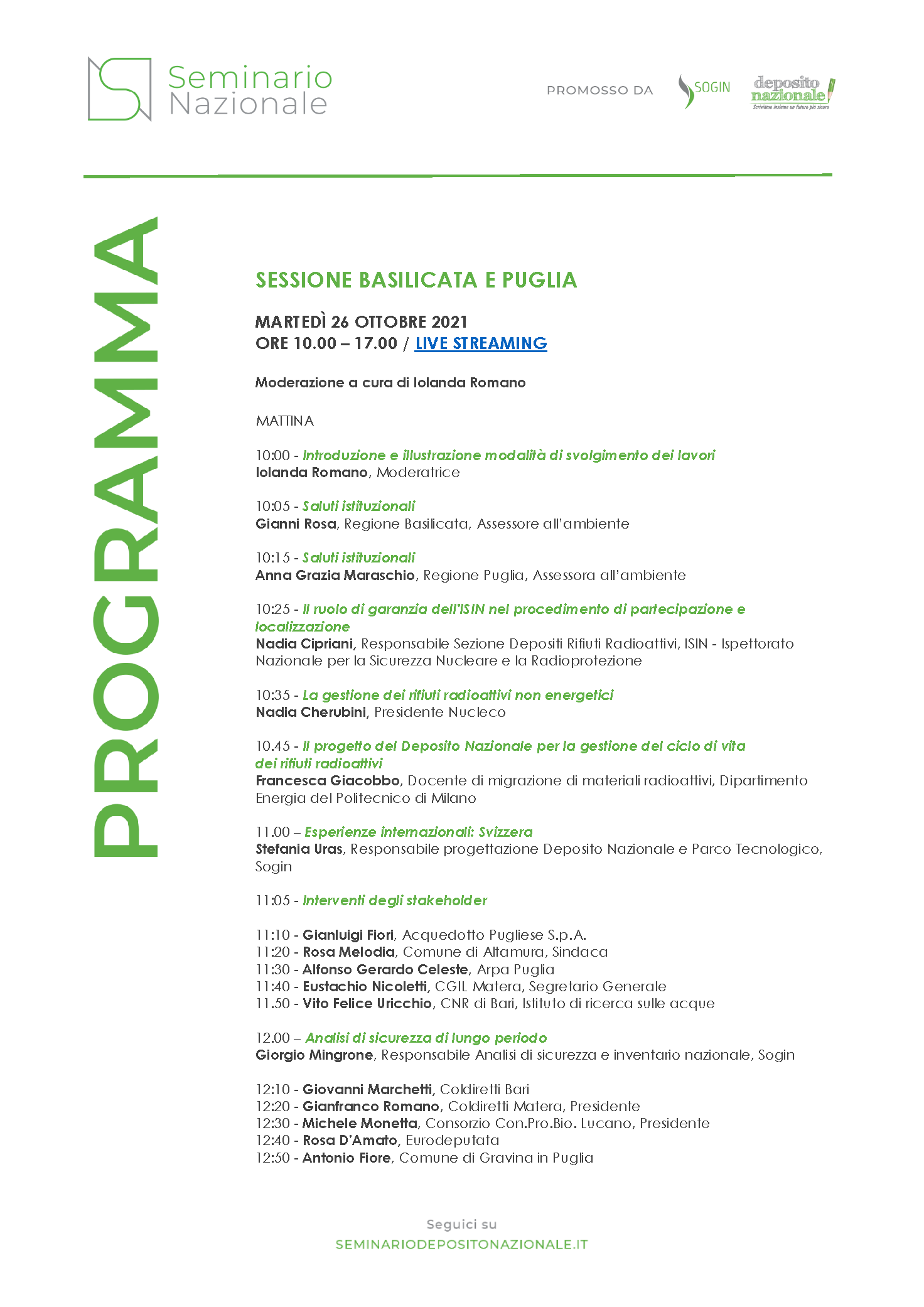
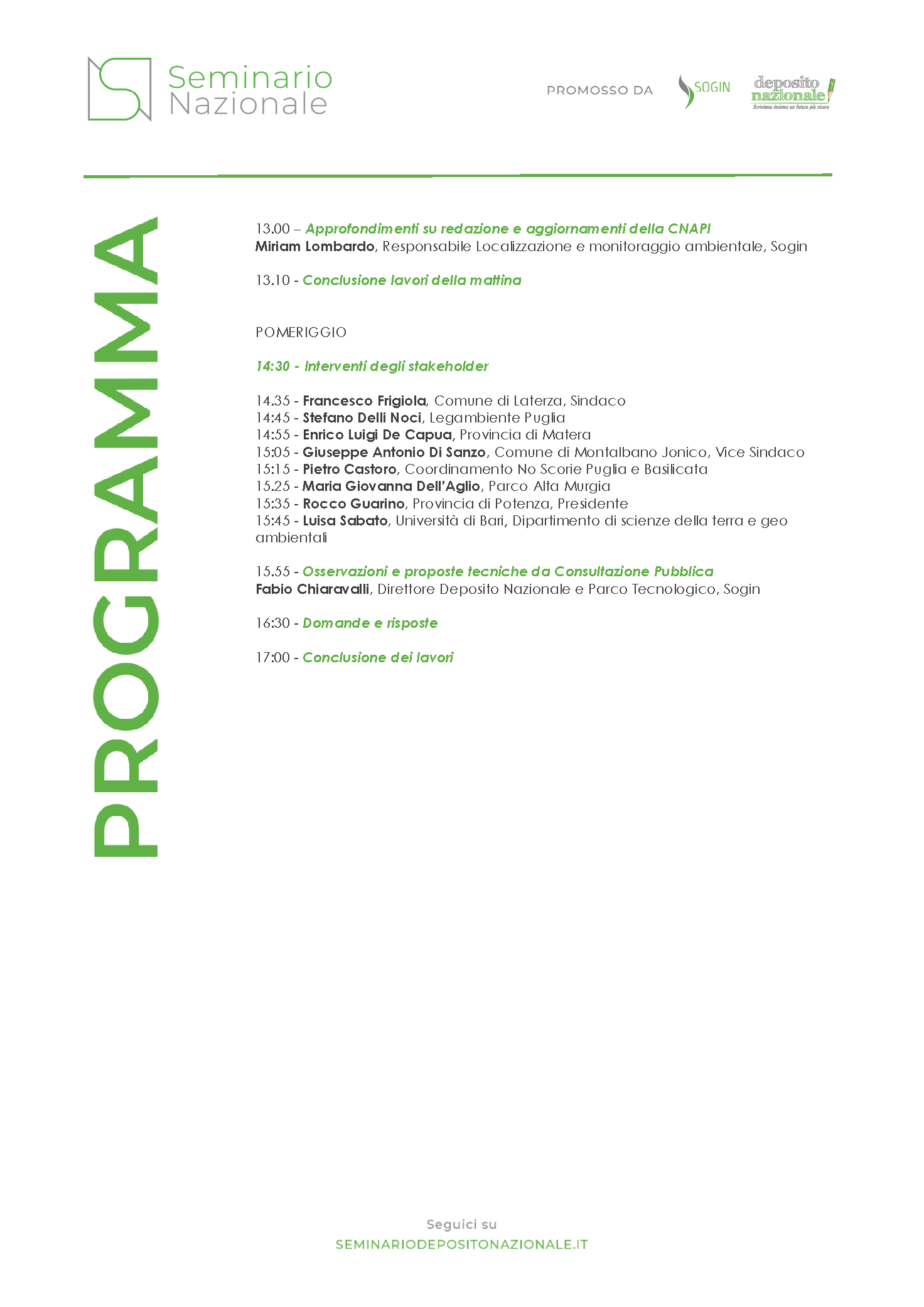
In filigrana, nello svolgimento dei Seminari si intuisce che:
- Sogin domina il contraddittorio da una posizione cattedratica: è il referente delle domande, fornisce chiarimenti e neutralizza le obiezioni;
- il confronto mira a neutralizzare le obiezioni sull’impianto generale del progetto, a convincere gli ascoltatori della necessità e non pericolosità del Deposito. Solo occasionalmente censisce fattori di esclusione di alcuni siti.
QUALI DUBBI E OBIEZIONI SONO EMERSI?
Nelle sintesi degli incontri sono riportate le principali classi di obiezioni emerse durante i seminari. Sogin identifica due classi di argomenti ricorrenti:
- quelli di carattere generale (non direttamente collegati ai territori interessati dalla CNAPI);
- quelli legati direttamente alla CNAPI e all’applicazione dei Criteri di localizzazione della Guida Tecnica n. 29 (Sintesi Sessione Piemonte) 8.
Nel secondo gruppo figurano problemi come:
- aspetti geologici locali (ad esempio: sismicità locale o particolarità idrogeologiche) non considerati che potrebbero sconsigliare la localizzazione in una determinata area;
- la presenza di aree naturali protette, di habitat faunistici, di direttive protezionistiche, quale, ad esempio, il Geoparco degli etruschi, in Lazio (Sintesi Sessione Lazio);
- la «presenza di coltivazioni di prodotti di pregio e la presenza di zone sottoposte a vincolo di tutela ambientale e dei beni culturali» o una concentrazione abitativa superiore a quanto rilevato (Restituzione dei lavori – Sessione Sicilia);
- possibili difficoltà logistiche, quali le condizioni dei trasporti e delle strade 9.
Questo genere di obiezioni è stato preso in considerazione dal Progetto 10 e ha portato all’esclusione di 16 siti potenzialmente idonei dalla Carta definitiva delle Aree Idonee, che ne contiene solo 51.
Scrive Sogin nella Sintesi della Sessione Lazio: «i temi affrontati e le indicazioni pervenute costituiscono un arricchimento della sua base conoscitiva, integrando le descrizioni preliminari fornite nelle Relazioni d’Area pubblicate a corredo della CNAPI […] Le tematiche evidenziate […] saranno debitamente tenute in conto nel corso delle eventuali successive fasi del processo di caratterizzazione. Le segnalazioni di potenziali criticità ed elementi di attenzione […] completeranno l’insieme delle conoscenze attualmente disponibili per ognuna delle API e integreranno la base conoscitiva a partire dalla quale verrà eventualmente elaborato il Piano di Indagine per la caratterizzazione tecnica di dettaglio delle aree idonee».
In questo senso, si può sostenere che la Consultazione Pubblica abbia raggiunto uno degli obiettivi: disegnare la mappa dei siti in cui è effettivamente possibile – visto il parere degli stakeholder nazionali e locali – costruire il Deposito Nazionale delle scorie radioattive.
Nella prima classe di obiezioni espresse dagli stakeholder, invece, ricadono temi quali:
- il mancato coinvolgimento nella decisione sui criteri per le Aree Potenzialmente Idonee;
- la mancata considerazione di principi rilevanti quali, ad esempio, la presenza di coltivazioni di prodotti di pregio (Coldiretti), di aree protette (WWF, LegaAmbiente), di vincoli dei beni culturali, che avrebbero potuto delineare con maggiore precisione la mappa di idoneità;
- la visione datata del territorio, in termini di densità abitativa, di antropizzazione, di tutele e di evoluzione dei vicoli, a causa del fatto che il Progetto è nato nel 2011, che le osservazioni spesso sono precedenti a quella data e che il Seminario si tiene nel 2021;
- la componente reputazionale dei territori, molti dei quali hanno una forte identità turistica – accentuata dal turismo di wilderness – che può essere messa in crisi dalla presenza del Deposito;
- la modalità eccessivamente strutturata e rigida della Consultazione Pubblica;
- infine, una serie di domande e obiezioni generali sulla pericolosità del Deposito, sull’opportunità di realizzarlo, sulla forma e sui contenuti del progetto 11.
Queste domande e obiezioni sono state neutralizzate dalle risposte di Sogin, che ha difeso, giustificato e sostenuto – di fatto senza possibilità di replica – l’adeguatezza del progetto e della consultazione, senza però – sembrerebbe dal tenore delle domande della Sessione conclusiva 12 – placare più di tanto i timori degli stakeholder.
IL FALLIMENTO DELLA DEMOCRATIZZAZIONE DELLA DECISIONE
Il terzo obiettivo della Consultazione Pubblica, quello di stimolare le candidature degli enti locali come aree obiettivo per la localizzazione del Deposito, è stato, invece, platealmente mancato.
Come abbiamo già visto, nessun Ente locale, fatto salvo per il Comune di Trino Vercellese che però non fa parte delle Aree Idonee, ha manifestato interesse ad ospitare il Deposito, vanificando di fatto lo sforzo organizzativo ed economico della Consultazione.
Tuttavia, è evidente che:
- la forma di road-show 13 con esposizione frontale e risposta alle obiezioni, adottata da Sogin per la consultazione pubblica, ha certamente favorito la contrapposizione tra il Progetto e le obiezioni, tra Sogin e le comunità locali;
- la segmentazione temporale e spaziale, regione per regione, dei lavori ha lasciato campo libero alla fuga dalla responsabilità, aggiungendo alla posizione NIMBY quella dello “scaricabarile” verso il successivo attore consultato;
- lo scarso coinvolgimento iniziale dei diversi attori e la mancanza sia di una fase co-creazione dei presupposti e dei valori dell’iniziativa, che di una adeguata “traduzione” del progetto e di un progressivo “arruolamento”, nei confronti delle comunità locali 14, hanno minato alla base il processo.
DARE SPAZIO AL DECISIONISMO OPPURE RIPROVARCI?
Si possono, ora delineare due possibili percorsi per uscire dall’impasse: il primo è – banalmente – che Sogin abdichi al ruolo (mal recitato, finora) di primus inter pares, che cerca di mettere d’accordo le istanze di tutti gli attori coinvolti, e la decisione passi nelle mani del Governo.
Tuttavia, dato che la mappa delle aree idonee, gli stakeholder e le obiezioni sono note a tutti e che – soprattutto – il fattore tempo non è ancora così stringente, si può pensare di fare un passo indietro e salvare l’idea della democratizzazione del processo di localizzazione.
Si può, forse, adottare un approccio co-creativo di maggiore coinvolgimento, sollecitare un dialogo paritetico tra tutti gli stakeholder, dedicare tempo e energie a esplicitare le scale valoriali locali, e condividere il valore irrinunciabile della realizzazione del deposito, l’analisi del rischio, le ragioni del timore, le opportunità, le regole per la localizzazione; si possono stimare le condizioni per l’alternativa di più siti, la componente economica, i vantaggi e le rinunce che comportano le diverse soluzioni – per sceglierne una che conti sull’adesione convinta di tutti.
Tuttavia, il fallimento di questo genuino 15 tentativo di coinvolgimento degli stakeholder getta un’ombra 16 inquietante sull’applicabilità del principio di democratizzazione delle decisioni tecnoscientifiche; perlomeno nei casi – come questo – di rilievo sociale e politico di grande respiro, con numerosi e variegati interessi coinvolti, che richiedano una forte assunzione di responsabilità da parte di alcuni segmenti di popolazione, il cui senso – soprattutto – sia legato a questioni ideologiche.
È possibile che alcune di queste decisioni, il cui oggetto ha carattere tecnoscientifico ma che sono così strettamente legate al sociale e al politico, implicano in ogni caso lo scontento di qualcuno: devono quindi essere affrontate con un articolato processo di ascolto degli interessi e dei potenziali vincoli, ma devono poi per forza convergere in una presa di responsabilità, informata e trasparente, ad opera di chi governa super partes.
NOTE:
Autore
-
Laureato in Scienze Filosofiche all’Università degli Studi di Milano e manager. Scrive appunti sul rapporto tra scienze, tecnologie e morale anche quando pedala come un pazzo, la domenica mattina. A volte dice di lavorare. È il direttore editoriale di Controversie.
Leggi tutti gli articoli
