Mais, à part ça, madame la Marquise,
tous va très bien, tous va très bien.
(Paul Misraki, 1935)[1]
Dalla celebre Tout va très bien,
madame la marquise, di Paul Misraki,
canzone umoristica francese del 1935.
Di fronte ai pericoli e ai rischi che lo sviluppo tecnologico presenta, sempre più spesso da parte dell’ideologia dominante si risponde o negandoli senz’altro (e riducendo le connesse preoccupazioni a semplici reazioni tecnofobiche), oppure dichiarando che tali controindicazioni in effetti esistono ma vanno per così dire ridimensionate, perché in prospettiva passibili a loro volta di soluzione tecnica. Questa seconda strategia argomentativa è negli ultimi tempi, a fronte della sempre maggior evidenza dei problemi ecologici e non solo, largamente dominante. Il risultato che si ottiene, sul piano ideologico, non è poi tanto diverso da chi nega semplicemente i problemi: si afferma, infatti, che i rischi connessi all’adozione di una certa tecnologia non devono in alcun modo frenarne o rimetterne in discussione l’applicazione. Dal momento che appunto, se problemi e rischi esistono, questi verranno immancabilmente, in futuro, risolti dallo stesso sviluppo tecnico. Così è stato, del resto in passato – si aggiunge – e così sarà in futuro, nei secoli dei secoli, amen. Quest’ultima parola, naturalmente, non viene detta; la metto io solo per richiamare (provocatoriamente) il carattere quasi religioso,[1] o meglio magico-religioso, di tale convinzione.
SOLUZIONISMO
Un esempio notevole di questa visione, che alcuni chiamano “soluzionismo tecnologico” (o semplicemente soluzionismo)[2] si trova nelle recenti dichiarazioni di uno dei big della Silicon Valley, Eric Schmidt, già CEO di Google (dal 2002 al 2011) e più di recente, tra le altre cose, presidente della National Security Commission on Artificial Intelligence statunitense. Parlando a proposito dell’impatto ecologico dell’universo digitale,[3] in particolare con riferimento alla prospettiva di diffusione dell’intelligenza artificiale (molto dispendiosa sul piano energetico), Schmidt ha sostenuto tra l’altro:
«Non raggiungeremo gli obiettivi di sostenibilità perché non siamo organizzati per farlo. Investiamo quindi senza limiti in intelligenza artificiale e data center, anche se consumano tantissima energia, e sarà proprio l’AI a risolvere il problema».
A una prima lettura di queste due frasi, riportate dal “Sole 24 Ore”, appare evidente il non sequitur del ragionamento; ma la cosa non deve stupire, perché alla base sta appunto il dogma soluzionista. Continua infatti Schmidt:
«È in arrivo un’intelligenza aliena. Tutto sarà sommerso dalle enormi esigenze di questa tecnologia […]. Potremo commettere degli errori nell’utilizzarla ma non arriveremo mai alla soluzione attraverso la conservazione. Investiamo senza barriere e sarà lei a fornirci la risposta».[4]
A voler essere benevoli, si potrebbe dire che questo “soluzionismo”, questo ottimismo radicale riguardo alla capacità del genere umano di trovare, appunto, soluzioni ai problemi che di volta in volta si trova di fronte, compresi quelli che esso stesso produce, sia in fondo lo sviluppo di un’idea profonda e ben radicata nella cultura dell’Occidente, e che troviamo per esempio in alcuni celebri versi dell’Antigone di Sofocle, allorché l’uomo viene definito «sempre capace di trovare soluzioni» (così si potrebbe tradurre l’aggettivo usato dal tragediografo greco, pantòporos).[5]
Ora, ammesso e non concesso che si debba necessariamente dar ragione a Sofocle, credo che si possa certo convenire che l’uomo è sempre stato capace di cavarsela in situazioni complesse; e tuttavia questo non è un buon motivo per credere che riuscirà a farcela sempre e comunque, e dunque per figurarsi una sorta di onnipotenza dell’uomo. E del resto, com’è noto, apparteneva alla saggezza dell’antica Grecia (e dello stesso Sofocle nel verso appresso), insieme a questa precoce capacità di cogliere l’ingegnosità umana e le sue capacità di sovrastare le asperità della natura, anche la precisa consapevolezza che – parole questa volta di Eschilo nel Prometeo incatenato – «la tecnica è di gran lunga più debole della necessità».[6] Da notare che lo stesso quotidiano economico, evidentemente perplesso, chiede il parere dello scienziato Francesco Stellacci (IPFL, Politecnico federale di Losanna), che definisce una simile posizione molto pericolosa,
«perché è basata sull’ipotesi che una soluzione esista; e cosa succederebbe allora se una soluzione non esistesse? Per altri aspetti importanti della sostenibilità come il consumo del cibo e di materie prime, ad esempio, la soluzione non esiste affatto».
E perché non pensare, allora, che tra i modi per fare fronte alle difficoltà e ai rischi, dunque per rendere onore a tale nostra pantoporìa, non ci sia, per esempio, il principio di precauzione, la scelta cioè di astenersi da certe scelte, il rifiuto di applicare certe tecniche ecc.? Non è anche questo un modo intelligente per andare verso un futuro così ricco di incertezze e pericoli?
ACCELERAZIONISMO E TECNO-OTTIMISMO
Qui – abbandonando ora gli antichi e tornando purtroppo ai contemporanei – si aggiunge un altro elemento a determinare il cocktail dell’ideologia tecno-nichilistica contemporanea: quello del culto dell’accelerazione, o accelerazionismo, anch’esso evidente nelle dichiarazioni che stiamo esaminando.
Già fortemente implicata nell’idea di progresso, e secondo alcune letture (come quella di Koselleck)[7] interpretabile almeno in parte come concetto religioso secolarizzato, l’idea di accelerazione appare un tratto caratterizzante del mondo moderno, in particolare dalla rivoluzione industriale in avanti. L’accelerazione appare non solo un carattere dell’industria moderna, ma allo stesso tempo un imperativo tecnico, etico e politico per la società nel suo complesso: se infatti – questa la tesi – la via intrapresa dall’umanità è senza dubbi orientata alla piena felicità, allora appare sensato invocare l’accelerazione di tutti i processi in essere.
A rigore, l’accelerazionismo sarebbe una corrente minoritaria (e piuttosto bizzarra) di marxisti angloamericani che, in linea con un certo Marx, perorano la causa di uno sviluppo estremo di ogni innovazione tecnologica, certi che questo infine porterà al comunismo, ambiente nel quale peraltro lo sviluppo troverà davvero modo di espandersi, dal momento che il modo di produrre capitalistico, secondo loro – e sempre secondo un certo Marx – è dello sviluppo tecnico in verità anche un freno (poiché i rapporti sociali di produzione costituirebbero, per ragioni su cui non è possibile qui soffermarsi, una “costrizione” allo sviluppo delle forze produttive).[8]
Non intendo però qui occuparmi di questa scuola di pensiero, ma di quell’accelerazionismo che è invece normalmente presente nella logica di funzionamento dell’attuale capitalismo e che soprattutto sta nella ideologia di molti dei suoi agenti, in particolare dalle parti dell’industria digitale, dove non s’accompagna certo a fantasie socialiste ma molto più prosaicamente alle proprie prospettive di arricchimento.[9] Ecco, nelle parole che abbiamo letto prima, infatti, risuona anche questo imperativo: lo sviluppo tecnologico, la macchina tecno-economica non si deve fermare, né rallentare, per alcuna ragione, ma anzi deve costantemente accelerare. Tanto più rapida sarà, in tal modo anche la soluzione ai problemi e ai “guasti” eventualmente prodottisi. Se si vuole un’esemplificazione molto chiara di tale concezione, si può leggere utilmente il Technooptimist Manifesto di Marc Andreessen (2023):
«Crediamo che non esista problema materiale, creato dalla natura o dalla tecnologia, che non possa essere risolto con maggiore tecnologia. […] Dateci un problema reale e noi inventeremo la tecnologia che lo risolverà. […] Crediamo nell’accelerazionismo – la propulsione consapevole e deliberata dello sviluppo tecnologico».[10]
Siamo qui in presenza di una variazione sul tema di quel «futurismo nichilista» di cui mi sono occupato in un saggio su “Controversie” qualche tempo fa.[11]
—–
È chiaro che quello che ho qui sommariamente descritto è un ottimo dispositivo culturale di supporto all’attuale sistema economico-sociale sotto forma di celebrazione dell’incessante progresso tecnologico (che è poi – non dimentichiamolo – progresso nell’affermazione del potere del capitale sull’umanità e sulla natura). Un dispositivo che, tra le altre cose, tende a liquidare l’idea che, in un qualunque senso, sia necessario porre qualche freno o controllo sullo sviluppo tecnologico in favore di più importanti valori umani o societari.
Proprio la capacità delle società di governare (lo dice oggi perfino un apologeta della transizione digitale come Luciano Floridi),[12] e dunque anche di frenare in determinate circostanze, gli sviluppi tecnologici sarebbe, invece, essenziale oggi di fronte all’evidenza dei danni ambientali prodotti dal crescere esponenziale dell’infrastruttura digitale. Lo osserva per esempio una studiosa americana di questi temi, Arielle Samuelson, che include tra le strategie per rendere Internet meno inquinante una «maggiore cautela nel considerare se l’applicazione dell’IA sia davvero necessaria in ogni industria».[13]
Parole sacrosante, che dovrebbero essere incise all’ingresso delle aziende, delle scuole e delle università, e più in generale fatte circolare nel dibattito pubblico delle nostre società, in un momento in cui la prospettiva della colonizzazione digitale di ogni ambito della vita ci viene presentata come ineluttabile Destino.
NOTE
[1] Che l’ideologia del digitale sia una «quasi-religione» è ben argomentato, da ultimo, nel notevole saggio di Gabriele Balbi, L’ultima ideologia. Breve storia della rivoluzione digitale, Bari-Roma, Laterza, 2022, p. 75-115).
[2] Il termine è stato coniato da E. Morozov in Internet non salverà il mondo, Milano, Mondadori, 2014, avendo poi una certa fortuna. Va detto, tuttavia, che non si tratta di una novità connessa specificamente alle tecnologie digitali, ma più in generale a un mito collegato alla cultura tecnica delle società industriali avanzate (capitalistiche certamente, ma non è mancata una tecnofilia socialista in Urss), secondo il quale in fondo la tecnica è, in termini quasi religiosi, una entità salvatrice.
[3] Su questi temi, oggi al centro di un crescente interesse delle scienze sociali, mi permetto di rimandare ad alcuni miei articoli apparsi su questa rivista: Internet non è una “nuvola”, https://www.controversie.blog/internet-non-e-una-nuvola-prima-parte/ e https://www.controversie.blog/internet-non-e-una-nuvola-seconda-parte/, e I costi ambienali del digitale. Una bibliografia ragionata, “Controversie”, anno I, n. 5 (2025), https://www.controversie.blog/costi-ambientali-del-digitale-bibliografia/
[4] Barbara Carfagna, Intelligenza artificiale: consumi di energia enormi, non sappiamo chi la produrrà, “Il Sole 24 Ore”, 13 ottobre 2024, p. 12. Sottolineatura mia.
[5] Sofocle, Antigone, ai vv. 360-61, dove si dice che l’uomo, pantpòros appunto, àporos ep’oudèn èrchetai to mèllon, ovvero «non va mai verso il futuro privo di risorse» (traduzione mia, ma la tr.it. di Ezio Savino, per esempio, recita «infinito artista, inerte non affronta / nessun domani». Sofocle, Edipo re. Edipo a Colono. Antigone , introduzione di Umberto Albini, traduzione, nota storica e note di Ezio Savino, Milano, Garzanti, 1988, p. 249).
[6] Traduce invece «O arte, quanto più debole sei del destino» Carlo Carena (Eschilo, Prometeo incatenato, a cura di Carlo Carena, Torino, Einaudi, 1995, p. 24). È proprio questa consapevolezza della cultura greca antica che costituì sempre un freno alla formazione del concetto di progresso illimitato nello sviluppo storico (per il quale si dovrà attendere l’età moderna), come aveva notato Dilthey, secondo il quale la concezione greca del mondo «faceva susseguire l’uno all’altro periodi di nascimento, di svolgimento e di regresso dell’universo, in una monotona mancanza di speranza; e questo corso circolare diventava per i Greci il più sublime simbolo della transitorietà della razza umana» (Wilhelm Dilthey, Il secolo XVIII e il mondo storico, Milano, Edizioni di Comunità, 1977, p. 28).
[7] Cfr. Reinhart Koselleck, Accelerazione e secolarizzazione, Napoli, Istituto Suor Orsola Benincasa, 1989.
[8] Per questa ideologia si veda Alex Williams – Nick Srniceck, Manifesto accelerazionista, postfazione di Valerio Mattioli, Roma-Bari, Laterza, 2018. Al termine di questa sfrenata fantasia utopistica sta poi l’utopia tecno-comunista che uno di questi teoreti, Aaron Bastiani, ha chiamato Fully Automated Luxury Communism, «comunismo del lusso integralmente automatizzato», da lui illustrato in un omonimo volume pubblicato (con sprezzo del ridicolo!) dalla casa editrice londinese Verso.
[9] Anche qui, comunque, le fantasie tecno(fanta)scientifiche non mancano, tra ibridazione uomo-macchina, “superamento della biologia”, prolungamento della vita, colonizzazione dei pianeti extraterrestri ecc. Per una rassegna di queste affabulazioni utopiche, si vedano, oltre a Gabriele Balbi, L’ultima ideologia, cit.; Mark O’Connell, Essere una macchina. Un viaggio attraverso cyborg, utopisti, hacker e futurologi per risolvere il modesto problema della morte, Milano, Adelphi, 2018; e, con particolare attenzione alla lunatica Weltanschaaung di Elon Musk e della sua combriccola, Paolo Bottazzini, The Musk. Teoria e pratica di un genio egoista, Milano, Bietti, 2025, sul quale tornerò prossimamente con un articolo dedicato.
[10] Marc Andreessen, The Techno-Optimist Manifesto, “Andreessen Horowitz”, October 16, 2023, https://a16z.com/the-techno-optimist-manifesto/
[11] Cfr. Toni Muzzioli, Avanti verso il nulla. Sul futurismo nichilista contemporaneo, “Controversie”, 24/06/2024, https://www.controversie.blog/futurismo-nichilista-1/
[12] Cfr. Luciano Floridi, L’era digitale richiede responsabilità, “La lettura” / “Corriere della sera”, 20 luglio 2025, p. 7-9. «La società digitale – leggiamo – necessita di nuove regole per gestire e indirizzare le trasformazioni in corso. (…) L’evoluzione tecnologica non dovrebbe procedere per inerzia di mercato o secondo logiche puramente ingegneristiche e di massimizzazione del profitto. Queste sono il motore necessario, ma le mani sul volante, e la decisione su dove andare, restano alla società e alla politica». Naturalmente una simile capacità di governo deve implicare anche la possibilità di fermare talune scelte tecniche, altrimenti ogni dichiarazione in favore delle regole resta “acqua fresca”. Come temo sia il caso anche di queste parole.
[13] Arielle Samuelson, Are your internet habits killing the planet?, “Heated”, May 28, 2024, https://heated.world/p/are-your-internet-habits-killing
Autore
-
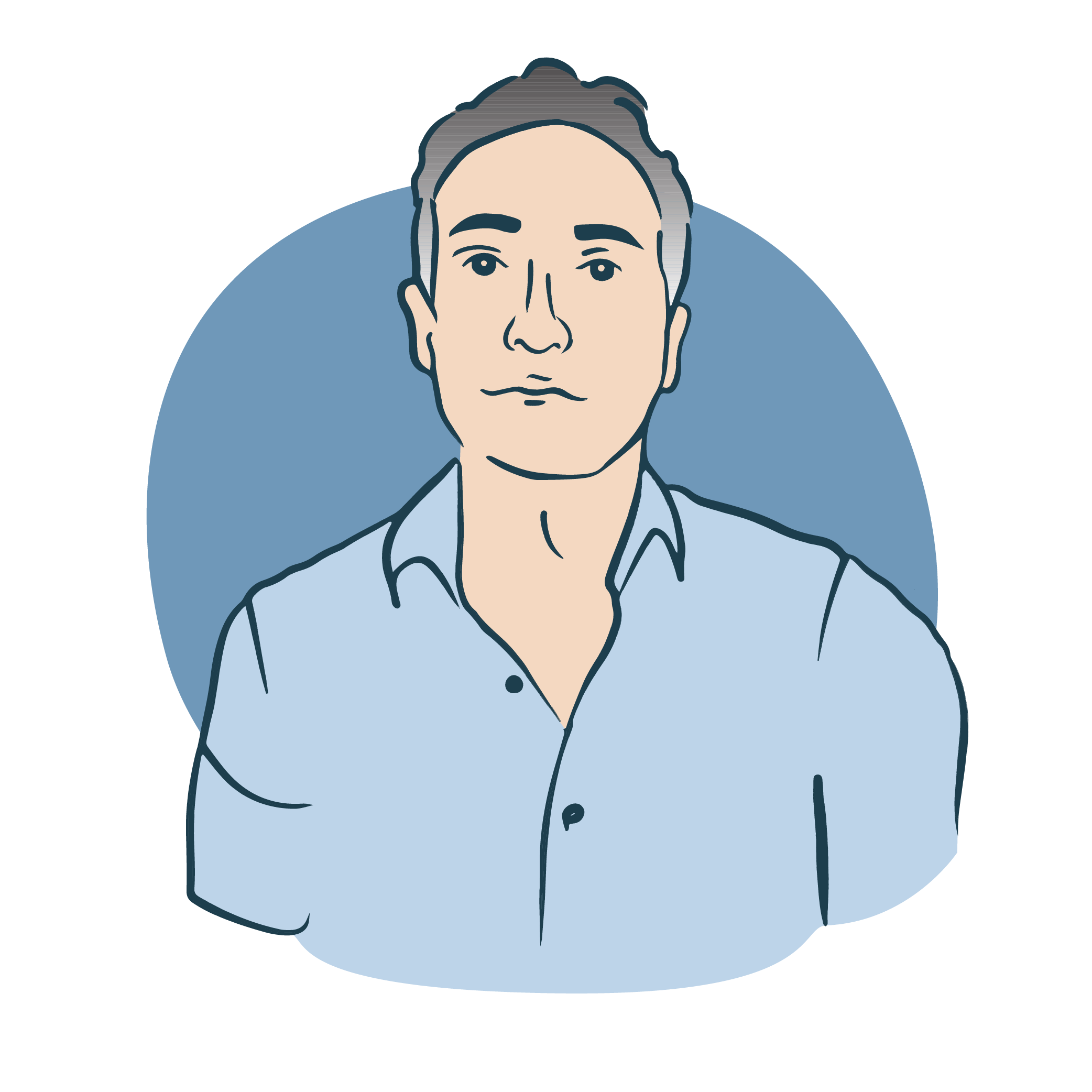
Laureato in filosofia, si occupa di questioni politiche e economico-sociali con gli strumenti della teoria critica e in una prospettiva eco-socialista. Ha pubblicato articoli e saggi su varie riviste e siti web, tra i quali “Marxismo oggi”, “Giano”, “L’ospite ingrato”, “Volere la luna”, “FormaCinema”. Sul sito ideeinformazione.org, espressione dell’omonima associazione politico-culturale, analizza e commenta dal 2022 l’inquietante deriva bellicista di un Occidente tanto pieno di armi quanto privo di idee: https://www.ideeinformazione.org/author/toni-muzzioli/ Ed è un peccato, perché ci sono cose che meriterebbero di più.
Leggi tutti gli articoli
