Quando J. Robert Oppenheimer, padre della bomba atomica, vide esplodere il primo ordigno nucleare nel deserto del New Mexico il 16 luglio 1945, non esultò. Non parlò di successo, né di trionfo. Pensò invece a un verso antico della Bhagavad Gita: “Sono diventato Morte, il distruttore di mondi.”
La frase cita parte del verso 32 capitolo 11 della Gita, uno dei testi fondamentali della spiritualità indiana : “Io sono il Tempo (Kāla), il grande distruttore dei mondi, e sono venuto per annientare queste genti. Anche senza di te, tutti i soldati schierati moriranno.”
Nella Gita, il principe guerriero Arjuna si trova sul campo di battaglia di Kurukshetra, tormentato all’idea di dover combattere contro parenti, amici e maestri. Il suo auriga è Krishna, che è in realtà una manifestazione divina che, per convincerlo a combattere, gli mostra la sua forma cosmica, una visione terrificante e sublime della divinità in tutta la sua potenza. Krishna dice ad Arjuna che il suo intervento è inevitabile, perché l’ordine cosmico va comunque avanti. Arjuna non è l’agente del destino: è solo uno strumento del dharma, dell’ordine cosmico.
Nel testo sacro la “Morte” o “Tempo” simboleggia il movimento inevitabile dell’universo, oltre il bene e il male umano; quindi, la frase non è una celebrazione della distruzione, ma una riflessione sul destino, sul ruolo dell’individuo, e sul fatto che la volontà divina (o il corso del tempo) trascende il volere umano.
Quando, dopo il test nucleare, Oppenheimer cita questa frase, la decontestualizza parzialmente, ma in modo molto significativo: lo scienziato si identifica non con Krishna, ma con l’atto distruttivo stesso, con la bomba.
Egli dice: “ho partecipato a un atto che cambia per sempre il corso del mondo e di cui ora sono consapevole. Abbiamo forse superato un limite che dovevamo tenere all’orizzonte?”. È una forma di shock esistenziale e morale: ha creato qualcosa che trascende il controllo umano, come il tempo o la morte.
Quella frase non è solo un riflesso personale di turbamento, ma il simbolo di un dilemma che attraversa tutta la storia moderna, la tensione tra il progresso e il darsi dei limiti. In essa si concentra la domanda che ogni società avanzata deve porsi: fino a che punto possiamo spingerci nella ricerca, senza compromettere ciò che ci rende umani?
La tecnoscienza è uno degli strumenti più potenti mai sviluppati dall’umanità. Gli strumenti che ne sono emanazione ci hanno permesso di sconfiggere malattie, esplorare l’universo, connettere continenti e prolungare la vita. Ma ogni nuova frontiera porta con sé un potenziale di meraviglia e di disastro. La meraviglia è irresistibile, ci chiama e ci muove; la consapevolezza di dove andremo, rispondendo alla chiamata, arriva solo dopo.
Nel caso della bomba atomica, la scoperta della fissione nucleare — una conquista intellettuale straordinaria — fu tradotta in una tecnologia di distruzione totale.
È qui che nasce la controversia: la scienza deve essere giudicata per la conoscenza che produce o per l’uso che se ne fa? O, più radicalmente, è possibile separare la ricerca pura dalle sue applicazioni concrete?
Sponsorizzare il progresso scientifico sembra essere giusto e necessario. A nostro avviso, fermarlo sarebbe come spegnere il fuoco per paura che bruci: sarebbe negare il potenziale del pensiero umano. Tuttavia, la fede cieca nella neutralità della scienza è pericolosa. La storia ha mostrato che non tutto ciò che può essere fatto, deve essere fatto. E lo ha mostrato con chiarezza molte volte. Ma la voce della meraviglia è irresistibile.
Oggi, le sfide si ripresentano in forme nuove: intelligenza artificiale, ingegneria genetica, manipolazione climatica, automazione militare. Anche qui la scienza offre strumenti di potere, ma chi decide come usarli? E chi ne sopporta le conseguenze?
Promuovere la ricerca senza interrogarsi sulle sue implicazioni etiche equivale a sponsorizzare la hybris umana che pretende di dominare la natura e il destino, dimenticando i propri limiti.
Il caso Oppenheimer è paradigmatico. Egli non era un folle né un cinico. Era un uomo colto, brillante, consapevole. Ma fu catturato dalla logica del tempo: la corsa contro i nazisti, la pressione politica, il desiderio di riuscire. Quando la bomba fu pronta, non c’era più spazio per fermarsi a riflettere. Da allora, si è discusso a lungo su cosa avrebbe potuto o dovuto fare; ma la domanda non riguarda solo lui, bensì tutti noi.
La scienza non avanza da sola. È parte di una rete fatta di governi, finanziamenti, opinione pubblica, interessi. Se vogliamo un progresso che non ci conduca alla rovina, dobbiamo creare una cultura della responsabilità condivisa. Dobbiamo stabilire come società estesa qual è la soglia del possibile e il confine dell’ammissibile.
“Sono diventato Morte, il distruttore di mondi.”
Non è una frase contro il progresso scientifico. È un avvertimento sulla necessità di non separare mai la conoscenza dalla saggezza, di non confondere la neutralità degli strumenti con l’innocenza dei fini.
I metodi sono neutrali, gli effetti non lo sono. Ogni nuova scoperta di impatto sociale ci avvicina a soglie irreversibili; confini oggi solo ipotizzati che improvvisamente vengono superati e socializzati. Per questo la riflessione critica deve precedere e non seguire l’applicazione tecnologica. Il futuro non si decide con le risposte giuste o sbagliate, ma ponendo le domande che richiedono quelle risposte prima di agire.
La neutralità degli strumenti non esiste.
Autore
-
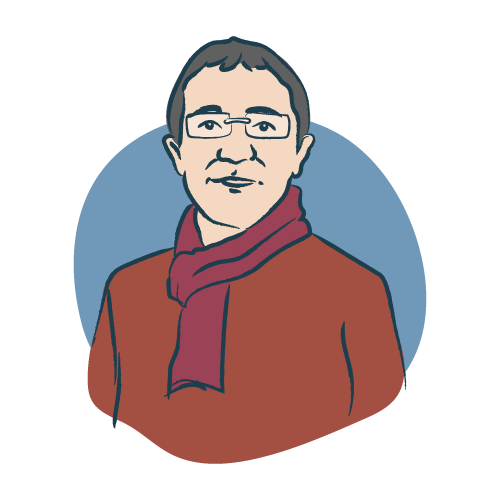
Ingegnere elettronico, manager in una multinazionale, matematico e scrittore. Cerca l’intelligenza nell’intelligenza artificiale. E forse la trova: o tutto è intelligenza oppure niente lo è.
Leggi tutti gli articoli
