Quando il 6 agosto 1945 a Hiroshima gli Stati Uniti lanciarono il primo ordigno nucleare (e tre giorni dopo sarebbe stata la volta di Nagasaki), unico modo per porre fine – così si disse e si dice – alla guerra contro il Giappone, non furono in molti tra gli intellettuali a rendersi conto di cosa fosse accaduto. Fra i pochissimi, in Francia, mentre per esempio “Le Monde” salutava la grande «rivoluzione scientifica» in atto, uno scrittore e filosofo singolare, militante e individualista al contempo, Albert Camus. Certo, era oggettivamente difficile, nella scarsità delle notizie (non c’era Internet, ma anche oggi quante cose non vediamo!) e soprattutto nel sollievo per la fine della guerra e la sconfitta dei progetti imperialistici tedesco e giapponese, avere chiara l’enormità di quella “prima volta”. Eppure, Camus la percepì e la denunciò nell’editoriale dell’8 agosto di “Combat”, il quotidiano della Resistenza francese di cui fu redattore-capo dal 1944 al 1947, evocando una «nuova angoscia, che ha tutta l’aria di essere definitiva».
Riproduciamo quel celebre documento, dal momento che, ottant’anni dopo, sono stati fatti passi avanti ulteriori sul piano tecnologico ma, a quanto sembra, ben pochi su quello morale.
Toni Muzzioli
Il mondo è quello che è, poca cosa. Da ieri, lo sappiamo tutti, grazie al formidabile concerto che radio, giornali e agenzie d’informazione hanno inscenato a proposito della bomba atomica. Nel mezzo d’una marea di commenti entusiastici ci informano, infatti, che qualsiasi città di media grandezza può essere completamente rasa al suolo da una bomba grande quanto un pallone da football. Giornali americani, inglesi e francesi si profondono in eleganti dissertazioni sul futuro, sul passato, sugli inventori, sui costi, sulla vocazione pacifica e sugli effetti bellici, sulle conseguenze politiche e persino sul carattere indipendente della bomba atomica. Detto in una frase: la civiltà della tecnica ha attinto il suo ultimo stadio di barbarie. Bisognerà scegliere, in un futuro più o meno prossimo, tra il suicidio collettivo o l’utilizzo intelligente delle scoperte scientifiche.
Per il resto, è consentito almeno pensare che c’è qualcosa d’indecente nel celebrare in questo modo una scoperta posta, innanzi tutto, al servizio della più spaventosa furia distruttrice di cui l’uomo abbia dato prova da secoli. In un mondo in balia a tutte le lacerazioni della violenza, completamente privo di controllo, insensibile alla giustizia e alla semplice felicità degli uomini, la scienza si dedica all’omicidio organizzato, e nessuno, a meno di un incorreggibile idealismo, sembra stupirsene.
Queste scoperte devono essere menzionate, commentate per quello che sono, annunciate al mondo perché l’uomo possa farsi una giusta idea del suo destino. Ma avvolgere queste terribili rivelazioni in una letteratura pittoresca o umoristica è davvero intollerabile.
In un mondo torturato già si respirava a fatica, ecco che ci propongono una nuova angoscia, che ha tutta l’aria d’essere definitiva. Questa è forse l’ultima occasione offerta all’umanità. E ciò può anche essere il pretesto per un’edizione straordinaria. Invece, dovrebbe essere soprattutto l’occasione per alcune riflessioni e di molto silenzio.
Del resto, ci sono altre ragioni per accogliere con riserva il romanzo di fantascienza che i giornali ci propongono. Quando vediamo il redattore diplomatico dell’Agenzia Reuter annunciare che questa invenzione vanifica i trattati e cancella tutti gli accordi, anche quelli di Potsdam, rilevare che è del tutto indifferente se i Russi sono a Kœnigsberg o la Turchia ai Dardanelli, non si può fare a meno di supporre dietro al bel concerto delle intenzioni piuttosto estranee al disinteresse scientifico.
Sia ben chiaro. Se i Giapponesi capitolano dopo la distruzione di Hiroshima e per effetto dell’intimidazione, possiamo solo compiacercene. Ma rifiutiamo di trarre da una notizia così grave nient’altro che la decisione di perorare con una maggior energia in favore di una vera società internazionale in cui le grandi potenze non avranno diritti superiori a quelli delle nazioni piccole e medie, e in cui la guerra, flagello divenuto definitivo solo a causa dell’intelligenza umana, non dipenderà dagli appetiti o dalle dottrine di questo o di quell’altro Stato.
Di fronte alle terrificanti prospettive che si aprono all’umanità, ci rendiamo sempre più conto che la pace è la sola battaglia per la quale valga la pena di combattere. Non è più una preghiera, è un ordine che deve salire dai popoli verso i governanti, l’ordine di scegliere definitivamente tra l’inferno e la ragione.
[Albert Camus, “Combat”, 8 août 1945]
Autore
-
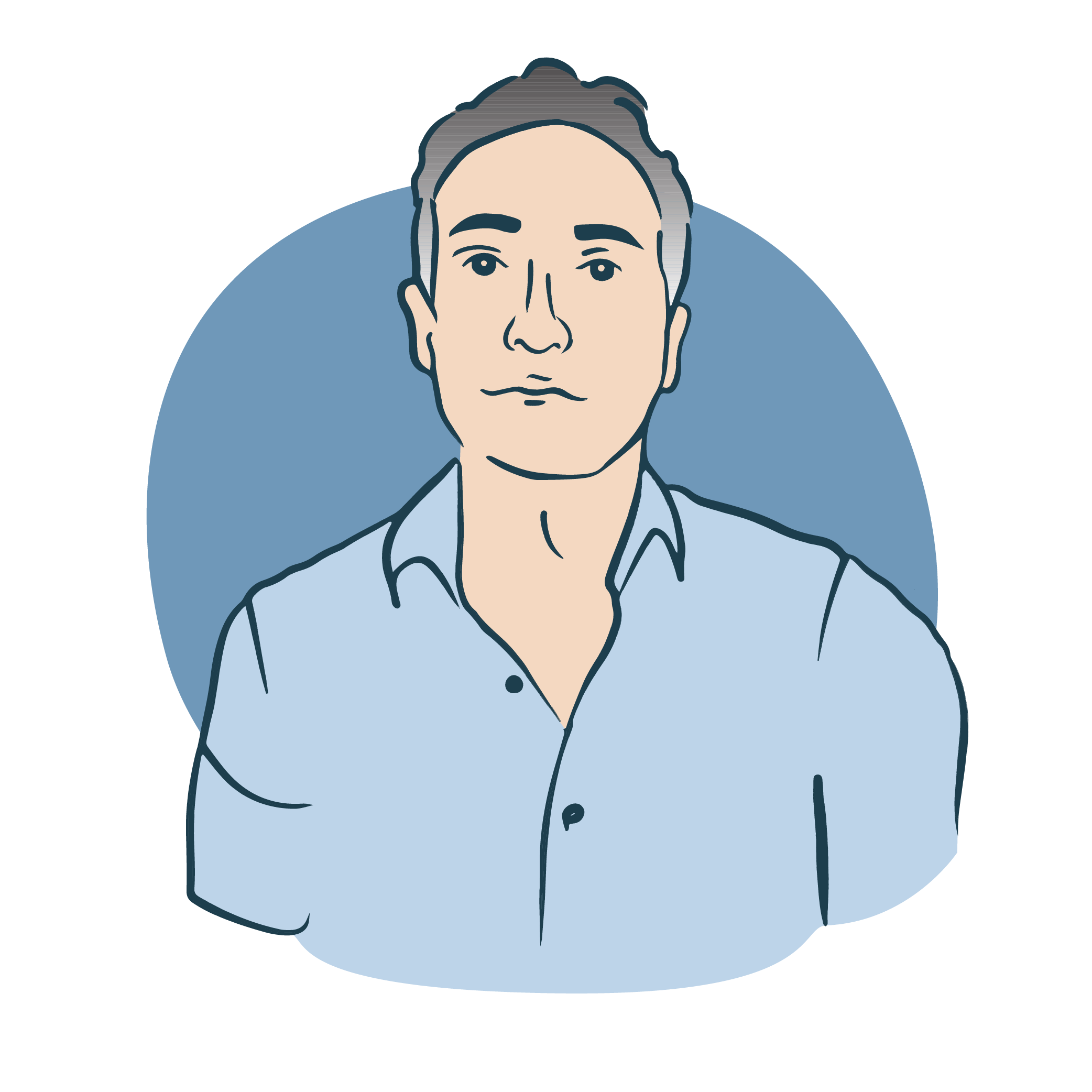
Laureato in filosofia, si occupa di questioni politiche e economico-sociali con gli strumenti della teoria critica e in una prospettiva eco-socialista. Ha pubblicato articoli e saggi su varie riviste e siti web, tra i quali “Marxismo oggi”, “Giano”, “L’ospite ingrato”, “Volere la luna”, “FormaCinema”. Sul sito ideeinformazione.org, espressione dell’omonima associazione politico-culturale, analizza e commenta dal 2022 l’inquietante deriva bellicista di un Occidente tanto pieno di armi quanto privo di idee: https://www.ideeinformazione.org/author/toni-muzzioli/ Ed è un peccato, perché ci sono cose che meriterebbero di più.
Leggi tutti gli articoli
