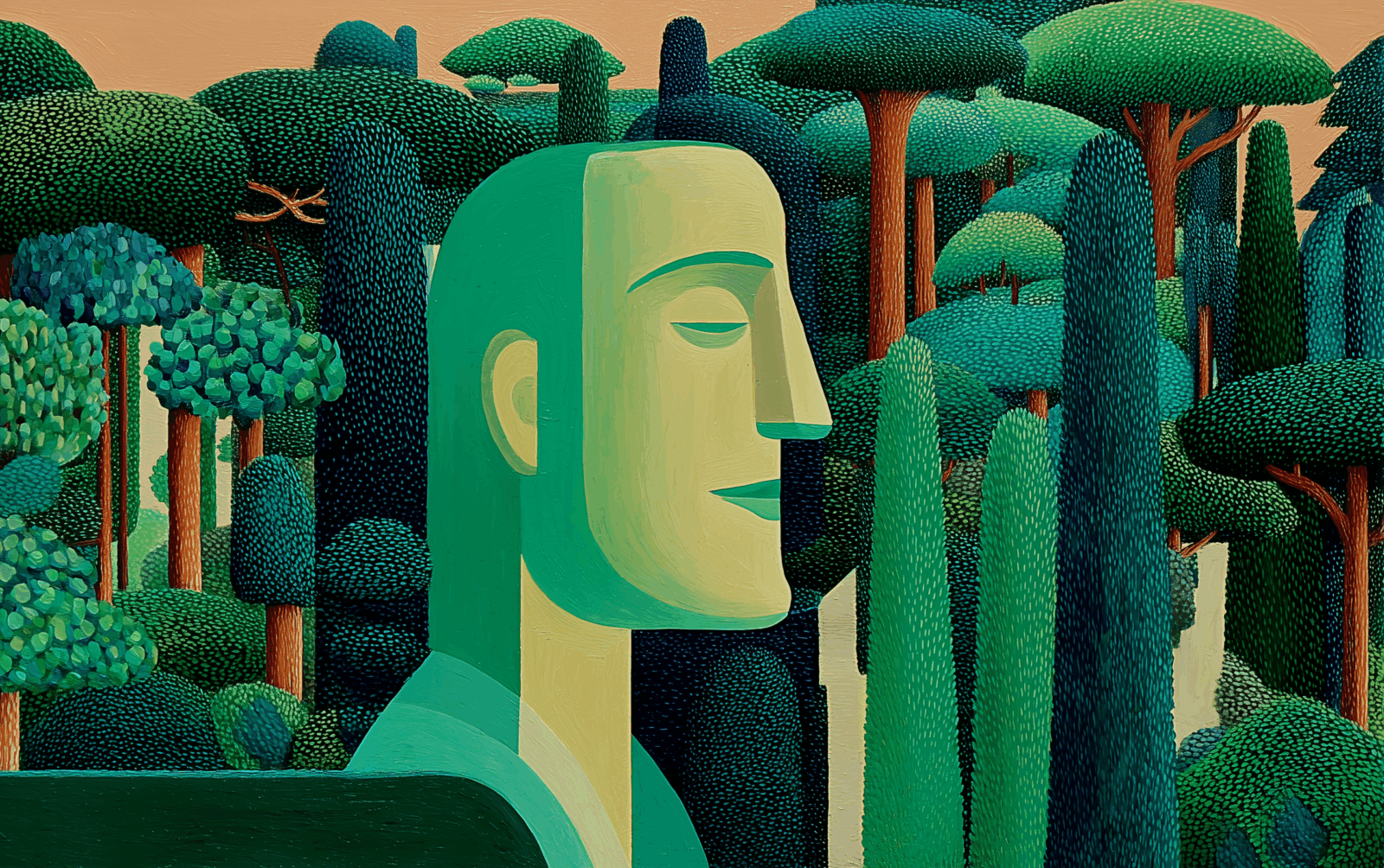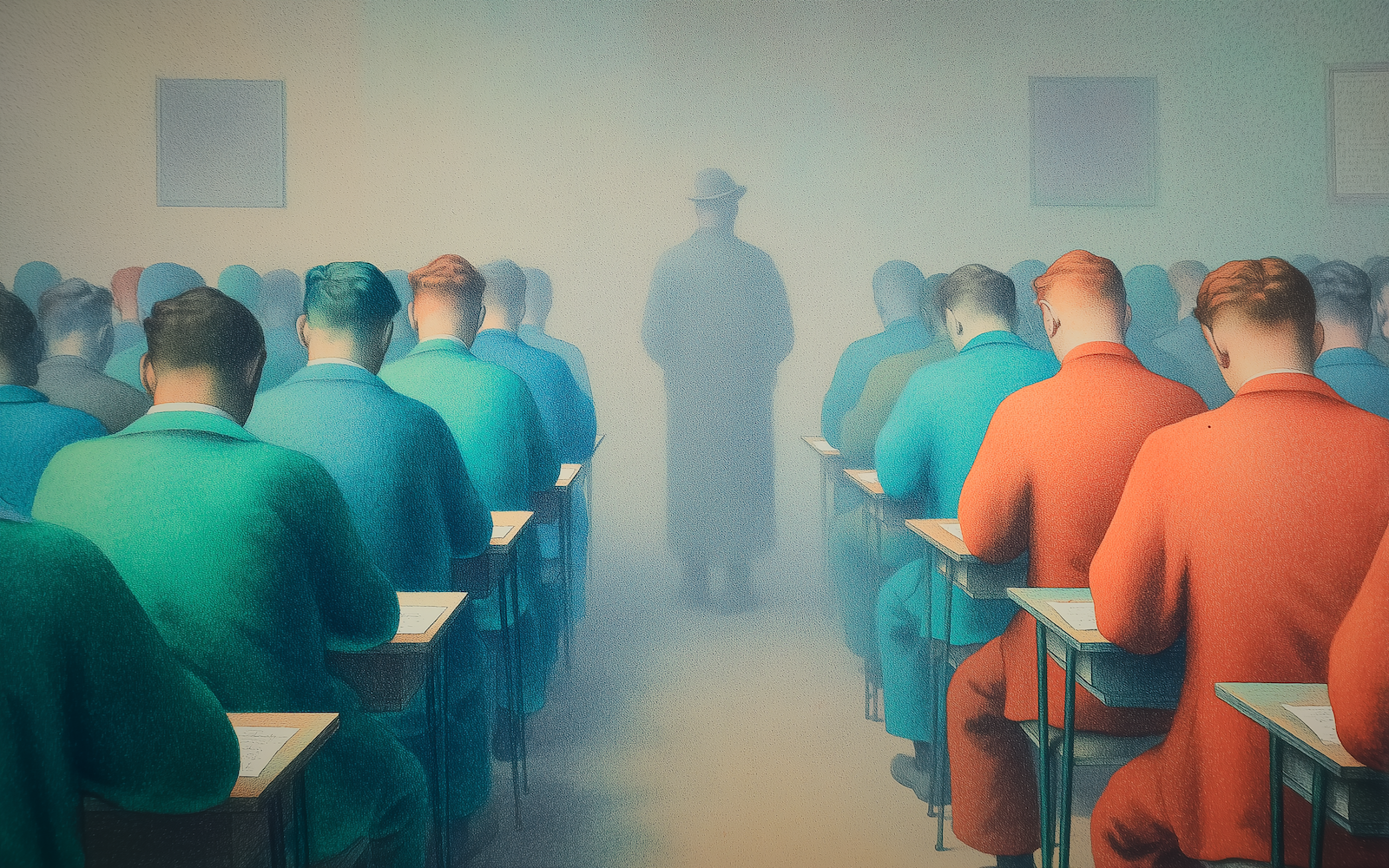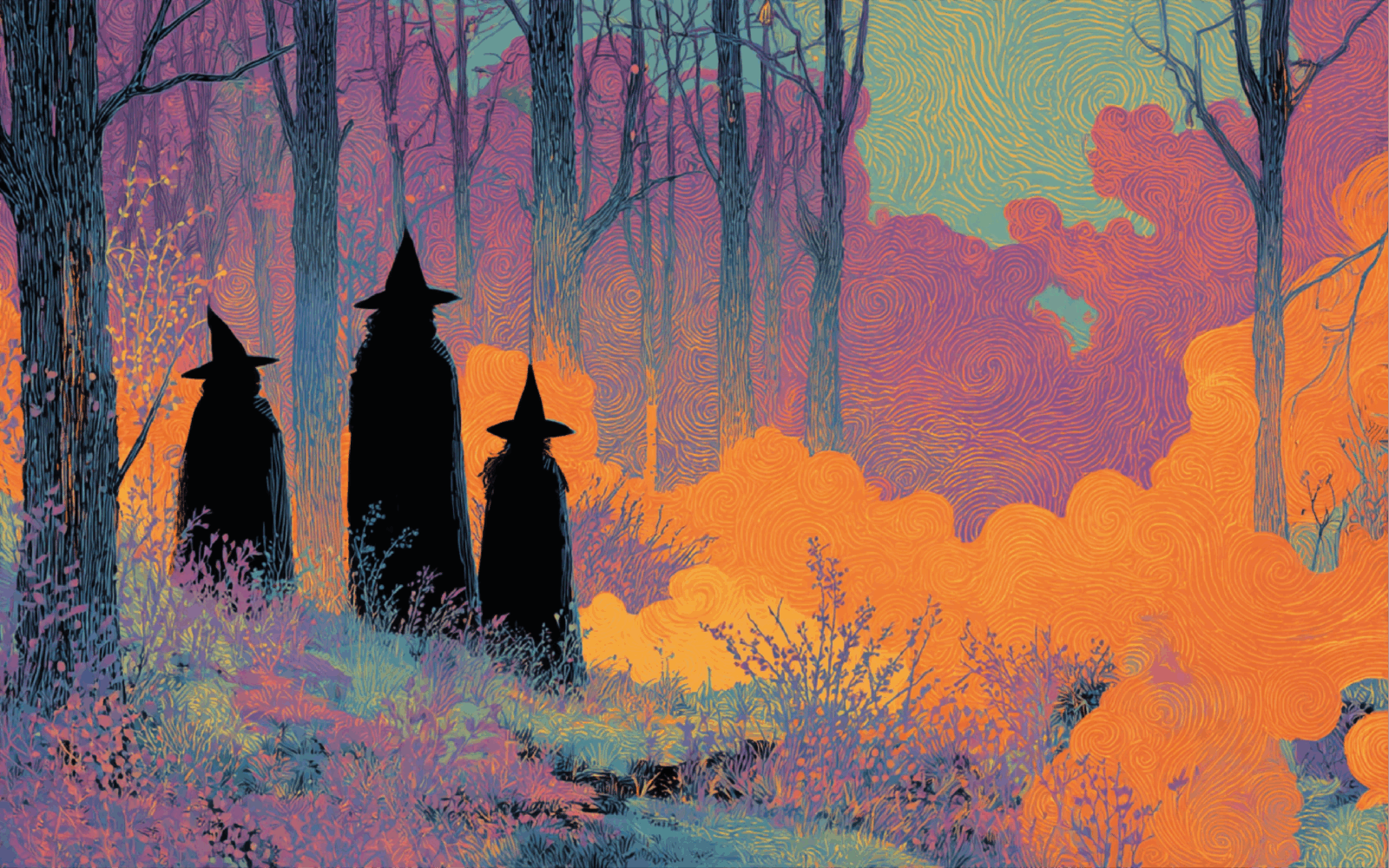Le relazioni sentimentali nella scienza - Evitarle o far finta di nulla?
Il 2 settembre scorso, i giornali hanno battuto la notizia che Nestlé ha licenziato, con effetto immediato, l’amministratore delegato Laurent Freixe, che da quasi quarant’anni lavorava nella multinazionale svizzera. Dopo che è emersa una sua relazione sentimentale non dichiarata con una diretta dipendente.
Parigino, 63 anni, Freixe lavorava per Nestlé dal 1986. Da settembre 2024 aveva assunto la direzione del gruppo, succedendo al tedesco Mark Schneider.
Il codice di condotta della Nestlé invita i dipendenti a evitare potenziali conflitti d’interesse e chiede loro di dichiarare tempestivamente eventuali relazioni con colleghi.
Una vicenda simile era capitata questa estate, quando Andy Byron (CEO di Astronomer) e Kristin Cabot (responsabile risorse umane della stessa azienda) furono beccati in atteggiamenti intimi dalla kiss cam durante un concerto dei Coldplay. In seguito a ciò furono prima sospesi dai loro incarichi, poi messi in congedo e infine entrambi si dimisero.
Nelle aziende italiane è rara la presenza di codici comportamentali che riguardano le relazioni sentimentali, sono al più noti alcuni casi in multinazionali americane e asiatiche. E, sicuramente, un tale codice non vige nell’accademia italiana, dove da alcuni anni non è possibile soltanto che un/a parente prossimo/a di un/a dipendente (ad es. marito o moglie) venga assunto nel suo stesso un dipartimento. Norma sicuramente utile ma che non tocca l’ambito, molto più vasto, delle relazioni sentimentali. Infatti, non c’è, a mia conoscenza, nessuna norma che richieda di dichiarare le relazioni sentimentali in essere nella stessa università e tanto meno nello stesso dipartimento.
LE EMOZIONI NELLE ORGANIZZAZIONI
Il ruolo delle emozioni nelle dinamiche lavorative e nelle organizzazioni è un tema studiato da diversi decenni: l’intelligenza emotiva, il potere delle emozioni, la presenza costante di invidia, gioia, rancore, ansia e frustrazione, come esse influenzino i processi decisionali, il clima aziendale, le relazioni e la produttività. Inoltre, la ricerca ha mostrato come saper gestire le emozioni permette di trasformare le emozioni spiacevoli (o non utili al contesto) in emozioni piacevoli, di motivare sé stessi e gli altri.
Poco si è scritto, però, sul ruolo che le relazioni affettive e sentimentali hanno nelle organizzazioni, nelle aziende, nelle istituzioni e nei contesti scientifici. Tuttalpiù questo fenomeno viene relegato al pettegolezzo o alle battute fra colleghi/e. Eppure, è un fenomeno esistente (un tempo, forse, più di adesso; in alcune discipline più di altre), legato al maschilismo fortemente presente (un tempo più di adesso) nell’accademia italiana. Tant’è che un noto e autorevole professore, ora emerito, diceva che “i concorsi si vincono a letto”. Certamente esagerava. Ma visto che lui di concorsi ne aveva visti tanti, qualcosa doveva sapere.
Sarebbe, quindi, auspicabile per un’istituzione scientifica, dove dovrebbero vigere criteri di merito, di qualità, di produzione scientifica ecc., introdurre un codice comportamentale simile a quello presente in Nestlè? Che (si badi bene) non impedisce le relazioni sentimentali intra moenia, ma richiede che vengano dichiarate.
Un tale codice manderebbe sicuramente a pezzi centinaia di matrimoni e convivenze, ma renderebbe un po’ trasparenti le decisioni prese all’interno di un’istituzione scientifica. Un bel dilemma…
Il rifiuto a sostenere l’orale agli esami di Maturità. Semi di rivolta?
In questo luglio stanco, in cui ogni mattina sentiamo discorsi di politici e intellettuali prevedibili dalla prima all’ultima parola, in cui si perpetua il rito avvilente delle finte sfide fra tribù politiche, un fatto nuovo c’è.
È la ribellione di alcuni ragazzi/e che si stanno rifiutando di sostenere l’esame orale alla Maturità. Questo è oggettivamente un qualcosa che non si era mai visto, un fatto su cui riflettere.
Sui media, la reazione alla notizia è stata abbastanza omogenea e improntata alla disapprovazione, altrettanto dicasi nei commenti delle persone (vedi social e commenti agli articoli).
In definitiva, con diversi gradi di aggressività, la società ha preso male questa piccola (nei numeri) ribellione.
Commenti che parlavano di atti di arroganza o di vittimismo narcisistico; pochissima apertura a provare a capire i perché.
Si può intuire che il fenomeno sia tutt’altro che secondario da un particolare; la reazione quasi rabbiosa, carica di astio, del ministro competente.
Quella reazione può far pensare che quei tre ragazzi abbiano dato vita - probabilmente in modo del tutto inconsapevole - a un atto politico, mettendo in discussione una “istituzione”, un architrave del sistema pedagogico-educativo su cui si basa la nostra società.
Quindi, a maggior ragione, è opportuno cercare di capire invece che arroccarsi sullo status quo.
C’è stato subito un intervento interessante del sociologo Nicola Ferrigni dell’Università della Tuscia e direttore dell’Osservatorio “Generazione Proteo”.
Questo l’inizio di un suo intervento (che si può facilmente trovare su internet – inserire fonte):
“Quanto accaduto al liceo Fermi di Padova e al liceo Galilei di Belluno non è un semplice gesto di rifiuto. Due studenti hanno scelto, in modo diverso ma altrettanto chiaro, di non sostenere il colloquio orale dell’esame di maturità. Non per superficialità o disinteresse, ma per inviare un messaggio forte e simbolico su come oggi tanti giovani vivono la scuola: con distanza, con fatica, a volte con rassegnazione. Una scuola che valuta ma non ascolta, che misura ma non riconosce. È una protesta simbolica, silenziosa, profondamente pacifica. Ed è proprio per questo che colpisce. Perché si impone senza rumore, ma con forza. Perché non cerca la ribalta, ma lascia un segno duraturo.” (N.d.R. gli studenti poi sono diventati tre).
Ma la critica al sistema scolastico selettivo di certo non è nuova, se leggiamo Don Milani:
“La scuola è fatta per dare a tutti le stesse opportunità, non per premiare chi già sa”.
Don Milani vedeva nella scuola uno strumento di formazione che lavorasse per mettere tutti i ragazzi nelle stesse condizioni di apprendimento e il lavoro dell’insegnate doveva essere molto mirato al raggiungimento di questo scopo; un processo che non doveva portare a una valutazione selettiva ma valutazione formativa, ovvero attraverso lo scambio docenti – studenti, questi potessero colmare lacune e vuoti.
Oppure Pasolini, la cui vita è stata sempre profondamente intrecciata nel rapporto con i ragazzi delle periferie, che parlava della scuola come luogo di omologazione, di appiattimento del pensiero, di mancanza di respiro critico, di libertà solo apparente, funzionale al perpetuarsi del dominio delle classi sociali al potere.
Sono passati molti anni dagli interventi di Don Milani, di Pasolini e di tanti altri che hanno cercato di cambiare nel profondo il modo di concepire l’insegnamento, eppure non sembra che le cose siano migliorate. È diminuita la severità degli insegnati (i quali, anzi, spesso si devono difendere da alunni e famiglie), è diminuito anche il carico di apprendimento per gli studenti, e quindi lo sforzo, ma tutto ciò che denunciavano Milani e Pasolini, ovvero le disuguaglianze educative, la selettività iniqua, il non insegnamento di un reale pensiero critico, sono ancora temi irrisolti.
Molto interessante anche la critica fatta da Luca Ricolfi e Paola Mastracola in tempi più recenti. In sintesi essi sostengono che la presunta “democratizzazione” della scuola, che si è concretizzata in un abbassamento del livello qualitativo, favorisce proprio quei ragazzi che vengono da contesti sociali privilegiati e che possono accedere per altri canali ad un’istruzione superiore. E questo blocca ancor di più il famoso “ascensore sociale”.
-------
Tuttavia, c’è un altro aspetto della “piccola rivolta” che sembra molto interessante, guardando oltre alla critica nei confronti del sistema di formazione e di giudizio scolastici.
In questa ribellione si intravedono – da parte di questa generazione di poco più che adolescenti di tutto il mondo - il rifiuto della società della competizione e degli evidenti segni di insofferenza verso la società che stiamo lasciando loro, che questa generazione di poco più che adolescenti - in tutto il mondo - stia dando palesi segni di insofferenza verso la società come gliela stiamo lasciando, credo sia evidente.
Serve, forse, ricordare le bande di teppisti giovanili che vogliono tutto e subito e rifiutano obblighi e doveri? Oppure, ricordare gli hikkimori, che certo non sono un fenomeno solo giapponese? O ripensare a Greta e al suo enorme seguito? Movimenti che vanno molto al di là della sola lotta ai cambiamenti climatici.
La verità è che il capitalismo, da anni, sembra aver imparato ad ammantarsi di un bel packaging (sì, certo, non è solo apparenza) e parla di etica, responsabilità sociale, sostenibilità. Ma poi quel che conta è sempre il profitto e la remunerazione del capitale, a tutti i costi. E per ottenere profitto c’è la competizione sui mercati: tra Stati, tra aziende, tra le persone. Da questo schema non si scappa. E ci sono regole da seguire (sempre più complesse) e percorsi da portare a termine, senza deroghe.
A questo, sembra che si stiano ribellando questi ragazzi.
Le società inquadrano, gli individui si adeguano, ma sotto sotto scorre un fiume carsico. Il fiume della voglia di libertà, della voglia di una vita senza lacci, forse anche di una salvifica “irresponsabilità”. E ogni tanto questo fiume si riaffaccia alla superfice e fa esplodere momenti di ribellione.
È stato così alla fine degli anni ’60, quando i movimenti studenteschi e gli hippy hanno scatenato una dura contestazione negli USA contro una società bigotta, retriva, chiusa, ottusa.
Come non ricordare le rivolte nelle università americane, contro la guerra in Vietnam, contro l’apartheid, ma soprattutto contro il conformismo asfissiante.
Come non ricordare gli studenti di tutto il mondo con in mano L’uomo a una dimensione di Herbert Marcuse, brandito come un’arma contro la società repressiva?
Jimi Hendrix che suona una versione distorta e acida di Star and Stripes sul palco di Woodstock davanti a decine di migliaia di ragazzi e ragazze che ballano seminudi nei prati devastati, è il simbolo più potente di questa sete di rivolta dal grigio opprimente e ottuso.
In America la rivoluzione hippy è finita rapidamente nel nulla e in Europa il ‘68 si è altrettanto rapidamente trasformato da una rivoluzione libertaria (ricordate? L’immaginazione al potere…) in una drammatica battaglia politica che nulla aveva di libertario, anzi, era la sua negazione.
Il fiume carsico è tornato a scorrere in profondità, la gente è tornata nei ranghi, ha ricominciato a pensare alla carriera, ai soldi, alla stabilità e quant’altro. Da conquistarsi con le buone o con le cattive.
Ma forse quei due ragazzi e quella ragazza che si sono rifiutati di fare l’orale alla Maturità sono solo un primo segnale che il fiume sta tornando in superfice.
Gli anni ’60 dell’illusione libertaria ebbero i loro cantori letterari: da Kerouac a Ginsberg, da Burroughs a Corso, tutti autori che sono stati il supporto culturale e immaginifico di una generazione che voleva cambiare completamente la realtà.
Suona bene chiudere con le parole sferzanti di una poesia di Lawrence Ferlinghetti:
“The world is a beautiful place to be born into if you don’t mind some people dying all the time or maybe only starving some of the time which isn’t half so bad if it isn’t you.”
Chissà se chi ha deriso senza appello quei tre ragazzi si renderà conto che quel rifiuto è molto più di un capriccio.
-------
Dopo alcune settimane dalla “piccola protesta”, riteniamo che sia il caso di aggiungere qualche appunto:
- Da un sondaggio organizzato da Unicef – Unisona emerge che il fenomeno della competizione è minoritario, meno del 20% degli studenti intervistati dichiara che a scuola ci sia un clima competitivo, contro una maggioranza che dice di sentirsi stressata, inadeguata o insicura, soprattutto a causa delle aspettative dei genitori, dell’immagine di ipercompetizione trasmessa dal mondo del lavoro, e del carico di studio.
- Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Valditara, ai primi di settembre, tra le novità introdotte per l’esame di maturità, ha reintrodotto l’obbligatorietà dell’esame orale, dando seguito a quanto detto ai primi di luglio: «Se un ragazzo non si presenta all'orale, o volontariamente decide di non rispondere alle domande dei docenti, […] perché vuole 'non collaborare' o vuole 'boicottare' l'esame, dovrà ripetere l'anno»
- L’analisi più dettagliata delle dichiarazioni degli studenti sembrano rivelare – più che i caratteri di una protesta strutturale – fenomeni di insoddisfazione personale sui giudizi o sul clima scolastico.
Contiamo di fare delle analisi più approfondite e sistematiche, con l’aiuto di esperti di scuola e di insegnamento, seguendo la traccia che propone Vittorio Pentimalli: «resto dell’idea che quei rifiuti a sostenere l’esame siano un segnale: debole, minimo, ma da non sottovalutare. C’è molta brace che cova sotto le ceneri».
Terrorismo: uso politico del termine?
È molto probabile che uno dei termini più menzionati nel gergo giornalistico quando si parla di politica internazionale sia “terrorismo”, una parola utilizzata per definire, identificare o categorizzare diversi individui, gruppi o addirittura organizzazione politiche o paesi.
L’Organizzazione delle Nazione Unite non ha una definizione ufficiale di “terrorismo” ma, di norma, il termine viene usato per riferirsi ad azioni violente e premeditate con lo scopo di suscitare terrore nella popolazione.
Pertanto, in ogni paese i codici penali nazionali fanno riferimento a una definizione diversa di “terrorismo” e di “azione terroristica”.
Al di là delle diverse definizioni, di frequente e nella pratica, sono state identificate come “terroristiche” quelle entità politiche con le quali non si era disposti a trattare. Si pensi, ad esempio, alla lista di paesi presunti sponsor del terrorismo, stilata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che viene – in realtà - aggiornata in base alle linee politiche e geopolitiche dell’amministrazione di turno.[1]
A complicare il ulteriormente il quadro, si noti che, di recente, in paesi come il Regno Unito o la Repubblica Ceca, alcune manifestazioni in favore della Palestina sono state segnalate come “difesa delle attività terroristiche”.
In questo senso, possiamo riprendere le parole Alex Schmidt, uno degli accademici che ha più studiato il termine:
«Terrorismo” è forse oggi il termine più politicizzato del vocabolario politico. Usato come etichetta per alcune forme di violenza politica, quando “attecchisce” incide negativamente su un avversario politico, demonizzandolo e delegittimandolo. Nella sua dimensione peggiorativa, il destino del termine “terrorista” è paragonabile all’uso e all’abuso di altri termini del vocabolario politico, come “razzista”, “fascista” o “imperialista».[2]
È evidente che il senso del termine molto spesso dipende dall'intenzione politica di chi lo utilizza. Ad esempio, gli Stati Uniti considerano Al-Qaeda un'organizzazione terroristica, ma non era così quando la stessa Al-Qaeda ricevette il sostegno degli Stati Uniti contro i sovietici durante gli anni Ottanta. Un esempio simile si riguarda Hezbollah: questa organizzazione politica e la sua ala paramilitare vengono considerati come organizzazione terroristica da 26 paesi, ma non dal resto del mondo, dove di solito è identificato come un movimento di resistenza libanese.
Allo stesso modo, c’è chi utilizza il termine di “terrorismo di stato” per riferirsi, ad esempio, al genocidio perpetrato dallo Stato di Israele contro i palestinesi, nella striscia di Gaza o in altre regioni della Palestina, e, invece, il termine viene evitato dalla maggior parte dei media nei paesi occidentali in cui è fortemente osteggiata una linea contraria alle politiche di Israele.
In altri casi, gli Stati Uniti (che, come ricordato prima, hanno una loro lista di paesi ritenuti sponsor del terrorismo), sono stati accusati a loro volta di terrorismo di stato per il sostegno, ufficiale o ufficioso, ad alcune attività della CIA. Ad esempio, l’attentato contro il volo di Cubana de Aviacion il 6 di ottobre 1976, che produsse 73 morti e nel quale furono coinvolti numerosi elementi legati alla Central Intelligence Agency.[3]
È possibile trovare altri esempi simili ad altre latitudini del pianeta. In Ucraina, quando i ribelli armati hanno rifiutato di riconoscere il governo di Kiev nel 2014 e hanno cominciato i primi scontri contro l’esercito ucraino, la presidenza di Poroshenko ha subito organizzato una operazione armata chiamata “Operazione Anti-Terroristica” (ATO). Pertanto, quando le autorità ucraine hanno definito come terroristi i ribelli nell'Est, intendevano già dire che non vi era alcuna reale intenzione di negoziare un cessate il fuoco pacifico o trovare un accordo politico per l'Ucraina orientale.[4]
Nei film di Hollywood si sente spesso la frase “Non negoziamo con i terroristi”, proprio per far capire che non c’è alcuna intenzione di trovare un accordo e per segnalare quindi che è possibile soltanto una soluzione di forza. Quella stessa frase viene ripetuta, con lo stesso significato, dagli organi di sicurezza di diversi paesi.
Questa volontà di mostrare risolutezza contro una posizione politica considerata inaccettabile, ed etichettata come “terrorista”, assume spesso tratti contraddittori. Infatti, per fare un esempio recente, questa logica è stata messa in questione dalla presidenza del Messico: nonostante il governo degli Stati Uniti avesse considerato il Cartel di Sinaloa come una organizzazione terroristica, poco dopo (come ha sottolineato Claudia Sheinbaum) trovarono un accordo con Ovidio Guzman, uno dei figli di Joaquin “El Chapo” Guzman, uno dei fondatori del cartello.[5]
Quindi, a quali condizioni non si negozia con terroristi? Oppure, attribuire questa etichetta è solo un mezzo per far pressione nei confronti dell’organizzazione definita “terroristica”?
Allo stesso modo, è possibile trovare altri esempi che mostrano in maniera evidente la natura politica del termine “terrorista”. In generale, sarebbe consigliato evitare l’uso del termine nei paesi con una forte polarizzazione del tessuto politico, a meno che non si proponga un'altra definizione.
Infatti, molti dei reati che tipicamente vengono considerati “terrorismo” sarebbero facilmente descritti anche senza utilizzare questo termine, il cui uso può essere strumentale, per esempio di fronte ad una strage per elevare o diminuire il livello di attenzione o di preoccupazione nell’opinione pubblica.
Si pensi al recente incidente del 26 maggio a Liverpool, in cui un’autista britannico ha diretto la sua auto contro folla e che ha causato più di 100 feriti.[6] Una volta che le autorità hanno determinato che l’incidente causato da un’autista (bianco) non era un atto terroristico, e che non vi erano state vittime fatali, l’evento è sparito dall’interesse dell’opinione pubblica.
Di conseguenza, sarebbe molto importante fare attenzione all’uso che si fa della parola “terrorismo”. Ovviamente, questo non significa avallare forme estreme di violenza, ma al contrario, significa fare attenzione alla sua vera origine e di trovare quindi spiegazioni che invitano all’analisi e alla riflessione piuttosto che usare un’etichetta che vieta, o quantomeno scoraggia, la ricerca di soluzioni e accordi politici.
Perché se, come diceva il generale prussiano e teorico militare Carl von Clausewitz, la guerra è un’estensione della politica, e se consideriamo la violenza estrema chiamata terroristica come un’estensione della guerra, allora non sarebbe forse più auspicabile trovare degli spazi per l’accordo politico prima di arrivare al momento di massima polarizzazione? O non sarà piuttosto che la ragione della diffusione dell’uso della parola terrorismo vada ricercato semplicemente nel fatto che ci troviamo in un periodo dove predominano posizioni politiche più estreme?
NOTE:
[1] Attualmente in questa lista si trovano Cuba, Siria, Corea del Nord e Iran. Cuba era stata tolta dalla lista durante l’amministrazione Obama ma è stata rimessa durante la prima presidenza Trump. Sudan, Iraq e Libia erano nella lista ma furono poi rimossi. I paesi appartenenti a questa lista sono soggetti a sanzioni unilaterali, non possono ottenere alcun aiuto economico, né acquistare armi, e sono sottoposti a un controllo rafforzato per diversi prodotti a doppio uso. United States Department of State, State Sponsors of Terrorism - United States Department of State
[2] Schmid, Alex P., ‘The definition of terrorism,’ in The Routledge Handbook of Terrorism Research, Edited by Schmid, Alex P., New York, Routledge, 2011, page 40. Traduzione Enrico Campo
[3] Luis Posada Carriles, The Declassified Record, The National Security Archive, Maggio 10, 2005. Luis Posada Carriles: The Declassified Record
[4] Rolando Dromundo, State-building in the middle of a geopolitical struggle: The cases of Ukraine, Moldova and Pridnestrovia, Ibidem, Stuttgart, 2018.
[5] Sheinbaum critica acuerdo EEUU con hijo de El Chapo | Las últimas Noticias de España y del Mundo - upday News
Negare l’evidenza. Un clima di disinformazione
Quando la realtà ci sfugge di mano, il nostro cervello si rifugia in un’antica strategia di sopravvivenza: trovare un colpevole. È più rassicurante immaginare un “volto tra le nuvole”, che accettare l’idea che il mondo sia, talvolta, caotico, privo di intenzione e difficile da controllare. È il cosiddetto modulo di rilevazione dell’agente: un dispositivo cognitivo descritto dalle scienze cognitive evoluzionistiche che ci spinge, per prudenza, a vedere intenzionalità dove non ce n’è. Meglio sospettare un predatore inesistente, che ignorarne uno reale.
Lo storico delle religioni Stewart Guthrie, nel suo Faces in the Clouds (Oxford University Press, 1993), chiama questo meccanismo “antropomorfismo cognitivo”: attribuire caratteristiche umane a entità o eventi naturali, come tuoni, terremoti o carestie. Un’ipotesi evoluzionista che spiega la nascita di molte religioni come estensione dell’animismo primitivo: ci dev’essere qualcuno dietro, anche se non si vede.
Non è un caso se lo stesso schema mentale viene riattivato oggi di fronte al cambiamento climatico, alla pandemia, all’instabilità globale. Come spiega la psicologa sociale Karen Douglas in “The Psychology of Conspiracy Theories” (Current Directions in Psychological Science, 2017), le teorie del complotto proliferano in situazioni di incertezza, ansia, senso di esclusione. Non servono a spiegare il mondo, ma a renderlo psicologicamente tollerabile. Dietro un virus? Un laboratorio. Dietro il riscaldamento globale? Un piano delle élite per controllare le masse.
Nel Medioevo, per spiegare carestie e pestilenze si cercavano streghe. Oggi, si cercano burattinai: Bill Gates, Klaus Schwab, George Soros e ovviamente Greta Thunberg. Cambiano i nomi, non lo schema. I roghi si sono trasformati in commenti sotto i post, meme, video virali. Ma la logica è la stessa: trovare un capro espiatorio e scaricare su di lui l’angoscia collettiva.
Il pensiero complottista offre un doppio vantaggio narcisistico: ci fa sentire sia speciali (“io so la verità”) sia perseguitati (“gli altri non capiscono”). È un rifugio identitario: se il cambiamento climatico fosse reale e causato da noi, dovremmo cambiare. Ma se è tutto un inganno, possiamo restare come siamo. E magari sentirci anche eroi per averlo smascherato.
Ogni smentita, poi, diventa una conferma. Se i dati scientifici contraddicono la teoria, è solo perché “loro” ci stanno mentendo. Una trappola mentale chiusa dall’interno, a doppia mandata.
Ma non c’è solo psicologia. Il negazionismo climatico è una strategia deliberata e ben orchestrata. A documentarlo in modo puntuale sono Naomi Oreskes e Erik Conway in Merchants of Doubt (Bloomsbury Press, 2012). Una vera radiografia del sistema: think tank finanziati dall’industria dei combustibili fossili, “esperti” compiacenti, studi isolati, messaggi ambigui. Non per negare apertamente il cambiamento climatico – oggi sarebbe insostenibile – ma per seminare dubbi. Perché se non puoi smentire la scienza, puoi almeno confondere il pubblico.
È la stessa tecnica usata, decenni fa, dall’industria del tabacco. Quando ormai era evidente il legame tra fumo e cancro, non restava che un’arma: chiedere “ulteriori studi”. Creare l’illusione di un dibattito aperto. Come dichiarò con cinismo S. J. Green, direttore della ricerca della British American Tobacco: «La richiesta di nuove prove scientifiche è sempre stata un espediente per giustificare l’inazione o il rinvio. Di solito è la prima reazione di chi è colpevole.»
Lo stesso copione, aggiornato, è stato messo in campo da ExxonMobil. Già negli anni ’70 e ’80 i loro scienziati interni producevano modelli previsionali molto accurati sugli effetti della CO₂. Ma la direzione aziendale scelse un’altra strada: finanziare il dubbio. Tra il 1998 e il 2004, la compagnia ha speso oltre 16 milioni di dollari per sostenere think tank negazionisti, come il Competitive Enterprise Institute. Celebre la loro campagna del 2006: «CO₂: They call it pollution. We call it life». Nessun dato. Solo retorica.
La disinformazione funziona anche perché sfrutta un altro meccanismo psicologico: la truthiness, termine coniato dal comico Stephen Colbert per indicare ciò che “suona vero”, anche se non lo è. Un effetto verità che prende scorciatoie emotive, bypassa il pensiero analitico e colpisce direttamente l’istinto.
Uno studio pubblicato su Science da Soroush Vosoughi, Deb Roy e Sinan Aral (“The Spread of True and False News Online”, 2018) ha mostrato che le fake news si diffondono più rapidamente, più lontano e più in profondità rispetto a quelle vere. Non sono i bot i principali responsabili, ma noi: indignati, frettolosi, disattenti. Le bufale provocano emozioni forti – rabbia, paura, disgusto – che attivano il cervello più rapidamente della riflessione razionale.
È il cosiddetto bullshit asymmetry principle (Brandolini’s law): per smontare una sciocchezza servono almeno dieci volte le risorse necessarie per produrla. La scienza richiede tempo, verifiche, cautele. Il complotto no. Viaggia leggero, virale, immune alla smentita. E mentre la politica si divide, la transizione ecologica si arena. Perché, intanto, il tempo corre.
Le teorie del complotto e la disinformazione scientifica sono la conseguenza, prevedibile, di come funziona il nostro cervello e di come funzionano – in modo non meno prevedibile – gli interessi economici organizzati. Comprenderlo è il primo passo per difenderci. Perché mentre la scienza avanza a passi lenti e incerti tra ipotesi, verifiche, margini d’errore e formule prudenti (“altamente probabile”, “coerente con i modelli”, “correlazione significativa”), la disinformazione finanziata dalle lobby del carbone, del petrolio e del gas corre – rapida ed emozionale – sul tapis roulant della truthiness. Non deve dimostrare nulla. Solo dirci quello che desideriamo sentire.
NOTA
Su questo tema Matteo Motterlini ha appena pubblicato, per Solferino Libri, Scongeliamo i cervelli, non i ghiacciai
Enrico Fermi e il premio Nobel controverso
Grazie a un intervento di Carlo Rovelli sul Corriere della Sera sul tema della Bomba Atomica, è tornata alla ribalta una controversia scientifica degli anni ’30 sulle motivazioni del premio Nobel a Enrico Fermi, che assume – rileggendola oggi - risvolti di genere e politici.
Il tema principale della controversia è, appunto, se l’attribuzione del premio Nobel a Enrico Fermi nel 1938 sia giustificata oppure sia stata un errore; di questo parere fu, pochi mesi dopo la consegna del premio, la chimica tedesca Ida Noddack.
Nella puntata della Serie “La bomba atomica” di Rovelli – che aderisce al “partito dell’errore” e al punto di vista di Ida Noddack, e sostiene che la posizione della chimica tedesca sia stata trascurata perché chimica e perché donna - ha dato il via, con molte risposte di fisici e accademici italiani, a una ulteriore controversia, sulla figura di Fermi stesso, dal punto di vista scientifico e morale [1].
LA CONTROVERSIA SUI DUE NUOVI ELEMENTI AUSONIO E ESPERIO
Tralasciando la discussione sulla statura scientifica e morale di Enrico Fermi, proviamo a sintetizzare i termini della discussione sul Nobel – che avvenne a distanza ed ebbe, effettivamente – ben poca risonanza.
Il Nobel per la fisica del 1938 fu assegnato a Fermi perché aveva scoperto – nel 1934 – la radioattività artificiale. Nella motivazione si parla della possibilità di frammentare gli elementi più pesanti della tavola periodica attraverso il bombardamento con neutroni; in sostanza, della fissione nucleare. Associato a questo fenomeno, si legge sempre nella motivazione, ci sono: l’emissione di radiazioni, sotto forma di nuclei di elio e di idrogeno; la generazione di isotopi radioattivi degli elementi bombardati; e – nel caso del bombardamento dell’uranio (che ha numero atomico 92) la probabile produzione di due nuovi elementi, con peso atomico 93 e 94.
Il punto cruciale della controversia è questa ultima “probabile” scoperta: la generazione dei due nuovi elementi, chiamati da Fermi e dai “Ragazzi di via Panisperna” Ausonio e Esperio, antichi nomi dell’Italia preromana.
Fermi e alcuni dei suoi collaboratori furono molto prudenti, non garantiscono la sicurezza defiitiva della produzione dei due elementi; fu Orso Maria Corbino, ex-fisico e ex-senatore del Regno, noto per la sua capacità di cogliere le potenzialità applicative delle scoperte scientifiche ad annunciare la scoperta come certa, all’Accademia dei Lincei; la scoperta fu poi caricata di valore simbolico e politico dalla stampa fascista.
Nel settembre del 1938, Ida Noddack, con un articolo pubblicato sulla Zeitschrift fur Angewandte Chemie (Rivista di Chimica Applicata), contesta che 1) il metodo applicato da Fermi sia corretto dal punto di vista chimico, che 2) sia effettivamente possibile produrre i due nuovi elementi in quel modo e che 3) le osservazioni effettuate ne provino l’effettiva presenza.
Noddak è molto precisa e circostanziata nella sua critica e – nello stesso tempo – molto corretta nel riconoscere a Fermi la prudenza con cui ha dichiarato la possibile scoperta dei due elementi e nell’attribuire la risonanza di questa scoperta ai media del tempo.
E, inoltre, non contesta null’altro dello studio di Fermi e dei suoi colleghi.
CONCLUSIONE DELLA CONTROVERSIA
La controversia non ebbe seguito, evidentemente, poiché il 10 dicembre dello stesso anno il Professor H. Pleijel, Chairman del Comitato Nobel per la Fisica della Royal Swedish Academy of Sciences, pronuncia il discorso di conferimento del premio che include anche la scoperta di Ausonio e Esperio.
Ida Noddack non ebbe modo – nonostante ne avesse i mezzi tecnici – di provare con certezza e sul campo che la sua contro-ipotesi fosse corretta.
Di fatto, è molto probabile che Noddack avesse ragione e che la presenza di isotopi 93 e 94 fosse poco più che casuale, difficilmente correlabile all’esperimento, nel mezzo di una quantità – questa indiscutibile – di prodotti della fissione indotta dal bombardamento neutronico.
I due elementi con peso atomico 93 e 94 furono prodotti poi dal ciclotrone del Lawrence Berkeley National Laboratory dell'Università della California, nel 1940, e chiamati con i nomi di Nettunio e Plutonio (di quest’ultimo fu trovata per la prima volta negli anni settanta la presenza allo stato naturale in Canada).
PRESUNTE QUESTIONI DI GENERE E DI CHIMICA
L’articolo di Rovelli avanza l’ipotesi che questa conclusione della controversia – a favore di Fermi - sia stata dettata da due pregiudizi, il primo di genere e il secondo disciplinare: secondo l’autore la contestazione di Noddack è stata trascurata perché lei era donna e perché era una chimica.
Entrambe le questioni sono degne di considerazione, poiché negli anni ’30 vigeva un deciso atteggiamento maschilista, nelle scienze e ancora di più nella società comune, con accenti ancora più pronunciati in Italia e in Germania, sotto le dittature nazi-fasciste; e poiché quelli erano gli anni in cui la fisica sembrava essere la scienza per eccellenza, anche se i lavori di Fermi e della sua squadra poggiavano su basi chimiche importanti.
Tuttavia, si può sollevare qualche dubbio su una di queste interpretazioni, infatti, Ida Noddack era una chimica di fama, a 26 anni ottenne un posto di visiting scientist nel prestigioso Istituto Fisico-Tecnico di Berlino, con il marito Walter Noddack pubblicò più di 100 articoli scientifici, insieme a lui e a Otto Berg scopre gli elementi con numero atomico 43 e 75, e nel 1931 fu premiata con la medaglia Liebig per la scoperta del Renio e fu candidata al Nobel 4 volte, oltre che essere riconosciuta dal suo gruppo di lavoro, composto da tutti maschi oltre a lei, come la mente e l’ispiritratrice di buona parte dei loro lavori.
Quello di Noddack non sembra, quindi, essere il profilo di una cenerentola della scienza; al contrario, Ida Noddack potrebbe a buon titolo essere considerata un esempio di scienziata che ha ricevuto attenzione e riconoscimento per il suo lavoro, in netta controtendenza rispetto al clima politico e culturale in cui si trovava a lavorare.
Interpretare la prevalenza dell’ipotesi di Fermi come l’effetto di un pregiudizio di genere sembra, quindi, essere azzardato, se non strumentale e finalizzato a collocare nel fil rouge, in voga oggi, delle discriminazioni di genere [2] una vicenda che – a nostro avviso – ha tutt’altro sapore.
POSSIBILI INFLUENZE POLITICHE SULLA DETERMINAZIONE DELLA CONTROVERSIA
La controversia tra Fermi e Noddack, in realtà, sembra essere stata di fatto sommersa, poiché Noddack si limitò a pubblicare l’articolo citato, senza dare seguito alla questione, articolo che probabilmente passò inosservato anche agli stessi scienziati coinvolti nella questione.
Se, al contrario, avesse avuto pubblicità e seguito, sembra fuori di dubbio che avrebbe potuto essere una controversia decisamente di sapore scientifico, giocata sul filo della validità del nesso causale tra struttura sperimentale e presenza degli elementi 93 e 94.
Causalità su cui lo stesso Fermi – come abbiamo già visto – sembrò essere molto prudente e, forse, dubbioso. Ma che fu data per certa dai media italiani, alimentati da O. M. Corbino.
Nel contesto politico degli anni ’30 del XX secolo, infatti, una scoperta comprensibile a tutti come quella di nuovi elementi portava onore alla scienza italiana e al regime; i nomi scelti, Ausonio e Esperio, erano in linea con la retorica romanizzante; l’ambiente accademico tedesco, già in piena fase di nazistizzazione (Heidegger, ricordiamolo, si iscrisse al Partito Nazional Socialista nel 1933), non era certamente favorevole a contrastare il successo scientifico e mediatico dell’alleato italiano.
Questa, a nostro avviso, potrebbe essere la chiave di lettura della risoluzione a favore di Fermi, con l’interpretazione certa della scoperta di Ausonio e di Esperio tra i risultati sperimentali di Fermi e – di conseguenza – sull’inserimento anche di questa tra le motivazioni del Nobel.
NOTE:
[1] Per chi volesse approfondire questa discussione, ecco alcuni link a interventi significativi:
- Commento della Prof.ssa Angela Bracco all’articolo del Prof. Carlo Rovelli su Enrico Fermi. https://associazioneitaliananucleare.it/commento-della-prof-ssa-angela-bracco-allarticolo-del-prof-carlo-rovelli-su-enrico-fermi/
- A. Zaccone, From physicist to physicist: Rovelli, you are wrong about Fermi, https://www.researchgate.net/publication/394926645_From_physicist_to_physicist_Rovelli_you_are_wrong_about_Fermi
- Lettera del prof. Ambrosini, membro del Direttivo AIN, in risposta al Prof. Rovelli su Enrico Fermi, https://associazioneitaliananucleare.it/lettera-del-prof-ambrosini-membro-del-direttivo-ain-in-risposta-al-prof-rovelli-su-enrico-fermi/
- Ugo Amaldi, Riccardo Barbieri, Giorgio Capon, Luciano Maiani, Monica Pepe Altarelli, La vera eredità di Enrico Fermi. Una risposta a Rovelli, https://normalenews.sns.it/la-vera-eredita-di-enrico-fermi-una-risposta-a-rovelli
[2] Si veda, ad esempio, G.M. Santos, A tale of oblivion: Ida Noddack and the 'universal abundance' of matter, DOI:10.1098/rsnr.2014.0009
La “reazione all’oggetto” - Una distorsione in cui (almeno) i politici non dovrebbero cadere.
La “reazione all’oggetto” è un fenomeno (molto?) noto a chi si occupa di costruzione dei questionari. Consiste nel fornire un’opinione che non si basa sul contenuto di una affermazione - sulla reazione a una dichiarazione - ma sull’autrice (in questo articolo viene usato il femminile sovraesteso. Ne abbiamo già parlato qui, qui e qui) della stessa. È un processo inferenziale di tipo cognitivo-emotivo, in cui incorriamo quasi quotidianamente: ascoltando dichiarazioni, sentendo pettegolezzi oppure leggendo notizie su eventi accaduti, spesso ci chiediamo: “chi l’ha detto?”. Siamo, cioè, più interessate alla fonte (l’emittente) che al contenuto del messaggio (enunciato). A volte questo è fondamentale, perché ci fa essere più caute nell’accettare un contenuto. Ma non è sempre bene agire così, dal momento che il contenuto potrebbe essere vero, anche se la fonte ha scarsa legittimazione. Ma non è questo il caso che voglio trattare.
DALLA METODOLOGIA…
La “reazione all’oggetto” è un processo cognitivo abbastanza ovvio, che però è rimasto a lungo ignorato nella letteratura metodologica. Quest’ultima aveva solo evidenziato che alcuni termini (come ad esempio ‘comunismo’, ‘democrazia’, ‘capitalismo’ ecc.) provocavano negli intervistati reazioni emotive che diventavano fonte di distorsione. Erano termini loaded, cioè carichi emotivamente (Kahn e Cannel 1957).
Invece a metà degli anni Ottanta, il metodologo ed epistemologo Alberto Marradi, ascoltando le registrazioni di interviste in cui Salvatore Cacciola somministrava delle scale Likert, scoprì che “una quota cospicua di interrogati non reagisce alle affermazioni, ma ai personaggi, alle azioni, alle situazioni menzionate dalle affermazioni stesse” (Cacciola e Marradi 1988, 86). Marradi battezzò ‘reazione all’oggetto’ questo fenomeno.
La prima forma di reazione all’oggetto, la più facilmente individuabile, si manifesta quando la frase esplicitamente o implicitamente disapprova un comportamento, un’azione o una situazione, che anche l’intervistata disapprova. Lei dovrebbe quindi dichiararsi d’accordo con la frase; invece, inaspettatamente, si dichiara in disaccordo, e solo dai suoi commenti (quando ci sono e sono registrati) si scopre che il disaccordo non riguarda l’affermazione in sé, bensì i personaggi o comportamenti descritti dall’affermazione (Cacciola e Marradi 1988, 87). Un esempio è il seguente: di fronte alla frase “Gli assenteisti sbandierano problemi di salute, ma sono soltanto dei fannulloni”, l’intervistata sceglie la categoria-Likert “del tutto in disaccordo” e poi commenta “Dovrebbero lavorare, non assentarsi dai propri posti di lavoro. Sono in disaccordo con gli assenteisti”.
Una seconda forma di reazione all’oggetto si produce quando la frase disapprova un personaggio o un comportamento che invece l’intervistata approva. Lei dovrebbe quindi dichiararsi in disaccordo con la frase; invece, si dichiara d’accordo e solo dai suoi commenti si scopre l’incongruenza (1988, 88). Ecco un caso: la frase dice “I sindacati italiani fanno troppa politica e così non possono fare gli interessi dei lavoratori”. Un intervistato, dopo aver assegnato (inaspettatamente) su tutte e tre le tecniche punteggi di moderato accordo, dichiara: “No, io dico che i sindacati hanno portato dei miglioramenti, che se non c’erano era peggio. Io mi ricordo, tempo del Duce, che i sindacati non c’erano; dopo, che si sono potuti fare, c’è stato un bel miglioramento. Io dico che non sono la rovina d’Italia”. (esempio riportato in Sapignoli 1992, 112).
… AL PROBLEMA DEL TESTIMONIAL…
Questa distorsione si accresce quando le intervistate vengono chiamate a reagire a frasi affermate da persone molto note, come ad esempio il Papa, la Prima Ministra, il Presidente della Repubblica o altri personaggi famosi, non importa se politiche, artiste, scienziate ecc. Anche in questo caso le intervistate prestano poca attenzione alla frase detta dalla testimonial e reagiscono (dichiarandosi d’accordo o in disaccordo) al personaggio stesso. Per cui se vogliamo conoscere il parere (non distorto) delle persone, dovremmo mettere la frase senza farla dire a qualcuna. Ad esempio, somministrare la domanda: “Alcuni dicono che l’eutanasia è un omicidio? Lei è d’accordo o in disaccordo?”, anziché la domanda “Il Papa ha detto che l’eutanasia è un omicidio? Lei è d’accordo o in disaccordo?”.
… ALLA POLITICA
In seguito alle dichiarazioni del presidente francese Macron, che non escludeva l'ipotesi di invio di truppe Nato in Ucraina, sottolineando che bisogna fare "tutto il necessario per garantire che la Russia non possa vincere questa guerra", il 20 agosto, il vice-premier Matteo Salvini ha dichiarato: "A Milano si direbbe taches al tram: attaccati al tram. Vacci tu se vuoi. Ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai in Ucraina".
In Italia sono pochi i partiti di opposizione che si sono espressamente dichiarati contrari a mandare armi e soldati in Ucraina. Fra questi il M5S e AVS (Alleanza Verdi e Sinistra).
Ebbene, davanti a una presa di posizione così netta da parte di un importante esponente dell’attuale Governo, ci si sarebbe aspettati un plauso del tipo: “Finalmente un esponente del Governo la pensa come noi” oppure “auspichiamo che la posizione di Salvini trovi ascolto nel governo”.
Invece no. Le reazioni sono state ben diverse.
Angelo Bonelli di AVS ha attaccato dicendo che “Salvini è il vicepremier e se lo dimentica sempre e conseguentemente usa un linguaggio volgare non adeguato al ruolo che riveste. Meloni dovrebbe insegnare o quanto meno ricordare a Salvini come ci si comporta e pertanto dovrebbe censurare le parole del suo vicepremier che hanno provocato un incidente diplomatico tra Italia e Francia”. Poi continua “che i militari italiani non debbano andare in Ucraina è fuori discussione ma con il linguaggio da osteria, Salvini dimostra di non essere adeguato al ruolo che ricopre”.
Meno drastico, ma comunque contorto, l’intervento di Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato del M5S, in un punto stampa a margine della sua partecipazione al Meeting di Rimini, il 24 agosto: “… non è soltanto da oggi che il Ministro Tajani e il Ministro Salvini hanno una dialettica piuttosto aspra e contrapposta rispetto ai temi della politica estera. Non mi sorprendono neanche i toni di Matteo Salvini, perché siamo abituati a quel tipo di linguaggio. Come ho detto prima, credo che non sia soltanto Macron che sta in questo momento sta interferendo in un percorso di pace, ma siano la maggior parte dei leader europei, compresa Giorgia Meloni. Le parole che Matteo Salvini ha rivolto a Macron potremmo rivolgerle tranquillamente anche alla premier".
Questi autorevoli esponenti dei due partiti, anziché reagire al contenuto delle dichiarazioni di Salvini hanno reagito al dichiarante (Salvini), al testimonial.
Ma se è comprensibile che in questa distorsione cognitivo-emotiva possano cadere delle intervistate, le persone che fanno politica dovrebbero essere più avvertite. In altre parole, quale scopo si prefiggono di raggiungere? L’affermazione della loro identità (partitica) oppure l’obiettivo di depotenziare sempre più l’ipotesi di inviare truppe in Ucraina?
Purtroppo, questo è solo uno delle centinaia di casi in cui esponenti politiche si comportano strumentalmente: criticare sempre qualunque cosa dica o faccia (saggia o meno, condivisibile o meno) l’avversaria politica.
Ma allora, che credibilità possono avere politici che usano la reazione all’oggetto al posto del discernimento?
Il cosmismo russo e le sue continuazioni
I cosmisti erano guidati dal desiderio di superare l'entropia del mondo e, come conseguenza, raggiungere l'immortalità umana, partendo dall'analogia tra il microcosmo umano e il macrocosmo universale. Se l'universo è infinito nello spazio, allora l'uomo deve essere infinito nel tempo e, dunque, solo nell'unione con il cosmo è possibile realizzare l’idea di immortalità. La realizzazione del progetto deve cominciare con la trasformazione antropologica dell'essere umano, basata su cambiamenti spirituali e morali. In sostanza, il cosmismo russo è una fase dell'evoluzionismo teistico, esistente da tempo, che prese la forma di un progetto dettagliato nel XIX secolo in Russia. Il progetto del XIX è stato seguito da una adozione, seppur modificata, nel pensiero sovietico post-rivoluzionario.
All'interno del grande movimento del cosmismo russo si distinguono tre direzioni:
- quella scientifico-naturale, in cui si poneva maggiore attenzione all'esplorazione scientifica e tecnica dello spazio;
- quella religioso-filosofica, che interpretava il significato dello sviluppo spirituale e morale dell'uomo;
- quella artistico-estetica, che insisteva sul ruolo predominante dell'arte come mezzo per la trasformazione cosmica del mondo.
Queste direzioni non si opponevano l'una all'altra, ma esistevano come tre in uno, con un obiettivo comune, la stessa piattaforma spirituale e un'unica idea della struttura del mondo, dell'uomo e dello spazio.
Il fondatore della direzione scientifico-naturale del cosmismo russo è il filosofo Nikolaj Fëdorov (1829–1903). Egli sosteneva che l'uomo, la natura e lo spazio sono uniti e interconnessi, perciò i cambiamenti nell'uomo, lo sviluppo della sua capacità di controllarsi non solo spiritualmente ma anche fisicamente, porteranno al controllo dell'uomo sulla natura e sullo spazio. E per fare ciò, è necessario superare le mancanze e i peccati che causano divisione tra le persone e ostilità. La direzione dell'evoluzione umana è indicata da Cristo nell'idea della resurrezione. Fëdorov unisce la dottrina cristiana al positivismo: per regolare la natura (stabilire nuove leggi), è necessario ricomporre gli atomi, il che cambierà non solo i fenomeni naturali, ma anche l'organismo umano.
Il più alto stadio di regolazione sarà uno stato della materia, della mente e dello spirito tale da permettere la resurrezione degli antenati defunti: essi appariranno nel mondo in una nuova forma ideale, dotata della capacità di autocreare un corpo a partire da sostanze inorganiche. Fëdorov non parla dell'immortalità cristiana delle anime, ma dell'immortalità dei corpi, che diventeranno come esemplari viventi da museo. Questo stadio dell'evoluzione verrà raggiunto quando l'umanità imparerà a controllare non solo se stessa e la natura, ma anche il Sole e l'Universo, che diventeranno il luogo per il reinsediamento degli antenati resuscitati e dei nuovi nati.
Konstantin Tsiolkovsky (1857–1935) credeva che non ci fosse alcuna frattura ontologica tra la mente e il mondo e, di conseguenza, che il cervello umano fosse una parte materiale dell'universo e che la volontà di un individuo riflettesse la volontà dell'universo.
Tsiolkovsky credeva nell'immortalità come indistruttibilità dell'essenza del mondo, che cambia solo forma. Creò una sua versione del Nuovo Testamento, secondo la quale Dio e l'universo, spirito e materia sono una cosa sola. La futura “beatitudine cosmica” non è immaginabile nello spazio tridimensionale: essa esiste in un oceano multidimensionale di luce, volontà razionale e grazia, abitato da esseri umani ideali. La competizione capitalista e lo sfruttamento devono essere sostituiti dal collettivismo e dalla solidarietà tra le persone.
Per avvicinare la felicità sulla Terra, Tsiolkovsky propose un piano di ricostruzione della società, che consisteva in uno stato totalitario su scala globale con una gestione gerarchica, al cui vertice si trovavano scienziati e artisti.
L'idea di Fëdorov di reinsediare gli antenati resuscitati nello spazio e di viaggiare attraverso le galassie ispirò Tsiolkovsky a sviluppare un modello di astronave. Egli effettuò i calcoli matematici dei parametri tecnici di un razzo in grado di lanciare un veicolo in orbita terrestre. In seguito, questi calcoli furono utilizzati da F.A. Zander, uno dei creatori del primo razzo sovietico a combustibile liquido, e da S.P. Korolev, progettista generale della tecnologia missilistica e spaziale sovietica.
Il “Regno dei Cieli” cosmico nella concezione di Vladimir Vernadsky (1863–1945) si manifesta nella forma della noosfera. Con noosfera (sfera dell'intelligenza), Vernadsky intendeva una fase nello sviluppo della biosfera, in cui l'attività razionale e intellettuale dell'umanità collettiva comincia ad avere una portata geologica, planetaria e poi extraplanetaria. Essa nasce come naturale sviluppo della biosfera in direzione etica e creativa.
L'ideale dello sviluppo noosferico diventa la sua “autotrofia”, cioè la liberazione dal bisogno di ottenere energia dalla biosfera terrestre e l'espansione dello sviluppo evolutivo dell'umanità prima nello spazio vicino (il sistema solare), e poi nello spazio lontano.
(Alla corrente religiosa e filosofica del cosmismo russo appartenevano Vladimir Solov’ëv, Nikolaj Berdjaev, Sergej Bulgakov, Pavel Florenskij e altri.
Il suo principale rappresentante, Vladimir Solov’ëv (1853–1900), affermava che l'umanità può rinascere solo attraverso la verità in Cristo, che comporta la distruzione della «grossolana ignoranza delle masse, la prevenzione della devastazione spirituale delle classi alte e l'umiliazione della violenza brutale dello Stato».
Solov’ëv riponeva le sue speranze nella trasformazione dell'umanità attraverso la teocrazia, ovvero tramite la creazione di uno Stato giusto e di un ordine sociale equo, in grado di realizzare gli ideali cristiani.
Come per gli altri cosmisti russi, nella sua visione l'idea dell'unità universale delle persone è di importanza primaria; questa idea, nella tradizione ortodossa russa, è chiamata "sobornost’" (conciliarità). Essa non è intesa come un'unione meccanica di individui, ma come:
«l'unità di tutti in uno, la coscienza di tutti in sé stessi e di sé stessi in tutti».
Tutti i cosmisti consideravano l'arte come mezzo di trasformazione del mondo, e non in senso metaforico, bensì in senso pratico: l'arte era riconosciuta come capace di trasformare fisicamente la materia.
Questo era il pensiero di Aleksandr Skrjabin (1872–1915), il rappresentante più coerente della corrente artistico-estetica del cosmismo russo. Con la sua ultima composizione (rimasta incompiuta), intitolata “Mistero”, il compositore intendeva completare l'esistenza del mondo attuale, unire lo spirito del mondo con la materia e dare così origine alla nascita di un nuovo mondo in forme non solo spirituali, ma anche materiali.
Quest'opera grandiosa e sincretica era pensata per un'enorme orchestra, un coro di 7.000 cantanti, luci, danza e movimenti plastici, e doveva essere rappresentata sulle rive del fiume Gange, in un tempio che si elevava sopra la Terra. L'intento era quello di unire l'umanità in un amore universale (compreso l'amore erotico), portando questo sentimento a uno stato estatico, in cui la materia si sarebbe fusa in un altro stato, unendosi con lo Spirito Assoluto per dare origine a una nuova vita cosmica in altre dimensioni.
Riassumendo le idee principali del cosmismo russo, possiamo evidenziare alcune proposte fondamentali considerate necessarie per raggiungere la fase cosmica dello sviluppo umano, nel senso più ampio del termine:
- Fede nei valori cristiani come base spirituale dello sviluppo umano.
- Relazione tra spirito e materia: lo sviluppo evolutivo della materia conduce a forme superiori di coscienza, la quale, a sua volta, è in grado di ricostruire la materia in una fase avanzata del progresso.
- Al centro del cosmismo vi è la creazione di un nuovo tipo antropologico di uomo e, di conseguenza, di una nuova umanità:
- Unità tra antropologico, sociale e ontologico: in altre parole, il modo fisico di esistenza dell'umanità è determinato dalle caratteristiche antropologiche dell'uomo, che a loro volta determinano la struttura sociale.
- La società spaziale del futuro si fonda sull'unione fraterna dell'umanità, basata sull'amore, sull'uguaglianza e sulla solidarietà a livello planetario.
- Le utopie cosmiste descrivono una società futura centralizzata, collettivistica e gerarchica, con scienziati e artisti al vertice della gerarchia cosmica, a testimonianza di una dominanza dello spirituale nella scala di valori.
Paradossalmente, ma in modo naturale, uno sviluppo concreto delle idee cosmiste fu rappresentato dalla Repubblica Sovietica nata nel 1917, che mirava alla costruzione di una società senza classi, in cui le differenze tra gli individui fossero superate. L'individualismo venne sostituito dal collettivismo, che trae origine sia dalla fratellanza cosmica che dalla sobornost’ ortodossa.
I comunisti sostituirono l'unità in Dio con l'unità nel collettivo, mettendo gli interessi della società e dello Stato al di sopra di quelli individuali. Questo contribuì al raggiungimento di straordinari risultati in tempi brevi, come i progressi scientifici e spaziali dell'URSS. Il “Codice del Costruttore del Comunismo” – documento ufficiale del Partito Comunista – proponeva una morale affine ai comandamenti cristiani, benché l'ideologia sovietica fosse basata sul materialismo marxista. La morale comunista affermava la prevalenza dello spirituale sul materiale, sia per l'individuo che per la collettività.
Fu così introdotta l'istruzione obbligatoria e gratuita per tutti, e fu assegnato un ruolo speciale a scienziati, letterati e artisti, che – come nei testi cosmisti – occupavano il vertice della piramide sociale. L'impulso spirituale collettivo, che pervadeva la coscienza popolare, conteneva in sé il potenziale per trasformarsi in risultati materiali concreti. Come affermò Lenin:
«Un'idea che si impadronisce delle masse diventa una forza materiale».
Tuttavia, i comunisti non portarono avanti l'idea di immortalità fisica, forse perché si prefiggevano di costruire il “Paradiso in Terra”, cioè il comunismo come ideale società terrena. È interessante notare come la descrizione dell'utopia terrena di Tsiolkovskij, il più materialista dei cosmisti, anticipi elementi della società sovietica: gerarchia, totalitarismo, collettivismo, centralizzazione.
La realizzazione di questo “paradiso in terra” era però possibile solo con un nuovo tipo di uomo, l'uomo ideale sovietico, caratterizzato da altruismo, eroismo, volontà, spirito, alto livello di istruzione, disprezzo per il materiale, dedizione al lavoro, modestia e umanesimo. Sebbene nella realtà non fosse possibile trasformare tutta la popolazione in esseri ideali, si ritiene che basti l'8% della popolazione a possedere queste caratteristiche per innescare un salto evolutivo. È ciò che accadde: l'URSS fu la prima a progettare un'astronave e a mandare un uomo nello spazio. È simbolico che il cognome del primo cosmonauta, Gagarin, fosse lo stesso del padre del fondatore del cosmismo, Nikolaj Fëdorov (Fedorov era il figlio illegittimo del conte Gagarin, il suo vero cognome era Gagarin).
Le idee dei cosmisti russi del XIX e XX secolo stanno tornando particolarmente attuali nel XXI secolo. Tra gli obiettivi dichiarati oggi ci sono:
- l'esplorazione dello spazio,
- il controllo dei cataclismi naturali,
- la trasformazione radicale del corpo umano (cambio di sesso, razza, ecc.),
- l'immortalità attraverso clonazione, ingegneria genetica, sostituzione degli organi.
Molti osservano come questo progetto transumanista e spaziale presenti somiglianze con le teorie cosmiste e con le ideologie di sinistra radicale. Tuttavia:
- Il progetto sovietico è un caso unico, in quanto ha unito una visione radicale di sinistra con la mentalità tradizionale russa, dando origine a un fenomeno socio-antropologico irriducibile ad altre teorie precedenti.
- Nonostante le somiglianze apparenti, esiste una differenza fondamentale: i cosmisti ponevano al centro la trasformazione spirituale e morale dell'uomo, come fonte primaria di ogni altro cambiamento, anche materiale. Al contrario, i progetti moderni partono dalla trasformazione fisica del corpo, della Terra e dello spazio. Ma un futuro costruito solo su queste basi potrebbe sembrare più un inferno che un paradiso.
Oggi, lo spazio vicino alla Terra, divenuto campo di competizione corporativa, è una discarica orbitale; si ipotizza perfino il suo uso militare. La gestione “efficiente” del pianeta, ignorando solidarietà e fratellanza, non resuscita i morti, ma uccide i vivi. La ricerca ossessiva dell'immortalità fisica ignora le anime. La disuguaglianza sociale cresce, l'amore fra gli esseri umani diminuisce. Questo vettore di sviluppo dell'umanità moderna è l'opposto di ciò che i filosofi cosmisti auspicavano.
BIBLIOGRAFIA
Fedorov, Nikolai. What Was Man Created For? The Philosophy of the
Common Task. Lausanne: Honeyglen Publishing/L'Age d'Homme, 1990.
Teilhard de Chardin, Pierre. The Phenomenon of Man.
Harper Perennial Modern Classics, November 4, 2008.
Tsiolkovsky, Konstantin Eduardovich. Public organization of mankind.
Kaluga: edition of the author, 1928.
Vernadsky W.I. The biosphere and noosphere. American scientist, vol.3,
January 1945, #1.
Young, George M. The Russian Cosmists: The Esoteric Futurism of Nikolai
Fedorov and his Followers. Oxford University Press, New York, 2012.
Nell’Ottocento, le donne avevano meno talento musicale degli uomini?
Questa che può sembrare oggi un’affermazione ridicola, è stata per un certo periodo la convinzione di molti critici musicali nella Vienna dell'Ottocento.
Ma anche oggi ci sono convinzioni simili. Ad esempio, nel tennis, come Vittorio Pentimalli ha mostrato in un post precedente.
A quel tempo, secondo molti critici musicali, le pianiste non suonavano la musica di Beethoven (1770-1827) bene quanto i pianisti uomini. Essi ritenevano che il motivo risiedesse nel talento. Quindi, se il talento (A) determinava un’esecuzione eccellente (B), allora le donne erano meno talentuose degli uomini.
Tuttavia, questa relazione causale era alquanto sospetta, come la sociologa statunitense Tia DeNora (1995; 2002) ha avuto modo di documentare ricostruendo il contesto sociale dell'epoca. La studiosa osserva, infatti, che nei cinquant’anni prima dell'avvento di Beethoven, sia i pianisti uomini che le donne si esibivano in pubblico con eccellenti performance e valutazioni. Come mai cinquant’anni dopo, si chiede DeNora, le donne erano diventate così mediocri? Lei nota che Beethoven innovò non solo la musica dell'epoca, ma anche il modo di eseguirla, da cui lo stereotipo del musicista romantico: bello, dannato, appassionato, disinvolto, che si esprime liberamente, che lascia andare il suo corpo, si agita, si dimena, da sfogo alle proprie emozioni.
Ci si può chiedere: una donna poteva esibirsi in questo modo? Non proprio, perché le convenzioni sociali dell'epoca non lo permettevano. Infatti, le donne dovevano apparire sobrie e dignitose nelle loro esibizioni pubbliche al pianoforte. Persino il loro abbigliamento era studiato per ricordare loro come muoversi sul palco: corpetti attillati con scollature profonde (per mettere in mostra collane e gioielli) ne limitavano i movimenti.
 |
 |
 |
Capite bene che, dentro questi vestiti, era complicato muoversi liberamente al pianoforte.
Molto più facile se vestite così:
 |
 |
 |
| Yuja Wang | Valentina Lisitsa | Irene Veneziano |
DeNora osserva, inoltre, che gli strumenti a fiato erano già stati preclusi alle donne perché suonarli richiedeva posture “poco femminili” e smorfie sconvenienti per una donna, ma accettabili per un uomo.
 |
 |
 |
 |
Solo il flauto era compatibile con l’estetica (facciale) femminile del tempo…
 |
 |
 |
In conclusione, era la variabile interveniente (C) ovvero l'etichetta dell'epoca che influenzava sia il (presunto) talento che l'esecuzione musicale. Non era la musica di Beethoven in sé, ma le convenzioni sociali dell'epoca che impedivano alle donne di suonare come richiedeva la moda del momento.
Tuttavia, questa riflessione non riguarda solo il passato. Ma, un po’, vale anche per oggi. Se guardiamo l’attività artistica contemporanea, ci accorgeremo che in certi generi musicali gli uomini sono stranamente sovrarappresentati. Infatti, ci sono relativamente poche donne musiciste (tolte le “semplici” cantanti) nel rock, nel folk, nel jazz, nel trap ecc. Gli uomini sono in misura maggiore. Come mai?
La risposta richiederebbe un altro post…
La cosa “strana” è che la musica classica (genere musicale considerato vecchio, conservatore, del passato) offre alle donne più chance per lavorare ed (eventualmente) emergere che i generi sopra citati, considerati moderni, innovativi, trasgressivi.
È solo un paradosso?
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
DeNora, T. (1995) ‘Gendering the piano: repertory, technology and bodily discipline in Beethoven’s Vienna’. Paper presented to the Center for Research into Innovation, Culture and Technology Workshop, Brunel University, London.
DeNora, T. (2002) ‘Music into action: performing gender on the Viennese concert stage, 1790–1810’, Poetics, 30(2): 19–33.
Le teorie del complotto, quinta parte – Complottismo, positivismo, disincanto
È un caso che si giunga oggi a una demonizzazione – costruita a suon di meme così come di dibattito colto – della stessa capacità di esprimere un pensiero autonomo, senza delegare agli esperti di turno? Oppure questa demonizzazione ha una qualche attinenza, e coerenza, con processi storici ben più lunghi, che attengono alla storia stessa del capitalismo?
Da qui parte la quinta e ultima puntata del nostro viaggio, per arrivare a riflettere sulle strettoie in cui noi stessi rischiamo di ingabbiare la nostra capacità di pensiero critico quando la costringiamo nel solo solco del razionalismo scientifico. E, da qui, proviamo ad esplorare qualche nesso con il tema del disincanto del mondo, per come ne ha scritto S. Consigliere (in “Favole del reincanto”, DeriveApprodi 2020, da cui sono tratte le brevi citazioni seguenti). Quel disincanto che “ci fa preferire un uragano scientifico a un rifugio magico”, una frase che ogni volta mi fa venire in mente istintivamente la famosa scienziata (e senatrice a vita) che attacca duramente l’agricoltura biodinamica salvando però la scientificissima agroindustria a base di monoculture, pesticidi e manipolazioni genetiche. Quel disincanto che ci ha resi, come Occidentali, “i terminatori di un numero altissimo di mondi umani, di modi della conoscenza e forme della presenza”.
Eppure, segni di una nuova consapevolezza affiorano nelle battaglie contro l’estrattivismo, dai Salar dell’America Latina devastati dall’estrazione dei minerali per la transizione green, ai nostri Appennini, alla Sardegna intera, che resistono contro l’assalto delle speculazioni sull’eolico. Il nostro viaggio si chiude così proprio con un pensiero, che vuole essere anche una dedica, accorato e solidale con queste battaglie. Che se certo sanno parlare (giustamente) il linguaggio esperto/scientifico dei danni “quantificabili” apportati dai progetti estrattivi, dall’altra riescono a dare voce anche a dimensioni non quantificabili e però non meno cruciali, incarnando la difesa di territori che, più ancora che marginali e sacrificabili, vengono colpiti forse proprio perché rappresentano gli ultimi scogli da cui è possibile immaginare una vita non del tutto colonizzata dai tristi, disincantati miti della modernità egemone.
Chissà cosa si prova a liberare
La fiducia nelle proprie tentazioni
Allontanare gli intrusi dalle nostre emozioni
Allontanarli in tempo e prima di trovarsi solo
con la paura di non tornare al lavoro
F. de André, La bomba in testa, 1973
Quest’ultimo punto – l’enfasi sugli aspetti quantificabili che mette in ombra tutto il resto – a mio avviso è cruciale. E si allaccia all’ultima questione dirimente: il complottismo è, in fin dei conti, qualcosa da rivendicare (come fanno gli autori del Manifeste) o da problematizzare? Ognuno darà la sua risposta.
Personalmente, posti tutti i distinguo e le cautele di cui sopra – chi definisce cosa sia complottismo e cosa no, l’uso del complottismo come arma politica, il classismo, le bugie delle élite come terreno di coltura, etc. – tendo a pensare che l’anticomplottismo sia, a conti fatti, più nefasto del complottismo. Perché l’anticomplottismo si traduce in una difesa dell’indifendibile, mentre il complottismo porta in sé una salutare sfiducia e diffidenza verso le narrazioni del potere. E rappresenta il rifiuto di abdicare al tentativo di capire e darsi una ragione.
Anche perché, in fondo, i limiti del complottismo solo in parte sono responsabilità dei “complottisti” stessi. Non dovremmo scordarci che derivano, in buona misura, dal fatto che li abbiamo lasciati da soli a misurarsi con questioni di enorme complessità e rilevanza. Mentre chi avrebbe strumenti ed expertise – e responsabilità… – per scandagliare questi temi troppo spesso preferisce utilizzare quelle risorse per indagare campi meno controversi. Dove non si rischia di passare per complottisti e anzi è più semplice accordarsi alle sensibilità in voga nel clima di opinione del momento. Alimentando, però, la sensazione di autoreferenzialità e irrilevanza del sapere esperto e quindi la delegittimazione di cui poi ci si lamenta.
Questo non significa, però, non riconoscere – e anche qui l’autore di questo libro si muove in modo molto intelligente – le criticità e i problemi che il “complottismo”, come particolare modo di incanalare una potenziale opposizione al potere, pone, e che possono fargli mancare il bersaglio, o persino sviare e curvare il dissenso verso posizioni in fondo comode al potere. Che possono portare a non prendere consapevolezza del rapporto tra mezzi e fini, come testimoniato dall’abuso di tecnologia. A sopravvalutare personaggi che diventano incarnazioni di ogni male e d’altra parte a non vedere dove invece ci sono i veri nemici. Per questo è importante l’operazione che compie M. Amiech in questo libro, cioè superare narrazioni incentrate sulla drammatizzazione di casi o personaggi interpretati nella loro singolarità/straordinarietà per leggere e collocare invece i fatti contemporanei in continuità con processi storici più lunghi. Perché è solo lavorando in questa direzione che possiamo cercare di colmare quel vuoto e produrre interpretazioni teoriche capaci di orientare l’azione collettiva lungo direzioni credibili.
Particolarmente convincente, da questo punto di vista, è la riflessione, negli ultimi capitoli, sulla digitalizzazione come progetto industriale che va collocato in piena continuità con una storia del capitalismo che può e deve essere raccontata anche – sulla scorta di autori come Luxembourg, Illich, Lasch – come una storia di progressiva divisione e specializzazione del lavoro, crescente delega agli esperti e quindi crescente perdita di fiducia nelle proprie competenze: competenze nel costruirsi gli strumenti di lavoro, nel costruire una casa, nella manutenzione degli oggetti, fino al prepararsi il cibo e al prendersi cura della propria salute. Come una storia di progressiva perdita di autonomia e, di converso, di crescita della dipendenza degli individui dal mercato e dagli esperti per rispondere a ogni bisogno della vita. Ma se pensiamo al nostro punto di partenza possiamo vedere come quella spirale di sfiducia/ delega/dipendenza arrivi a coinvolgere, oggi, persino il bisogno di pensare: meglio evitare di farlo, ci sono gli esperti a cui delegare. In fondo, è proprio questo che si teorizza, quando l’idea che sia possibile pensare con la propria testa diventa hybris, e si arriva, come abbiamo visto, a sostenere la necessità di rinunciare a esercitare le proprie facoltà critiche – diventate ingannevoli e pericolose – per affidarci, proprio in nome della divisione del lavoro (scientifico e cognitivo), agli esperti semplicemente perché sono esperti, a scatola chiusa. E più non dimandare.
Ma forse la perdita di autonomia si spinge ancora più in là del pensare: arrivando a coinvolgere la sfera del sentire, la fiducia nelle proprie percezioni, l’ancoramento del soggetto alla realtà. Affascinanti, a questo proposito, le riflessioni del Manifeste (p. 22-25) a proposito dell’adozione di politiche, durante il Covid-19, che hanno costretto le persone a sospendere le loro attività e a chiudersi nell’isolamento, ma che le hanno anche precipitate in un regno dell’assurdo e del nonsense quotidiano con le mille regole, restrizioni e raccomandazioni che si contraddicevano tra loro giorno dopo giorno, evidenziando in questo qualcosa di più di mera casualità/ disordine legati alla circostanza, il cui effetto è farci perdere il filo di ogni certezza, farci dubitare della nostra presa sulla realtà, delle nostre percezioni elementari.[1] La stessa direzione cui ha condotto il chiederci di adottare uno sguardo statistico per guidare i nostri comportamenti (Ivi, p. 241-246). Il che è un nonsense in sé, visto che la statistica si basa necessariamente sulla distruzione della soggettività per costruire aggregati fittizi che hanno finalità di gestione e governo, e da quel livello non è dato tornare indietro, alla soggettività: che, all’opposto, è sempre incontro sensoriale del particolare col particolare, del soggettivo con il soggettivo, cioè esattamente quello che la statistica deve depurare per poter essere rappresentativa e generalizzabile. Solo individui deprivati di soggettività, intercambiabili, possono essere guidati dalla statistica. Ma in fondo, quando ci è stato chiesto di diventare insensibili di fronte agli anziani lasciati a morire da soli, senza congedo dai propri cari, e in alcuni momenti/Paesi senza nemmeno i riti dell’inumazione, mentre ci si estorceva un sentimento di compassione verso le cifre dei decessi riportate nei bollettini quotidiani, proprio questo ci è stato chiesto di fare: lasciare che altro si intrudesse tra noi e le nostre percezioni, fino ad adottare, al loro posto, uno sguardo statistico.
Un tema, questo, che si collega con un’ultima immagine particolarmente stimolante evocata da M. Amiech, che ci riporta ai limiti del complottismo: quest’ultimo visto come feticismo dei fatti e delle cifre portato all’estremo, come “positivismo impazzito”. Una critica, cioè, che si perde nello sparare disperato ed estenuante di dati e documenti da fonti sempre più difficilmente verificabili che, in fondo, deriva dal nostro stesso – “nostro” come movimenti, come sinistra antagonista nelle sue diverse anime, come studiosi più o meno militanti e prima ancora, semplicemente, come persone – aver idolatrato il razionalismo tanto da non saper vedere i pericoli derivanti dal porre la scienza al centro della politica. Ancora di più, tanto da non renderci conto della misura in cui abbiamo lasciato che la nostra capacità di critica venisse fagocitata dalle strettoie della degenerazione positivista dell’Illuminismo già individuata da Horkheimer e Adorno nella Dialettica dell’illuminismo (1966), giustamente ripresa dall’autore.
Dovremmo allora imparare a motivare le nostre opposizioni – agli OGM/TEA, al nucleare, all’estrattivismo, alla digitalizzazione di tutto, all’ibridazione uomo/macchina… – uscendo dalla logica dei dati, e ribadendo che anche qualora non ci fossero evidenze scientifiche di danni e nocività accertate o accertabili per la salute o l’ambiente, quelle innovazioni non le vogliamo ugualmente. E non le vogliamo perché rifiutiamo quel sistema economico che le rende necessarie allo stesso modo in cui rifiutiamo i valori e la visione del mondo che quel sistema economico innervano e legittimano. E che ce lo fanno apparire, come ci spiega Stefania Consigliere nelle Favole del reincanto, come l’unico possibile e ancor prima desiderabile, in una dinamica totalizzante, di sbarramento persino delle porte dell’immaginario, che è necessaria alla sua stessa esistenza.
Si tratta di riconoscere come la reductio ad unum da una pluralità o ecologia dei regimi conoscitivi esistenti ed esistiti nel mondo alla monocultura della scienza occidentale faccia parte di quella stessa dinamica totalizzante che ha fatto dei moderni i «terminatori di un numero altissimo di mondi umani, di modi della conoscenza e forme della presenza» (Ivi, p. 28); tanto da darci l’illusione che solo il nostro modo di essere al mondo è il punto di arrivo universale, a cui gli altri non sono ancora pervenuti, e a cui non è quindi dato, neppure a noi, immaginare alternative. È la stessa reductio ad unum che ha ridotto la pluralità dei regimi ontologici al naturalismo, dei regimi economici al plus-valore, dei regimi terapeutici alla medicina di stato (Ivi, p. 23).
Eppure, questa pretesa superiorità della modernità occidentale e della forma di conoscenza ad essa propria è esattamente ciò che ci ha portati al limite del collasso. Di fronte alla distruzione del vivente e al dominio dei pochissimi sulle moltitudini resi entrambi possibili in una portata inedita nella storia umana proprio dalla scienza e dalla tecnologia, ma di fronte anche ai vicoli ciechi in cui si è lasciata ingabbiare la nostra capacità di pensiero e di critica rendendoci tanto consapevoli quanto impotenti, quello che dovremmo problematizzare è il disincanto del mondo. Il disincanto indagato, in un passaggio bellissimo del libro, come precipitato etimologico in cui il silenziamento del mondo non umano e la sua riduzione a cieca meccanica si incontrano e si fondono con quelle passioni tristi – avidità, egoismo, sopraffazione, il leggere del mondo solo la grettezza – che devono esautorare la natura umana affinché l’organizzazione capitalista possa continuare la sua corsa (Ivi, p. 46-47).
Si tratta, dunque, di problematizzare quell’inganno che ci porta a preferire «un uragano scientifico a un rifugio magico» (Ivi, 15-16), di riaccogliere l’irrazionale e il sacro.[2] Riammettere anche le «presenze non umane», che in culture differenti dalla nostra rappresentano presenze con cui negoziare, limiti che demarcano orizzonti di non appropriabilità (Ivi, p. 28-29). Riconoscere, nella visione per cui fuori dalla socialità umana non ci sono senso o intenzionalità possibili ma solo cieco movimento meccanico, precisamente ciò che fa di noi esseri speciali autorizzati a qualunque forma di violenza sul non umano: è il disincanto che «rende accettabili le spoliazioni che incrementano i godimenti fungibili» (Ivi, 38), spazzando via ogni limite alla piena appropriabilità del reale.
Si tratta, anche, di considerare con distacco, e per fare questo di prendere atto delle vicende storiche e politiche, più che scientifiche, che hanno portato al suo affermarsi, la visione molecolare della vita basata su una biologia meccanicistica, combinazione in fondo ottimale – come ricostruiscono gli autori del Manifeste (p. 247-257) – tra visione tecnocratica della manipolazione tecnologica della vita e controllo sociale finalizzato all’estirpazione di quei “vizi” che rischiavano di frenare l’espansione capitalistica; terreno di incontro tra ingegneria genetica e sociale.
Se, come ci ricorda l’autore riprendendo Rosa Luxembourg, il capitale ha incessantemente bisogno di un ambiente non capitalistico per proseguire la sua necessaria espansione, dovendo colonizzare nuovi spazi geografici e sociali, mercificare ciò che merce non era, imporre la logica mercantile dove la produzione di beni e servizi avveniva fuori dal mercato, è utile anche ricordare, con le parole non parafrasabili di Stefania, che
Lo sbarramento dell’immaginario è indispensabile alla dinamica della totalizzazione. Le frontiere da superare e le terre da recintare non sono solo quelle geografiche: partite altrettanto rilevanti si giocano intorno a quelle psichiche, simboliche, oniriche e narrative. Nell’assoggettamento integrale niente deve arrivare, da fuori, a spezzare la continuità tra individui e mercato […]. Del mercato, infatti, sentiamo ogni sussulto, i suoi fremiti riverberano in noi: desideriamo ciò che desidera, temiamo ciò che teme. Per contro, alberi, lupi, fonti, fantasmi, mulini a vento, stelle, dèi e demoni hanno smesso di parlare. Nei sogni e nell’ebbrezza non c’è conoscenza ma solo sragione. Nel destino del mondo non ne va più di noi, nel destino nostro non ne va del mondo. È il disincanto. (Ivi., p. 33)
Forse è per questo che nelle battaglie contemporanee contro l’estrattivismo – dai Salars dell’America Latina devastati dalle estrazioni di minerali e terre rare alle periferie europee che iniziano a fare i conti con lo stesso assalto, fino, in Italia, alle proteste che nelle campagne del meridione, lungo tutto l’Appennino e in Sardegna si oppongono alle speculazioni sulle rinnovabili – mi sembra di cogliere voci che si assomigliano tanto da potersi vicendevolmente riconoscere. Sensibilità che giustamente denunciano i danni quantificabili e reclamano ricerca indipendente che possa metterli in luce, ma che imparano a parlare anche altri linguaggi. Linguaggi con cui cercare di dare parole ed espressione all’identità, alla storia, alla dimensione spirituale, ai simboli in cui ci si riconosce e in cui si riflette la propria appartenenza; alla scelta di un mo(n)do di vita nei suoi aspetti non solo materiali; alla difesa del paesaggio, e non solo per farne un prodotto da immettere nel mercato del turismo. Linguaggi capaci di riconoscere il senso di un attaccamento non quantificabile a una montagna, a un fiume, a una fonte; o al muro a secco, al complesso nuragico, alla Domus de Janas che rischiano di venire coperti dal cemento della piattaforma su cui verrà installata la prossima megapala.
Del resto, è vero che il nuovo assalto green del capitalismo ricalca e approfondisce diseguaglianze geografiche consolidate, svelando il suo volto più famelico nei territori marginalizzati, impoveriti, nelle green sacrifice zones (zone di sacrificio verdi, cfr. Zografos e Robbins 2020). Dove il ricatto della disoccupazione e della mancanza di futuro, unito alla mancanza di voce e rappresentanza, rende plausibile (e spesso, ma per fortuna non sempre, veritiera) l’ipotesi che si possano incontrare meno resistenze.
Tuttavia, se proviamo a rovesciare la prospettiva, vediamo altro. Perché non sempre, e comunque non solo, si tratta di luoghi marginalizzati e impoveriti. Anzi, a volte quella della marginalità e della mancanza di futuro diventa una retorica cavalcata da governi e investitori perché funzionale alla logica del “sacrificio”. Quegli stessi luoghi, prima che marginali – o meglio, proprio perché marginali nella prospettiva della modernità egemone – sono anche gli ultimi avamposti di biodiversità, ma soprattutto sono gli ultimi luoghi dove la modernità fa ancora i conti con qualcosa di pre-esistente e duro a morire; dove è ancora possibile dialogare con quelle parti dell’umano che non si lasciano ridurre al ciclo di produzione e consumo; e dove più attenuato arriva l’eco delle sirene dell’attivismo urbano più spettacolarizzato. Gli ultimi scogli da cui sarebbe forse possibile immaginare una vita diversa, al riparo dall’inferno tardocapitalista che ci avvolge, e che forse proprio qui, non potendo tollerare alternative che possano anche solo prefigurare resistenze al suo dover tutto ingoiare, mostra il suo volto più feroce. Ma proprio qui è anche dove incontra e suscita resistenze che ancora accendono una speranza.
NOTE
[1] Ne hanno trattato Stefania Consigliere e Cristina Zavaroni, riprendendo in particolare Micheal Taussig (1986): La cognizione del terrore. Ritrovarci tra noi, ritrovare la fiducia che l’Emergenza pandemica ha distrutto, 22 settembre 2021, <www.wumingfoundation.com/giap>.
[2] Su questo, decisivo è il rifiuto di una necessaria, automatica associazione tra incanto/irrazionale e fascismo. Su questo rimando al testo di S. Consigliere, in cui l’autrice chiarisce in modo assai convincente come l’incanto possa essere, ma non sia necessariamente, strumento di dominio; e come, d’altra parte, la modernità non ha certo cessato di farne uso, a sua volta in modo malevolo (Ivi, p. 37 e, in particolare, p. 62-72).
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Anonimo (2022), Manifeste conspirationniste, Parigi, Seuil.
Attwell K., Smith D.T. (2017), Parenting as politics: social identity theory and vaccine hesitant communities, “International Journal of Health Governance”, 22(3): 183-98.
Bazzoli, N., Lello, E. (2022), The neo-populist surge in Italy between territorial and traditional cleavages, “Rural Sociology”, 87(1): 662-691.
Bordignon, F. (2023), Alternative science, alternative experts, alternative politics. The roots of pseudoscientific beliefs in Western Europe, “Journal of Contemporary European Studies”, 31(4): 1469-1488.
Bucchi, M., Neresini, F. (2002), Biotech remains unloved by the more informed, “Nature”, 416: 261.
Chalmers J. (2017), The transformation of academic knowledges: understanding the relationship between decolonizing and indigenous research methodologies, “Socialist Studies”, 12(1): 97-116.
Coniglione, F., eds. (2010), Through the mirrors of science. New challenges for knowledge-based societies, Heusenstamm, Ontos Verlag.
Consigliere, S. (2020), Favole del reincanto: molteplicità, immaginario, rivoluzione, Roma, DeriveApprodi.
de Sousa Santos, B., Nunes, J. A., Meneses, M.P. (2022), Opening up the canon of knowledge and recognizing difference, “Participations”, 32(1): 51-91.
Dentico, N., Missoni, E. (2021), Geopolitica della salute: Covid-19, OMS e la sfida pandemica, Soveria Mannelli, Rubbettino.
Dotson, T. (2021). The divide: how fanatical certitude is destroying democracy, Cambridge, MIT Press.
Foucart, S., Horel, S., Laurens, S. (2020), Les gardiens de la raison: enquête sur la désinformation scientifique, Parigi, La Découverte.
Gigerenzer, G. (2015), Imparare a rischiare: come prendere decisioni giuste, Milano, Cortina.
Goldenberg, M. (2016), Public misunderstanding of science? Reframing the problem of vaccine hesitancy, “Perspectives on Science”, 24(5): 552-81.
Goldenberg, M.J. (2021), Vaccine hesitancy: public trust, expertise, and the war on science, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.
Grignolio, A. (2016), Chi ha paura dei vaccini?, Torino, Codice.
Harambam, J. (2021), Against modernist illusions: why we need more democratic and constructivist alternatives to debunking conspiracy theories, “Journal for Cultural Research”, 25(1): 104-122.
Harambam, J., Aupers, S. (2015), Contesting epistemic authority: conspiracy theories on the boundaries of science, “Public Understanding of Science”, 24(4): 466-480.
Jasanoff, S. (2021), Knowledge for a just climate, “Climatic Change”, 169(3): 1-8.
Kahneman, D. (2012), Pensieri lenti e veloci, Milano, Mondadori.
Keren, A. (2018), The public understanding of what? Laypersons’ epistemic needs, the division of cognitive labor, and the demarcation of science, “Philosophy of Science”, 85(5): 781-792.
Lello, E. (2020), Populismo anti-scientifico o nodi irrisolti della biomedicina? Prospettive a confronto intorno al movimento free vax, “Rassegna Italiana di Sociologia”, 3: 479-507.
Lello, E., Raffini, L. (2023), Science, pseudo-science, and populism in the context of post-truth. The deep roots of an emerging dimension of political conflict, “Rassegna Italiana di Sociologia”, 4: 705-732.
Lello, E., Saltelli, A. (2022), Lobbismo scientifico e dirottamento dello spazio pubblico, in E. Lello, N. Bertuzzi (eds.), Dissenso informato. Pandemia: il dibattito mancato e le alternative possibili, Roma, Castelvecchi, 187-203.
Lolli, A. (2023), Il complottismo non esiste o Miseria dell’anticomplottismo, in M.A. Polesana, E. Risi (eds.), (S)comunicazioni e pandemia. Ricategorizzazioni e contrapposizioni di un’emergenza infinita, Milano-Udine, Mimesis, 239-271.
Nunes, J. A., Louvison, M. (2020), Epistemologies of the South and decolonization of health: for an ecology of care in collective health, “Saude e Sociedade”, 29(3): e200563.
Osimani, B., Ilardo, M.L. (2022), “Nessuna correlazione”. Gli strumenti per la valutazione del nesso causale tra vaccinazione ed evento avverso, in E. Lello, N. Bertuzzi (eds.), Dissenso Informato. Pandemia: il dibattito mancato e le alternative possibili, Roma, Castelvecchi, 167-186.
Pielke, R.A.J. (2005), Scienza e politica, Roma-Bari, Laterza.
Quijano, A. (2005), Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina, in A colonialidade do saber: etnocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas, Buenos Aires, Clacso, 117-142.
Reich, J.A. (2014), Neoliberal mothering and vaccine refusal: imagined gated communities and the privilege of choice, in “Gender and Society”, 28(5): 679-704.
Sarewitz, D. (1996), Frontiers of illusion: science, technology, and the politics of progress, Philadelphia, Temple University Press.
Saurette, P., Gunster S. (2011), Ears wide shut: epistemological populism, argutainment and Canadian conservative talk radio, “Canadian Journal of Political Science”, 44(1): 195-218.
Schadee, H.M.A., Segatti, P., Vezzoni C. (2019), L’apocalisse della democrazia italiana: alle origini di due terremoti elettorali, Bologna, Il Mulino.
Smith, P.J., Chu, S.Y., Barker, L.E. (2004), Children who have received no vaccines: who are they and where do they live?, “Pediatrics”, 114(1): 187-95.
Steinberg, T. (2006), Acts of God: the unnatural history of natural disaster in America, Oxford, Oxford University Press.
Taussig, M.T. (1986), Shamanism, colonialism, and the wild man: a study in terror and healing, Chicago, University of Chicago Press.
Wei, F., Mullooly, J.P., Goodman, M., McCarty, M.C., Hanson, A.M., Crane, B., Nordin, J.D. (2009), Identification and characteristics of vaccine refusers, “BMC Pediatrics”, 9(18): 1-9.
Wu Ming 1 (2021), La Q di Qomplotto. QAnon e dintorni. Come le fantasie di complotto difendono il sistema, Roma, Alegre.
Ylä-Anttila, T. (2018), Populist knowledge: post-truth repertoires contesting epistemic authorities, “European Journal of Cultural and Political Sociology”, 5(4): 356-388.
Zagzebski, L.T. (2012), Epistemic authority: a theory of trust, authority, and autonomy in belief, Oxford, Oxford University Press.
Zografos, C., Robbins, P. (2020), Green sacrifice zones, or why a green new deal cannot ignore the cost shifts of just transitions, “One Earth”, 3(5): 543-546.
La dimensione morale delle scienze e delle tecnologie
In questi 18 mesi di attività, prima come blog e ora – finalmente – come rivista settimanale, abbiamo cercato – come ci eravamo ripromessi con il programma di lavoro - di presentare una visione più equilibrata delle scienze e delle tecnologie, riconoscendone la specificità ma anche facendo luce sulla loro natura di impresa umana, storicizzate e sociologizzate. Attraverso il riconoscimento del carattere sociale sia delle scienze che delle tecnologie abbiamo proposto un rapporto più bilanciato e un atteggiamento più tollerante verso le opinioni e ipotesi diverse, a beneficio sia della società che delle scienze.
Come scrivono lucidamente Collins e Pinch (1993), la scienza – e lo stesso vale per la tecnologia - è un’attività controversa: da una parte ci fornisce i mezzi per curare gli ammalati; dall’altra produce l’infido veleno causato dagli incidenti nucleari; da una parte ci offre migliori condizioni di vita e dall’altra il rischio di trovare la morte a causa degli effetti collaterali di un farmaco.
In questo tragitto, come ricorda Teo Donolato, abbiamo affrontato ― e continueremo ad affrontare ― una serie di tematiche scientifiche evidenziando l’illusione del piedestallo epistemico, della deificazione laica delle scienze e della ricerca di verità assolute; abbiamo mostrato controversie, errori e non sequitur nello sviluppo delle scienze; e, abbiamo provato a ripensare le concezioni limitanti e banalizzanti, sia delle scienze che delle tecnologie, dando spazio a pluralità di voci.
Parallelamente, sottolinea Paolo Bottazzini, abbiamo sottoposto ad analisi critica la narrazione delle più recenti tecnologie e del soluzionismo tecnologico, svelando alcune false assunzioni e la sottrazione dello sviluppo tecnologico alle decisioni collettive e responsabili, in nome del progresso, sviluppando una visione – anche in questo caso – non banalizzante e nello stesso tempo non luddista.
Quello che promettiamo è di investigare e anche la dimensione morale e, quindi, politica, della pratica scientifica e dello sviluppo tecnologico.
Quando parliamo di pluralità di voci, infatti, non lo facciamo per allinearci a una moda di democratizzazione delle scienze ma perché ogni scoperta scientifica - e ogni relativa applicazione – si basa su dei presupposti nati da scelte morali e porta con sé degli effetti morali su individui e su collettività. Individui e collettività che hanno istanze di benessere e di sopravvivenza, istanze che la ricerca scientifica e – soprattutto – le sue applicazioni devono sempre prendere in considerazione.
Facciamo un esempio: il Progetto Life Ursus di reinserimento degli orsi nell’habitat del Trentino, progetto il cui carattere scientifico – tra studio di fattibilità e organizzazione preliminare - è indiscutibile, risponde in maniera primaria all’istanza morale di preservare la presenza della specie nel territorio, portando un certo numero di esemplari dalle montagne slovene. Il rilascio di 10 “nuovi orsi” è avvenuto tra il 1999 e il 2002 con l’obiettivo di arrivare a 40 – 60 individui nel giro di alcune decine d’anni. Il progetto ha funzionato e nel 2024 la popolazione di orsi nel 2024 è stimata in un centinaio di esemplari. Ma, c’è un “ma” importante, oltre a numerosi casi di danni a strutture antropiche e numerosi incontri con gli umani, ci sono state delle vittime umane: il giovane Andrea Papi ucciso da un ‘orsa nell’aprile del 2023 e un turista francese ferito nel 2024 (e almeno 6 orsi abbattuti per ragioni di sicurezza della popolazione). Oggi, in Trentino, una elevata percentuale della popolazione sembra essere favorevole allo spostamento degli orsi altrove.
Lo studio scientifico di fattibilità comprendeva, oltre a più di 60 parametri ambientali, delle valutazioni socioeconomiche, tra cui:
- l’analisi del favore degli abitanti verso la reintroduzione degli orsi nel territorio (che è risultata statisticamente superiore al 70%, su un campione di 1.500 abitanti, il 1,25 % della popolazione del Trentino, intervistati telefonicamente[1]);
- la valutazione economica (effettuata da una Società di consulenza di Roma che ha suggerito una serie di misure di protezione e di risarcimento verso le attività economiche potenzialmente vulnerabili);
È stata poi organizzato una Emergency team, «squadra di persone appositamente addestrate potrà applicare misure dissuasive per gli orsi, procedere alla loro eventuale cattura e trasferimento ed infine sarà anche pronta ad abbattere individui che mostreranno comportamenti devianti».
In questo caso il lavoro di Controversie è di evidenziare che, probabilmente, le scienze – in nome del principio morale di «riportare l’orso su queste montagne» – hanno trascurato una serie di istanze morali non irrilevanti: quelle degli allevatori e della popolazione che abita densamente le montagne interessate, ei turisti, delle forze politiche di opposizione (che oggi sono al potere in Trentino e agiscono contro la presenza degli orsi), degli scienziati ecologisti che non riconoscono nella specie un soggetto morale rilevante e, infine, degli orsi, che sono stati tolti dal loro habitat in Slovenia e trapiantati in un territorio con una densità antropica drammaticamente superiore.
Come direbbe Bruno Latour, tutti questi attanti sono inseriti in una rete, e per ciascuno di essi occorre pensare una traduzione (o traslazione) dei loro interessi/bisogni in quelli degli altri. Pena la prevaricazione di alcuni su altri e l’entropia che si introduce nella rete e nella catena di associazioni/relazioni.
Allo stesso modo, quando si parla di sviluppo e di progresso tecnologico è necessario chiedersi “in nome di cosa e di chi” si realizzano gli sviluppi tecnologici? Chi godrà di questo progresso e come? Se c’è un prezzo da pagare per il progresso, chi lo pagherà?
La dimensione morale della tecnologia è sotto i nostri occhi ogni giorno: un bot intelligente che risponde a un cliente di un’azienda del gas allevia il lavoro degli operatori telefonici – che possono, quindi, svolgere lavori più qualità e competenza – oppure li sostituisce, creando disoccupazione? Una automobile a guida automatica permette al proprietario di fare meno fatica ma come decide in caso di emergenza?
Poiché il desiderio di una scienza intonsa, perfetta, che proponga verità assolute e di tecnologie che portino sempre e solo benessere per tutti, è legittimo ma sta nella sfera dell’impossibile, ecco che Controversie si impegna anche a lavorare sul versante della dimensione morale, evitando posizioni di negazione tecnoscientifica ma – al contrario – cercando di tracciare e di suggerire dei percorsi di ricerca e di sviluppo che tengano conto delle lateralità, delle istanze morali di benessere, se non di sopravvivenza, degli attori meno rappresentati e meno capaci di far sentire la propria voce.
NOTA
[1] Sondaggio affidato alla DOXA di Milano. Più di 1500 abitanti dell’area sono stati intervistati telefonicamente, per analizzare la loro attitudine verso l’orso, la percezione verso questa specie e la possibile reazione di fronte ai problemi che l’orso porrà. I risultati sono stati sorprendenti: più del 70% degli abitanti si sono dimostrati a favore del rilascio di orsi nell’area. Questa percentuale sale fino all’80% di fronte all’assicurazione che verranno prese misure di prevenzione dei danni e che se un orso si dimostrerà potenzialmente pericoloso per l’uomo verrà immediatamente allontanato o abbattuto. (Le probabilità di successo del Progetto di immissione di E. Duprè, P. Genovesi, L. Pedrotti Tratto da: "Adamello Brenta Parco" anno 1998 n. 2 pag. 2)