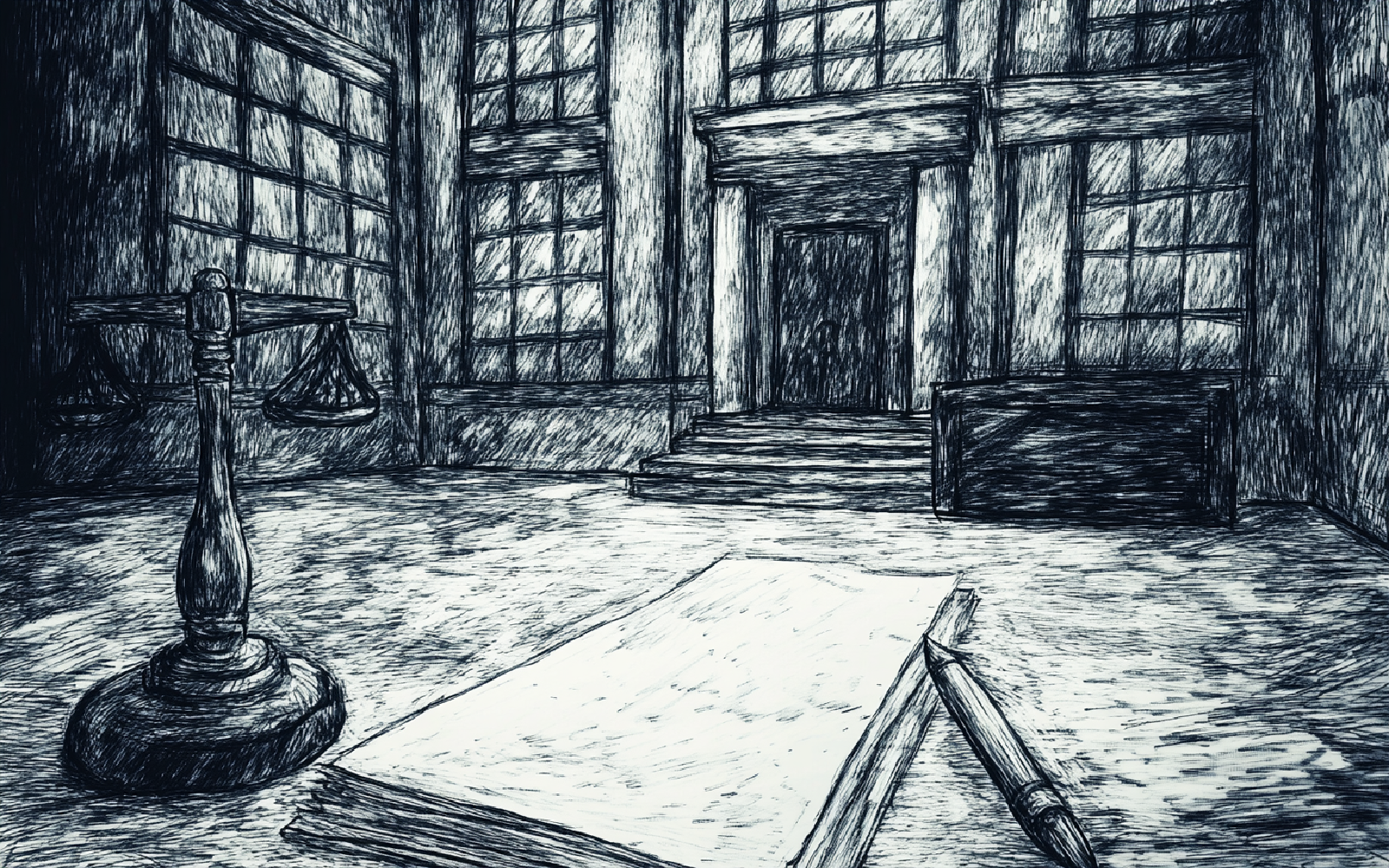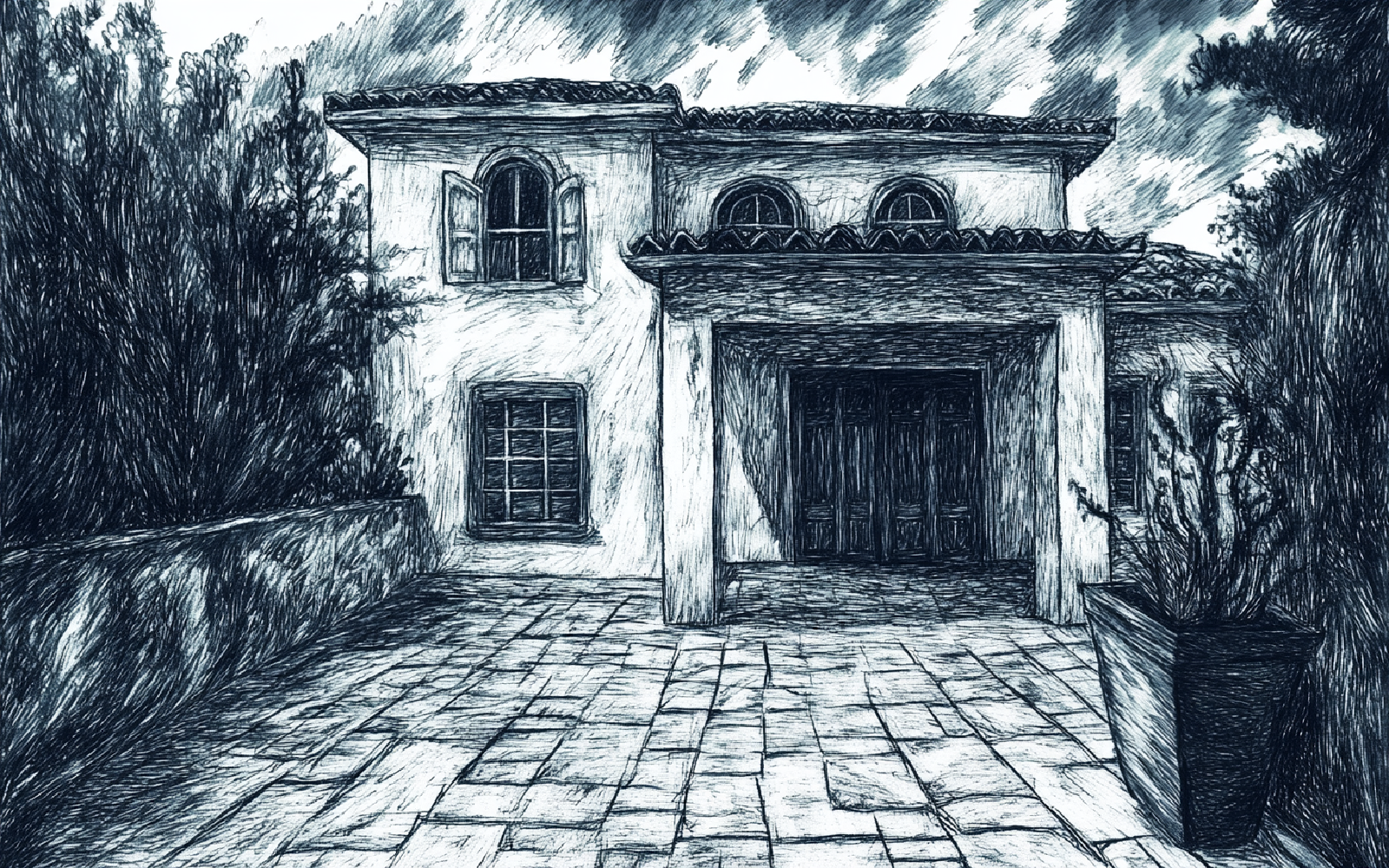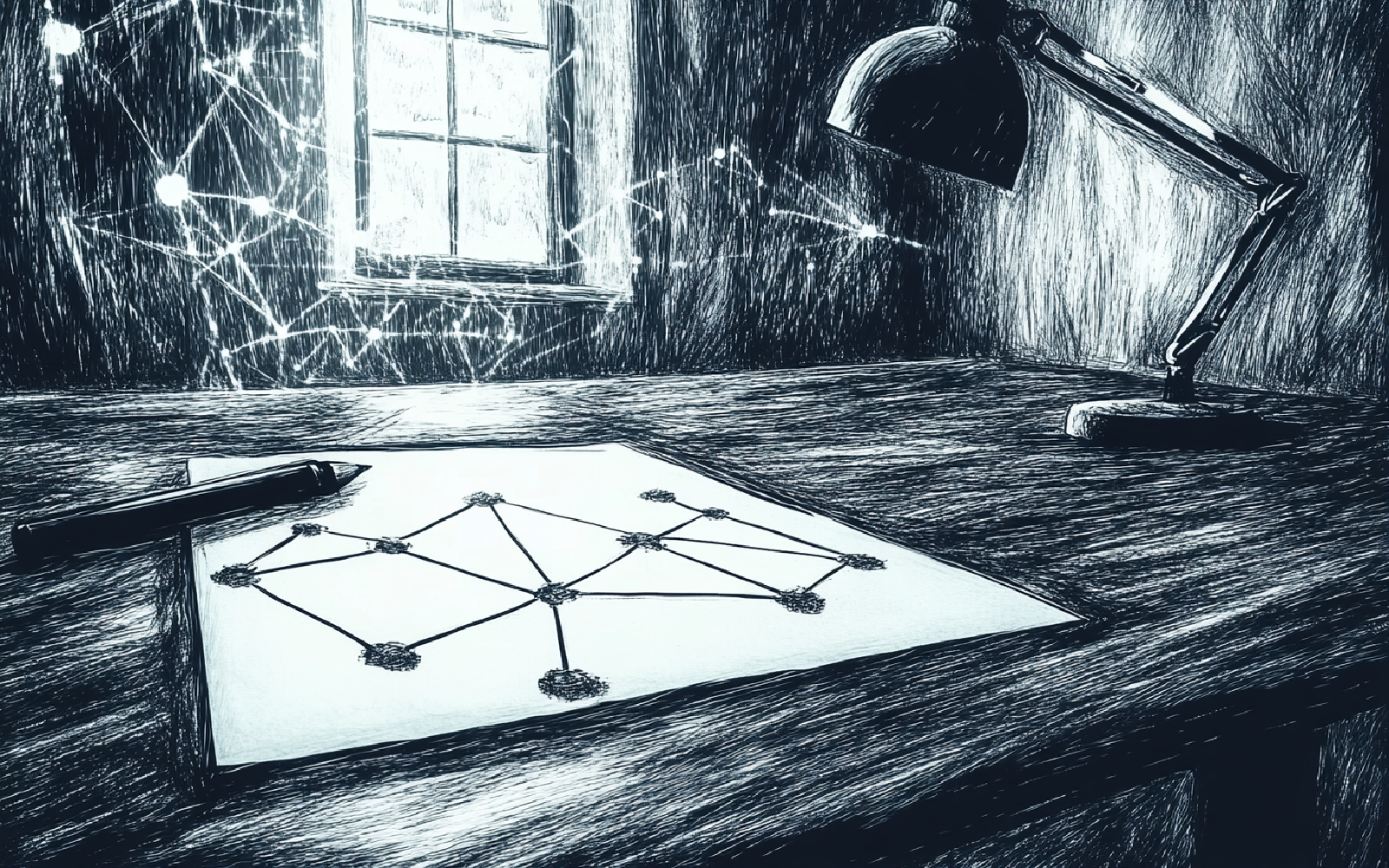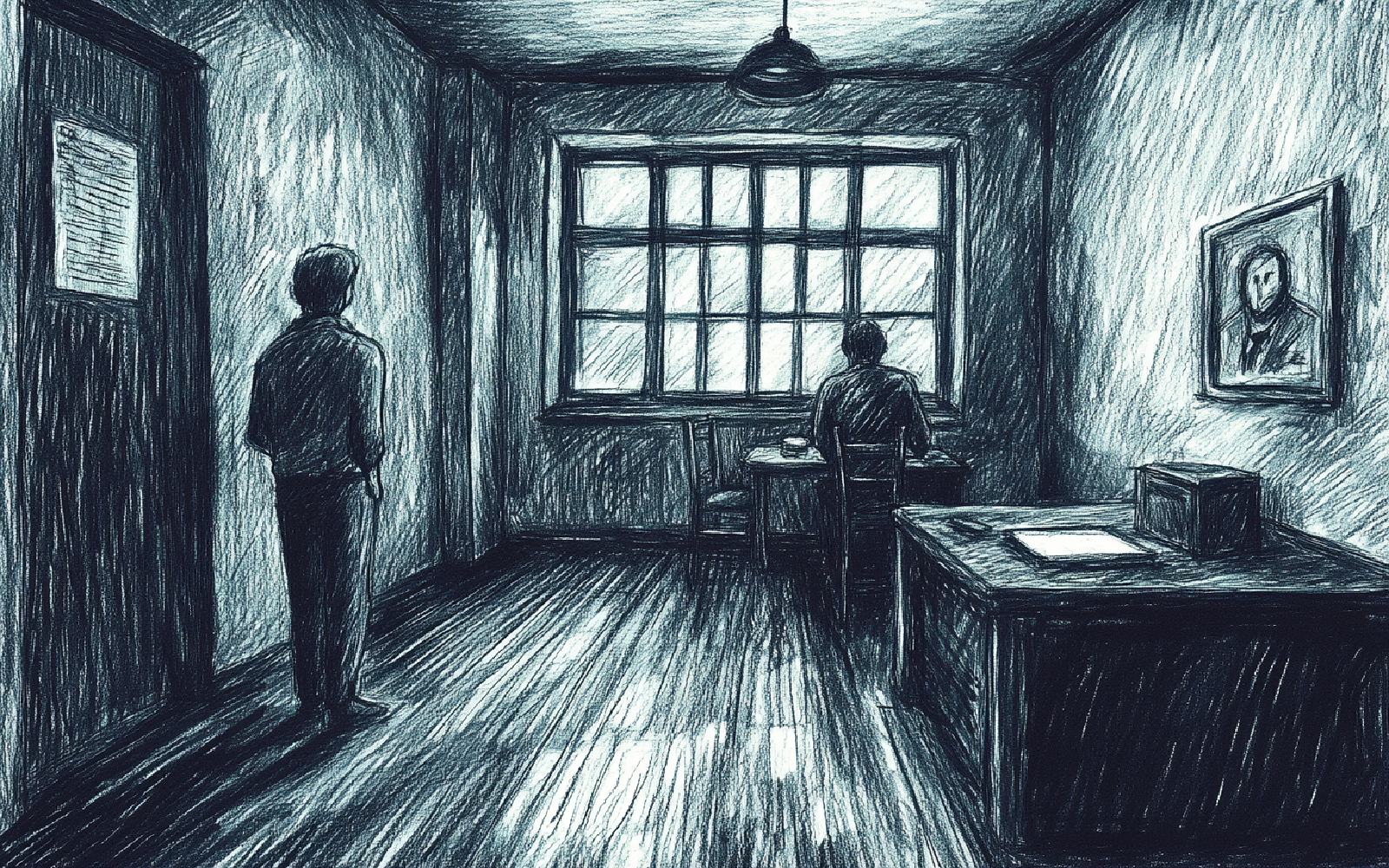Il tempo schermo e i suoi impatti educativi sull’infanzia
Le tecnologie digitali non sono né buone né cattive, ma nemmeno neutre. Il concetto di "tempo schermo”, benché sia poco diffuso in Italia, gode di un ampio uso in ambito internazionale ed è particolarmente adatto per comprendere gli effetti di un’esposizione precoce e prolungata su bambine/i. Il tempo schermo è l’insieme delle ore trascorse davanti a uno schermo, indipendentemente dal tipo di contenuto o dal tipo di dispositivo (connesso o meno a internet) sia esso smartphone, televisione, tablet o qualsiasi altro schermo. Il concetto permette quindi di non guardare solo alle tecnologie digitali “recenti” e includere la “vecchia” televisione, anche perché con l’arrivo delle smart Tv la distinzione è sempre più sfumata. Paradigmatico è oggi You Tube che è sia un canale televisivo, sia una app di smartphone, sia una piattaforma di internet, ed è seguitissimo da piccoli/e.
Oggi, la presenza di schermi in ogni casa è significativa: in una famiglia occidentale media (di quattro persone) ci sono dieci schermi; si tratta di diversi dispositivi, per lo più connessi a internet, che caratterizzano un vero e proprio “ambiente schermo" in cui i bambini crescono. Questa disponibilità di schermi – per lo più accesi e visti anche in modo indiretto – contribuisce a modellare l’ambiente, il ritmo di vita, gli stimoli e le stesse attività quotidiane, con impatti misurabili anche in termini di minore parole ricevute e prodotte e maggiori interruzioni di attenzione focalizzata.
IMPATTO DEL TEMPO SCHERMO SULLO SVILUPPO FISICO E MENTALE
L'aumento del tempo schermo riduce drasticamente altre temporalità essenziali nell’infanzia, come il tempo di sonno, di gioco libero, di interazione sociale; riduce il tempo trascorso all'aria aperta e il tempo della lettura. Gli studi in letteratura scientifica confermano che il tempo schermo ha un impatto sia diretto sia indiretto su questi tempi, i quali sono fondamentali per l’apprendimento e lo sviluppo delle capacità cognitive, sociali e sullo stesso sviluppo psicofisico, soprattutto nei primi cinque anni di vita, per i quali l’OMS consiglia il meno tempo schermo possibile, in particolare zero minuti nei primi due anni.[1]
È importante chiarire però che non è corretto affermare che il tempo schermo abbia sempre un impatto negativo sullo sviluppo psicofisico: fattori come il contesto familiare, il tipo di contenuti fruiti e le differenze individuali di bambini/e giocano un ruolo cruciale nel determinare l’entità dell’effetto. D’altro canto, il tempo schermo precoce (prima dei cinque anni) e prolungato (superiore alle due ore giornaliere dopo i cinque anni) è certamente un fattore di rischio, poiché aumenta le probabilità di riscontrare problemi di vario tipo. È anche opportuno precisare che i dati mostrano che gran parte del tempo schermo nei bambini da 0 a 8 anni è impiegato per la visione di brevi video (73%) o videogiochi (16%), e quindi, al netto di eccezioni, minoranze e contesti specifici, il tempo schermo non è un tempo dedicato a contenuti adeguati all’età, ad app effettivamente educative o dedicate a un uso creativo.
Le principali associazioni pediatriche a livello mondiale, basandosi su una vasta letteratura scientifica, sottolineano come il tempo schermo influenzi aspetti fondamentali dello sviluppo, quali la vista, l’alimentazione, il rischio di sovrappeso e, soprattutto, il sonno; nell’area cognitiva influisce negativamente su attenzione, linguaggio, memoria e quindi capacità scolastiche. Inoltre, sono stati riscontrati effetti relazionali come ansia, depressione, isolamento sociale, cyberbullismo, dipendenze che sollevano preoccupazioni per il benessere mentale a lungo termine. Benché nei prossimi anni possano divenire tra gli effetti più preoccupanti, sono ancora poco studiati gli effetti sulla intimità, affettività e sessualità dovuti a una esposizione precoce a video pornografici (l’età media si sta abbassando spaventosamente persino sotto i dieci anni), al punto che in Spagna si parla di Generación Porno.
Il mio interesse di ricerca si concentra sui rischi legati all’esposizione precoce e prolungata agli schermi in bambine/i, dalla nascita fino alla fine della scuola primaria, dove insegno. Sono anni in cui si apprendono le cose essenziali per la vita, ma anche anni vulnerabili: sono anni in cui si sviluppano le capacità cognitive alla base della carriera scolastica, nei primi quattro anni il linguaggio orale, fino a dieci la letto-scrittura.
La psicologia dell’età dello sviluppo ci spiega che l’attenzione e il linguaggio si possono sviluppare solo con una relazione umana; il tempo schermo non solo non sviluppa queste capacità ma spesso lo rallenta[2] Infatti in assenza del cosiddetto "co-viewing" – ovvero la visione congiunta dei contenuti e il dialogo costante con l’adulto su ciò che si sta vedendo e facendo – l’apprendimento tramite schermi risulta non solo limitato ma anche limitante poiché intacca i prerequisiti di apprendimento, rendendo l’attenzione più frammentata. Un’intera linea di esperimenti nota come il video deficit effect spiega proprio come l’apprendimento (non la comprensione) sia migliore con la presenza umana, mentre risulti molto arduo se non persino assente, quando è mediato dagli schermi. Il "co-viewing" è considerato una condizione essenziale per garantire che i bambini traggano un beneficio educativo reale da questi dispositivi, riducendo gli effetti negativi. Per fare in modo che si possa apprendere tramite gli schermi fino all’inizio della scuola primaria è caldamente consigliata la presenza e la mediazione adulta, non solo nella scelta dei contenuti ma proprio nell’attività di ascolto e interazione. Il che è in palese contraddizione con quanto fanno oggi gli adulti, che danno gli schermi proprio per essere separati (o non disturbati) dai bambini.
LE SETTE CARATTERISTICHE DEL TEMPO SCHERMO
Il tempo schermo si caratterizza per lo più per alcune caratteristiche che derivano dal suo far parte dei mezzi di comunicazione di massa con le relative evoluzioni digitali del XXI secolo. Benché si possano fare usi creativi e attivi del digitale, e la Media Education ne descriva una infinità, essi rimangono “potenzialità” auspicate, perché la realtà è meno edulcorata di come questa disciplina di norma ce la presenta; le salienze del tempo schermo possono essere sintetizzate in sette punti che ne indicano la tendenza:
- Sedentarietà. La caratteristica principale del tempo schermo è la sedentarietà. Il movimento di mani e piedi è essenziale nei primi anni di vita per lo sviluppo del cervello, mentre il tempo schermo smaterializza il corpo immobilizzandolo. La mancanza di attività fisica associata all’uso prolungato degli schermi può influenzare negativamente lo sviluppo fisico e cognitivo del bambino.
- Deprivazione Sensoriale. Il tempo schermo è limitato quasi esclusivamente alla visione, deprivando la stimolazione multisensoriale di cui il bambino ha bisogno (tatto, olfatto, gusto e anche l’ascolto della parola nella misura in cui i dialoghi sono spesso inutili). Recenti studi oftalmologici hanno inoltre osservato che l’uso precoce di piccoli schermi può portare a un aumento della miopia in bambini/e e dello strabismo con ulteriori effetti negativi persino sulla capacità di lettura e di equilibrio.
- Convergenza Digitale. La convergenza digitale, ovvero il fatto che un dispositivo sia contemporaneamente telefono, telegrafo, macchina fotografica, e la possibilità di utilizzare lo stesso contenuto (per es. un videogioco, una partita di calcio, ecc…) su diversi dispositivi (televisione, tablet, smartphone), comporta il precipitare di ogni esperienza nel tempo schermo, con una fruizione continua e spesso priva di interruzioni lunghe, pervasiva e difficilmente limitabile.
- Illimitatezza. Le piattaforme digitali sono progettate per offrire contenuti in maniera continua, senza una "fine" naturale, tramite algoritmi che rilevano e si adattano alle preferenze dell’utente, incentivando un uso prolungato dello schermo.
- Divertissment. La maggior parte delle app e dei contenuti rivolti ai bambini è pensata principalmente per il divertissment, termine francese che designa il distrarre, il divertire, l’intrattenere. Non hanno scopo principalmente educativo. Questo tipo di intrattenimento punta alla "distrazione" eterodiretta, cioè a una gestione dell’attenzione orientata a trattenere il bambino davanti allo schermo divertendolo, che è esattamente il contrario della salutare distrazione propria al fantasticare della rêverie.
- Spettacolarità e isolamento. Il tempo schermo è spesso una fruizione individuale, che comporta l'isolamento sociale perché ciascuno ha il suo schermo; limita le attività di gruppo e le interazioni faccia a faccia, limitando così lo sviluppo di abilità sociali cruciali.
- Cronofagia. Il tempo schermo distorce la percezione del tempo. Bambini e adolescenti spesso non riescono a controllare il tempo trascorso davanti agli schermi, con un impatto negativo sulla gestione del tempo. Questo effetto è stato definito filosoficamente "cronofagia", ovvero la capacità di “divorare” il tempo.
In aggiunta, studi recenti indicano che l’esposizione precoce e prolungata agli schermi è associata a una diminuzione delle capacità attentive richieste in ambito scolastico. L’attenzione stimolata dagli schermi è di tipo "bottom-up", cioè orientata alla cattura immediata dell’attenzione tramite stimoli visivi, allarmi o segnali di pericolo, piuttosto che alla concentrazione sostenuta. Questo tipo di attenzione, studiato dalla psicologia cognitiva, può essere associato alla progettazione di app e piattaforme che utilizzano meccanismi per incentivare l’uso prolungato, perseguendo finalità commerciali più che educative.
QUALCHE CONCLUSIONE
È importante essere consapevoli che più ci si avvicina alla nascita più gli studi concordano sulla negatività degli effetti, a prescindere dai contenuti. Il fenomeno della disgiunzione dell’attenzione è forse il più importante. L’attenzione è infatti un prerequisito della trasmissione culturale in ogni cultura ed è per questo che educatori ed educatrici di tutto il mondo hanno individuato l’attenzione come la fonte dei processi di apprendimento. Come vedremo nel prossimo numero, la relazione pedagogica si basa su processi attentivi, ma negli esseri umani l’attenzione si sviluppa principalmente per vie extracorticali ed è predittiva dello sviluppo del linguaggio umano e delle capacità simboliche. L’attenzione cioè si sviluppa anche a livello biologico grazie all’aggancio oculare con altri simili tramite la condivisione di intenzionalità e il fenomeno da tempo noto di attenzione congiunta.
NOTE
[1] Cfr. World Health Organization (Who) (2019), Guidelines on Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep for Children Under 5 Years of Age, Genève; cf. Grollo M., Zanor S., Lanza S., et al. (2022), Pediatri custodi digitali, la prima guida per i pediatri di famiglia sull’educazione digitale familiare dalla nascita, IAM Edizioni, Udine.
[2] Per una ampia bibliografia si veda: Desmurget M. (2020) Il cretino digitale. Difendiamo i nostri figli dai veri pericoli del web, Rizzoli, Milano. Mi sia permesso rimandare al mio saggio: in corso di pubblicazione: L’attenzione contesa, come il tempo schermo modifica l’infanzia, Armando, Roma.
Legge 13 maggio 1978, n. 180 – Testo integrale
Comunemente, la legge n. 180 viene chiamata “legge Basaglia”; in realtà il suo estensore fu lo psichiatra e politico democristiano Bruno Orsini e Franco Basaglia non ne fu particolarmente soddisfatto – anche se la difese come impianto teorico ed ideologico, come dichiarò in una intervista fatta da Maurizio Costanzo:
«Non è importante tanto il fatto che in futuro ci siano o meno manicomi e cliniche chiuse, è importante che noi adesso abbiamo provato che si può fare diversamente, ora sappiamo che c'è un altro modo di affrontare la questione; anche senza la costrizione.»
La legge n. 180 nacque con un iter frettoloso: il progetto iniziale – che recepiva le istanze e le proposte di Franco Basaglia, del movimento di Psichiatria Democratica e di un numero non indifferente di psichiatri – prevedeva che la precedente legge che regolava il trattamento “dei matti” (Legge 14 febbraio 1904, n. 36 - Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati) fosse parzialmente abrogata attraverso un referendum e sostituita nell’ambito della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.
Tuttavia, il referendum rappresentava un rischio, perché il tema “dei matti” poteva essere sentito in modo controverso nella società, e la legge sul Sistema Sanitario avrebbe potuto avere tempi più lunghi del previsto. Il governo Andreotti optò, allora, per lo stralcio degli articoli che riguardavano i principali temi correlati ai manicomi e ne fece la legge n. 180, abrogando in buona parte (fatta esclusione per i temi economici e fiscali) la legge del 1904.
La “180” è una legge breve, molto sintetica, densa di contenuti e difficile da mettere in opera, soprattutto negli anni ’70.
Controversie ha ritenuto – per evitare che il dibattito viaggi sull’onda dei soli commenti e opinioni – di riportarla qui integralmente, insieme all’articolo 64 della legge n. 833/1978, istituiva del Sistema Sanitario Nazionale.
Legge 13 maggio 1978, n. 180
Sommario
Art. 1 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori
Art. 2 Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale
Art. 4 Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio
Art. 7 Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica
Art. 8 Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici
Art. 9 Attribuzioni del personale medico degli ospedali psichiatrici
Art. 10 Modifiche al codice penale
" Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1978, n. 133.
Art. 1 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti o istituzioni pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.
Art. 2 Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale.
Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie mentali. Nei casi di cui al precedente comma la proposta di trattamento sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel precedente comma.
Art. 3 Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale.
Il provvedimento di cui all'articolo 2 con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 e dalla convalida di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno e al consolato competente, tramite il prefetto. Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico di cui all'articolo 6 è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso. Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare. Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo. La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Art. 4 Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Sulla richiesta di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Art. 5 Tutela giurisdizionale.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 3, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio. Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero. Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo aver assunto informazioni e raccolte le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.
Art. 6 Modalità relative agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presìdi psichiatrici extra ospedalieri. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i trattamenti sanitari per malattie mentali che comportino la necessità di degenza ospedaliera e che siano a carico dello Stato o di enti e istituzioni pubbliche sono effettuati, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici di cui ai successivi commi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento agli ambiti territoriali previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuano gli ospedali generali nei quali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura. I servizi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo - che sono ordinati secondo quanto è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, per i servizi speciali obbligatori negli ospedali generali e che non devono essere dotati di un numero di posti letto superiore a 15 - al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale sono organicamente e funzionalmente collegati, in forma dipartimentale con gli altri servizi e presìdi psichiatrici esistenti nel territorio.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le istituzioni private di ricovero e cura, in possesso dei requisiti prescritti, nelle quali possono essere attuati trattamenti sanitari obbligatori e volontari in regime di ricovero. In relazione alle esigenze assistenziali, le province possono stipulare con le istituzioni di cui al precedente comma convenzioni ai sensi del successivo articolo 7.
Art. 7 Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni amministrative concernenti la assistenza psichiatrica in condizioni di degenza ospedaliera, già esercitate dalle province, sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle regioni ordinarie e a statuto speciale. Resta ferma l'attuale competenza delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'assistenza ospedaliera disciplinata dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, numero 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, comprende i ricoveri ospedalieri per alterazioni psichiche. Restano ferme fino al 31 dicembre 1978 le disposizioni vigenti in ordine alla competenza della spesa. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le regioni esercitano anche nei confronti degli ospedali psichiatrici le funzioni che svolgono nei confronti degli altri ospedali. Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, e comunque non oltre il 1° gennaio 1979, le province continuano ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione degli ospedali psichiatrici e ogni altra funzione riguardante i servizi psichiatrici e di igiene mentale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano e coordinano l'organizzazione dei presìdi e dei servizi psichiatrici e di igiene mentale con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio e attuano il graduale superamento degli ospedali psichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. Tali iniziative non possono comportare maggiori oneri per i bilanci delle amministrazioni provinciali. E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni neurologiche o neuropsichiatriche. Agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle amministrazioni provinciali o da altri enti pubblici o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza si applicano i divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. Ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali generali, di cui all'articolo 6, è addetto personale degli ospedali psichiatrici e dei servizi e presidi psichiatrici pubblici extra ospedalieri. I rapporti tra le province, gli enti ospedalieri e le altre strutture di ricovero e cura sono regolati da apposite convenzioni, conformi ad uno schema tipo, da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità di intesa con le regioni e l'Unione delle province di Italia e sentite, per quanto riguarda i problemi del personale, le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Lo schema tipo di convenzione dovrà disciplinare tra l'altro il collegamento organico e funzionale di cui al quarto comma dell'articolo 6, i rapporti finanziari tra le province e gli istituti di ricovero e l'impiego, anche mediante comando, del personale di cui all'ottavo comma, del presente articolo. Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 in sede di rinnovo contrattuale saranno stabilite norme per la graduale omogeneizzazione tra il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del personale degli ospedali psichiatrici pubblici e dei presidi e servizi psichiatrici e di igiene mentale pubblici e il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico delle corrispondenti categorie del personale degli enti ospedalieri.
Art. 8 Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici.
Le norme di cui alla presente legge si applicano anche agli infermi ricoverati negli ospedali psichiatrici al momento dell'entrata in vigore della legge stessa. Il primario responsabile della divisione, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con singole relazioni motivate, comunica al sindaco dei rispettivi comuni di residenza, i nominativi dei degenti per i quali ritiene necessario il proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio presso la stessa struttura di ricovero, indicando la durata presumibile del trattamento stesso. Il primario responsabile della divisione è altresì tenuto agli adempimenti di cui al quinto comma dell'articolo 3. Il sindaco dispone il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 e ne dà comunicazione al giudice tutelare con le modalità e per gli adempimenti di cui all'articolo 3. L'omissione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio. Tenuto conto di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 7 e in temporanea deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6, negli attuali ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, esclusivamente coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera.
Art. 9 Attribuzioni del personale medico degli ospedali psichiatrici.
Le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
Art. 10 Modifiche al codice penale.
Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 6 del codice penale sono soppresse le parole: "di alienati di mente". Nella rubrica dell'articolo 716 del codice penale sono soppresse le parole: "di infermi di mente o".
Nello stesso articolo sono soppresse le parole: "a uno stabilimento di cura o".
Art. 11 Norme finali.
Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 3-bis della legge 14 febbraio 1904, n. 36, concernente "Disposizioni sui manicomi e sugli alienati" e successive modificazioni, l'articolo 420 del codice civile, gli articoli 714, 715 e 717 del codice penale, il n. 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge restano in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale. Fino a quando non si provvederà a modificare, coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, sono fatte salve in materia di trattamenti sanitari obbligatori le competenze delle autorità militari, dei medici di porto, di aeroporto e di frontiera e dei comandanti di navi o di aeromobili.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Data a Roma, addì 13 maggio 1978
Leone - Andreotti - Bonifacio - Anselmi
Visto, il Guardasigilli: Bonifacio
STRALCIO DELLA LEGGE 833/1978
TITOLO III
Norme transitorie e finali
Art. 64 - Norme transitorie per l'assistenza psichiatrica.
La regione nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980 . Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente attività psichiatrica . È in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche. La regione disciplina altresì con riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità sanitarie locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e degli altri enti pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge provvedono, per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonché la destinazione dei beni e del personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi interessino più regioni, queste provvedono d'intesa. La regione, a partire dal 1° gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici di cui all'articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano sanitario regionale e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione per concorso di altro personale indispensabile al funzionamento di tali presidi. Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i servizi di cui al quinto comma dell'articolo 34 sono ordinati secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 , al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all'adozione e di provvedimenti delegati di cui all'art. 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 e dall'art. 7, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 . Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i divieti di cui all'art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri enti pubblici e dalle amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente prima dell'entrata in vigore della presente legge. Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , sono compresi gli infermieri di cui all'art. 24 del regolamento approvato con R.D. 16 agosto 1909, n. 615 . Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 6 della presente legge la regione provvede all'aggiornamento e alla riqualificazione del personale infermieristico, nella previsione del superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela della salute mentale delle unità sanitarie locali. Restano in vigore le norme di cui all'art. 7, ultimo comma, L. 13 maggio 1978, n. 180
Controcanto - Mario Tobino e la controversia con Basaglia
«I novatori social-psichiatrici».
(Per le antiche scale, 1982, Arnoldo Mondadori Editore)
Così, con questo linguaggio sorpassato e con evidente fastidio, Mario Tobino – psichiatra e scrittore che esercita nei manicomi dal 1939 al 1980 - chiama gli psichiatri che sostengono le proposte di Franco Basaglia e di Psichiatria Democratica.
Tobino rappresenta – di fatto - il controcanto alla rivoluzione basagliana e della Legge n. 180, controcanto che cerchiamo di far emergere analizzando la controversia con Franco Basaglia, che, nel 1978, si sviluppa sui quotidiani La Nazione e Paese Sera.
Alla fine del testo si trovano una Nota Biografica, una Bibliografia e le Note, che permettono di leggere le esatte parole usate da Tobino e da Basaglia.
LA CONTROVERSIA
Tra i due psichiatri, a pochi giorni dalla approvazione della Legge 180, si svolge una discussione pubblica, molto dura, dipanata sulla stampa in tre articoli: Lasciateli in pace, il manicomio è la loro casa, scritto da Tobino e pubblicato il 18 aprile su La Nazione; una intervista di Paese sera a Basaglia, Magliano, le false donne (4 maggio 1978); Dolorosa follia, ho udito la tua voce, di nuovo su La Nazione, 7 maggio.
(Ringraziamo la Fondazione Mario Tobino che ha messo a disposizione - dai propri archivi - le immagini dei tre articoli linkate sopra).
LASCIATELI IN PACE
Lasciateli in pace nasce dai dubbi sulla legge 180 e sulla presumibile difficoltà nel metterla in atto, preoccupazioni condivise con alcuni medici e paramedici di Maggiano. Il contenuto rilevante è nella seconda parte dell’articolo, nel dialogo tra lo psichiatra e l’infermiere Scipioni, in cui si enunciano i principi della carità continua e dell’assistenza amorevole, senza sosta, verso i malati e verso le loro esigenze. Scipioni si fa rappresentante dei timori sulla abolizione degli ospedali psichiatrici, decretata dalla legge in procinto di essere approvata.
La preoccupazione di Scipioni – e di Tobino, che sembra parlare attraverso l’infermiere – è per il destino dei tanti malati. Soprattutto quelli anziani e soli, che hanno vissuto per anni nel manicomio di Lucca e che – una volta dimessi per decreto – non avrebbero un posto dove andare. Per loro non ci sarebbe nessuna famiglia ad accoglierli, sarebbero lasciati all’abbandono e allo scherno, se non alla violenza, del mondo “libero”.
In sostanza, Tobino difende l’istituzione manicomiale come luogo di cura e di protezione per i malati di mente; una casa, per loro che una casa “fuori” non avrebbero più. È l’appello di un medico che ha vissuto tra i matti e per i matti, che adotta un criterio morale con al primo posto la dignità e l’individualità complessa di ogni singolo malato.
UNA RISPOSTA POLITICA
La risposta di Basaglia su Paese sera è durissima, quasi violenta, su un registro completamente diverso da quello di Tobino: egli accusa Tobino di ostacolare il progresso della psichiatria, di puntare sulla dimensione emotiva[1], di essere lui stesso demagogico e sprezzante quando definisce la nuova linea della psichiatria demagogia e moda.
In questa intervista, Basaglia attacca violentemente la psichiatria tradizionale e manicomiale, che ritiene essere al servizio del potere per controllare le persone emarginate, e accusa Tobino di essere al servizio del potere[2] con il suo articolo.
Il suo discorso è di carattere politico: Franco Basaglia sostiene[3] che carità continua e aspetto umano non abbiano alcun significato e che Tobino non affronti il discorso politico che sta dietro al tema della chiusura dei manicomi; egli oppone - alla dignità dell’individuo di cui parla Tobino – la dimensione antropologica molto più ampia, teoretica, della dignità dell’uomo[4]; nega la possibilità di dialogare con le posizioni altre, perché lo ritiene inutile e impossibile[5], nell’ottica di distruggere il potere.
A conclusione dell’intervista, denigra l’avversario per minarne l’autorevolezza, attaccando il romanzo Le libere donne di Magliano[6] che, a suo avviso, contiene solo falsità[7].
L’ULTIMO ATTO, TOBINO RISPONDE SULLO STESSO PIANO
Mario Tobino non può esimersi dal controbattere alle accuse di Basaglia e lo fa 3 giorni dopo, sul quotidiano toscano La Nazione, con l’articolo intitolato Dolorosa follia, ho udito la tua voce.
La controrisposta non è più né aneddotica né di piglio letterario, ma calata nello spazio analitico, teorico e metodologico. [8]
Dopo un breve preambolo di deviazione dei colpi diretti alla sua persona, va diritto ai punti che gli premono: la realtà di manicomi ben diversi dalle prigioni; l’effettiva esistenza della follia [9]; l’inopportunità della chiusura dei manicomi.
In risposta alla ideologizzazione del concetto di manicomio - prigione, Tobino ricorda che le esperienze “liberalizzanti” di Gorizia, di Colorno e di Trieste – dove ha operato Basaglia - non sono le uniche in Italia, ma ne esistono altre, altrettanto “aperte” e innovative; che lo stesso manicomio di Lucca[10] fu tra i primi ad aprirsi; che, a Lucca, i matti sono trattati con attenzione alle singole esigenze, sono liberi e girano tranquillamente, giocano a carte, lavorano allo spaccio, fanno riparazioni, sostituiscono i custodi.
Tobino ricorda - e fa appello alla memoria dello stesso Basaglia – le manifestazioni della follia, i deliri, le urla e le violenze; reali, innegabili, spesso difficilmente controllabili; la follia, secondo Tobino è questa, non la si può dimenticare.
Ed è solo grazie alla nuova chimica, all’alleanza con gli psicofarmaci[11], che si danno questi progressi: senza di essi non sarebbe stato possibile né controllare la follia – pur sopprimendo[12] una parte della personalità dei malati – né aprire i manicomi.
È l’ultimo tema, quello della chiusura dei manicomi[13], su cui Tobino pone l’accento più accorato e pone le domande critiche: dove andranno i malati che da anni vivono nei manicomi e che non hanno un luogo dove andare? Come saranno assistiti sul territorio dove le strutture ipotizzate dalla Legge non esistono, dove i reparti psichiatrici negli ospedali avranno al massimo 15 posti?
Di fatto, Tobino, affronta in modo esplicito la dimensione politica della follia e ne sottolinea l’esistenza puntuale, sociale e contestuale, chiamando in causa la fragilità dei dispositivi della Legge 180, l’impreparazione del tessuto sociale e la necessità di un posto per questi malati, di sapere che c’è un luogo adatto alla follia, seppure mascherata dalla chimica.
UNA ANALISI DELLA CONTROVERSIA
Ci sono elementi, tra quelli che emergono dalla controversia, per i quali si può intravedere una possibilità di conciliazione. È il caso della cancellazione dei trattamenti coercitivi e segreganti dei soggetti psichiatrici e dell’apertura nei confronti della società e della quotidianità, che sembrano essere obiettivi comuni a entrambi gli psichiatri.
Entrambi, inoltre, sembrano essere su una linea simile sulla modalità di gestione dei pazienti non più internati: Basaglia parla di diffusione della cura sul territorio, di somministrazione delle cure vicino a dove stanno i malati, di reinserimento; Tobino ipotizza l’ospedale come luogo di riferimento[14] per il malato; entrambi coinvolgono i pazienti in attività costruttive di laboratorio o di lavoro socialmente utile.
Nel focalizzare i principi, i criteri morali, che stanno alla base di questa etica della psichiatria, si possono trovare alcuni medesimi fondamentali: l’attenzione al malato, la cura e non la repressione, l’occupazione come mezzo per restituire un senso del tempo e dell’utilità sociale, la libertà di scelta sul ricovero e sulla presenza nel luogo di cura, il rapporto con il tessuto sociale.
Invece, sul punto dell’esistenza o meno della follia, non è possibile una composizione della controversia: Tobino, seppure non escluda del tutto l’origine sociale, ha una visione organica, fisiologica della follia, e accusa[15] Basaglia di credere che la chiusura dei manicomi cancelli ogni traccia della follia. Basaglia, infatti, la nega e nello stesso tempo, ne attribuisce la creazione alla società malata, al potere, per rinchiudere i disallineati, i disturbatori dell’ordine e dello sfruttamento[16].
Altro punto di dissidio insanabile è il tema della presenza e della forma delle strutture di cura, che coinvolge anche la visione politica delle due posizioni: Tobino non prescinde dalla necessità di un luogo dove i matti possano trovare – per periodi lunghi o brevi, più o meno volontariamente, in modo comunque aperto – riparo, protezione, cura e tranquillità[17]; e sottolinea l’assenza di preparazione dei territori, della popolazione e delle famiglie per la trasformazione dalle strutture accentrate a quelle diffuse; Basaglia, al contrario, non transige, insiste sulla necessità di distruggere l’istituzione manicomiale[18] e ribadisce la necessità della riforma, da farsi subito, in nome della «crescita politica, e quindi civile e culturale del paese».
VINCITORI
A volte le controversie scientifiche hanno un vincitore (come tra Pasteur e Pouchet[19], a metà del XIX secolo), a volte nessuno, a volte vincitori e vinti, ben oltre i contendenti.
In questo caso, la “vittoria” arride a Basaglia e alle proposte di Psichiatria Democratica[20], che vedono il parlamento prendere atto del lavoro fatto[21] e varare la legge 13 maggio 1978, n. 180.
Oltre che dalla condizione di possibilità fornita dai farmaci, questa vittoria è stata decretata:
- dal fatto che il progetto di riforma della psichiatria è nato e cresciuto nel mezzo degli anni ’70[22], in un contesto con cui condivideva lo stile di pensiero[23], il linguaggio[24] e le forme di espressione;
- dall’abilità degli innovatori nell’arruolare le forze politiche usando – appunto – concetti evocativi irrinunciabili in quegli anni: libertà dalle costrizioni, distruzione delle istituzioni, lotta contro il potere; e evocando la lotta anche contro chi resiste all’innovazione[25].
- dalla leva su elementi motivazionali anch’essi parte integrante della cultura rivoluzionaria di quegli anni, come il senso di colpa della “società”, rea della creazione e dell’espulsione della follia e dei folli[26].
ALTRI VINCITORI E MOLTI PERDENTI
Alla lunga, hanno vinto, dopo 20-30 anni, tutte le persone colpite da problemi psichiatrici – depressione, psicosi, schizofrenia – che hanno guadagnato il diritto a essere curati restando, almeno in parte, all’interno del proprio tessuto sociale (grazie al duro lavoro di chi quella legge[27] ha voluto interpretare e attuare e grazie alla diffusione e alla messa a punto dei farmaci antipsicotici).
Hanno perso, invece, i matti che vivevano dentro ai manicomi, progressivamente espulsi, poiché – scrivono Corbellino e Jervis nel 2008 – l’impossibilità di nuovi ricoveri negli ospedali psichiatrici genera una drammatica situazione di mancata assistenza per i malati critici[28].
Hanno perso anche le famiglie dei ricoverati e dei nuovi malati che, a causa della fretta della rivoluzione e dell’assenza di reali alternative alla struttura psichiatrica, si trovano sulle spalle tutto il carico della gestione, i sacrifici e le tragedie[29].
Hanno perso, più di tutti, alcune centinaia di malati che – dimessi dal manicomio – sono morti per suicidio o accidentalmente, per incapacità di vivere in un mondo ad essi ormai sconosciuto.
Dice lo psichiatra Cherubino Trabucchi[30] che si tratta di duemila – tremila persone.
MARIO TOBINO, NOTA BIOGRAFICA
Mario Tobino nasce a Viareggio nel 1910, si laurea in medicina nel 1936 e prende la specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali nel 1941, con una tesi sulla necessità di una rifondazione umanizzante della psichiatria contemporanea.
Esercita come psichiatra nei manicomi dal 1939 al 1980: ad Ancona, a Gorizia e a Firenze San Salvi (1939-1940), dal 1941 al 1980 nell’ospedale psichiatrico di Maggiano, in provincia di Lucca, dal 1948 come primario del reparto femminile. Nel 1944 partecipa alla guerra partigiana. Vive all’interno del manicomio – nelle stanze dei medici – fino quasi alla morte (1991).
La scrittura contende alla psichiatria il ruolo di principale occupazione. Dalla prima raccolta di poesie del 1934 a Una vacanza romana del 1992, Tobino pubblica 4 raccolte di poesie e 23 romanzi e raccolte di racconti. Di questi, almeno 4 sono incentrati sull’esperienza psichiatrica a Maggiano: Le libere donne di Magliano, Per le antiche scale (Premio Campiello 1972), Gli ultimi giorni di Magliano, Il manicomio di Pechino (Premio Strega 1990).
BIBLIOGRAFIA
M. Tobino, Lasciateli in pace, il manicomio è la loro casa, La Nazione, 18 aprile 1978
F. Basaglia, Magliano: Le false donne, Paese sera, 4 maggio 1978
M. Tobino, Dolorosa follia, ho udito la tua voce, La Nazione, 7 maggio 1978
M. Tobino, Le libere donne di Magliano, Arnoldo Mondadori Editore, 1963
M. Tobino, Per le antiche scale, Arnoldo Mondadori Editore, 1972
M. Tobino, Gli ultimi giorni di Magliano, Arnoldo Mondadori Editore, 1982; Ed. del 2019, Mondadori Libri
M. Tobino, Il manicomio di Pechino, Mondadori, 1990
health, volume 14, 1985, issues 1 and 2, The Unfinished Revolution in Italian Psychiatry: An International Perspective
https://doi.org/10.1080/
G. Corbellino - G. Jervis, La razionalità negata: psichiatria e antipsichiatria in Italia, Bollati-Boringhieri, 2008
F. Basaglia, F. Ongaro, A. Pirella, S. Taverna, La nave che affonda, Cortina, 2008
V. Furlanetto, Cento giorni che non torno – Storie di pazzia, di ribellione e di libertà, Laterza, 2024
V. Andreoli, Fratelli di Carmelo Samonà: il matto in casa, in Il matto di carta. La follia nella letteratura, BUR, 2008
S. Redaelli, Circoscrivere la follia, Mario Tobino, Alda Merini, Carmelo Samonà, Sub Lupa Academic Publishing, Warsaw, 2013
NOTE
[1] Basaglia parla di «equivoca pietà» e di «agire emotivo» (Magliano: Le false donne, Paese sera, 4 maggio 1978)
[2] «il suo scritto rende un grosso servizio al potere, su questo non si può discutere» (Cit.)
[3] «Tobino parla “di carità continua e aspetto umano”. Quale significato hanno oggi queste espressioni? Nessuno. Il discorso è politico e Tobino non lo affronta. Anzi, finge di non affrontarlo poiché tutta l’impostazione del suo articolo è politicizzata al massimo» (Cit.)
[4] «la dignità dell’uomo, di tutti gli uomini» (Cit.)
[5] «instaurare un dialogo comune, generale […] impresa impossibile poiché l’istituzione che vogliamo distruggere è il potere stesso e nessuno rinuncia senza lottare al suo potere» (Cit.)
[6] Romanzo che lo stesso Basaglia, in gioventù, aveva amato e considerato una sorta di trattato psichiatrico (cfr. Magliano: Le false donne, Paese sera, 4 maggio 1978
[7] «a Gorizia […] ho potuto verificare ogni cosa, controllare ogni sensazione. Era tutto falso» (Cit.)
[8] «non ho potuto non sorridere quando ho letto che sarei strumento del dominante potere. Da quasi quarant'anni vivo al manicomio di Lucca e in verità mai sono stato in relazione, a contatto con chi comanda, chi è dominante. Per anni e anni la mia vita si è svolta in compagnia dei malati; adesso la mattina il primo dialogo lo faccio allo spaccio, al loro spaccio, dove vado a prendere il caffè e poi ancora durante la giornata. Nel dopopranzo sono solito passeggiare qui intorno e molto spesso con malati mi accompagno, malati liberi, che se la girano tranquillamente. La sera, dopo cena, quante volte ho giocato con loro a carte e, lo giuro, mai, mai abbiamo insieme trescato col potere, mai ordimmo per difenderlo» (Dolorosa Follia, ho udito la tua voce, La Nazione, 7 maggio 1978)
[9] Come già visto, in tutta la sua produzione Mario Tobino usa in modo diretto i termini follia, malattia mentale, matto/matti, lasciando poco spazio agli eufemismi; da una parte può essere un retaggio del periodo in cui ha studiato ed esercitato, dall’altra possiamo considerarlo un modo per non dimenticare di cosa si parla in termini comuni.
[10] Tobino definisce l’ospedale psichiatrico di Maggiano «libero e umano» e ricorda che «con entusiasmo […] fummo tra i primi a tirare giù i muri di cinta, strappare le inferriate, aprire, dare luce» (M. Tobino, Dolorosa follia, ho udito la tua voce, La Nazione, 7 maggio 1978)
[11] «nel 1952, arrivarono gli psicofarmaci che riescono a velare, a intorpidire, a rendere apparentemente molli molti segni della pazzia» (Cit.);
[12] «Sono stati gli psicofarmaci a rivoluzionare i manicomi e non le loro teste. E nemmeno si domandano se la follia loro la conoscono, se ne saprebbero distinguere il volto, loro che l'hanno frequentata soltanto dopo l'avvento degli psicofarmaci, se ne sanno la violenza, la fantasia, l'orrore, l'inesprimibile immacolatezza, l'impenetrabile lutto. E neppure amano conoscere, per nulla sono ansiosi di valutare di quanto con i composti chimici la follia è stata offuscata, travestita, mascherata (ma non vinta); e a volte costretta a brancolare.
Neppure sorge loro l'inquietante interrogativo, l'as-sillo morale, se è giusto con gli psicofarmaci ottundere la personalità, arginare, imbavagliare, legare una delle più profonde, meravigliose, misteriose manifestazioni umane: la follia.» (Gli ultimi giorni di Magliano, p. 20)
[13] « fuori, come gli andrebbe? I cittadini, che hanno da lavorare, che trascinano i loro affanni, li ascolterebbero, li sopporterebbero? I cittadini debbono essere sensibilizzati ma io finora di questa sensibilizzazione non ho visto nessun progresso, se anche non è aumentato il sospetto» (M. Tobino, Dolorosa follia, ho udito la tua voce, La Nazione, 7 maggio 1978)
[14] «[Un luogo] dove ritornare, rifarsi vedere, venire […] a prendere le cure, […] un luogo dove si entra e si esce tranquillamente» (Cit.)
[15] «io credo che la follia esista e Basaglia invece mi pare che sia convinto che, chiusi i manicomi, svanisca la cupa malinconia, l’architettura della paranoia, le catene delle ossessioni» (Cit.)
[16] «La follia non esiste, non è mai esistita. Sono stati la Società, il Potere a crearla [...] hanno eretto i manicomi per rinchiudere chi disturbava il loro sfruttamento [...]» (F. Basaglia, F. Ongaro, A. Pirella, S. Taverna, La nave che affonda, Cortina, 2008)
[17] Tobino è autore, nel 1958 in tempi non sospetti, insieme a due giovani architetti, di un progetto di «un futuro ospedale psichiatrico, un ospedale per matti in armonia con le vicende dei savi, un istituto che avesse, dopo le sequele di cattiverie, dopo tanto sangue versato, un grano, appena un grano di più di bontà e tolleranza» (Gli ultimi giorni di Magliano, ed. 2019, p. 206); per avere un’idea del progetto: Mappe del progetto per l'Ospedale di Vicenza (Mario Tobino, Giorgio Ramacciotti, Piero Marello) (MTb.II.30.41), Mostre Virtuali Ficlit, #3508
[18] «I manicomi […] noi diciamo che si possono distruggere e lo abbiamo dimostrato in anni di lotta» (F. Basaglia, Magliano: Le false donne, Paese sera, 4 maggio 1978)
[19] Cfr. H.M. Collins, T. Pinch, Il Golem, Tutto quello che dovremmo sapere sulla scienza, Edizioni Dedalo, 1995
[20] https://it.wikipedia.org/wiki/Psichiatria_Democratica, https://www.psichiatriademocratica.org/
[21] «Sono perciò soddisfatto che il Parlamento abbia preso ufficialmente atto della lotta di questi anni» (F. Basaglia, Magliano: Le false donne, Paese sera, 4 maggio 1978)
[22] Cfr. Franco Basaglia e la legge 180: frammenti dello scenario sociale e politico, Controversie, 4 dicembre 2024
[23] Cfr. L. Fleck, Genesi e sviluppo di un fatto scientifico : per una teoria dello stile e del collettivo di pensiero, Il Mulino, 1983; L. Fleck, Stili di pensiero, La conoscenza scientifica come creazione sociale, a cura di F. Coniglione, Mimesis Edizioni, 2019
[24] scrive Tobino: «Si indicono di continuo le riunioni - qualsiasi scusa è buona - alle quali debbono assistere medici, infermieri e anche malati di mente […] Nelle riunioni si rimuginano le prossime salutari innovazioni, ciò che si è in procinto di operare per il trionfo della giustizia, lo smascheramento del Potere, la liberazione degli schiavi, dei martiri», (Gli ultimi giorni di Magliano, p. 19)
[25] «Tutti hanno paura: sanno che il potere, quello politico in primo luogo - quello che in molti casi li ha fatti assumere nell'ospedale -, è con la 180, e con questo i mezzi di comunicazione» (M. Zappella, Introduzione a Gli ultimi giorni di Magliano, ed. 2019)
[26] «La follia non esiste, non è mai esistita. Sono stati la Società, il Potere a crearla [...] hanno eretto i manicomi per rinchiudere chi disturbava il loro sfruttamento [...]» (Paese sera, Cit.)
[27] La legge n. 180 e il suo successivo incoroporamento nella legge istitutiva del Servizio Sanitari Nazionale, Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
[28] «La nuova legge rendeva immediatamente illegale ogni nuovo ricovero negli ospedali pubblici […] fattore principale che causò […] una drammatica – e talora tragica – carenza di assistenza per i nuovi pazienti affetti da disturbi mentali acuti e gravi» (G. Corbellino – G. Jervis, La razionalità negata: psichiatria e antipsichiatria in Italia, Bollati-Boringhieri, 2008)
[29] «gran parte del carico fu sostenuto dalle famiglie dei pazienti con grandissimi sacrifici e non poche vere tragedie» (Cit.)
[30] Gli ultimi giorni di Magliano, p. 258
Investire sulla relazione e sugli operatori - Intervista a Raffaella Bricchetti
L: Buongiorno Dott.ssa Bricchetti.
R: Buongiorno a Lei
L: Vorrei iniziare questa nostra chiacchierata chiedendole anzitutto se ci potesse raccontare qualcosa di Lei, di cosa fa. Per poter introdurre meglio i lettori nel vivo dell’intervista
R: Certo. Dunque, chi sono e cosa faccio... Sono laureata in filosofia specializzata in psicologia alla facoltà di Lettere e Filosofia con indirizzo psicologico all’Università Statale di Milano perché ai miei tempi le facoltà di psicologia erano solo a Padova e a Roma e non avendo la possibilità di andare a Padova per mille motivi familiari ho intrapreso questa strada. Laureata mi sono iscritta alla specializzazione e sono stati altri quattro anni. Ricordo tra i miei docenti anche il Dottor Musatti[1]. Nel frattempo, sia per la prima tesi, quella di facoltà, che per la tesi di specializzazione, avevo contattato il dottor Erba[2], che ai tempi lavorava al Paolo Pini (manicomio cittadino per eccellenza ai tempi) come psichiatra.
L: Ecco Dottoressa Bricchietti, può raccontarci per la sua esperienza la realtà manicomiale Italiana prima del 1978? Qual era il vero tessuto quotidiano dell’esperienza d’esser folli e del tentare di curare e lenire?
R: Certamente, come le dicevo ho conosciuto Erba nel ’74 e insieme abbiamo fatto la prima tesi (quella di facoltà) analizzando moltissimi casi di persone che arrivavano in manicomio. Persone con delle storie psichiatriche assolutamente incredibili, “gli alienati”. Persone che non potevano essere considerate soggetti, ma erano considerate semplicemente dei reietti che dovevano essere controllati, sedati, repressi perché creavano scompiglio all’interno della società. Ricordo in manicomio, ad esempio, quest’uomo di nome Luciano che era comunque una persona molto degna, non saprei come altro definirla, sempre vestito bene con camicia e giacca, mai sciatto o trasandato, di una famiglia modesta che dall’età di 15 anni l’aveva mandato in manicomio perché era un “masturbatore compulsivo”. Lui si masturbava sempre, continuamente, anche in manicomio poi lo faceva perché in realtà diciamocelo, cosa diavolo aveva da fare di meglio?! E così lui era lì da sempre.
Ai tempi i manicomi erano dei luoghi di contenimento perché queste persone venivano prese e lì stavano. Mi ricordo anche Angela, che è stata anche uno dei capitoli della mia tesi; quando l'abbiamo presa in considerazione era arrivata al centocinquantesimo ricovero. Lei entrava, stava dentro due giorni, si rifocillava un po' e poi se ne andava. Le porte le venivano riaperte sempre perché era una donna giovane di nessuna pericolosità né per sé né per gli altri... era molto bizzarra quello sì. Mi è capitato di rivederla poi dopo la chiusura del reparto psichiatrico e mi prese in giro dicendomi “ma guarda io ti ho vista che eri grande così!” Ecco, c'erano anche questi personaggi che andavano e venivano in questo reparto molto aperto. Faccia conto che in Italia ai tempi c’erano 98 manicomi con 100mila persone dentro. La cosa che colpì di più Basaglia quando entrò nell’ospedale di Gorizia fu “l’odore di morte e di piscio”, che è vero perché l’odore di morte e di piscio caratterizzava tutto.
Io da bambina mi ero fatta delle fantasie su come fosse un manicomio. Abitavo in un piccolo paese vicino a Brescia e c’erano alcune persone che lavoravano a Canton Mombello che era il manicomio di Brescia. Ai tempi la cosa che mi aveva incuriosito molto era che gli infermieri venivano assunti anche in base alla stazza perché più erano grandi, grossi e potenti più erano in grado di contenere le persone che avrebbero potuto avere delle manifestazioni violente. Questo anche per farvi capire il clima riguardo questi luoghi, le idee che circolavano. A me però questa voce mi aveva sempre incuriosita e quando decisi di fare la prima tesi di laurea sul tema fu perché avevo casualmente letto un articolo su un giornale in cui intervistavano Sergio Erba che aveva introdotto il concetto di “terapia della famiglia all’interno del manicomio”. Ecco questa cosa mi fece scattare ulteriormente la curiosità e gli chiesi di poter assistere e di poter fare la tesi. Mi avvicinai così alla settima divisione del Paolo Pini di Milano dove il Dottor Erba dirigeva un reparto. Quando entrai scoprì che il clima era completamente diverso da quello che avevo immaginato da bambina: ad esempio, il giovedì mattina c’era un’assemblea di reparto dove i pazienti non erano considerati dei numeri ma delle persone, ciò che poi è stato uno dei principi della Legge Basaglia, considerare la persona ricoverata una persona non da sedare o da contenere con fascette ma una persona con la quale parlare. Era faticoso e questa fatica non era tanto dovuta al comportamento dei pazienti, quanto dal personale infermieristico che non era abituato a mettersi in gioco nella relazione con il paziente. Era difficile per loro non intrattenere con i pazienti rapporti che non fossero di forza. Ad un certo punto infatti ci fu proprio una divisione degli infermieri tra chi voleva provare a lavorare in questa maniera e chi no. Così funzionava al piano dove c’era il Dottor Erba, al piano di sotto un altro psichiatra di cui non ricordo il nome procedeva con idee molto ma molto più tradizionaliste...
L: Nel 1978 grazie a Franco Basaglia inizia quindi il percorso verso la riorganizzazione dell’assistenza psichiatrica ospedaliera, ci racconti di questo periodo di transizione...
R: Faccia conto che io sono entrata in questo mondo nel ’74, la Legge 180 è del maggio ’78. Già prima comunque c’era una tendenza ad un approccio diverso alla malattia mentale solamente che era riservata al singolo psichiatra e al reparto dove lavorava, non era una cosa generalizzata e generalizzabile... Qualcosa a livello di chi operava nei contesti manicomiali si stava muovendo ma il livello di establishment diciamo “ufficiale” e politico era ancora orientato nel mantenere il manicomio come luogo di contenimento. È stato molto più difficile a livello istituzionale cambiare qualcosa. Le singole persone erano sicuramente più illuminate ma a livello di istituzioni è stato difficile. Con l’avvento della Legge Basaglia e la chiusura di questi manicomi uno dei temi di base della legge era proprio quella dell’umanizzazione del manicomio.
Basaglia aveva iniziato giovanissimo a Gorizia come direttore e lì aveva avuto grossi problemi. Era finito quindi a Colorno, in provincia di Parma, poi era andato a Trieste, insomma aveva girato vari manicomi sempre con questa idea che voglio esprimere leggendo proprio le sue parole:
“restituire l’individualità e la dignità ai pazienti che dovrebbero essere riconosciuti prima come esseri umani e poi come delle persone da riabilitare. La prima cosa da fare è sospendere ogni forma di giudizio e considerare l’individuo nella sua interezza partendo dalla sua storia, dal ruolo sociale svolto, dalle emozioni e dal malessere, per poi procedere con diagnosi e terapia ma evitando stigmatizzazioni inutili”. Questa legge è stata talmente rivoluzionaria che era arrivata ben prima alle orecchie di tanti psichiatri che non potevano ignorare queste cose. A Milano ad esempio c’era il “Gruppo di Psichiatria Democratica” che era molto attivo (ne facevano parte personaggi come Benedetto Saraceno[3], Leo Nahon[4] etc). I concetti quindi di cui parlava Basaglia li si maneggiava. Cercavamo di andare verso una nuova realtà, il desiderio di umanizzare il manicomio cercando di trasformarlo in quelle che potevano essere delle comunità terapeutiche dove per i pazienti, ad esempio, si iniziavano ad introdurre delle attività per evitare che questi passassero l’intera giornata a letto o in giro per i vialetti del Paolo Pini senza niente da fare se non fumare, fumare, fumare...
Un’altra innovazione di questo momento di transizione era l’idea di ricoverare anche i famigliari del paziente designato. Ricordo questi due ragazzi molto giovani che erano istituzionalizzati al Paolo Pini entrambi con diagnosi di schizofrenia e ad un certo punto venne invitata a rimanere tutta la famiglia, con questa madre molto dominante e un padre che si faceva più piccolino e la seguiva sempre da dietro. Questa donna arrivava sempre alle 9 del mattino con una borsa piena di cibo per i figli, che per altro erano magrissimi e lei riempiva loro la bocca di polpette, questi ragazzi me li ricordo come degli scoiattolini con le guanciotte piene di polpette che tenevano lì. La mattina avevamo un appuntamento fisso e si cercava di lavorare sulle dinamiche che venivano ad instaurarsi, ad un certo punto avevamo lavorato anche sul suo riempire le bocche dei figli. Insomma, esperienze ed esperimenti molto particolari.
La legge Basaglia comunque era molto bella nella teoria ma nella pratica è stata disattesa per molti anni. Addirittura se non ricordo male quelli che erano i precursori degli attuali Cps iniziarono ad aprire negli anni ’90. L’unica cosa rapida fu l’apertura dei reparti di psichiatria negli ospedali civili “normali” chiamiamoli così, come conseguenza immediata della chiusura manicomi.
L: Ma secondo lei quindi che cos’è cambiato veramente dopo che questi posti hanno chiuso?
R: Beh, hanno iniziato a creare i servizi di igiene mentale... A quei tempi Milano era divisa prima in 20 zone, poi 13, etc e una zona che faceva riferimento alla divisione del Paolo Pini era (adesso non si chiama più così) la zona 13 che era attorno all’aeroporto Forlanini (quindi via Mecenate, viale Ungheria etc) dove tutta la via Ungheria aveva un “buon gettito” di pazienti psichiatrici, invece la via Salomone erano tossici e lì cerano prima le case minime, poi le case bianche dove c’era, e forse c’è ancora oggi, una grossa presenza di tossicodipendenti. Quando hanno chiuso il Paolo Pini, hanno aperto in zona un ambulatorio con tre stanzette: una per l’infermeria, una per l’assistente sociale e una dove ruotavamo noi. Ecco lì siamo stati parecchi anni, nella stessa palazzina misero il consultorio e il fatto che ci fosse questa commistione tra matti e tossici (perché ai tempi ancora non avevano creato i servizi per la tossicodipendenza) non piaceva.
E nel concreto cosa succedeva, succedeva che c’erano appunto tutti questi tentativi di creazione di comunità terapeutiche, ambulatori zonali dove affluivano i pazienti psichiatrici mandati dai medici o che venivano ricoverati 10/15 giorni nei reparti di psichiatria e poi una volta dimessi passavano direttamente al territorio mandati con tanto di foglio di via in queste strutture per prendere contatti con il personale. Molti assumevano farmaci, per cui venivano a prenderli e a questo punto non ci si limitava a dare solamente il farmaco al paziente ma si cercava di parlare con lui, di vedere che cos’era successo nel frattempo, che cosa l’aveva portato in ospedale. Sempre in quell’ottica di umanizzazione e di rispetto della persona, di rendere la persona soggetto della propria potenziale -non tanto guarigione- quanto consapevolezza che il disagio che lui stava vivendo poteva essere affrontato diversamente e non solo con il farmaco. Ad esempio, se veniva una signora depressa si cercava di instaurare un approccio relazionale sia con lei, persona che arrivava portando una sofferenza, che con la famiglia.
L: Come prendevano i pazienti, a livello di cambiamento di approccio e non solo di cambiamento strutturale, l’esser trattati così diversamente, in questa maniera appunto relazionale?
R: Non era facile, non era facile. Però questo era ciò che ritenevamo l’approccio migliore cioè di “responsabilizzazione del paziente”. Il paziente non è oggetto di cura ma è soggetto. Il lavoro era quello di fare in modo che la persona si rendesse conto di essere portatore di una domanda e portatore di un possibile dimensionamento del suo star male. Solo lui poteva in qualche modo fare qualcosa per uscire da quella situazione. Noi, nella nostra posizione di curanti, potevamo “aiutarlo a”.
L: Lei prima diceva che però i manicomi erano dei luoghi per i pazienti di contenimento sì, ma in qualche modo luoghi in cui le persone che li abitavano ci avevano passato tutta la vita per poi ritrovarsi a dire “cosa faccio/dove vado”?
R: Assolutamente! Persone smarrite... Se vi ricordate Luciano di cui vi parlavo prima, quando hanno chiuso i manicomi lui si era trovato veramente perso perché dentro almeno era in una situazione molto protetta. Chiuso il manicomio lui è stato sbattuto fuori ma la famiglia non lo voleva, non sapevano dove cacciarlo e onestamente non mi pare siano riusciti a trovargli una sorta di comunità dove farlo stare... Mi pare di ricordare che non abbia vissuto a lungo fuori. Questo per dire che non è che ai tempi ci fossero i matti attaccati al cancello che urlavano “noi vogliamo uscire”, perché quello paradossalmente era un ambiente molto protetto dove le persone magari erano lì da sempre. Come dicevo anche per Angela; lei arrivava lì, mangiava un po’ perché magari passava qualche giorno in giro per Milano senza mangiare, e se ne andava. Era anche una Milano degli anni ’70 in cui la realtà fuori non è come quella di adesso. Io ai tempi ho visto solo un signore di colore nell’arco di tutta la mia esperienza, che era stato ricoverato perché aveva dato un po’ fuori di matto ma rimesso un attimo in sesto se ne era andato ed aveva continuato a fare quel che faceva, lavorare etc. Adesso credo che nelle odierne comunità terapeutiche ci siano molti più immigrati, piazzati ovunque senza esserci tante altre strutture per poterli ospitare...
L: Quindi lei crede che quello un tempo fosse un po’ un rifugio per gli emarginati sociali di allora...
R: Sicuramente... un’alternativa era il dormitorio di Viale Ortles. Perché una volta “liberati” dai manicomi questi soggetti non sapevano dove andare e andavano nei dormitori. Avevo avuto dei contatti con il direttore del dormitorio di viale Ortles anche per capire come cercare di fare questi passaggi perché non è che nei dormitori le persone poi potessero vivere: andavano là per dormire, stavano fino alla mattina alle 6, facevano la colazione ma poi dovevano andare fuori. Non c’era più quindi un luogo dove queste persone potevano stare 24 ore su 24. Il concetto di fondo però era quello del rispetto della persona, perché prima non era assolutamente così. Persona in quanto portatrice di un disagio, e quindi, nella sua storia come è nato, come si è evoluto questo disagio? Quindi, parlare e lavorare con queste persone.
L: Come prendeva l’opinione pubblica questo cambio di approccio in termini più relazionali di cui parlavamo poco prima?
R: L’opinione pubblica era arrabbiata! Comunque c’era ancora e credo ci sia tutt’ora una fetta più tradizionalista e in questo senso anche più assistenzialista, e le persone stesse arrivano da te con un’ottica di assistenzialismo. Riuscire a far cambiare alle persone questa ottica e renderli partecipi della terapeuticità della loro relazione non era facile. Persone che non ci stava anche ad assumersi la propria parte di responsabilità, volevano solo il farmaco e allora “va bene ti do il farmaco, però te lo do a modo mio”. Quando ad esempio venivano per fare le iniezioni depot[5] dei farmaci anti depressivi, questi nuovi infermieri erano capaci sì di fare l’iniezione ma anche di parlare con la persona, di cercare di sensibilizzarle in questo senso. Le famiglie spesso erano poco disposte a starci perché venivano messe in discussione, veniva messo in discussione il loro modo di relazionarsi con quello che doveva essere il paziente designato e magari le famiglie non avevano nessuna voglia di mettersi in gioco, era più comodo dire “lui è matto, è lui quello strambo, gli dia la medicina e a posto così”.
L: In Italia invece a livello di humus culturale, le persone erano spaventate da questo cambiamento?
R: Direi di no. Ma nemmeno gli importava così tanto anche perché le persone direttamente interessate non erano chissà quante e quindi si lavorava su quei numeri piccoli.
L: Siamo alla domanda finale, secondo lei, ad oggi c’è qualche aspetto che avrebbe bisogno di una nuova rivoluzione in ambito di salute mentale?
R: Sì. Ancora oggi fa molto più comodo somministrare quattro pillole piuttosto che tenere il paziente lì, una volta alla settimana, a parlare del suo male. Le cose sono cambiate ma fino ad un certo punto. Finché ho lavorato in consultorio sono sempre stata poco “ossequiosa” rispetto a quello che l’istituzione mi diceva di fare, ad esempio il pacchetto da dieci colloqui: io faccio i colloqui che mi servono, se il paziente ne vuole fare venti ne farà venti, se ne vuole fare cinque ne farà cinque ma lavoriamo insieme in quei venti o cinque che siano. Ho seguito ad esempio più pazienti per anni in consultorio, mandando su tutte le furie i responsabili. Adesso bisogna anche registrare tutte le prestazioni, c’è una sorta di controllo non tanto sui pazienti ma su noi operatori, ora. Per l’istituzione se tu fai più del tuo pacchetto standardizzato da dieci sedute con un paziente vuol dire che stai togliendo la possibilità ad un altro di utilizzarti e quindi tu devi fare dieci colloqui, punto. Finiti i dieci colloqui la persona che hai davanti speri si sia rimpannuncciata un po’ e se non si è rimpannuncciata pazienza e avanti il prossimo. Ora si cerca di lavorare sui comportamenti, così che la persona qualcosa modificherà, starà meno male in dieci appuntamenti e quindi vai, può arrivarne un altro che ha bisogno. Io questo non lo farò mai, faccio quello che ho imparato, lavorare con la relazione e quindi ho fatto così anche in consultorio.
L: Quindi se ci fosse una rivoluzione da fare ad oggi sarebbe quella di investire veramente sulla relazione?
R: Sì e anche di investire sugli operatori. Dare all’operatore la possibilità di lavorare un po’ più tranquillo rispetto alla registrazione della prestazione ad esempio. Io credo che questo approccio al disagio mentale ed emotivo non può passare attraverso una schematicità. Si sta tornando molto indietro ahimè...
***
Dovendo scrivere di Basaglia, dei suoi anni e di ciò che hanno rappresentato per la psichiatria italiana le sue intuizioni, ho pensato che potesse essere molto interessante parlarne con una persona che quegli anni li ha vissuti, permettendoci di rivivere la storia da un punto di vista privilegiato e originale in quanto legato al vissuto reale dei pazienti più ancora che alla teoria accademica.
Per chi scrive, giovane psicologa, alla luce di questa preziosa chiacchierata resta una sensazione di perdita. La sensazione è che oggi questo fermento di idee con al centro il benessere dei pazienti sia carente e si stia scivolando verso una standardizzazione di metodologie e un rigore operativo che lasciano poco spazio alla relazione.
Il sistema ha già riassorbito anche Basaglia e le idee di tutti i “rivoluzionari” di quegli anni?
NOTA BIOGRAFICA
Raffaella Bricchetti. Psicoterapeuta individuale e di coppia, laureata in Filosofia con indirizzo Psicologico e specializzata in Psicologia con indirizzo Sociale nel 1984, presso l’Università degli Studi di Milano. Dal 1974 collabora con la Scuola di Formazione Il Ruolo Terapeutico come docente clinica e teorica. Inoltre è redattrice della rivista “I Quaderni del Ruolo Terapeutico”.
NOTE
[1] Cesare Luigi Eugenio Musatti (Dolo, 21 settembre 1897 – Milano, 21 marzo 1989) è stato uno psicologo, psicoanalista, filosofo e politico italiano, tra i primi che posero le basi della psicoanalisi in Italia
[2] Sergio Erba psichiatria con formazione psicoanalitica. Dagli anni '60 sino all'85 ha lavorato per il servizio pubblico nella Clinica psichiatrica dell'Università di Milano, nell'Ospedale Psichiatrico P. Pini e al Centro psicosociale di zona 13. Fondatore della scuola "Il Ruolo Terapeutico" di Milano e dell’omonima rivista
[3] Benedetto Saraceno, Psichiatra ed esperto di sanità pubblica, ha lavorato a Trieste sotto la direzione di Franco Basaglia e a Milano come responsabile della Comunità per pazienti psicotici gravi prevista dalla legge Basaglia. Direttore del Laboratorio di epidemiologia e psichiatria sociale presso l’Istituto Mario Negri. È stato uno dei leader del movimento di Psichiatria antistituzionale e ha lavorato per molti anni in America latina, dove ha promosso modelli comunitari di assistenza psichiatrica ispirati alla difesa dei diritti umani dei pazienti. Dal 1999 al 2010 ha diretto il Dipartimento di salute mentale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra
[4] Leo Nahon, Psichiatra, è stato assistente di Franco Basaglia all’ospedale di Trieste. È stato poi Primario dei Servizi Psichiatrici di Vimercate e Carate e poi Direttore della Struttura Complessa di Psichiatria dell’Ospedale Niguarda a Milano.
[5] Letteralmente deriva dalla lingua francese e significa deposito. In medicina viene riferito a particolari formulazioni di farmaci che consentono l’accumulo nei tessuti ed il graduale rilascio nel tempo della sostanza terapeutica somministrata. Il farmaco quindi è disciolto in particolari veicoli oleosi che ne consentono lo stoccaggio nel tessuto muscolare (tramite iniezione intramuscolare profonda) o nelle mucose (mediante ovuli)
Rete psichiatrica sul territorio - Intervista a uno psichiatra che attuò la legge 180
Nell'ottica di raccontare la legge 180, descritta in altri articoli di questi speciale di Controversie, decido di cercare di farmi raccontare le pratiche di chi ha lavorato nel contesto sociale successivo alla promulgazione della legge. Così incontro Antonio Iraci, medico psichiatra. Mi invita gentilmente a casa sua una sera e fin dalle prime chiacchiere, i convenevoli, ci inoltriamo nel suo lavoro dei primi anni '90 nelle comunità della provincia di Como...
Antonio Iraci: A inizio anni ‘90 lavoravo per l’Unità Operativa di Psichiatria di Menaggio. Avevo l’area di Porlezza che all’epoca coincideva con tre vallate del profondo Nord: la Val Rezzo, la Val Cavargna e la Val Solda.
Ricordo queste case con un’unica stanza, la parte nera per il fumo del camino, un letto, un tavolo e le imprecazioni di chi vi abitava. Si andava anche solo per fare un’iniezione di farmaco depot, per garantire la continuità delle cure.
Racconto sempre di una paziente che si chiamava Nini. Le volevo molto bene e lei ne voleva a me. Non sempre il medico vuole bene al paziente! La Nini diceva di essere la moglie del sindaco dimessosi, ma che lei non si era affatto dimessa! La Nini manteneva il suo ruolo sociale interessandosi a tutto ciò che poteva essere di nocumento ai suoi concittadini. Faceva proclami per il paese e andava in chiesa a seguire ogni messa per poi salire sul pulpito alla fine dichiarando: “Adess parli mi”.
La Nini in una metropoli sarebbe stata rinchiusa. Lì, in effetti, si è riusciti a fare un grosso lavoro. In una riunione col sindaco e col prete spiegai loro che se le avessi dato un antipsicotico si sarebbe buttata dal balcone (era già successo): a volte i sintomi sono meccanismi di difesa e se io non sono più nessuno allora non ha senso vivere e mi butto.
Allora montammo una bacheca all’ingresso del paese dove lei poteva mettere tutti i suoi proclami. Aderì tutta la comunità e questo è l’esempio di un caso gestito tenendo conto di tutte le problematiche del momento. Dovevamo gestirla in termini sociali e ce l’abbiamo fatta. Perché quando i pazienti non sono più rinchiusi e rintanati in una struttura allora devi costruire processi di integrazione del paese.
Jacopo Gibertini: Raccontami per favore come arrivi a questo. Il tuo rapporto con l’antipsichiatria e la legge Basaglia.
AI: La comprensione di tutto parte, per me, verso la fine degli anni ‘70 dove mi arriva fra le mani un libro, che leggo, che si chiama L’io diviso di Laing (edizioni Einaudi, ancora oggi). Avevo 25/26 anni, stavo studiando medicina. Vado a capire chi è Laing, insieme a David Cooper mi intrigano. Erano parte di quella gente che veniva considerata l’antipsichiatria. Non quella di oggi che sono dei beceri ignoranti. Allora l’antipsichiatria era la base di quella che sarebbe diventata la psichiatria sociale.
Cosa diceva l'antipsichiatria? Che i folli non sono dentro al manicomio, ma fuori perché per aderire alle regole di questo modello sociale bisogna essere matti. Che è una posizione estrema, ma come tale riesce a farti vedere le cose in una certa nuova maniera.
Nel ‘78 poi viene approvata la legge 180. Legge Orsini, Basaglia ne fu il consulente. Allora c’era anche questa possibilità d’illuminazione da parte dei democristiani. Uno dei temi fondamentali della legge 180 era la decriminalizzazione del paziente psichiatrico. Banalmente si escluse dal TSO il criterio di pericolosità sociale, riducendolo a criteri esclusivamente clinici.
E questa mi è sembrato un elemento di civiltà, di grande civiltà. I manicomi poi resteranno aperti per altri 20 anni circa, nel ‘98 si arriva alla chiusura completa. Durante questo periodo, a esempio, a Como avvenne ancora qualche ricovero.
JG: A Como quindi c’era ancora la struttura e funzionante?
AI: Io entro nel servizio pubblico nel 1990. Il manicomio era ancora aperto e buona parte dei miei colleghi più anziani venivano dall’esperienza manicomiale. Così anche gli infermieri psichiatrici che dovevano essere forti fisicamente per poter gestire certe situazioni. Qualcuno di questi poi non aveva un grande afflato empatico e capitava che alcune zone del manicomio diventassero pericolose la sera. Per gli infermieri!
Declinare la legge 180 era un bel casino. Questi medici erano tutte persone di grande esperienza, come dicevano loro. Tu arrivavi ideologizzato, coi tuoi capelli lunghi e ti mandavano a cagare in tempo zero. Non ero da solo, ma abbiamo dovuto unirci e studiare. Capire, comprendere cosa volesse dire servizio territoriale.
Noi abbiamo voluto dare al servizio territoriale una logica di presa in carico totale del paziente. Tu sei sul territorio e lui avrà te come riferimento sempre e comunque, per qualsiasi cosa. Se il paziente necessità una visita, lo aiuti fino a prenotargliela tu. Così come si andava per le valli per le iniezioni quando stavo nel CPS di Menaggio. E territorio non è l’ambulatorio. Basaglia diceva che bisogna far entrare in qualche modo la città nel manicomio. Per questo mi piace raccontare l’esempio della Nini.
Abbiamo anche fondato una delle prime comunità della zona, a Montemezzo, nel 1991. Durante la costruzione della casa andavo a prendere 6/7 pazienti con un furgone che aveva ancora il clacson a pedale. Li portavo a Montemezzo durante la costruzione della casa. La logica era quella di una cooperativa orto-floreale, produzione in proprio e altre attività che oggi consociamo perché si sono diffuse. Si trattava di un luogo dove le persone potevano convivere condividendo un quotidiano supportato. Abbiamo anche scritto articoli e fatto un convegno su questo.
JG: Mi piace il fatto che avete dovuto studiare. C’era una teoria e un modo diverso di spiegare la psichiatria a cui avevate accesso, eravate ideologizzati come hai detto tu. Però era una teoria del fare psichiatria irriducibilmente legata alle persone e al territorio. Come lo applichi allora?
AI: L’aspetto di vivacità di quell’epoca è che ognuno diceva “qual è il senso del CPS? (Centro Psico Sociale)”, “qual è il senso di una comunità?”. Dovevamo costruire senso su queste cose. Il reparto psichiatrico - il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) - aveva una sola funzione. Ci ricoveri una persona, fai i colloqui per arrivare a una diagnosi, imposti la terapia e rinvii la persona al servizio territoriale per la continuità delle cure. Lo SPDC poteva e può essere una stazione del percorso terapeutico. La sua funzione è che la persona recuperi delle competenze dopo la fase acuta e di scompenso.
Poi però devi avere una lettura del servizio psichiatrico come rete. In questa rete ci sono dei nodi che sono l’ambulatorio, l’attività domiciliare sul territorio, il CRA (Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza) e le comunità dove fare percorsi più lunghi di risocializzazione. Ognuna di queste realtà doveva produrre un pensiero. Partecipare alla costruzione di una cultura di riferimento che era il modello complessivo. E l’area del territorio era il fulcro della progettualità. Il progetto lo costruivi sulla base di ogni paziente che incontravi, delle sue esigenze, dei suoi bisogni, delle sue criticità e pensando alle strutture a disposizione del territorio.
Nel 1993 entro in reparto a Menaggio. Avevo passato 6 mesi lì in precedenza e mi era piaciuto perché vedevo che si potevano fare delle cose. Al tempo il reparto era gestito da un anziano che aveva una buona filosofia, ma trovavo che l’applicazione fosse carente. Quando lui se n’è andato dopo un anno, il sostituto non c’era e il primario di allora propose a me di prendere la direzione. Io ho detto “sì, se posso fare”. Lui era un illuminato e - a patto che gli parlassi dei miei progetti - mi ha lasciato fare.
Ho recuperato un gruppo di giovani infermieri senza esperienze e abbiamo iniziato a fare riunioni e formazione tra di noi. “Vediamo qual è il modo migliore per poter lavorare qui dentro” ci siamo detti, sulla base delle fantasie che avevamo e del lavoro che volevamo fare. È molto identitaria come cosa. Nel senso che concerne l’identità che ognuno di noi esprime facendo riferimento a sé e al mondo. Come voglio pensarmi lì dentro, come voglio che quel posto venga pensato. Tutti i nodi contribuivano, mi sono venuti dietro in modo esplosivo. Tutti avevano voce in capitolo.
Un giorno ho chiesto al primario illuminato di coinvolgere i familiari. Io stavo facendo la scuola sistemica di terapia della famiglia che prevede un setting di colloquio specifico: lo specchio unidirezionale. In questo modo hai due setting, quello della conduzione del colloquio e quello degli operatori che osservano. Io facevo i colloqui con i pazienti e dietro lo specchio gli infermieri e i familiari si formavano. Registravamo tutto con il loro consenso e quello del paziente e poi lavoravamo tutti insieme su quel materiale. Più teste sono meglio di una si diceva, abbiamo fatto dei lavori bellissimi.
Per avere lo specchio poi avevo avuto qualche difficoltà perché nessuno veniva inviato a costruire la stanza. Così un giorno, con il primario, ci siamo messi a tirare giù la parete! A quel punto l’ospedale ha mandato delle persone a fare il lavoro e abbiamo iniziato.
JG: E i parenti si prestavano volentieri a questo lavoro?
AI: Assolutamente. Eravamo diventati attrattivi, arrivavano pazienti anche da fuori provincia e ci mandavano i casi più impestati. E a noi piaceva perché cercavamo di capire come, in effetti, stessero funzionando le cose lì, in quella persona e in quel contesto familiare.
Noi puntavamo sempre a ridurre il più possibile l’istituzione, a dare un grande supporto ai familiari tirando fuori la persona dal reparto il prima possibile. Il reparto non è che un momento di sgancio in cui ci sistemiamo. Non ha senso se stai bene dentro il reparto. Devi star bene fuori dove c’è il casino. Ci arrivavano tutte le forme di psicosi e dovevi cercare di far sì che il paziente tornasse almeno a galleggiare nel migliore modo possibile, ma nella sua vita quotidiana.
Ti racconto un caso emblematico del lavoro fatto. Arrivano due genitori che avevano ricoverato la propria figlia per mesi in una clinica privata in Svizzera. Volevano valutare come fosse il reparto di Menaggio perché ormai raschiavano il fondo. Menaggio era bellissimo: luminoso, senza il tipico puzzo dolciastro da psichiatria, avevamo camere con vista lago! Se tu sei in un posto dignitoso stai dando dignità alle persone. Avevo anche scritto un articolo, Le mura terapeutiche…
Bene, questa paziente aveva un disturbo ossessivo compulsivo gravissimo. Il suo problema era che qualunque tipo di movimento lei facesse lasciava indietro pezzi di sé. Quindi lei doveva tornare indietro a riprenderli, rifacendo lo stesso movimento, più e più volte.
Abbiamo iniziato a lavorare con l’accordo dei genitori. Anche insieme a loro abbiamo parlato moltissimo con lei cercando di comprenderla. Abbiamo valutato una terapia, modificandola e sistemandola mano mano.
In un mese è passata da non muoversi dal letto – la sua isola – a muoversi e infine tornare a casa con un piano terapeutico e un progetto di psicoterapia, che in quel caso segui direttamente io. Dopo 5 mesi giocava a tennis! Successone! Certo, lei donna intelligente e laureata ha abbassato le sue aspettative professionali. Però si è impegnata, ha fatto del suo meglio riuscendo a vivere una vita più serena.
JG: Un’opinione diffusa e contraria alla legge 180 è quella per cui si è scaricato tutto sulle famiglie. Pensi che questo sia differente dove l’istituzione si adopera verso le famiglie? Non le lascia sole?
AI: Certo, dove questo succede. Sono stato anche responsabile del Servizio territoriale di Como dal 2005. Quando sono arrivato lì ho scoperto che l’ovvio è rivoluzionario.
Ricordo la Presidente dell’associazione delle famiglie dei pazienti psichiatrici arrivare da me entrando adagio con il cappello in mano dicendo “noi siamo i parenti e noi siamo i colpevoli del resto, perché abbiamo prodotto noi il paziente psichiatrico”. Io ho detto “no, voi adesso vi sedete e parliamo perché io ho bisogno di voi!”, “dobbiamo costruire progetti insieme”. Era un contesto che si dimostrava arretrato culturalmente perché abituato al modello ospedaliero, manicomiale.
Dico così ma ho lavorato molti anni in ospedale. Sempre però rimanendo nell’ottica della rete. Io ero un nodo della rete e ogni nodo deve funzionare come si deve. Se anche solo vuoi dare una terapia devi spiegare bene al paziente cosa sta prendendo e perché, devi prenderti il tempo e sapere che ha capito. Come dicono gli analisti con il farmaco si assume anche il medico. E se il medico è un oggetto buono, io assumo un oggetto buono. La famiglia è parte fondamentale di tutto questo, della rete.
JG: In questo rapporto tra istituzione e famiglia mi viene in mente una cosa che ho sentito spesso, cioè che nonostante – anzi contro – Basaglia ci fosse una fetta importante dell’accademia, conservatrice…
AI: La scuola milanese non ha mai amato il modello territoriale. Anche perché nel modello territoriale hai meno potere. Se stai nell’ospedale mantieni potenti i reparti di pischiatria. Era, secondo me, una politica della scuola di Milano quella di favorire il reparto tralasciando il territorio.
Del resto se andavi a Trieste, a Udine o Arezzo trovavi reparti con numeri ridotti di posti letto. A Trieste poi facevano persino la gestione della fase acuta a domicilio. Loro grazie al fatto che lì c’era stato Basaglia riuscivano a fare tutto.
Tu non ti relazioni solo con il paziente. Hai un rapporto con le istituzioni, con i colleghi, con le famiglie e con le città. Se non leggi questa complessità rischi di fare un lavoro come stanno facendo in questo momento.
Nell’anno 2000 eravamo 35 psichiatri in tutta la provincia di Como. Oggi ce ne sono 9 forse 10. È stato chiuso il reparto di Menaggio (nel 2022), stanno chiudendo quello di Cantù. Como avrà 28 posti letto. Pensare ad Arezzo che ne ha 8, Trieste che ne ha una decina ti dice quale livello di arretramento c’è stato. Ed è doloroso perché cosa vuoi fare con 10 colleghi? Arriveranno dei giovani psichiatri, ma qual è la cultura che hanno? C’è un progetto di riproporre una cultura territorialista? Chi la porta avanti? Qualcuno al governo arriva a dire di riaprire i manicomi… io mi incateno.
JG: Pensi che non sia comunque possibile un passaggio culturale tra chi è rimasto e i giovani che arrivano?
AI: In questo momento faccio fatica a pensarlo. Anche perché c’è una fatica generale di chi sta lavorando. L’unica cosa che devi fare adesso è gestire l’emergenza, urgenza per urgenza, non hai tempo di fare altro.
JG: Non pensi che potrebbero essere comunque in atto, in chi si sta specializzando ora, dei nuovi modelli positivi?
AI: Si stanno attivando dei modelli. Devi in ogni caso seguire una scuola di pensiero. Devi comunque approcciarti all’ambito psicoterapico. I milanesi portano avanti però la scuola cognitivo comportamentale. Perché si ritiene sia quella misurabile! Binswanger diceva che la scientificità all’interno della psicologia è il cancro della psicologia. Come puoi pensare di standardizzare l’umano?
Secondo il metodo scientifico quello che io riesco a fare qui, con te, dovrebbe riuscire a farlo un signore negli Stati Uniti con un altro. Non è standardizzabile! È un disastro così come i protocolli di intervento… e i tirocinanti vengono da me dicendo con orgoglio di essere cognitivo-comportamentali.
Va bene, mi dico sempre che son partito sistemico e non so cosa sono ora. Forse è giusto comunque partire da qualcosa, un qualcosa che ti struttura per poi andare oltre.
JG: Quindi in un certo modo i modelli sono utili. Far passare il senso in cui sono nati quei modelli è più difficile?
AI: Devi anche considerare che anche i modelli di patologia psichiatrica si sono evoluti nel tempo. È rarissimo oggi vedere una paziente con una manifestazione isterica di tipo charcotiano. Adesso sono esplosi gli attacchi di panico. Depressioni in quantità notevoli (e c’è da dire che le terapie farmacologiche aiutano molto). Le psicosi sono molto ridotte mentre si ha un aumento vertiginoso delle nevrosi e dei disturbi della condotta alimentare così come delle tossicofilie in comorbilità con le patologie psichiatriche. Un aumento di circa il 30% della casistica, limitandosi a quella misurabile, quindi è una stima per difetto.
Inoltre, è cambiata anche la qualità dei pazienti e in mancanza di una cultura di riferimento anche i modelli organizzativi sono inutili. L’espansione delle sostanze psicoattive, a esempio, l’aumento delle persone intossicate e il relativo aumento delle aggressioni fuori e dentro l’ospedale ne sono un esempio. Il paziente psichiatrico è solitamente dentro a un mondo tale che è difficile riesca a far del male a qualcuno. Al contrario l’intossicato da cocaina o crack può esser molto pericoloso.
Senza un’organizzazione basata sul territorio di riferimento, si cerca poi di scaricare i pazienti socialmente pericolosi sui reparti di psichiatria o sulle CRA (Comunità Riabilitative ad Alta Assistenza). Questo è uno degli effetti del non aver pensato strutture adeguate dopo la chiusura degli Ospedali giudiziari. Quando lavoravo in ospedale c’era una lista di attesa di 70 pazienti per le REMS. Il reparto era diventato l’anticamera delle REMS, ma questo è pericolosissimo e io mi sono sempre opposto.
Torno alla tua domanda. Far passare il modello è una questione più delicata. Sono stato richiamato in servizio per sostenere l'ambulatorio per i disturbi della condotta alimentare, ma credo che a dicembre di quest’anno mi fermerò, in fondo sono un pensionato. Poi credo anche che probabilmente, se arriva il nuovo psichiatra, continuerò a lavorare per affiancarlo nel passaggio. Se mi sta simpatico. Nel frattempo passerò le prossime settimane a costruire un modello per i disturbi del comportamento alimentare. Mi aiuterà la dottoressa Floris, psicoterapeuta con cui lavoro da tempo. Sarà un modello territoriale perché è a casa che ci sono i problemi.
Franco Basaglia e la legge 180: frammenti dello scenario sociale e politico
Franco Basaglia nasce a Venezia nel 1924, un anno e mezzo dopo la presa di potere fascista.
Cresce e studia tra regime fascista e Seconda guerra mondiale. Consegue la maturità classica nel 1943; poi, si iscrive a medicina a Padova, dove svolge anche attività antifascista, che lo porta all’arresto, nel dicembre del 1944. Resta in carcere fino ad aprile del 1945, alla fine della guerra.
Nel 1949 si laurea in medicina e inizia la pratica clinica nel dipartimento per le malattie nervose e mentali di Padova, studia con Roberto Belloni, pioniere della neurofisiologia clinica, della neurochimica applicata e della neuroradiologia, base diagnostica delle neuroscienze cliniche padovane.
Negli anni dell’Università e della pratica clinica si dedica anche allo studio filosofico, all’esistenzialismo di Sartre, alla psichiatria fenomenologia di L. Binswanger.
Nel 1953 si specializza in malattie nervose e mentali e sposa Franca Ongaro, che – a differenza di quanto spesso si pensa – non era medica, né psicologa, ma letterata. Con lei lavora per tutta la vita.
Dal 1953 al 1961, assistente di Belloni a Padova, si dedica alla ricerca e alla pratica clinica, come; nel 1958 ottiene la libera docenza in psichiatria.
Il 1961 è l’anno della svolta: Franco Basaglia inizia il rivoluzionario lavoro di direzione dell’ospedale psichiatrico di Gorizia.
Tra il 1961 e il 1970 visita una comunità terapeutica di Maxwell Jones in Scozia e le esperienze di apertura francesi. Nel 1967 cura il volume Che cos'è la psichiatria? e nel 1968 L'istituzione negata. Rapporto da un ospedale psichiatrico, che racconta l'esperienza di Gorizia.
Tra il 1970 e il 1971, dirige – per poco tempo – la struttura psichiatrica di Colorno, vicino a Parma e, nel 1971, accetta la direzione dell’ospedale psichiatrico di Trieste, enorme struttura che sorge sul colle di San Giovanni e ospita 1182 malati di cui 840 sottoposti a regime coatto.
Trieste è il luogo in cui mette in pratica, in modo ampio e completo, il suo approccio di normalizzazione della malattia mentale e di apertura dell’ospedale psichiatrico alla città e della città all’ospedale psichiatrico.
Nel 1973 fonda la Società Italiana di Psichiatria Democratica; nello stesso anno l’Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce Trieste come zona pilota per la ricerca sui servizi per la salute mentale.
Il 1978 è l’anno in cui il suo approccio prende forma in termini istituzionali con l’approvazione della legge 13 maggio 1978, n. 180 - la Legge Orsini, chiamata quasi sempre Legge Basaglia – che abroga quasi completamente la legge del 14 febbraio 1904, n.36 e che impone la chiusura dei manicomi, regolamenta il trattamento sanitario obbligatorio e istituisce i servizi di igiene mentale pubblici.
Franco Basaglia nel 1980 prende servizio come coordinatore dei servizi psichiatrici della Regione Lazio – dove potrebbe mettere in pratica il modello di psichiatria aperta e territoriale ma, colpito da un tumore, muore nel mese di agosto, a 56 anni.
FRAMMENTI DI CONTESTO SOCIALE ED ECONOMICO
Per comprendere “dove e come” nascono ed evolvono il pensiero e l’opera di Franco Basaglia e dei suoi colleghi, abbiamo provato a isolare alcuni frammenti di contesto che esemplificano quale fosse lo stile di pensiero che ha accompagnato questa evoluzione.
FRAMMENTO #1– IL REGIME FASCISTA
Franco Basaglia studia tra fascismo e Seconda guerra mondiale e viene incarcerato per alcuni mesi tra 1944 e 1945, per attività antifascista. È il periodo in cui, gli eccessi fascisti e nazisti, le leggi razziali e la repressione politica stimolano il desiderio di libertà. Durante il regime fascista le libertà fondamentali, di parole, di movimento, di educazione e di professione sono negate e il manicomio – più che nel passato -è usato come strumento politico, di contenimento, non solo della cosiddetta devianza sociale e mentale, ma anche della opposizione politica.
Un caso emblematico è quello di «Giuseppe Massarenti, leader del movimento bracciantile emiliano e poi sindaco socialista di Molinella – ricordato come il Santo del Socialismo italiano – fu mandato al confino nel 1926 e da lì seguirà un doloroso processo di impoverimento e di caduta nella marginalità che si concluse con il trasferimento alla Clinica delle malattie nervose e mentali di Roma prima e al celebre ospedale psichiatrico della capitale – il Santa Maria della Pietà – poi. Delirio paranoico la prognosi. Un classico» (Petracci M., I matti del duce. Manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, 2014, Donzelli, XVIII, p. 238).
Durante il regime di Mussolini il numero di reclusi psichiatrici quasi raddoppia rispetto ai decenni precedenti, i manicomi italiani passano ad ospitare da 55 mila (dati del 1920) a 95 mila persone (dati del 1941)[1]
FRAMMENTO #2 – L’IMMEDIATO DOPOGUERRA
Il periodo della laurea e degli studi per la specializzazione scorre tra la fine della guerra e i primi anni ’60. Sono gli anni del boom economico, della scoperta del benessere, in Italia, per (quasi) tutti, della condanna delle miserie come quelle dei Sassi di Matera (la visita di P. Togliatti a Matera è del 1948), dell’affermazione di una nuova economia industriale – della Fiat che “importa” manodopera dal sud del Paese, della “fabbrica aperta” di Adriano Olivetti; sono anni in cui – sollevata dall’oppressione del regime, dalle disgrazie della guerra e dalla miseria delle difficoltà economiche - la società italiana può pensare anche a cose marginali: i matti e la malattia mentale, per esempio, le modalità coercitive in cui vengono trattati.
Nel 1957 Sergio Zavoli realizza il documentario radiofonico Clausura all’interno di un monastero di clausura delle Carmelitane scalze e – intervistando Padre Rotondi, cita Pio XII che, nell’enciclica Sponsa Christi aveva definito non più tollerabili certi disagi in cui vivono le monache di clausura.
Questo atteggiamento – però - non sembra toccare la facoltà di medicina di Padova e – in particolare – l’istituto di malattie nervose e mentali, diretto da Belloni, che era «intriso di positivismo scientista e lombrosiano […] fedele alla tesi organicistica che vede la malattia mentale come la conseguenza di tare biologiche congenite».
In quegli stessi anni, la fenomenologia e l’esistenzialismo dominano la scena filosofica e si spingono all’interno del perimetro della psicologia, della medicina, della psichiatria.
FRAMMENTO #3: GLI ANNI ’60, FINO AL 1968
Il periodo in cui Basaglia dirige l’ospedale psichiatrico di Trieste, tra il 1961 e il 1970, è quello in cui maturano le istanze che sfoceranno nella “rivoluzione” del 1968.
È un vero e proprio tentativo di rovesciamento del paradigma sociale, in cui la tradizione e la conservazione dei valori borghesi della fine del XIX secolo e anche del primo dopoguerra – gli stessi valori di ricerca del benessere economico che hanno favorito l’attenzione ai marginali – vengono messi in crisi.
Sono gli anni in cui si parla, si scrive, si canta e si urla – nelle manifestazioni e nei momenti di lotta - di immaginazione al potere, di libertà da ogni costrizione – culturale, sociale, sessuale.
È nel 1968 che il Ministro della Sanità Luigi Mariotti firma la Legge di riforma psichiatrica che porta il suo nome e che abolisce l’obbligo di iscrizione nel Casellario giudiziale e prevede la possibilità del ricovero volontario e i Centri di Igiene Mentale con equipe multi professionali composte da psichiatri, psicologi, infermieri, assistenti sociali [2]
Sono gli anni in cui inizia la fine del boom economico e – sulla scia del libertarismo del ’68 – si affermano le istanze di rivendicazione economica e sociale dei lavoratori delle fabbriche, sostenuti da ampie schiere di studenti liceali e universitari.
Nel 1968, ancora Zavoli, “entra” nel manicomio di Gorizia con le telecamere di TV7 a documentare
FRAMMENTO #4: DAL 1968 AL 1978
Negli anni tra il 1968 e la promulgazione della Legge 180 accadono fatti che possono essere ricordati come elementi rilevanti per la formazione del pensiero di Basaglia e del suo gruppo di co-pensatori, per il favore che questo pensiero può trovare tra società e contesto politico.
Si tratta – ad esempio - della crescita di consenso del Partito Comunista Italiano, che nel 1976 raggiunge il 34% delle preferenze, guadagnando quasi 10 punti percentuali e 5 milioni di voti rispetto al 1963, a solo 4 punti dalla Democrazia Cristiana.
Si tratta anche del tentativo di rovesciare il paradigma di contrapposizione partitica tra DC e PCI, che aveva dominato fino ad allora, attraverso la formula del compromesso storico che si sostanziò prima nel governo di solidarietà nazionale (1976), a guida Andreotti, e nell’ipotesi di entrata del Partito Comunista nella compagine del successivo governo, studiata da Enrico Berlinguer e da Aldo Moro e sostenuta da Zaccagnini. Il compromesso storico naufragò proprio nel 1978 con il rapimento e la successiva uccisione di Aldo Moro.
Sono anche gli anni del sindacalismo, della promulgazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300 nota come Statuto dei lavoratori, che riconosce formalmente e in maniera organica una serie di diritti ai lavoratori di tutti i comparti, diritti fino ad allora spesso negati o ignorati, a partire dal Diritto all’opinione (Art. 1 della Legge Cit.) e del diritto all’Assemblea Sindacale, considerata in molti casi un atto di sedizione.
E del contro-sindacalismo: nel 1969 vengono ufficialmente riconosciuti i consigli di fabbrica; Alla fine del 1970 i CdF sono già 1.374 con 22.609 delegati: nel 1971, 2.566 con 30.493 delegati, nel 1972 un totale di 83.000 delegati; non mancano - però – le forme di opposizione da parte di alcune frange sindacali, che vedono nel Consiglio di Fabbrica un sistema per ingabbiare la protesta e suggeriscono mezzi di espressione con base più ampia e – in alcuni casi – modi più aggressivi.
Le assemblee sono un elemento chiave dei due decenni che seguono il 1960: note solo come momenti di aggregazione partitica o di movimento – molto spesso clandestine - diventano in breve tempo uno degli strumenti teoricamente portatori di democrazia più diffusi nelle fabbriche, nelle aziende, nelle scuole e nelle università; tutto si discute in assemblea, tutto si decide in assemblea, tutti i leader vengono nominato o acclamati in assemblea.
Le assemblee sono un modo per fare sentire la propria voce, per fare partecipare, per sentirsi liberi; Libertà è partecipazione, canta Giorgio Gaber nel 1972.
Far sentire la voce di chi non l’ha mai avuta in pubblico è anche uno dei momenti – chiave delle prime radio libere “impegnate”[3], che fanno intervenire gli ascoltatori al telefono in diretta.
Tra le voci che conquistano il diritto ad essere – finalmente – ascoltate ci sono quelle delle donne che, ad esempio, nonostante dure opposizioni interne, conquistano una propria progressiva rilevanza all’interno dei movimenti sindacali verso la metà degli anni ’70; e lo fanno con assemblee e comitati femminili, non contrapposti ma paralleli a quelli sindacali ufficiali.
E, a Verona, nel 1976, si svolge il primo processo per stupro in cui la vittima rifiuta di interpretare il ruolo passivo di “oggetto” della violenza sessuale per diventare “soggetto” di un’accusa che trascende i suoi stupratori, spiegando quanto la sua vicenda “personale” sia in realtà “politica”. In aula la ragazza è sostenuta dalla presenza di un coordinamento di gruppi femministi e la sua voce – non più silenziata come nei casi analoghi – si fa sentire in una dimensione pubblica, grazie alla copertura dei media più tradizionali e della televisione, che ne fa un documentario trasmesso in prima serata alla fine di ottobre dello stesso anno.
-----------
È in questo scenario o, meglio, questo susseguirsi di scenari sociali e politici – delineato in pochi tratti a cui manca sicuramente molta “storia” – che si forma l’esperienza e la rivoluzione di Franco Basaglia, di Franca Ongaro, di Giovanni Jervis e dei loro colleghi.
Idee ed esperienze che attingono anche a quella che fu chiamata da Pasolini – e non a torto - «ubriacatura di astrazione teorica» ma che ha sicuramente segnato la trasformazione della società italiana dal dopoguerra alla fine degli anni ’70.
NOTE
[1] Cfr. Petracci M., Cit.
[2] Reggio Emilia è in prima fila nell’avvio dell’esperienza territoriale e nel 1968 la Provincia apre i primi Centri di Igiene Mentale, affidati dal 1969 a Giovanni Jervis, psichiatra che aveva lavorato con Basaglia a Gorizia.
[3] Cfr. F. Monteleone, Storia della radio e della televisione in Italia, Feltrinelli, 2021
Epistemologia e clinica (oltre la politica) in Franco Basaglia
“Basaglia” è il nome di una rivoluzione quasi universalmente riconosciuta, anche se poco o nulla applicata fuori dall’Italia. I dibattiti sulla legge 180, sulle sue luci impossibili da spegnere, ma anche sui suoi limiti attuali, si susseguono ciclicamente. Spesso il Basaglia clinico tende a essere offuscato dalla, giustamente celebre, portata politica della sua battaglia e del suo gesto. Eppure, clinica e politica, in lui, sono legati.
Figlio della tradizione della psichiatria fenomenologica, esistenziale, dasein-analitica, in lui sono costanti i riferimenti a pensatori ritenuti fondamentali fino agli anni 60’-70’, e oggi un po’ in ombra, come Sartre, Heidegger, Merlau-Ponty, Husserl, Biswanger. Autori politici, ognuno a suo modo, da cui Basaglia trarrà i propri echi; correnti di pensiero appunto, non solo strettamente filosofiche, tali da investire tutti i campi delle scienze cosiddette “umane”.
La psichiatria è chiaramente una scienza limite, avendo come oggetto qualcosa di eternamente sfuggente come l’umano, rimanendo con un piede o entrambi, all’interno di un’altra scienza limite, cioè la medicina.
Medicina: sapere, tecnica, che unisce arte, nel senso ippocratico, e scienza transitata nella cornice del moderno. E sullo psi della iatreia (cura), su cosa sia o come sia quella psyché a salire fino alla nostra “psiche” o “mente” la risposta non è definitiva.
Tantomeno sulle sue malattie e le sue cure. Ne consegue che teoria e prassi, epistemologia e azione sono indissociabili; di qui, il problema storico, sociologico e infine politico non cesserà mai di ripresentarsi.
In Un problema di psichiatria istituzionale e testi vicini (L’ideologia del corpo, Corpo, sguardo e silenzio, ecc), l’originalità dell’intreccio che presenta Basaglia è evidente: emerge una teoria della clinica come specchio di una teoria politico-critica.
Il sottotitolo è eloquente: L’esclusione come categoria socio-psichiatrica. Da un punto di vista di filosofia politica, o anche socio-antropologico, la categoria dell’escluso è inerente a ogni società, e in particolare in quelle dove siano presenti divisioni gerarchiche.
Il capro espiatorio è quel “dispositivo” (politico, sociologico, antropologico) in cui le contraddizioni di una società vanno a concretizzarsi, scaricando l’aggressività che esse comportano.
Ma il malato mentale ha una sua peculiarità: egli è posto fuori dalla dialettica. Quelli che oggi chiameremmo “gruppi marginalizzati” hanno sempre avuto un potenziale attivo di rivolta. Il malato mentale è una figura più enigmatica: se Foucault voleva dare parola alla follia, è perché essa non parla mai in modo univoco, e dunque è al confine col silenzio; ma se il malato mentale è ridotto all’espressione della propria malattia, confine sempre aperto, la sua stessa parola sarà puro silenzio.
Così funziona la realtà di quest’esclusione peculiare: ogni parola di risposta, di tentativo di dialettica, è nuovo rinforzo, motivo per prolungare l’esclusione.
Il tutto comporta per Basaglia, che egli è all’interno della sua stessa epistemologia, cioè nel dispositivo per dire e poi curare, trattare, la follia come malattia mentale. Comporta che la psichiatria può trovare le leve per dialettizzare il malato. Le parole quasi d’ordine dell’impianto degli autori sopracitati sono imperniate intorno alla soggettività, alla libertà, al corpo, alla scelta.
Il problema centrale per quest’approccio è la questione della scelta, scelta di sé come libertà e dell’angoscia che questa comporta, eco esistenzialista, la cui difesa primigenia è l’esclusione. Ma non solo: l’altro da sé è anche la propria “fattità”.
Fattità che si è come corpo, “corpo oggettuale”, opacità, passività, nonché soggetto delle percezioni, corporeità con cui si è nel mondo (Merleau-Ponty), di cui ci si deve appropriare per essere soggetti di scelta propria, cioè per soggettivarsi.
L’opacità è anche, specularmente, quella dell’altro. Dunque, incorporare la propria estraneità è parte dello stesso processo del riconoscere l’altro come altro da sé. Non solo come oggetto, come “concretizzazione” dell’estraneità che si rifiuta, ma come a sua volta luogo di una soggettività. Corpo oggettuale, ma anche – husserlianamente – centro di un “io fungente”.
Al contrario, la mancata appropriazione della propria opacità corporea – della vulnerabilità, della materialità – dell’essere corpo-oggetto sia di se stessi sia dello sguardo altrui porterà alla sua esclusione nell’altro divenuto “osceno”. Altro incomprensibile e dunque riducibile soltanto a oggetto, così come a oggetto dell’altro si è sempre ricondotti in questa dinamica.
La genialità di Basaglia, nell’intrecciare clinica e politica, sta qui nel proporre una diagnosi strutturale tra nevrosi e psicosi, capisaldi freudiani, come due modi di essere-nel-mondo con connotazione politica: esclusione ideologica e utopia psicotica. Se per Freud il conflitto centrale della prima è tra Io ed Es, per accettazione del mondo esterno, quello della seconda tra Io e mondo esterno, per lo strabordare dell’Es, qui il conflitto è frutto di un’esclusione del reale.
Per il nevrotico tale esclusione è ideologica, nel senso che non v’è rinuncia a un rapporto con l’altro, ma comunque rifiuto della propria contingenza, dell’ansia derivante dalla scelta di sé e dell’appropriazione del proprio corpo.
Come risposta – o difesa – edificherà un’ideologia, un’immagine “ideale” del corpo, con cui controllarne l’opacità, potendosi per lo meno relazionare con l’altro per il quale avrà comunque una certa oblatività.
È sull’altro e nel desiderio di essere accettato, che egli la edificherà. Pagando questo al prezzo di un’angoscia che produce inibizione, indeterminazione, restringimento.
L’altro è dunque mantenuto nella sua soggettività, sempre nel filtro di un’ideologia che lo conduce alla malafede sartriana.
Per lo psicotico, invece, il rifiuto è ben più radicale. Il risultato di questo processo non è la costruzione di un’ideologia, ma di un’utopia.
La contestazione che il reale continua a far irrompere, reale come opacità, viene a tal punto mal tollerata che è solo nel delirio – cioè in una costruzione sganciata dall’altro, dal “co-mondano” – che uno psicotico potrà trovare una sorta di stabilizzazione e controllo.
Ma proprio lì è un mondo senza limiti, sotto la costante minaccia di quell’angoscia che non cesserà di tormentarlo, divenendo sempre più schiacciante e distruttiva con conseguenti difese estreme.
Se la terminologia politica è qui esplicita, diviene evidente il problema politico dei manicomi: alla regressione psicotica viene aggiunta, intrecciata, una regressione istituzionale. All’esclusione che il malato opera si aggiunge l’esclusione che la società opera su di lui attraverso le mura del manicomio, difesa non del malato, ma dei sani.
L’opacità, l’incomprensibilità del malato di mente, è ridotta a pericolosità sociale. Egli rimane quell’“osceno” (fuori-scena) privo di qualunque soggettività. Alla malattia si sovrappone dunque una malattia indotta direttamente dall’istituzione, in un circolo vizioso in cui le due diventano indistinguibili, fortificandosi a vicenda e giustificando quindi l’apparato manicomiale.
Il restringimento dell’Io – il rimpicciolimento, il rinchiudersi della soggettività, a cui già fa fronte il malato – è speculare al risultato di quella “carriera morale” a cui è sottoposto dall’istituzione disciplinare. L’Io è ridotto a spettro, uomo privato di tutto, homo sacer o musulmano di Auschiwtz, seguendo la concettualizzazione successiva di Giorgio Agamben: non a caso c’è riferimento esplicito a Primo Levi.
È qui che si innesta una specifica teoria del potere: rifiuto dell’autorità o dell’autoritarismo, ma non rifiuto del potere tout court. Perché il potere contiene in sé anche lo spazio di una dialettica, che non si riduca a quella servo-signore hegeliana.
Da questo breve excursus si può notare come epistemologia, clinica e politica non siano dissociabili. Al netto dell’impossibilità di liberarsi della contingenza, in particolare storica, quando si tratta della prassi, Basaglia offre un originale e si spera non dimenticato esempio di questo gesto di annodamento.
Neuroscienze e giudizio morale - Emozione e razionalità appartengono a sistemi distinti?
L’oggetto di questa controversia è il modello di funzionamento dei correlati neurali dei giudizi morali.
Nell’ambito delle neuroscienze (vedi i due articoli precedenti: Il libero arbitrio oltre il dibattito filosofico – Incontro con le neuroscienze e Incontri con le scienze empiriche) sono stati fatti numerosi studi che si appoggiano alle tecniche di neuroimaging funzionale, seguendo tre filoni principali di lavoro:
- Lo studio di pazienti con danni o lesioni cerebrali e pazienti con patologie psichiatriche (“Bad brains”, Greene 2014a, 2020);
- L’analisi della valutazione morale di certi atti o situazioni da parte di individui sani (“Good brains”, ibid.);
- Lo studio delle modificazioni cerebrali durante la valutazione di dilemmi morali come il Trolley dilemma, il Footbridge dilemma e il Crying Baby dilemma.
Per contestualizzare meglio, ecco qualche definizione e informazione sugli studi con pazienti con lesioni cerebrali e sui tre principali dilemmi morali:
PAZIENTI CON LESIONI CEREBRALI
Le ricerche su pazienti con lesioni cerebrali o patologie psichiatriche offrono dati interessanti per l’indagine sul coinvolgimento di determinate aree del cervello nella realizzazione di varie funzioni cognitive.
Qualsiasi studio relativo a pazienti con lesioni cerebrali connesse alla sfera del comportamento sociale non può non fare riferimento al lavoro di Antonio Damasio. La sua prima opera divulgativa, “L’errore di Cartesio” (1994), è un’esposizione delle ricerche sull’emozione a livello cerebrale e le loro implicazioni in ambito decisionale, soprattutto nella sfera del comportamento sociale. Tali ricerche hanno preso avvio dall’osservazione di soggetti con lesioni alla corteccia prefrontale ventromediale, i quali mostrano un comportamento atipico soprattutto in relazione al giudizio etico e alla condotta sociale. Come sostenuto da Damasio, sembra che questi individui abbiano una “razionalità menomata”, nonostante gli elementi associati convenzionalmente a un buon funzionamento della ragione non siano in alcun modo danneggiati. Tra questi ultimi in genere figurano: la memoria, l’attenzione, il linguaggio, la capacità di calcolo e la capacità di ragionamento logico per problemi astratti (Damasio, 1994, pp.18-19). Il primo caso storicamente registrato di questo tipo di lesioni è quello di Phineas Gage, caposquadra di un gruppo di costruzioni ferroviarie, vissuto in America durante il XIX secolo, e il cui teschio è oggi conservato a Boston, al Warren Medical Musem della Harvard Medical School.
TROLLEY DILEMMA
Il Trolley Dilemma o Dilemma del carrello, proposto originariamente da Philippa Foot nel 1967, descrive un treno che corre senza controllo su un binario dove più avanti sono legate cinque persone, mentre su un binario alternativo c’è una sola persona legata; il quesito è se sia legittimo tirare una leva in modo da deviare il treno sul secondo binario e uccidere una sola persona anziché cinque. Generalmente, le persone tendono a considerare moralmente accettabile tirare la leva in virtù di un’analisi costi-benefici.
I protagonisti della controversia sono tre neuroscienziati: da una parte lo psicologo statunitense J. Greene; dall’altrail filosofo statunitense Shaun Nichols e il filosofo tedesco Hanno Sauer. Essi si concentrano soprattutto sul terzo tipo di studi.
FOOTBRIDGE DILEMMA
Il Footbridge Dilemma è stato formulato da Judith Jarvis Thomson nel 1976 e descrive una situazione analoga alla precedente ma, anziché avere la possibilità di tirare la leva, si chiede se sia legittimo buttare giù da un ponte che passa sopra il binario un uomo molto grasso, il quale fermerebbe il treno perdendo al tempo stesso la vita. In questo caso le persone non considerano moralmente accettabile compiere l’atto, nonostante secondo un’analisi costi-benefici il risultato sarebbe lo stesso del problema precedente. Quindi, i soggetti a cui viene sottoposto i test tendono a ritenere accettabile deviare il treno nel primo caso, ma non ritengono lecito spingere l’uomo dal ponte (Songhorian, 2020, p.77). Perché le persone rispondono in modo diverso ai due scenari?
CRYING BABY DILEMMA
La formulazione del Crying Baby dilemma è la seguente: “In tempi di guerra tu e alcuni concittadini vi state nascondendo da dei soldati nemici in un seminterrato. Tuo figlio comincia a piangere e tu gli copri la bocca per far sì che non se ne senta il suono. Se togli la mano il bambino piangerà, i soldati lo sentiranno, troveranno te e i tuoi compagni e uccideranno tutti quanti, compreso te e il tuo bambino. Se non togli la mano, tuo figlio morirà soffocato. È legittimo soffocare tuo figlio per salvare te stesso e gli altri?”
GREENE e il modello della “macchina fotografica” o del doppio processo
Joshua Green ha dedicato gran parte del suo lavoro all’approfondimento del perché i dilemmi del carrello, Footbridge e Crying Baby, apparentemente simili nel risultato, suscitano risposte diverse e reazioni discordanti nei soggetti a cui vengono sottoposti.
Uno dei punti chiave dell’analisi è il fatto che i dilemmi presentano forme diverse di problematiche morali, che interessano in modo differenziato l’area delle “violazioni personali” - violazioni che comportano un grave danno fisico, ad una persona specifica, in modo che il danno non sia il risultato di un effetto collaterale di un’azione rivolta altrove (come dire: “io danneggio te”), e quella dei temi morali impersonali - quelli dell’utilità generale, per esempio, meno coinvolgenti nell’immediato.
Greene ha provato ad osservare, attraverso le tecniche di neuroimaging funzionale, l’attività cerebrale degli individui mentre cercano di rispondere a questi dilemmi.
I risultati del neuroimaging, con tempi diversi – più rapidi per i problemi che implicano le violazioni personali” e più lenti negli altri casi - e aree cerebrali coinvolte diverse, hanno suggerito a Greene che nel giudizio morale vi sia una dissociazione tra i contributi affettivi e quelli cognitivi, e che le persone tendano a esprimere i loro giudizi morali sulla base di due sistemi cerebrali distinti, uno più emotivo e un altro più razionale. Questa distinzione è stata corroborata – secondo Greene – anche dal fatto che sembra esserci una correlazione tra i sistemi cerebrali e il tipo di giudizi che questi producono: le aree del cervello associate all’emozione tendono a suscitare giudizi impulsivi che prendono la forma di giudizi deontologici, quindi giustificati in termini di diritti e doveri; le aree del cervello associate al ragionamento producono, invece, giudizi fondati su un’analisi costi-benefici.
Green propone, quindi, il modello della “macchina fotografica”; in analogia con le due modalità di funzionamento della fotocamera (una modalità automatica e una manuale, ciascuna con caratteristiche più adatte ed efficienti in situazioni diverse); così l’essere umano giudica moralmente servendosi di due processi differenti, di due sistemi cerebrali distinti che non possono funzionare congiuntamente, ciascuno dei quali funziona meglio in determinate circostanze.
Secondo Greene, l’analogia con la macchina fotografica è in grado di esprimere anche il compromesso tra efficienza e flessibilità di questi sistemi cognitivi: le risposte emotive, infatti, sono efficienti proprio in quanto istintive, mentre le risposte razionali sono flessibili perché si servono del ragionamento per perseguire obiettivi a lungo termine, prevedendo e programmando i comportamenti necessari. L’autore ritiene che a supporto dell’idea che le aree emotive siano automatiche c’è il fatto che sono le stesse aree che presentano attività quando il cervello è a riposo o, come anticipato, quando è coinvolto in attività non tipicamente di “attenzione”. Per queste ragioni, solo le azioni che derivano da giudizi razionali sarebbero da ritenersi pienamente consce, volontarie e frutto di uno sforzo.
Le teorie alternative e concorrenti: Nichols e Sauer
Shaun Nichols propone una teoria che integra il ruolo dei due sistemi, basata su due tipi di studi empirici fondamentali (Songhorian, 2020, pp.88-95): il primo, che ha per oggetto la distinzione tra norme morali e norme convenzionali, definisce come non necessario presupporre una teoria della mente per tale distinzione poiché i bambini autistici, i quali non hanno buone capacità di comprensione degli stati mentali altrui, rispondono allo stesso modo dei bambini a sviluppo tipico nei test di riconoscimento dei due tipi di violazione; il secondo è quello relativo ai deficit di empatia degli psicopatici.
Nichols – a differenza di Greene - ritiene che vi siano due componenti integrate che costituiscono i giudizi morali: un meccanismo affettivo (che si attiva quando vediamo o sappiamo che gli altri soffrono) e una teoria normativa che impedisce di danneggiare gli altri.
Inoltre, egli definisce come teoria normativa qualunque insieme di regole interiorizzate che proibiscono certi comportamenti e afferma che sia possibile riscontrare la presenza di questi elementi in tutti quei giudizi che sono condivisi in maniera universale e transculturale.
In tal modo rende conto del perché gli psicopatici e i bambini prima dei due anni non siano in grado di formarsi giudizi morali; infatti, i bambini non dispongono di una teoria normativa e gli psicopatici non hanno un meccanismo emotivo concomitante tale teoria.
Sauer sviluppa la sua idea a partire dai risultati degli esperimenti di Greene sul dilemma dell’incesto consensuale; secondo Sauer, il fatto che dopo un tempo adeguato le persone ritengano accettabile l’incesto tra fratello e sorella è indicativo del fatto che le nostre intuizioni morali sono soggette al ragionamento razionale.
Quello di Sauer è un modello di “sfida e risposta”, per cui le intuizioni morali “sono soggette a continui miglioramenti, sovra-apprendimento e abituazione” (Sauer, 2017, p. 122, citato in Songhorian, 2020, p. 103).
A giudizio di Sauer, i nostri giudizi morali nascono da delle intuizioni emotive che possono essere integrate e corrette dalla riflessione e dal ragionamento, i quali vengono sollecitati proprio in risposta a una sfida; tuttavia, non sono solo frutto di un processo evolutivo soggettivo, ma anche socio-culturale. In questo modo riesce a integrare il ruolo di emozione e ragione nella cognizione morale e rende anche conto del processo evolutivo dei giudizi morali.
Differenze tra le tre teorie
Le teorie di Nichols e Sauer propongono entrambe una concezione non oppositiva di emozione e ragione, anche in linea con le tesi di Damasio, ma differiscono nei loro obiettivi polemici: il primo vuole mostrare che anche le regole morali devono essere sentimentali; il secondo compie il percorso inverso, cercando di mostrare che anche l’emozione ha bisogno del supporto del ragionamento (Songhorian, 2020, pp. 102-106).
Ciò che distingue queste teorie da quella di Greene è il fatto che gli autori in questione considerano i giudizi morali dei “processi”, in una prospettiva diacronica; mentre Greene li ritiene degli stati mentali puntuali, e non tiene, quindi, conto del loro carattere evolutivo, del perché i valori morali si modifichino nel corso della storia e del perché anche i singoli individui possano mutare prospettiva nei loro giudizi morali.
Conclusione
Le neuroscienze cognitive ci offrono oggi molte possibilità di approfondimento di svariate questioni filosofiche estremamente affascinanti e antiche, ma è evidente che siamo ancora agli inizi di questo nuovo approccio e le teorie che ne emergono devono ancora molto alla dimensione di costruzione sociale e – in alcuni casi – metafisica.
Dal confronto di queste tre prospettive sui giudizi morali sembra emergere anche l’enorme discordanza e opacità che vi è oggi in molte definizioni metaetiche; non certo fonte di scoraggiamento ma, anzi, indice del fatto che c’è un ampio spazio per nuove riflessioni filosofiche e sociologiche.
Che gusto ha studiare il cannibalismo? - Un punto di vista sociologico (seconda parte)
Nel titolo del mio saggio un altro termine chiave è questioni di genere, da intendere semplicemente come la variabilità con la quale si viene definiti uomo o donna e correlata all’orientamento sessuale. Questi due aspetti sono stati essenziali per questa opera, poiché sono stati utilizzati per scegliere ed analizzare 5 soggetti cannibali: Leonarda Cianciulli la Saponificatrice di Correggio, Andrej Romanovič Čikatilo il Mostro di Rostov, Dmitry Baksheev e Natalia Baksheeva la Coppia cannibale, Jeffrey Lionel Dahmer il Mostro di Milwaukee e Armin Meiwes il Cannibale di Rotenburg an der Fulda.
I primi quattro soggetti menzionati possono essere definiti serial killer, ricordando che serialità è la terza parola chiave del titolo della mia opera, poiché un serial killer è un soggetto che compie almeno tre omicidi tra i quali intercorre un periodo di raffreddamento emozionale, il cui agire sottende un insieme ampio e variegato di pulsioni sessuali devianti, tali da indurre, soventemente, durante l’omicidio, anche il coito. Poiché sono soggetti che agiscono sotto l’influsso del desiderio sessuale, sono incapaci di smettere di uccidere, a meno che non sopraggiunga un evento esterno alla loro volontà: l’arresto o la morte. Armin Meiwes, invece non è un serial killer avendo ucciso una sola vittima.
Vediamo alcune principali caratteristiche.
Leonarda Cianciulli, la Saponificatrice di Correggio, uccise 3 donne, le fece a pezzi per poi ricavarne del sapone, mentre il sangue lo raccolse, lo essiccò per poi farne biscotti che mangiò lei stessa con diversi conoscenti. Nel caso di questa donna, per esempio vi sono elementi tipicamente maschili: l’utilizzo di armi come un martello e una scure, l’atto di sezionare i corpi, ecc. A suo dire fece tutto ciò per annullare una maledizione che le aveva lanciato sua madre, e avendo perso molti figli temeva che gli unici in vita potessero fare la stessa fine.
Andrej Romanovič Čikatilo, il Mostro di Rostov, uccise tra 53 e 56 vittime tra bambini, disabili e giovani donne, cibandosi di diverse parti dei loro corpi, con modalità omicidiarie tra le più brutali ed efferate nella storia della criminologia del cannibalismo. Era solito accanirsi sui polmoni, il cuore e gli organi sessuali; in particolare, asportava e divorava i genitali delle vittime ancora in vita; sembrerebbe aver strappato a morsi e masticato la lingua, il labbro, il naso e i capezzoli di alcune sue vittime. Inoltre, si cibò dell’utero di una donna dove aveva precedentemente rilasciato il suo seme. Dunque, nel suo caso vi sono elementi tipicamente maschili nel modus operandi.
Dmitry Baksheev e Natalia Baksheeva, la Coppia cannibale, il loro caso è uno dei più recenti. Dalle dichiarazioni rilasciate, avrebbero non solo cannibalizzato più di 30 persone, ma anche parte di queste per delle ricette utilizzate per dar da mangiare ai militari nella mensa in cui lavorava Natalia. Nella strutturazione di questa coppia, le questioni di genere sono interessanti. Il loro modo di agire rientra nel disturbo psichiatrico noto disturbo psicotico condiviso. Questa sindrome venne descritta, sotto il nome di Folie à deux, per la prima volta da Lasègue e Falret. Si tratta di un quadro clinico peculiare in cui un soggetto dominante, denominato induttore o caso primario, influenza un soggetto più debole, denominato indotto, arrivando ad imporgli il suo sistema delirante. Normalmente l’uomo è l’induttore e la donna l’indotto, mentre in questo caso Dmitry ha ucciso una donna, Elena Vakhrusheva, su richiesta di Natalia in preda alla gelosia.
Jeffrey Lionel Dahmer, il Mostro di Milwaukee, ha ucciso e cannibalizzato 17 ragazzi. La sua ossessione era quella di trovare qualcuno che non lo abbandonasse, tanto è vero che tentò di realizzare un vero e proprio zombie iniettando varie sostanze nel cranio di una vittima. In Dahmer sono state riscontrare varie peculiarità criminologiche, una fra tutte: la splancnofilia, una tipologia di disturbo parafilico individuato in tutta la storia del serial killer sono in Dahmer appunto, e consiste nell’attrazione sessuale provata per l’involucro esterno degli organi interni. Dahmer infatti ha dichiarato di avere avuto rapporti sessuali non solo con i cadaveri delle vittime, praticando quindi necrofilia, ma a volte con parti di essi come crani, organi ecc. Nel modus operandi di questo serial killer si rilevano elementi tipici della serialità femminile come l’uso di sostanze per avvelenare e/o addormentare le proprie vittime.
Armin Meiwes, il Cannibale di Rotenburg an der Fulda, si è cibato di un solo soggetto, che si consegnò volontariamente, perché desiderava essere mangiato vivo. Meiwes tagliò il pene della vittima e lo consumarono insieme per poi ucciderlo e mangiarsi la sua carne per diversi mesi. Ha dichiarato che la carne umana ha un gusto simile a quello della carne di maiale ma un po’ più amara.
In realtà molte di queste pratiche fino ad ora descritte si ritrovano nei culti di diverse divinità cannibali come il demone Asmodeo definito come il distruttore, capace di cibarsi delle sue vittime; Lamaštu, divinità di origine mesopotamica; secondo diversi miti, a differenza delle altre divinità mesopotamiche, ella attaccava le sue vittime autonomamente e non per ordine di altre divinità. Le sue vittime predilette erano le donne prossime al parto e i neonati, che venivano rapiti durante l’allattamento per cibarsi delle loro ossa e del loro sangue; Crono, nella denominazione greca, o Saturno, nella denominazione romana, dopo aver sposato sua sorella Rea, la quale partorì i suoi figli, a divorarli uno per uno. Il suo atto antropofagico è stato reso celebre, nel mondo dell’arte, da Francisco Goya e la sua opera Saturno devorando a su hijo.
Nel saggio però, ho dato molto spazio ad una divinità che ha un rapporto peculiare con il cannibalismo ossia Śiva, dio ermafrodito degli umili, i śūdra. Nel culto di questa divinità i sacrifici umani rispecchiano certe credenze dell’essere umano, certi aspetti della natura del mondo che sarebbe imprudente ignorare. Sono parte dell’inconscio collettivo e rischiano di manifestarsi in forme perverse se non osiamo affrontarli. “Esistere vuol dire mangiare ed essere mangiato. L’uomo è ciò che mangia. Ogni essere vivente si nutre di altri esseri e diverrà nutrimento di altri esseri in un ciclo interminabile”. Śiva viene così considerato sia come divorato che come divoratore; Śiva stesso afferma: “Io sono il cibo, io sono il cibo, io sono il cibo! Io sono il mangiatore del cibo, io sono il mangiatore del cibo, io sono il mangiatore del cibo!… Dal cibo le creature nascono, per opera del cibo una volta generate si mantengono in vita, nel cibo morendo ritornano”. È indubbia la correlazione con le concezioni socio-psicoanalitiche sul cannibalismo seriale, come se negli antropofagi seriali vi fossero delle sopravvivenze inconsce, ovvero una sorta di esternazione di queste concezioni sedimentate nel proprio inconscio, un istinto primitivo e śivaista che si slatentizza.
Primitivo perché l’atto di uccidere e cannibalizzare era tipico delle popolazioni primitive, o meglio ancora del passato, perché spesso in periodi più recenti caratterizzati da grave carestia sono stati praticati atti antropofagi per garantire la propria sopravvivenza. E questo aspetto è abbastanza noto e trattato nella letteratura in generale, soprattutto lombrosiano-freudiana di cui si è fornita una breve panoramica.
Sul secondo aggettivo, ossia śivaista, a oggi non vi è alcun riferimento e legame, se non per gli atti antropofagici, al campo della criminologia. È necessario precisare che non si sta sostenendo che gli śivaisti siano dei serial killer, ma che in questi ultimi sembrerebbe riaffiorare un’attitudine che ricorda la ritualità, i principi, e alcuni aspetti tipici di questo culto; una vera e propria forma di regressione, o forse la dimostrazione del fatto che tutti siano accomunati da un unico grande inconscio collettivo. Una prima prova legata a questa ipotesi potrebbe essere rappresentata da una delle poche popolazioni inclini al cannibalismo ancora in vita, ossia gli Aghori.
Dunque, il gusto del cannibalismo ha molte sfumature perché mette a nudo pensieri e desideri che fanno paura, e ci mettono innanzi ad una domanda difficile da porsi: chi è un mostro? Forse potremmo rispondere con il titolo di un’opera dello psichiatra forense, Robert Simon, I buoni lo sognano, i cattivi lo fanno.
Il libero arbitrio oltre il dibattito filosofico – Incontro con le neuroscienze
Redazione: Per riaprire il discorso iniziato il 27 febbraio con il post “Il libero arbitrio oltre il dibattito filosofico – Incontri con le scienze empiriche”, è il caso di ricordare come spesso la questione del libero arbitrio sia posta come un’alternativa tra due scenari contrapposti: uno nel quale gli esseri umani sono vincolati in modo rigido ad agire e a scegliere in modo determinato meccanicamente; l’altro, nel quale essi sono agenti con la possibilità di determinare il proprio destino.
In quell’occasione hai delineato in che modo la riflessione filosofica si sia avvicinata alla meccanica quantistica, e come abbia tentato – secondo te senza riuscirci - una interpretazione dei risultati empirici come giustificazione dell’indeterminismo libertario.
Nel tuo lavoro Neurobiologia della volontà (2022), invece, hai parlato degli studi delle neuroscienze sull’esistenza o meno di condizionamenti a cui sono sensibili gli agenti e che condizionano o determinano in anticipo le azioni che verranno dispiegate.
Stella: Sì, da un lato alcuni autori si sono chiesti se fattori come l’ambiente o la genetica possano determinare le scelte che compie di volta in volta l’individuo; altri si sono chiesti se i sistemi neurali che vengono di solito associati alle deliberazioni individuali siano liberi (nel senso di capaci di iniziare nuove catene causali) o se sono preceduti da altre attività cerebrali sulle quali non abbiamo il controllo.
Tra questi ultimi, ho preso in considerazione il lavoro di Benjamin Libet che ha studiato gli eventi coscienti e la loro relazione con l’iniziazione di atti fisici.
Ricordiamo che, secondo la psicologia del senso comune, l’essere umano concepisca i propri atti liberi e la propria volontà come frutto della propria coscienza.
Seppure tali funzioni siano attribuite in maniera intuitiva alla sfera mentale, dal punto di vista delle neuroscienze non è facile comprendere su quali processi neurali queste si poggino. La ricerca empirica non è stata ancora in grado di fornire evidenze di rilievo che siano in grado di supportare l’ipotesi di processi indeterministici a livello cerebrale. In altre parole, non è stato ancora spiegato se e come il cervello umano possa produrre delle azioni libere, secondo le condizioni di autodeterminazione e non condizionamento esterno, in accordo con il senso comune.[1]
Redazione: Secondo te, il lavoro di Libet è da interpretare come una valida confutazione del libero arbitrio oppure come una spiegazione più realistica di come potrebbero funzionare dei meccanismi mentali indeterministici?
Stella: Va sicuramente evidenziato che il lavoro di B. Libet è stato portato avanti nella convinzione che la questione del libero arbitrio sia un tema dalla forte rilevanza speculativa e pratica, per cui Libet ritiene che “una teoria che si limita a interpretare il fenomeno del libero arbitrio come illusorio e nega la validità di questo fatto fenomenologico è meno interessante di una teoria che accetta o accoglie un tale fatto” (Libet, Mind Time - Il fattore temporale nella coscienza, Raffaello Cortina Editore, 2007, p. 159). Libet dichiara, inoltre, che la sua “conclusione sul libero arbitrio – libero per davvero, in senso non deterministico – è che la sua esistenza è un’opinione scientifica altrettanto buona, se non migliore, della sua negazione in base alla teoria deterministica delle leggi naturali” (p.160).
Redazione: Nei suoi lavori Libet ha fornito delle prove sperimentali dell’intuizione che abbiamo di agire in modo libero e conscio?
Stella: Sì, Libet ha cercato di testare sperimentalmente questa intuizione studiando l’esperienza cosciente dell’intenzione di agire in atti motori semplici volontari. Per sorpassare la soggettività dell’esperienza, Libet ha osservato le relazioni temporali che intercorrono fra gli eventi neurali di azioni volontarie specifiche e la percezione che hanno gli agenti mentre le compiono.
Il presupposto per questa ricerca è che – secondo Libet – “il problema dei rapporti mente-cervello e quello delle basi cerebrali dell’esperienza cosciente possono essere studiati sperimentalmente” (cit., p. 1) perché gli eventi fisici e quelli mentali, sono correlati ma
- costituiscono due categorie fenomenologicamente indipendenti e “nessuno dei due fenomeni può essere ridotto all'altro o descritto da esso” (cit., 21).
- “la natura non fisica della consapevolezza soggettiva (e dei sentimenti di spiritualità, creatività, volontà consapevole e immaginazione) non è descrivibile o spiegabile direttamente in termini di prove fisiche pure e semplici” (cit., p. 9).
A questo proposito, Libet evidenzia i limiti degli studi morfologici e fisiologici del cervello – basati su ICBF, PET, RM funzionale – per la comprensione dell’esperienza cosciente, perché «forniscono informazioni solo su dove, nel cervello, le attività delle cellule nervose possono essere collegate alle varie operazioni mentali» e non dicono nulla sul genere di attività delle cellule nervose, sulle correlazioni temporali tra attività nervosa e funzione mentale e né, tantomeno, garantiscano che i siti cerebrali localizzati siano davvero quelli di primaria importanza per quelle operazioni mentali.
Redazione: In che modo Libet ha indagato questo tema dell’intenzione più o meno cosciente?
Stella: Libet ha deciso di lavorare su soggetti in grado di collaborare e di rispondere alle domande a loro rivolte, sveglie coscienti[2] perché riteneva che un’indagine fenomenologica dell’esperienza cosciente dell’intenzione possa essere svolta solo su un soggetto in grado di riportare la propria esperienza.
L’assetto sperimentale[3] vede, quindi, dei soggetti che devono compiere atti motori semplici, volontari ed endogeni, come flettere un dito o il polso.
Il punto centrale dell’esperimento è la rilevazione – fatta con elettroencefalogramma – del “potenziale di prontezza” cioè di un significativo incremento dell’attività elettrica nell’area motoria supplementare coinvolta nel controllo dei movimenti poco prima e in preparazione di ogni azione; si pensa che questo potenziale sia correlato causalmente, sulla base di analisi statistiche, all’esecuzione delle azioni.[4]
Contestualmente alla rilevazione dell’attività cerebrale associata all’iniziazione dell’atto motorio, viene chiesto al soggetto sperimentale di osservare uno speciale orologio così da poter registrare l’esatto momento in cui ha sentito l’impulso di agire e confrontarlo con i dati sull’attività cerebrale.
Le rilevazioni hanno mostrato che il potenziale di prontezza insorge circa 550 millisecondi prima del dispiegarsi dell’azione, mentre generalmente gli individui riportano di aver sentito l’impulso ad agire 200 millisecondi prima dell’azione stessa.
Pertanto, è possibile osservare uno scarto di 350 millisecondi tra l’attività elettrica di preparazione all’azione e la percezione soggettiva di volerla compiere, sebbene l’individuo non ne avesse alcuna consapevolezza o percezione.[5]
Redazione: Cosa conclude Libet sulla base di questi risultati, che sembrano abbastanza indicativi per la riflessione sull’arbitrarietà delle azioni?
Stella: La prima conclusione di Libet è che gli individui non hanno un controllo sull’iniziazione delle proprie azioni, in quanto questa si manifesta a livello cerebrale già prima di diventare cosciente.
Redazione: Parrebbe che questa sia una netta confutazione dell’esistenza dell’arbitrio, o sbaglio?
Stella: In effetti, una prima interpretazione potrebbe essere di questo tenore. Però, lo stesso Libet ha ritenuto meglio riformulare il concetto in una forma ridotta: sebbene l’iniziazione dell’azione non sia frutto del libero arbitrio, gli agenti godono della “libertà di veto” (cit., p. 141). In termini pratici, l’esperienza cosciente si manifesta 200 millisecondi prima dell’azione MA l’agente ha tempo fino a circa 50 millisecondi prima di questa per interromperla.
In estrema sintesi, da una parte Libet conclude che gli esseri umani non decidono né avviano consciamente le proprie azioni e, pertanto, la coscienza non svolge un ruolo diretto nei processi deliberativi (Levy N., Neuroethics. Challenges for the 21st Century, 2007, p. 226) ma, dall’altra parte, osserva che “la volontà liberamente cosciente può controllare il risultato di un processo iniziato in modo non cosciente” (p. 147).
Redazione: Ci sono interpretazioni disallineate alle conclusioni di Libet?
Stella: Decisamente! Altri autori hanno considerato poco convincente il lavoro di Libet. Tra le critiche più interessanti c’è senza dubbio quella di Schurger e colleghi, che hanno riprodotto l’assetto sperimentale di Libet per mostrare che l’attività neurale soggiacente la preparazione dell’azione segue delle fluttuazioni spontanee, correlate all’azione solo a livello probabilistico. La loro sperimentazione ha rivelato come tra l’insorgere dell’esperienza cosciente dell’intenzione e l’esecuzione a livello neurale di tale iniziazione ci sia uno scarto di 50 millisecondi, tempo che consentirebbe alla coscienza di avviare e controllare l’esecuzione del processo motorio.
La conclusione di Shurger e colleghi è che le affermazioni di Libet sul libero arbitrio siano infondate e che una volontà libera sia in linea teorica perfettamente compatibile con un modello di attività neurale ad onde, come quello da loro illustrato.
Redazione: Mi pare che sia Libet, con il suo tentativo di salvare la coscienza dall’etichetta di mero epifenomeno proponendo la teoria della libertà di veto, che i suoi oppositori cerchino di escludere elementi deterministici che agiscano a livello neurale, come dei processi mentali inconsci, e che possano influenzare e condizionare le nostre azioni. Se ne esce in qualche modo?
Stella: Credo che sia bene ricordare che questi risultati offrono un contributo speculativo esclusivamente nell’ambito dei determinismi locali, che - come in questo caso per l’attività neurale – potrebbero condizionare la nostra volontà libera.
Mi pare chiaro che questi contributi non siano in grado di sciogliere la questione sul piano del determinismo universale e che rappresentano un contributo limitato all’interno del dibattito filosofico sul libero arbitrio.
Ritengo – però - che questo tipo di studi possa mantenere vivo l’interesse sulla riflessione morale sulla responsabilità e sui nostri giudizi di liceità o illiceità di una determinata azione.
Inoltre, i risultati di questo tipo di studi potrebbero supportare la formulazione di teorie etiche normative informate e adeguate rispetto al nostro modo di agire, ragionare e giudicare moralmente.
NOTE
[1] A tal proposito, Libet suggerisce che vi siano due modi per configurare un’attività mentale conscia che si sottrae alle leggi fisiche note: “La prima è che le violazioni non sono rilevabili, dal momento che le azioni della mente possono essere a un livello inferiore a quello dell'indeterminazione permessa dalla meccanica quantistica. (Se quest'ultima ipotesi condizionale possa in effetti essere sostenuta è un tema che deve essere ancora risolto.) Quest'idea permetterebbe, quindi, l'esistenza di un libero arbitrio non deterministico senza una violazione percepibile delle leggi fisiche. Un secondo punto di vista sostiene che le violazioni delle leggi fisiche note sono abbastanza grandi da essere rilevate, almeno in linea di principio. Ma si può supporre che le effettive possibilità di rilevazione in pratica siano nulle. Le difficoltà nella rilevazione sono particolarmente vere se la volontà cosciente è in grado di esercitare la sua influenza attraverso azioni minimali su elementi neurali relativamente poco numerosi, cioè se queste azioni possono servire come innesco per schemi amplificati di cellule nervose dell'attività del cervello. In ogni caso, non abbiamo una risposta scientifica alla questione di quale teoria (deterministica o non deterministica) descriva in maniera corretta la natura del libero arbitrio.
[2] Per approfondimenti su queto punto, si veda Boncinelli, Chi prende le mie decisioni?, 2007.
[3] Il setting di Libet era ispirato agli esperimenti degli anni Sessanta (1969) di Deecke, Scheid e Kornhuber, Distribution of Readiness Potential, Pre-motion Positivity, and Motor Potential of the Human Cerebral Cortex Preceding Voluntary Finger Movements.
[4] Si veda Benini, Neurobiologia della volontà, 2022.
[5] Gli esperimenti di controllo sostenuti da Libet hanno escluso che la disparità sia dovuta semplicemente al tempo supplementare necessario per notare e riferire il momento indicato dal puntino mobile dell’orologio (si veda Kosslyn, 2007, p. XVI); inoltre Libet ha affermato che, sebbene gli esperimenti riguardassero atti motori semplici, i risultati possono essere generalizzati e assunti come validi per qualsiasi atto motorio volontario.