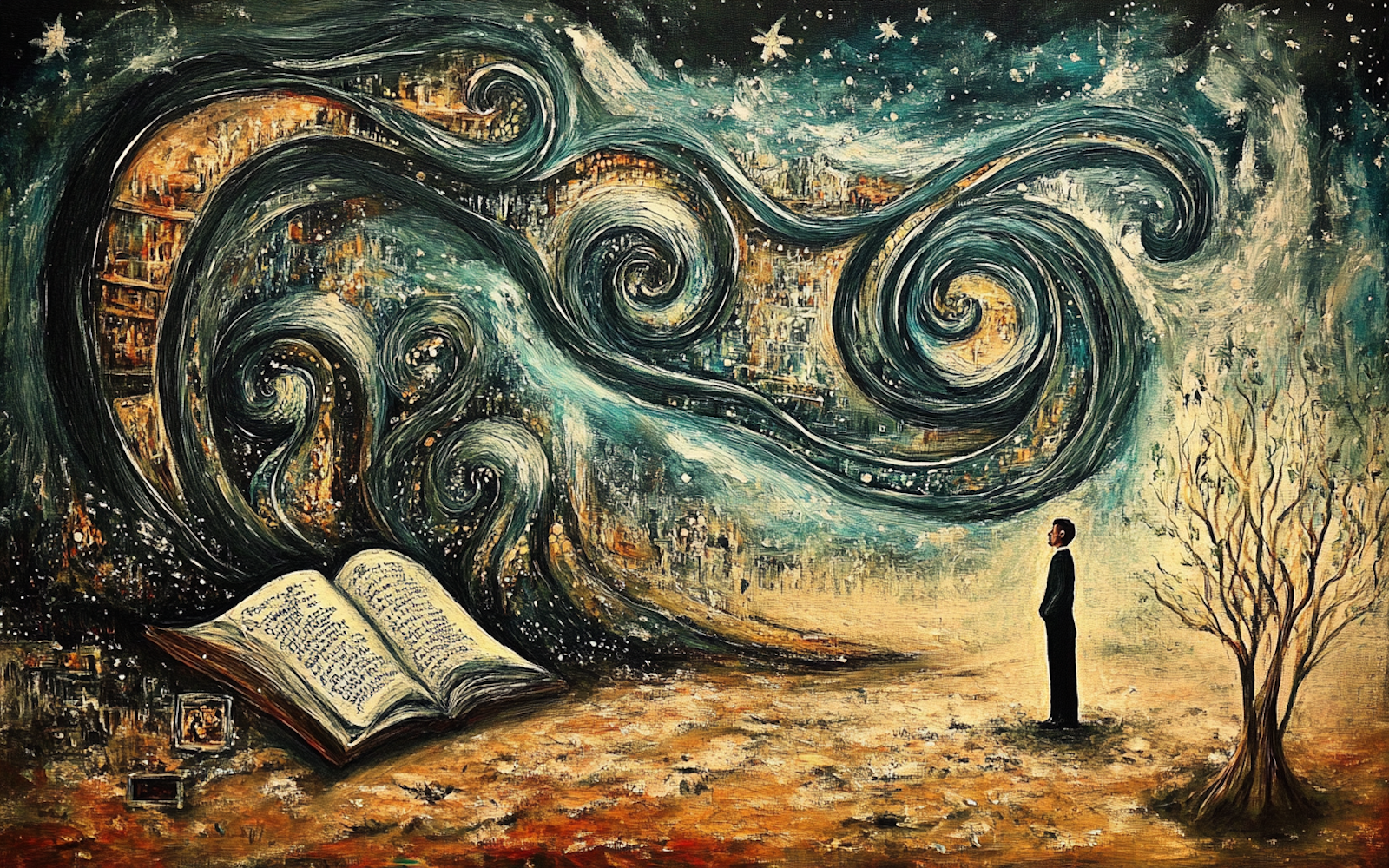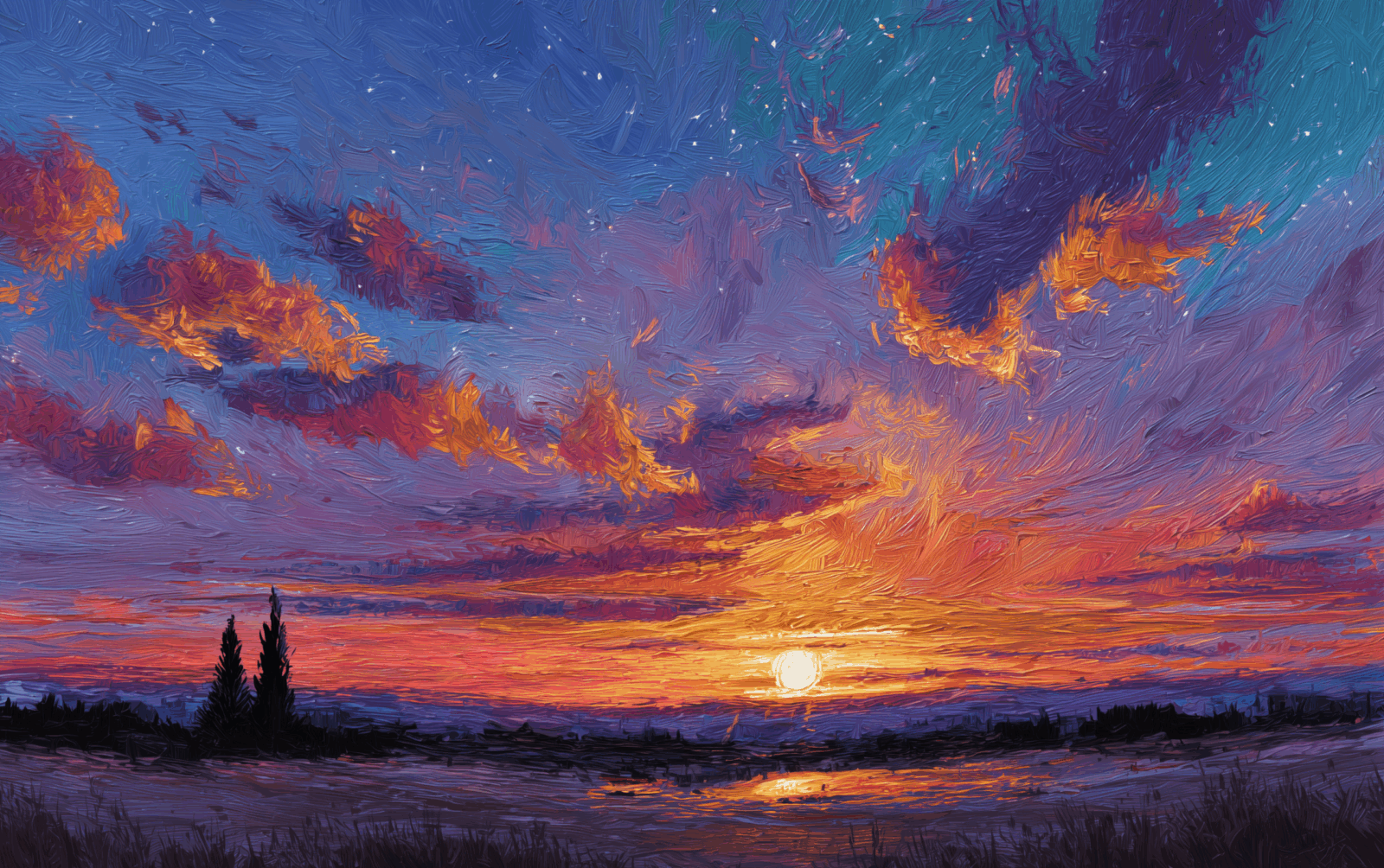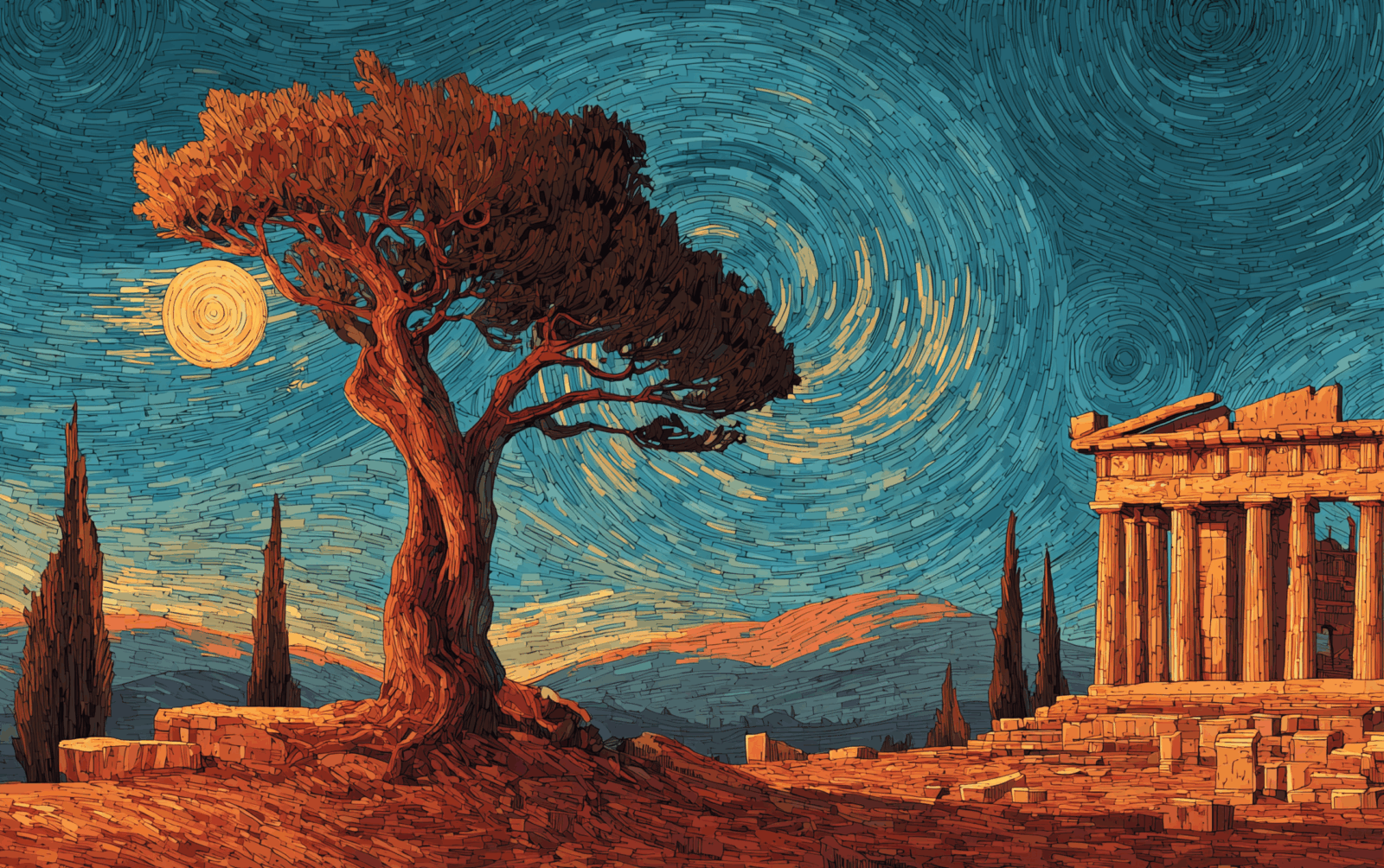La santificazione di Hiroshima - Un pensiero di Alvin Weinberg, fisico del XX secolo
Alvin M. Weinberg fu un fisico statunitense e collaborò al Progetto Manhattan con la realizzazione del primo reattore nucleare insieme ad E. Fermi, all’Università di Chicago.
Direttore del Centro di arricchimento dell'uranio di Oak Ridge dal 1955 al 1973, fu tra i propositori della Società Nucleare Americana e, nel 1961, presiedette il Panel of Science Information, che produsse il fondamentale "Weinberg Report" sulla comunicazione della scienza a un pubblico sia tecnico che non specialistico.
Nel 1970 avvia il primo grande progetto di ecologia negli Stati Uniti: la National Science Foundation.
Nel 1975, Weinberg fondò e divenne direttore dell'Istituto per l'Analisi Energetica dell’Oak Ridge Associated Universities. Si ritirò nel 1985 ma rimase strettamente legato sia all'Istituto che al laboratorio. Morì nel 2006.
In questo testo del 1986 riflette sull’effettiva necessità del lancio dell’atomica nel 1945 e su come sacralizzare quell’evento per scongiurare il pericolo nucleare per i prossimi millenni.
--------
Sin da quasi il primo giorno che sono andato a lavorare nel Laboratorio Metallurgico dell'Università di Chicago, nel 1941, ho capito che quello che [noi fisici] stavamo facendo avrebbe cambiato il mondo. Leo Szilard si era dato da fare affinché la biblioteca acquistasse i due libri H.G. Wells The World Set Free [1914; La liberazione del mondo, 1981, Mursia], e di H. Nicholson Public Faces [1932] che immaginavano come poteva essere un mondo in cui c'erano le armi nucleari. Questi libri di fantascienza mi impressionarono molto.
Il problema dell'uso bellico dell'arma nucleare nella Seconda guerra mondiale non ci coinvolse moltissimo. Però in molti firmammo la petizione di Szilard del 1945 affinché la bomba non fosse usata con rabbia e gran parte di noi firmò la raccomandazione della commissione Franck [di scienziati che avevano costruito la bomba nucleare] di dimostrare la potenza della bomba [in un luogo deserto del Giappone] piuttosto che sulle città.
Dopo di che la posizione di Szilard era molto cambiata rispetto a quella iniziale: "Sarà molto difficile che riusciamo ad avere un'azione politica, a meno che...; ormai le bombe atomiche sono state usate in guerra e il fatto che esse hanno una enorme potenza distruttiva è entrato nella testa della gente [che vuole finire la guerra]." Curiosamente questa posizione era in accordo con la risposta del panel scientifico consultivo che, in risposta alle raccomandazioni degli scienziati di non arrivare ad usare le bombe [sulla popolazione], aveva affermato: "Non possiamo proporre dimostrazioni [della bomba solo] tecniche che abbiano una buona probabilità di porre fine alla guerra; non vediamo alternative accettabili all'uso diretto delle bombe [sulla popolazione]." J. Robert Oppenheimer, un membro del panel, fu d'accordo con questa posizione; Teller, nel suo libro The Legacy of Hiroshima [L'eredità di Hiroshima, Tamburini, 1965], racconta che cercò di persuadere Oppenheimer che una dimostrazione tecnica non sulla popolazione era la condotta migliore, ma poi permise ad Oppenheimer di abbandonare questa posizione.
Debbo confessare che, anche se avevo firmato la petizione di Szilard, non sono mai stato turbato dalla decisione di bombardare [le città giapponesi]. Sono stato sempre convinto della argomentazione elementare che essa ha salvato molte vite umane sia Giapponesi che Americane. Non mi hanno fatto cambiare idea né la tesi revisionista che i Giapponesi comunque avrebbero capitolato molto presto, né l'accusa di esagerazione nel numero di morti che ci sarebbero stati con una invasione [del Giappone] ad Honsu.
Il quarantesimo anniversario di Hiroshima ha molto rafforzato la mia convinzione che [il bombardamento di] Hiroshima (ma non di Nagasaki) era necessario; ma non per la ragione suddetta; per una ragione di più grande rilevanza, che deriva dal ragionamento che allora portò a preferire l'uso della bomba. L’attuale 40° anniversario ha visto una grande espressione di emozioni, molte dichiarazioni di coinvolgimento, molte di più che nelle precedenti ricorrenze del bombardamento di Hiroshima. Stiamo forse assistendo ad una graduale santificazione di Hiroshima, cioè alla elevazione dell'evento Hiroshima ad un evento profondamente mistico, un evento che in sostanza ha la stessa forza religiosa degli eventi biblici? Non posso dimostrarlo, ma sono convinto che il 40° anniversario di Hiroshima, con il suo ampio coinvolgimento, le sue grosse manifestazioni, i molti servizi dei mass media assomiglia alla osservanza delle più grandi festività religiose.
Questa santificazione di Hiroshima è uno dei più auspicabili sviluppi della era nucleare. Spesso si parla con disinvoltura di riuscire ad evitare le guerre nucleari, ma non si tiene conto che non si tratta di prendere decisioni per il prossimo decennio o due; ma per millenni! Come può l'umanità accettare veramente, ai livelli più fondamentali, la necessità assoluta di evitare gli olocausti nucleari — 50, 100, 1.000 anni dopo Hiroshima — se non perché Hiroshima è diventata una leggenda orrenda, da tutti ben conosciuta e accettata da tutti come orrenda, così come è conosciuta la crocifissione tra i Cristiani, la uccisione di Abele da parte di Caino tra gli Ebrei e così come l'Egira è conosciuta dai Mussulmani? In poche parole, solo santificando Hiroshima possiamo aspettarci che la sua lezione sia appresa e ripetuta per sempre - ricordando anche le morti per il fuoco atomico, le malattie da radiazione, il terribile annientamento della città?
Potrebbe oggi essere santificata Hiroshima se invece ci fosse stato solo un bombardamento tecnico senza morti? Non potrei immaginare una ricorrenza annuale di impegno mistico che commemorasse un semplice test nucleare. Di fatto, anche l’attuale ricordo è del 6 agosto, non del 16 luglio [quando ci fu la prima esplosione per esperimento nel poligono di Alamagordo, Nuovo Messico]. Nella lunga marcia della storia umana, i 100.000 e passa che morirono a Hiroshima saranno visti come martiri: essi sono stati sacrificati - questa è la valutazione che si sta affermando - affinché l'umanità possa vivere all'ombra della bomba, ma non venga sterminata da essa.
Il mio caro amico William Pollard, che è pastore episcopale e un veterano del progetto Manhattan [di invenzione e fabbricazione della bomba], ha scritto una lettera dove queste cose sono dette in una maniera molto adeguata:
Hiroshima sta diventando un mito profondamente radicato nella psiche di tutti i popoli della terra. Il... teologo e studioso Mircea Eliade ha distinto nella vita popolare un "tempo profano" da un "tempo sacro". Nel tempo sacro le gesta e gli avvenimenti storici gradualmente prendono la persistenza dei miti, mentre nel tempo profano essi hanno meno presa sul popolo e diventano semplicemente materiali storici per gli studiosi, cioè, entrano nel tempo storico.
È forse questo il destino di Hiroshima: diventare un mito universale profondamente fondato nel
tempo sacro di tutti i popoli della terra; cioè, il simbolo della loro convinzione che non si dovrà mai più permettere che avvenga una guerra nucleare?
Io credo che sia così, e che il mondo sempre farà memoria di quelli che morirono a Hiroshima, il che renderà così possibile la santificazione di Hiroshima.
Sintesi
Sin da quasi il primo giorno che sono andato a lavorare nel Laboratorio Metallurgico dell'Università di Chicago, nel 1941, ho capito che quello che [noi fisici] stavamo facendo avrebbe cambiato il mondo…
L’attuale 40° anniversario ha visto una grande espressione di emozioni, molte dichiarazioni di coinvolgimento, molte di più che nelle precedenti ricorrenze del bombardamento di Hiroshima. Stiamo forse assistendo ad una graduale santificazione di Hiroshima, cioè alla elevazione dell'evento Hiroshima ad un evento profondamente mistico, un evento che in sostanza ha la stessa forza religiosa degli eventi biblici? Non posso dimostrarlo, ma sono convinto che il 40° anniversario di Hiroshima, con il suo ampio coinvolgimento, le sue grosse manifestazioni, i molti servizi dei mass media assomiglia alla osservanza delle più grandi festività religiose.
Questa santificazione di Hiroshima è uno dei più auspicabili sviluppi della era nucleare…
Spesso si parla con disinvoltura di riuscire ad evitare le guerre nucleari, ma non si tiene conto che non si tratta di prendere decisioni per il prossimo decennio o due; ma per millenni! Come può l'umanità accettare veramente, ai livelli più fondamentali, la necessità assoluta di evitare gli olocausti nucleari — 50, 100, 1.000 anni dopo Hiroshima — se non perché Hiroshima è diventata una leggenda orrenda, da tutti ben conosciuta e accettata da tutti come orrenda, così come è conosciuta la crocifissione tra i Cristiani, la uccisione di Abele da parte di Caino tra gli Ebrei e così come l'Egira è conosciuta dai Mussulmani? In poche parole, solo santificando Hiroshima possiamo aspettarci che la sua lezione sia appresa e ripetuta per sempre - ricordando anche le morti per il fuoco atomico, le malattie da radiazione, il terribile annientamento della città?...
Nella lunga marcia della storia umana, i 100.000 e passa che morirono a Hiroshima saranno visti come martiri: essi sono stati sacrificati - questa à la valutazione che si sta affermando - affinché l'umanità possa vivere all'ombra della bomba, ma non venga sterminata da essa.
Poi cita quanto ha scritto un suo amico pastore (ex scienziato di Manhattan) in una lettera:
È forse questo il destino di Hiroshima: diventare un mito universale profondamente fondato nel
tempo sacro di tutti i popoli della terra; cioè, il simbolo della loro convinzione che non si dovrà mai più permettere che avvenga una guerra nucleare?
Io credo che sia così, e che il mondo sempre farà memoria di quelli che morirono a Hiroshima, il che renderà così possibile la santificazione di Hiroshima.
Nella lacrima di Lucifero: amore, guerra e il paradosso della libertà
Quando Caravaggio dipinge Amor vincit omnia, non dipinge un semplice trionfo dell’amore. Dipinge un paradosso. Quel giovane Cupido, nudo e sorridente, che domina il mondo dalle sue ali scure, mette in scena l’ambiguità originaria del desiderio. Attorno ai suoi piedi giacciono strumenti di cultura — il liuto, la spada, il globo, gli strumenti geometrici — come se l’amore avesse trionfato su tutto ciò che l’umanità costruisce per dominare, comprendere, misurare. Ma quel sorriso ha qualcosa di perturbante: non è il sorriso dell’amore che illumina, ma quello dell’amore che conquista.
Già Platone, nel Simposio, distingueva l’amore come mancanza — eros come tensione verso ciò che non si possiede — e come desiderio che spinge a colmare un vuoto. Ma quando il desiderio diventa volontà di possesso, ciò che nasce come aspirazione si trasforma in dominio. Caravaggio sembra ricordarci che l’amore è sempre anche una forza oscura: conquista ciò che vuole, e per farlo deve vincere — e ogni vittoria implica un vinto.
Da qui il passaggio è breve: dall’amore come possesso alla guerra come massima espressione della volontà di possedere. La guerra, diceva Hobbes, nasce dalla diffidenza, dal bisogno di garantire la propria sopravvivenza e affermare il proprio potere. Ma è anche, in fondo, una forma estrema di relazione: due volontà che vogliono affermarsi, due desideri che entrano in collisione. La guerra, allora, è il lato tossico dell’amore: quando il desiderio di relazione diventa desiderio di controllo.
Ma se esiste un amore tossico che invade, esiste anche un amore semplice, che libera. La pace non è solo assenza di conflitto: è presenza di libertà. Spinoza ci ricorda che la libertà non è fare ciò che si vuole, ma comprendere ciò che si è: è il movimento quieto dell’essere che non ha bisogno di conquistare. La pace, in questo senso, è un atto d’amore che non pretende, non occupa, non costringe. È il riconoscimento dell’altro come altro.
Fin qui siamo nel campo della filosofia, dove i concetti si sostanziano come idee. Ma la fisica moderna ci chiede di andare oltre. La meccanica quantistica — con gli intrecci, l’entanglement, l’impossibilità di separare completamente un sistema dal suo osservatore — ci dice che nulla esiste in modo isolato.
Due particelle possono influenzarsi anche a enormi distanze, come se condividessero un’unica storia. Esse sono relazione, prima ancora di essere oggetti. Niels Bohr lo definiva "complementarità": non si può dire cos’è un ente senza dire con che cosa è in relazione.
Se portiamo questa intuizione dentro il campo umano, scopriamo un paradosso: la libertà non può essere compresa senza la costrizione; la pace non può essere pensata senza il conflitto; l’amore non può esistere senza la possibilità della sua degenerazione. La guerra diventa allora l’espressione irrazionale di un’umanità che non ha ancora imparato a gestire le proprie relazioni; la scienza, con la sua razionalità, non può esserne responsabile — perché la guerra è figlia dell’istinto e della fragilità, non dell’equazione. La guerra, soprattutto l’armageddon nucleare, diviene allora minaccia per incutere paura, diviene arma di controllo. Sono gli uomini che, accecati dal desiderio di controllo, trasformano la conoscenza in minaccia, la paura in arma.
Qui tocchiamo un nodo antico quanto le religioni: il timor Dei.
Gli dei dell’Olimpo punivano, Zeus scagliava fulmini, Atena guidava gli eserciti. Il Dio cristiano, pur predicando l’amore, mantiene come suo strumento il timore — non come terrore, forse, ma come reverenza che disciplina, che regola. Il timore divino diventa un’energia che ordina il mondo: un’ombra che insegna all’uomo i limiti.
Ma cosa succede quando l’uomo, fatto a immagine e somiglianza di quel Dio, imita quel potere?
Non crea mondi. Crea bombe.
L’umanità trasfigura il timor Dei nella bomba atomica: prende la paura e la rende materia, la condensa in codici di lancio.
Quella che era una dimensione teologica diventa una geometria di distruzione. La scienza fornisce gli strumenti, ma non lo scopo: la responsabilità non è dello scienziato che calcola, ma dell’essere umano che sceglie. La paura — antica alleata degli dei — si fa tecnologia. E la tecnologia, come ricordava Günther Anders, supera la nostra capacità di immaginarne le conseguenze.
Ma se vogliamo comprendere davvero la sconfitta che si annida nella guerra, dobbiamo tornare all’arte. E guardare La caduta di Lucifero di Alexandre Cabanel. Lucifero non è raffigurato come un demone, ma come un essere di straordinaria bellezza: il più luminoso degli angeli, precipitato nell’abisso. Il suo corpo è perfetto, il suo volto giovane, il suo sguardo colmo di una disperazione eloquente. Su quel viso scende una lacrima.
Quella lacrima è la testimonianza che anche per Dio la guerra è una sconfitta. La punizione del suo prediletto — del portatore di luce — è una vittoria che costa troppo, come tutte le vittorie della forza.
È l’amore che fallisce nel tentativo di imporre se stesso.
È la libertà che viene amputata per salvare l’ordine.
In quella lacrima c’è qualcosa che ci riguarda profondamente: c’è la possibilità dell’errore, c’è la nostalgia di ciò che è perduto, c’è la consapevolezza che ogni atto di violenza, anche quando appare necessario, porta con sé la negazione di ciò che vorremmo essere.
Ed è lì, in quell’unica goccia di luce che scivola sul volto dell’angelo caduto, che si nasconde — paradossalmente — la salvezza dell’umanità.
Perché mentre la bomba atomica è la caricatura sbiadita del timor Dei, un’imitazione malriuscita del potere divino, la vera forza non è nella distruzione, ma nella capacità di plasmare il pensiero, di orientare il desiderio, di trasformare la relazione.
Il controllo vero non sta nella minaccia ma nel significato. Non nella paura ma nella consapevolezza.
Non nell’atomica ma nella capacità di immaginare mondi in cui la conquista si trasforma in cura, e la forza in responsabilità.
E allora, forse, Caravaggio, i fisici, i teologi e Cabanel ci dicono la stessa cosa: che l’amore vince davvero solo quando accetta il rischio della relazione; che la libertà esiste solo se esiste la possibilità della sua perdita; che la pace non si costruisce eliminando la guerra, ma comprendendone la radice umana; e che la nostra umanità — fragile, luminosa, piena di contraddizioni — vive tutta, intera, dentro quella lacrima di Lucifero.
Una lacrima che non annuncia la fine, ma la possibilità di ricominciare.
Di essere migliori.
Di scegliere, finalmente, un amore che non trionfa: che libera.
Nobel per la Fisica 2025 - Un premio antropocentrico ed economicista?
«La meccanica quantistica “permette” a una particella di attraversare direttamente una barriera, utilizzando un processo chiamato tunnelling. Non appena sono coinvolti un gran numero di particelle, gli effetti quantistici di solito diventano insignificanti. Gli esperimenti dei vincitori del premio di quest’anno hanno dimostrato che le proprietà quantistiche possono essere rese concrete su scala macroscopica»[1]
Inizia così la motivazione del Nobel per la fisica del 2025, che premia la ricerca di John Clarke, di Michel H. Devoret e di John M. Martinis, proprio in occasione del centenario della formulazione della meccanica matriciale (W. Heisenberg) e della meccanica ondulatoria (E. Shroedinger).
I premiati, infatti, hanno dimostrato e messo in opera – nella seconda metà degli anni ’80 - la quantizzazione dell’energia in un circuito elettrico a livello macroscopico, quello della vita di tutti i giorni.
Il concetto di tunneling quantistico riguarda il comportamento di particelle subatomiche – in particolare di elettroni e di particelle alfa – che, in particolari condizioni indotte sperimentalmente, riescono ad oltrepassare le barriere del legame nucleare; barriere che, normalmente, sono quasi impenetrabili.
In modo molto semplificato, è come se ci fossero delle condizioni in cui la pallina del cane, lanciata al cane contro il muro di cinta del giardino passasse attraverso il muro (e anche il cane, che possiamo assimilare per dimensioni relative ad una particella alfa) invece che rimbalzare indietro.
Tra i vari effetti, l’esperimento dei premiati spiega - e ne facilita la strada tortuosa – la superconduttività, ossia la proprietà di alcuni materiali di condurre elettricità senza quasi opporre resistenza. Proprietà che offre una elevatissima efficienza nella trasmissione elettrica e nella generazione di campi magnetici, utile – ad esempio – nelle risonanze magnetiche, permette di studiare il comportamento delle particelle subatomiche in modo più semplice.
Ma che, soprattutto, sembra poter essere (il condizionale rafforzato è d’obbligo) il fattore di successo per la realizzazione dei supercomputer quantistici.[2]
ANTROPOCENTRISMO DELLA MECCANICA QUANTISTICA
Una delle caratteristiche della Meccanica Quantistica è che “rende bene” i fenomeni, ossia ne descrive bene l’andamento e ha un elevato successo predittivo di cosa succederà nel sistema osservato, ma – nello stesso tempo - non fornisce prove che le cose stiano davvero così nella realtà. La MQ è, infatti, ardua da capire, e misteriosa a causa del suo essere basata su formulazioni matematiche complesse e difficilmente rappresentabili con schemi vicini alla realtà di tutti i giorni – a differenza di altre teorie come il modello orbitale dell’atomo pensato da Bohr e da Sommerfeld tra 1913 e 1916, che, seppur di fantasia, era rappresentato con figure come quella affianco.
La MQ è così lontana dalla rappresentabilità realistica che W. Heisenberg affermava «la comprensione di quei tratti ancora non chiariti della fisica atomica si può raggiungere solo con una rinuncia all'intuitività e all'oggettivizzazione» (Fisica e filosofia, Feltrinelli 2021).
In questo contesto di contro-intuitività, si innestano il principio della sovrapposizione e quello di perturbazione del sistema causata dalla misura: in sintesi, una misurazione di ciò che accade in un sistema quantistico è possibile solo a patto di disturbarlo, e lo stato del sistema resta indefinito fino al momento dell’intrusione umana che ne causa il collasso, ossia lo definisce, lo rende reale e fattuale.
Detto in altri termini, la realtà atomica è normalmente in condizioni di indefinitezza e solo quando l’umano la osserva, tocca, disturba, questa prende forma. [3]
Il sottostante filosofico della MQ sembra affondare le sue radici tanto in posizioni empiriste estreme, come l’immaterialismo di Berkeley, quanto in visioni come quella del sistema geocentrico di Aristotele e di Tolomeo, con l’uomo [4] al centro di tutto, che fa girare il mondo, ne determina la forma e ne dispone a proprio piacere.
Nel XX secolo della nascita della MQ, e nel XXI secolo – che cerca faticosamente di superare l’antropocentrismo – questo premio Nobel non sembra essere un segno di cambiamento ma, anzi, di riaffermazione del principio di centralità dell’umano nell’universo, in questo caso di quello microscopico.
VISIONE ECONOMICISTA
Le motivazioni del premio sono esplicite: per il Comitato, la ricerca dei tre fisici è più funzionale allo sviluppo di nuove tecnologie – super computer, crittografia, sensori quantistici – che alla rilevanza scientifica.
A dispetto del fatto che l’apertura di un orizzonte quantistico nella dimensione macroscopica suoni come un percorso estremamente interessante dal punto di vista della ricerca fisica fondamentale, il Comitato pone l’accento sulla prospettiva di sviluppo tecnologico e, di conseguenza, economico.
Ora, se vale sempre il principio costitutivo del premio Nobel mirato a riconoscere risultati scientifici che portino «i maggiori benefici all'umanità»[5], appare che - per il Comitato – i benefici per l’umanità e lo sviluppo tecno-economico si sovrappongano fino quasi a coincidere e che, dietro al Nobel, si nascondano l’ideologia accelerazionista e una scala di valori fortemente economicista.
IN POCHE PAROLE
Nel secolo in cui è molto vivo il dibattito tra le due posizioni di persistenza e di superamento della visione antropocentrica, questo premio, che esalta la teoria quantistica, sembra essere ben ancorato alle tesi dell'antropocentrismo.
E, inoltre, in questa dimensione, tra le due polarità umanistica ed economicista dello sviluppo e del benessere dell'umanità, l’Accademia di Svezia e il Comitato del Nobel sembrano scegliere con decisione la via dell'economia, senza tenere conto delle inevitabili distorsioni, in pieno allineamento con il recente Nobel per l'economia.
NOTE:
[1] «Quantum mechanics allows a particle to move straight through a barrier, using a process called tunnelling. As soon as large numbers of particles are involved, quantum mechanical effects usually become insignificant. The laureates’ experiments demonstrated that quantum mechanical properties can be made concrete on a macroscopic scale», https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2025/press-release/, trad. nostra.
[2] Secondo il fisico professor Parisi, i computer quantistici possono essere «complementari all'A.I. che macina un numero incredibilmente elevato di dati mentre i computer quantistici risolvono problemi molto più ‘piccoli’, in termini di dati, ma estremamente difficili, per cui per qualche problema si può usare l'A.I. per altri problemi i computer quantistici, e per altri ancora i calcolatori tradizionali». Secondo altri, come Pat Gelsinger, ex-CEO di Intel, I.A. e computer quantistici sono mutualmente esclusivi dal punto di vista dello sviluppo e del successo, e i secondi faranno scoppiare la bolla dell’Intelligenza artificiale. Ma questa è un’altra Controversia.
[3] Cfr, ad esempio, Putting the U in quantum, Zack Savitsky, Science, 4 dicembre 2025
[4] Sarebbe fuori luogo evitare il maschile sovraesteso o aggirarlo con formule come “l’umano” quando si parla di teorie e pensiero dei secoli scorsi. Gli autori parlavano di “uomo”, con tutte i presupposti e le conseguenze sociali del caso.
[5] Cfr. le volontà di Alfred Nobel in Full text of Alfred Nobel’s will
L'etica dei fisici sulle armi nucleari - Seconda parte
Nella prima parte, Antonino Drago ha esaminato come gli "eventi nucleari" hanno modificato il modo di fare la fisica, inaugurando il tempo della big science, organizzata in modo quasi industriale, e hanno portato molti fisici a tradire i principi mertoniani della scienza: universalità, comunitarietà, disinteresse e dubbio sistematico. Inoltre, hanno sdoganato l'adesione di molti fisici al lavoro con fini militari. In questa seconda parte, l'autore disamina i diversi atteggiamenti etici, e le relative strategie di comunicazione, adottati dai fisici di fronte ai possibili effetti della loro ricerca: neutralità, opposizione più o meno ampia, etica della convinzione.
5 - QUATTRO TIPI DI ATTEGGIAMENTO ETICO DEI FISICI RESPONSABILI
Consideriamo ora la risposta etica dei fisici (principalmente gruppi di fisici) che, secondo la loro etica autosufficiente, si sentivano responsabili delle novità storiche[1]. Questi fisici saranno classificati in quattro gruppi in base agli atteggiamenti etici rispetto alla loro istituzione, ovvero la ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici[2].
1) Il gruppo di scienziati che considerava la scienza un'impresa eticamente neutra e che tuttavia voleva stabilire un rapporto diretto con la società civile per metterla in guardia sul pericolo rappresentato dalle armi nucleari. L'esempio più celebre delle loro dichiarazioni è il Manifesto Einstein-Russell (1955) (di seguito ERM). (Ionno Butcher 2005; Nathan, Norden, pp. 623ff)
2) Il gruppo di scienziati che si opponeva alla ricerca scientifica finalizzata a risultati militari. Questo gruppo comprendeva i fondatori del Bulletin of the Atomic Scientists, i fisici dell'Università di Roma che durante la seconda guerra mondiale interruppero deliberatamente le loro ricerche su argomenti nucleari, Meitner, Bethe, ecc.; un esempio rilevante delle loro dichiarazioni fu la petizione di Mainau (1955).
3) Il gruppo di scienziati che si opponeva anche all'energia nucleare civile. Questa opposizione fu perseguita in modo attivo e incisivo dall'Unione degli Scienziati Preoccupati, un gruppo nato nel 1968.
4) Il gruppo di scienziati che hanno subordinato la loro ricerca scientifica all'etica della convinzione: comprende Kapitza, Born, Rasetti[3] e alcuni fisici "non assolutisti": Rotblat, Oppenheimer e Weinberg.
L'analisi di Weber sul processo di razionalizzazione nella società si è avvalsa delle seguenti caratteristiche: scienza, male sociale, etica della responsabilità, razionalità, società. Poiché gli scienziati dovrebbero rappresentare al meglio questo processo di razionalizzazione, l'atteggiamento generale di questi quattro gruppi di scienziati può essere caratterizzato attraverso queste caratteristiche[4].
1) La natura della scienza è neutra e buona, le armi nucleari sono un male, ma un'azione importante da parte delle persone, a condizione che siano razionalmente informate, può ripristinare la situazione precedente e persino, grazie alle potenzialità dell'energia nucleare civile, introdurre l'umanità in un nuovo "paradiso", dove non ci saranno più problemi, nemmeno per l'etica della responsabilità degli scienziati. Questo era il messaggio fondamentale dell'ERM (1955).
2) La struttura della scienza comprende un'attività altamente negativa, la ricerca militare sulle armi nucleari; l'etica della responsabilità degli scienziati è in crisi; è necessaria la collaborazione tra scienziati e potere politico per evitare i prevedibili risultati scientifici peggiori per l'umanità. Questo era il messaggio essenziale della dichiarazione di Mainau (1955).
3) La struttura profonda della scienza include il male fino al punto di provocare il suicidio dell'umanità; è necessario un cambiamento radicale sia dell'etica della responsabilità degli scienziati che dell'atteggiamento della società nei confronti della scienza.
4) La struttura profonda della scienza include un male così estremo da essere in grado di produrre il suicidio dell'umanità attraverso diversi mezzi; è necessaria una nuova razionalità, secondo la quale è un atteggiamento razionale subordinare sia la scienza che l'etica della responsabilità degli scienziati all'etica della sopravvivenza dell'umanità.
6 - LE STRATEGIE SEGUITE DAGLI SCIENZIATI RESPONSABILI
I fisici del Progetto Manhattan hanno sperimentato che i leader politici senza scrupoli insistevano sul fatto che il bombardamento del Giappone era inevitabile, sebbene fosse noto che si trattava di una questione quantomeno controversa per ragioni etiche, militari e politiche. In seguito, una piccolissima minoranza di scienziati responsabili ha voluto rispondere a un problema sociale così colossale come quello rappresentato dalle armi di distruzione di massa. Questi scienziati hanno dovuto abbandonare una concezione rousseauiana della scienza per scegliere una strategia su come interagire con l'opinione pubblica e i governi. Sono state sperimentate sette strategie.
La diffusione delle informazioni fu la prima strategia sperimentata. Dopo che gli scienziati del Progetto Manhattan avevano subito il segreto militare, le dichiarazioni collettive di alcuni di loro rappresentarono un atto di indipendenza e autonomia politica. Tuttavia, i primi appelli pubblici dimostrarono che la loro capacità di diffondere informazioni e influenzare l'opinione pubblica era scarsa; pertanto, questa strategia fu rapidamente abbandonata o lasciata a iniziative specifiche condotte da professionisti della comunicazione al pubblico.
Una seconda strategia, il lavoro educativo, è stata temporaneamente sperimentata dall'ECAS (un'associazione di scienziati fondata da Einstein e sopravvissuta per alcuni anni) e dall'iniziativa permanente del Bulletin. Sicuramente, quest'ultima iniziativa è stata più produttiva. Ha diffuso informazioni, dato voce al dissenso, aperto uno spazio per le controversie e sostenuto gli appelli degli scienziati ai governi; in sintesi, un grande lavoro pedagogico.
Le strategie successive, relative a un lavoro sociale trasformativo, hanno svolto un ruolo decisivo nel cambiare l'immagine pubblica dello scienziato, che si è trasformata in una pluralità di immagini, da quella di obiettore di coscienza a quella di scienziato pienamente coinvolto negli affari politici.
Le assurdità sopra menzionate derivanti dalla produzione di armi nucleari hanno scosso l'etica della responsabilità degli scienziati. L'etica della convinzione ha spinto alcuni scienziati ad abbandonare l'attività scientifica in campo militare. Infatti, Jòzef Rotblat lasciò il Progetto Manhattan quando la Germania fu sconfitta nel maggio 1945 (Rotblat 1985) e J. Robert Oppenheimer si pentì. Per quanto riguarda il comportamento degli altri scienziati, quelli che facevano appello all'etica della convinzione sembrano aver condiviso le seguenti opinioni (ottenute parafrasando le frasi di Oppenheimer e Rasetti): "La comunità dei fisici ha conosciuto il peccato dell'uccisione di massa". "Questa comunità ha venduto la fisica allo Stato (militare)". Ma l'obiezione di coscienza al lavoro scientifico militare era considerata un atto individualista, forse giustificato a livello personale, ma senza alcuna influenza sulla risoluzione dell'enorme problema sociale[5]. In realtà, il numero di azioni simili era molto esiguo e non godeva di un ampio sostegno.
Un'ulteriore strategia consisteva nel fare pressione attraverso un movimento sociale contro le armi nucleari sulle decisioni prese dai rappresentanti politici. Alcuni promossero un movimento sociale; in particolare, Rotblat, dopo aver redatto l'ERM, fondò, insieme a Russell, la Campagna per il disarmo nucleare. Questi scienziati responsabili che hanno fondato e guidato movimenti sociali contro le armi nucleari sono riusciti a influenzare sia l'opinione pubblica che la politica dei governi. Tuttavia, stranamente, gli scienziati che hanno avuto più successo non sono stati quelli più direttamente interessati, cioè i fisici[6] , ma un matematico-filosofo, Bertrand Russell, e un chimico, Linus Pauling (che ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace, dopo aver ricevuto il Premio Nobel per la Chimica).
7 - LE STRATEGIE SEGUITE DAGLI SCIENZIATI ISTITUZIONALIZZATI
Una strategia consisteva nel fare pressione, attraverso appelli all'opinione pubblica, sulle decisioni prese dai massimi rappresentanti politici. Questa strategia merita attenzione perché è stata scelta dagli scienziati più rinomati e rappresentativi. Proprio per questo motivo il loro appello rivendicava una visione razionale del mondo. Speravano che, una volta che l'opinione pubblica avesse preso coscienza dell'estrema pericolosità delle armi nucleari, questo fatto da solo avrebbe portato il governo a prendere la decisione di raggiungere un accordo contro le armi nucleari. Questa visione, basata sulla razionalità della politica nazionale, si rivelò ingenua.
Sebbene scritto da un grande filosofo e sottoscritto dalle menti acclamate come le più brillanti dell'epoca, l'ERM taceva sui cambiamenti della drammatica crisi dell'istituzione scientifica ora direttamente soggetta al potere politico; in particolare, non diceva nulla sull'etica degli scienziati, a parte un appello a comportarsi come esseri umani (questo appello può essere interpretato come un rifiuto della loro etica di responsabilità a favore di un'etica di convinzione?). Piuttosto, l'ERM insisteva nel presentare il ruolo degli scienziati come osservatori e promotori più saggi sia della razionalità che del benessere dell'umanità, in breve la coscienza razionale dell'umanità. Questa auto-presentazione incompleta e pontificante pregiudicava un rapporto franco tra questi scienziati e l'opinione pubblica.
L'ERM mise in guardia l'opinione pubblica contro «un pericolo», ovvero la più grande distruzione possibile. Di fronte a ciò, questi scienziati non volevano né dichiarare la crisi della loro etica della responsabilità né adottare l'etica della convinzione; piuttosto, volevano promuovere nella società civile una nuova convinzione etica: «che lo scopo [delle superpotenze] [di risolvere il loro conflitto] non può essere perseguito con una guerra mondiale»[7].
Invece, la contemporanea dichiarazione di Mainau (1955) presenta una valutazione negativa drastica sulla nascita di una potente scienza militare ("Vediamo con orrore che proprio questa scienza sta dando all'umanità i mezzi per distruggere se stessa"). Inoltre, questa dichiarazione era indirizzata direttamente ai governi. Gli scienziati firmatari rifiutarono di riferire la loro etica della responsabilità alla politica di deterrenza dei governi e cercarono inoltre di convincere razionalmente i governi ad abbandonare questa politica[8].
Tuttavia, entrambe le dichiarazioni non hanno indotto alcun cambiamento né nella corsa agli armamenti nucleari che minacciava la sopravvivenza dell'umanità, né nel destino che il Progetto Manhattan aveva imposto alla scienza: quella di trasformarsi in una grande scienza che fosse anche uno strumento del potere militare e politico.
Un'altra strategia è stata seguita da quegli scienziati che sono stati chiamati dai governi per ricevere consigli sugli aspetti scientifici degli accordi (e dei disaccordi) politici internazionali sulle armi nucleari. Questo invito ha generato anche risposte da parte di gruppi di scienziati. Ad esempio, il segretario nazionale della suddetta USPID ha dichiarato:
"Noi, come scienziati per il disarmo, volevamo fare qualcosa che in Italia non era mai stato fatto; volevamo essere un partner credibile per le istituzioni" (Lenci 2004).
Questo tipo di lavoro è stato presentato anche come un impegno per la promozione della pace. Tuttavia, questi scienziati hanno dovuto riferire la loro etica della responsabilità all'istituzione della grande scienza, che dipendeva dai fondi finanziari del governo. In questo modo, l'istituzione finale di riferimento della loro etica della responsabilità era, attraverso la ricerca scientifica, il governo politico. Di fatto, fu stabilito un patto: il governo forniva generosi finanziamenti per la ricerca scientifica e in cambio questi scienziati assicuravano due funzioni sociali: 1) lavorare come massimi tecnici delle questioni nucleari della politica internazionale e 2) lavorare come migliori raccoglitori del consenso pubblico sulle politiche del governo in materia scientifica. Qualcuno ha caratterizzato l'atteggiamento di tali consulenti come la pretesa di godere di un QI più elevato rispetto alla gente comune (Alfven 1981 p. 4).
Col senno di poi, i consulenti scientifici del governo non possono essere orgogliosi di aver promosso la pace; la crescita sconsiderata dell'arsenale nucleare fino a dieci volte la capacità di distruggere l'intera umanità non è mai stata contrastata dai loro consigli; più che promotori di una nuova politica del governo, hanno lavorato come tecnici subordinati alle decisioni politiche[9].
Un ruolo particolare è stato svolto da alcuni altri scienziati (il gruppo internazionale Pugwash; Nickerson 2013) che, in nome dell'autorità di una scienza neutrale rispetto a tutte le divisioni politiche nel mondo, hanno cercato di essere riconosciuti come mediatori nelle controversie internazionali sulle questioni nucleari. Poiché la loro azione doveva essere rivolta ai consulenti dei governi, le loro iniziative dovevano essere sostenute solo da autorità scientifiche rinomate. Di conseguenza, il gruppo Pugwash si è costituito come un'organizzazione elitaria e cooptativa. Nel complesso, questo gruppo è riuscito ad aprire alcuni canali di comunicazione tra Est e Ovest durante la Guerra Fredda.
Quale relazione esiste tra le sette strategie sopra descritte e i quattro gruppi di scienziati elencati nella sezione 5? La tabella seguente rappresenta la varietà di relazioni.
| Neutralità della scienza | Nessun militare | Nemmeno energia nucleare civile | Etica al di sopra della scienza | |
| Informazione | x | x | x | x |
| Istruzione | x | x | x | x |
| Obiezione di coscienza | x | |||
| Movimento sociale | x | x | x | |
| Appello all'opinione pubblica e ai governi | x | (x) | (x) | (x) |
| Consulenti dei governi | x | |||
| Relazioni internazionali | x |
Nel complesso, le azioni degli scienziati responsabili hanno ottenuto successi limitati nell'influenzare gli altri scienziati, l'opinione pubblica, i leader politici e le decisioni militari. In particolare, la corsa alla bomba H, iniziata nel 1949, ha brutalmente dimostrato che quasi tutti i fisici erano stati catturati dalla politica del confronto nucleare con l'URSS; in altri termini, la "razionalità" (?) della politica ha prevalso sulla razionalità degli scienziati.
Ciò che invece è stato determinante nell'eliminare la minaccia immediata di un’apocalisse nucleare è stata la serie di rivoluzioni del 1989 e degli anni successivi. Questo fatto suggerisce che durante la Guerra Fredda gli scienziati devono scegliere come strategia migliore quella di sostenere le persone, piuttosto che i governi. Questa strategia richiedeva un'etica preoccupata della sopravvivenza dell'umanità, piuttosto che della politica dei governi o di relazioni internazionali più fluide. Questa etica è stata seguita più da vicino dagli scienziati che seguivano l'etica della convinzione piuttosto che da quelli che seguivano l'etica della responsabilità. In particolare, gli scienziati più efficaci sono stati Russell e Pauling, che hanno scelto di guidare i movimenti popolari; ovvero, la strategia più efficace è stata quella di mobilitare la popolazione su obiettivi specifici sui quali gli scienziati hanno lavorato come esperti del popolo.
NOTE:
[1] Il periodo di tempo considerato è quello della Guerra Fredda, o meglio gli anni 1945-1981; quest'ultima data precede "l'anno degli appelli" (Feld 1982), che richiede un'analisi diversa.
[2] Questa classificazione è in accordo con l'illustrazione (Drago 1996) dei quattro atteggiamenti generali nei confronti della scienza.
[3] Ricordiamo alcune frasi severe di questi scienziati. Rasetti: "Hanno venduto la fisica al diavolo"; Oppenheimer: "I fisici conoscevano il peccato; e questa è una conoscenza che non possono perdere". Sebbene oscillasse tra un pacifismo estremo e un coinvolgimento nel lavoro militare (Ventura 2005), Einstein appartiene a questo gruppo, poiché lamentava con fermezza che il progresso etico fosse troppo lento rispetto al progresso scientifico. Inoltre, era un ammiratore incondizionato di Gandhi, da lui considerato l'unico maestro del XXsecolo.
[4] Pochi scienziati si sono interessati agli aspetti sociali degli eventi storici che hanno caratterizzato la loro epoca e ancora meno scienziati hanno razionalizzato questi eventi attraverso valutazioni accurate. Max Born sembra essere il più perspicace.
[5] Si veda ad esempio la valutazione in (Calogero 1983), scritta al momento dello schieramento dei missili Cruise a Comiso (Sicilia). L'autore è stato a lungo segretario internazionale del gruppo Pugwash.
[6] Einstein ha avuto una grande influenza in entrambi i sensi, sia nel promuovere l'ottenimento dell'arma nucleare, sia nell'avvertire l'opinione pubblica del pericolo rappresentato dalle armi nucleari.
[7] Un gran numero di scienziati (primo fra tutti Russell) ha considerato i negoziati per il disarmo nient'altro che uno strumento di propaganda delle superpotenze (Panofsky 1981, p. 33).
[8] Tuttavia, il precedente Rapporto Franck (Franck Report 1945), declassificato nel 1946, sembra essere il documento più significativo sulla coscienza degli scienziati. Il suo "Preambolo" è sicuramente il documento più rilevante in materia di politica etica, strategica e internazionale relativa alle armi nucleari. Purtroppo, è stato diffuso nella società civile solo per un breve periodo (pochi anni) e non è mai stato citato nelle dichiarazioni successive, nonostante il suo contenuto sia tra i più incisivi.
[9]Di fatto, questa etica della responsabilità è stata sistematicamente e senza pietà smentita dagli eventi storici. 1) Le democrazie non sono state minacciate da un attacco nucleare perché Hitler non è riuscito a ottenere la bomba. 2) Il governo degli Stati Uniti ha ingannato gli scienziati sulla motivazione dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki. Piuttosto che la motivazione ufficiale - cioè ridurre al minimo il numero delle vittime per porre fine alla guerra - sono state decisive altre due ragioni importanti: 1) ottenere il guadagno dal gigantesco fondo finanziario attribuito al Progetto Manhattan e 2) superare la rivale URSS nella regione del Pacifico. 3) I bombardamenti delle due città giapponesi rappresentano un uso illegale delle armi, almeno secondo il diritto internazionale di guerra che vieta il bombardamento della popolazione civile. 4) Gli scienziati sono entrati incautamente in una grande e complessa istituzione scientifica, la grande scienza, che è cresciuta secondo gli obiettivi del governo piuttosto che secondo uno sviluppo indipendente di questa istituzione. 5) Sono stati in gran parte coinvolti in attività professionali volte a promuovere la corsa agli armamenti nucleari, piuttosto che a frenarla. 6) Nel dibattito sulla costruzione della bomba H, gli scienziati non hanno compreso il governo degli Stati Uniti che, contrariamente alle loro speranze, non voleva la pace.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
Alfven H (1981) "Human IQ versus Nuclear IQ", Bull. Atomic Scientists, gennaio, pp. 4-5.
Ben-David J. (1971), The Scientists' Role in Society, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.
Calogero F. (1983), "Scienziati e armi nucleari", Sapere, luglio.
De Solla Price D. (1963), Little Science, Big Science, New York, Columbia U.P.
Drago A. (1985), Scienza e Guerra. La responsabilità degli scienziati, Napoli, CUEN,
Drago A. (1996), "Scienza", in Dizionario di Teologia della Pace, in L. Lorenzetti (ed.), Bologna, EDB, pp. 151-163.
Drago A. (2010), “Un’etica biblica da età matura del mondo”, Riv. Teologia Morale, n. 165, genn.-mar., 71-84.
Drago A., Salio G. (1983), Scienza e Guerra. I fisici contro la guerra nucleare, Torino, EGA.
Einstein A. (1937), New York Times. 1937.
Manifesto Einstein-Russell (1955): https://it.wikipedia.org/wiki/Manifesto_Russell-Einstein
Feld B.T: (1982), “The year of appeals”, Bull. Atomic Scientists, dicembre, pp. 6-9.
Frank Report (1945), http://blog.nuclearsecrecy.com/2012/01/11/weekly-document-9-the-uncensored-franck-report-1945-1946/
Ionno Butcher S. (2005), The Origins of the Russell-Einstein Manifesto”, Pugwash History series n. 1, ”
https://pugwashconferences.files.wordpress.com/2014/02/2005_history_origins_of_manifesto3.pdf
Jonas H. (1985) Il principio di responsabilità (orig. 1979), U. Chicago P., Chicago.
Jungk R. (1958), Brighter than a Thousand Suns: A Personal History of the Atomic Scientists, New York, Harcourt Brace.
Lenci F. (2003), “Carlo Bernardini e l'Unione Scienziati Per il Disarmo (USPID)”, PRISTEM Newsletter, http://matematica-ld.unibocconi.it/interventi/carlobernardini/bernardini2005.htm
Lenci F. (2004), ”Responsabilità della scienza nei confronti della pace e della guerra” http://www.parrocchiadipaterno.it/PDF/Pace%20-%20Lenci.pdf
Dichiarazione di Mainau (1955), https://en.wikipedia.org/wiki/Mainau_Declaration
Manifesto dei Novantatre (1914), ottobre
https://en.wikipedia.org/wiki/Manifesto_of_the_Ninety-Three
Merton R. K. (1938), “Science, Technology and Society in Seventeenth Century England”, Osiris, Vol. 4, pp. 360-632.
Merton R. K. (1973), The Sociology of Science, Chicago., U. Chicago P..
Nickerson S: (2013), “Taking a Stand: Exploring the Role of the Scientists prior to the First Pugwash Conference on Science and World Affairs, 1957”, Scientia Canadensis, 36, 2, pp. 63-87.
Panofsky W.K.H. (1981), “Science, Technology and the Arms Race,” Physics Today, giugno, 32-41.
Rhodes R. (1986) The Making of Atom Bomb, New York, Schuster.
Rotblat J. (1985), "Leaving the Bomb Project" (Abbandonare il progetto della bomba). Bulletin of Atomic Scientists, agosto, pp. 16-19.
Petizione di Szilard (1945), Petizione al Presidente degli Stati Uniti,
http://www.dannen.com/decision/45-07-17.html.
Teller E. (1945), "Letter to Szilard", 4 luglio ,
http://www.atomicarchive.com/Docs/ManhattanProject/SzilardTeller2.shtml
Vadacchino M. (2002), "La morale degli scienziati e la bomba atomica"
http://cisp.unipmn.it/files/pubblicazioni/08-Vadacchino-Morale-e-scienziati.pdf
Ventura T. (2005), “Einstein’s Antigravity”,
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_antigravity01.htm
Weber M. (orig. 1918), "La scienza come vocazione", in Gerth H.H. e Wright Mills C. (a cura di) (1958), Da Max Weber: Saggi di sociologia, Oxford, Oxford U. P., pp. 129-56.
Weber M. (1930), L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, New York, Routledge.
Weinberg A. S. (1985), "Sanctifying Hiroshima", Bull. Atomic Scientists, 41, ottobre 1985, p. 34.
Weisskopf V.F. (1983), "Los Alamos anniversary: "We meant so well"", Bull. At. Sci., 39, agosto-settembre, pp. 24-26.
Woollett E.L. (1980): "Physics and Modern Warfare: The Awkward Silence", American J. Physics, 48, febbraio, 105-117.
La dottrina di Palantir - "La repubblica tecnologica" di Karp e Zamiska
1 - PALANTIR
Alex Karp (CEO di Palantir Technologies, azienda statunitense specializzata nell'analisi dei big data che lavora per le agenzie federali statunitensi e di altri paesi, e per aziende private, finanziarie e di assistenza sanitaria) ha costruito il libro[1] sull’ideologia di Palantir nello stesso modo in cui monta le sue macchine: la veste corrisponde al canone in voga, ma il contenuto è un ordigno pericoloso, che deflagra quando viene raggiunto il target. Come insegnano i giornalisti scientifici, ogni capitolo si apre con la presentazione di un personaggio esemplare, si sviluppa con una generalizzazione, si conclude con una morale: cerca un pubblico universale, con un linguaggio e una linearità argomentativa che non si preoccupano delle trappole del semplicismo. Meglio dieci banalizzazioni in più che un lettore perso: Karp sa bene che sono tempi duri per la saggistica.
L’autore è il cofondatore con Peter Thiel di Palantir, l’unica società della Silicon Valley che si è sempre dichiarata a favore della collaborazione con lo Stato, con i servizi di intelligence, con le agenzie della Difesa e gli eserciti degli Stati Uniti e dei loro alleati. In italiano il volume è stato pubblicato da Silvio Berlusconi Editore, confermando lo spiazzamento degli editori (progressisti? tradizionali?) rispetto ai temi più urgenti dell’attualità. Karp non teme le imboscate della superficialità perché il problema che dibatte è così impellente da disegnarsi in contorni netti anche attraverso una forma divulgativa.
Il primo ingranaggio dell’esposizione riguarda il rapporto tra le tecnologie informatiche e gli interessi nazionali americani. Karp rimprovera ai colleghi startupper e innovatori dell’area di San Francisco di vergognarsi delle origini dell’industria digitale, contaminate dagli interessi e dai finanziamenti militari. Turing, Von Neumann, Vannevar Bush, i padri nobili del settore, erano consapevoli del valore strategico che le nuove tecnologie conferivano alle nazioni che le stavano sviluppando. Non è così per i loro eredi moderni. La classe di hacker creativi, che ha innescato dalla fine del millennio scorso l’esplosione di invenzioni, imprese, progetti, da cui è caratterizzata l’economia della Rete, è cresciuta in un’era e in un’area geografica mai minacciata dalla guerra, e dalle preoccupazioni che le sono collegate. Ha considerato l’inviolabilità del territorio americano (ed europeo) come una conseguenza del primato intellettuale, più che militare; di conseguenza, ha stimato imbarazzante ogni contatto con la pesantezza burocratica dello Stato e con i malcostumi dei politici, preferendo ritirarsi nell’ambito del mercato rivolto al pubblico di massa. La Silicon Valley è indietreggiata da ogni impegno nell’ambito della sicurezza nazionale, e ha rinunciato ad avventurarsi nell’ambito della complessità morale delle armi e della guerra, dedicandosi in modo completo alle tecnologie di consumo, alle app sociali, al mercato dell’intrattenimento, dei giochi, dello spettacolo.
Karp considera la fiducia nella solidità della pace un tromp l’oeil prodotto dalla deterrenza dell’arsenale bellico americano; ma oggi, come già osservava Kissinger in una delle sue ultime pubblicazioni[2], l’intelligenza artificiale disattiva i meccanismi di equilibrio degli ultimi decenni, perché diventa impossibile stimare il potenziale distruttivo gestito dagli avversari. I conflitti del futuro non saranno consumati nelle trincee, con masse di uomini inviati alla carneficina – ma non saranno nemmeno decisi dai depositi di bombe e di veicoli militari a disposizione delle nazioni. L’asset differenziale sarà rappresentato dalle informazioni utili per identificare gli obiettivi corretti (individui, server farm, bunker, passaggi e locali segreti, archivi), per coordinare stormi di droni e di robot, per compiere manovre di sabotaggio preventivo, per manipolare l’opinione pubblica degli avversari, per accedere agli strumenti di controllo delle infrastrutture strategiche nemiche (centrali e dorsali elettriche, sistemi bancari, infrastrutture di gestione multiutility), insomma per neutralizzare gli antagonisti prima di sparare un colpo sul campo di battaglia – e soprattutto, senza alcuna dichiarazione di guerra, in forma segreta o dissimulata, e senza rivendicazione degli attacchi compiuti. Il nemico non è mascherato, è del tutto senza volto. La moltiplicazione degli scenari possibili di scontro è resa possibile dalla dipendenza dalla Rete e dai dispositivi elettronici delle società avanzate; l’imprevedibilità degli effetti dell’intelligenza artificiale deriva dall’efficienza di queste tecnologie nell’accedere ai servizi informatici avversari, e nel controllare apparati complessi. Palantir si esercita su questo genere di attività, e Karp sostiene che gli avversari dell’Occidente siano già da tempo all’opera per ottenere risultati più efficienti di quelli raggiunti dagli USA e dai loro alleati. La diserzione della Silicon Valley ha permesso alle dittature orientali – soprattutto la Cina – di ridurre il ritardo nell’evoluzione tecnologica che le distanziava dall’America, fino ad azzerarlo: il vallo che ha assicurato la pace delle democrazie liberali è ormai quasi del tutto scavalcato, e non permette più di trascurare il problema.
2 - OCCIDENTE, EPOS E IDENTITÀ
Il concetto di Occidente è problematico, e Karp ne è consapevole: l’area del mondo che si denota con questa etichetta, la storia e i valori che le sono attribuiti, emergono da una costruzione concettuale molto compromessa con il periodo delle colonizzazioni. Come osserva Edward Said[3], è una nozione che sorge tra la fine del Settecento e l’Ottocento attraverso l’opposizione alle civiltà e alle regioni che i britannici e i francesi hanno occupato e sfruttato, fuori dai confini europei; e che ha legittimato queste operazioni di conquista. Karp rivendica l’artificialità di questo costrutto ideologico – e questo è il secondo ingranaggio della sua esposizione – riconducendolo ad un contesto di più ampia portata, in cui confluiscono le sue riflessioni su identità, creatività, evoluzione, senso dell’esistenza. Il taglio con cui procede l’argomentazione è quello della parresia: l’autore accusa di ipocrisia e di inerzia l’élite che domina l’industria culturale contemporanea, gestendo le piattaforme e producendo le narrazioni ideologiche in cui siamo tutti immersi. E qui si trova il paradosso per cui è Silvio Berlusconi Editore ad aver tradotto in italiano il libro.
Il riconoscimento della dignità dell’altro – civiltà, minoranza etnica, genere – ha finito per paralizzare qualunque discorso assertivo sui valori, sulle preferenze estetiche, sugli obiettivi, su ciò che è meglio e su ciò che è peggio, diluendo e annacquando il senso stesso di qualunque attività culturale, che invece si fonda sull’assiologia delle differenze. La capacità di giudizio consiste nell’assegnare pesi diversi all’eterogeneità delle istanze, stabilendo priorità e asimmetrie di interesse.
Nell’ambito delle imprese, questo atteggiamento ha promosso la mediocrità di chi preferisce una gestione routinaria delle attività quotidiane, e favorisce le decisioni accomodanti (quindi l’assenza di decisioni), evitando l’impegno in sfide interessanti, sottraendosi all’investimento sulle novità rischiose. La ricerca che viene autorizzata da questa impostazione del lavoro è quella che conosce in anticipo i risultati che possono essere raggiunti, e che quindi si limita a incarnare un simulacro dell’indagine, privo di ambizioni originali.
Sul terreno politico, il timore preventivo dell’oltraggio ha finito per equiparare tutte le differenze, annullando il significato delle identità. La battaglia per la tutela del diritto alla permalosità è servita a nascondere l’assenza di idee per il futuro, a sfuggire all’urgenza di elaborare progetti antropologici di ampio respiro; ha condotto all’abdicazione dalla funzione politica, affidandola ai guru della Silicon Valley. Visto che gli interessi degli imprenditori californiani sono focalizzati sulla dimensione privata, su una visione dell’individuo che non è cittadino, ma consumatore della vita (persino di quella eterna, promessa dal «Singolarismo» di Ray Kurzweil[4]), il dibattito sul bene comune, sulla configurazione ideale della società per raggiungerlo, sulla forma della felicità collettiva e sul modo di realizzarla (5), scivola al di sotto del tracciato di tutti i radar mediatici, scompare da tutti gli schermi. La politica nel senso di Aristotele[5], nel significato essenziale della sua missione, è stata abbandonata. Questa è l’occasione persa dagli editori (di sinistra?) nell’aver lasciato a Silvio Berlusconi Editore il compito di tradurre il libro di Karp.
L’ingegneria del software è un percorso di coordinamento del lavoro collettivo, dall’ideazione all’implementazione, per identificare problemi di interesse comune, tentare la soluzione, realizzarla e testarla. Per Karp questo modello è anzitutto l’esemplificazione del valore dell’impegno personale nella produzione di un significato che abbia valore collettivo. Sembra strano che tocchi al CEO di una Big Tech, protagonista dello sviluppo dell’AI, sottolineare la connessione di argomenti come la rilevanza del coinvolgimento dell’individuo, della dedizione di tutta la sua soggettività, con lo sviluppo di un bene comune. Michael Polanyi insegnava[6] che la condizione necessaria per la conservazione e il trasferimento dei significati contenuti nella letteratura di qualunque scienza, per la continuità delle maestranze artigianali, per l’intera riproduzione sociale – è l’impegno personale con cui gli individui sperimentano e assorbono un’intero patrimonio di conoscenze tacite, non tematizzate, non coscienti, che permettono l’interpretazione di tutto quello che può essere compreso e praticato in modo esplicito. È un impegno ontologico, non solo etico, perché dà consistenza reale ai valori della comunità, e coinvolge gli esseri umani nella loro soggettività, nella loro esistenza complessiva.
Karp denuncia la ritirata da questo tipo di impegno: questa è la sfida più importante del suo libro.
Ogni tradizione è artificiale, l’identificazione con i suoi valori è l’effetto di una decisione, così come l’immersione nel suo solco; la scelta pretende anche la responsabilità sincera dell’individuo che l’ha compiuta. L’Occidente è un taglio arbitrario, che separa la Grecia, Roma, Gerusalemme, dai loro vicini egizi, fenici e mesopotamici; distingue l’arte di Michelangelo, Raffaello, Leonardo, dalle maschere africane; oppone Leibniz alla Cina, Schopenhauer ai Veda. Solleva una questione di adesione emotiva, suscita sentimenti che le correnti politiche moderne irridono o sfruttano come oggetti di pura propaganda – perché la cultura contemporanea non ammette più l’epos. La narrazione di gesta eroiche è una patologia della soggettività, che riguarda il passato o le civiltà etniche, o che può essere utilizzata per operare interventi di ingegneria sociale sulle masse stupide, o frustrate (o entrambe le cose), che anelano l’oppio cognitivo dispensato dai movimenti alt-right. Ma gli uomini hanno bisogno di un senso per la loro esistenza, si devono impegnare per un significato che vada oltre la constatazione obiettiva dei fatti, la replica infinita dell’attualità, senza prospettive, senza giustizia, senza riscatto. Palantir è un nome che viene dal Signore degli anelli, e nella sua ambiguità indica uno strumento per osservare fatti lontani, per comunicare a grande distanza. Nel suo carattere controverso, equivoco, impregnato di soluzionismo tecnologico, la voce di Karp si solleva per domandare un nuovo impegno nei confronti della comunità, una serietà settecentesca per progettare, desiderare, immaginare, al di là del nichilismo, oltre il cinismo contemporaneo – l’uomo nuovo che verrà.
NOTE:
[1] Alexander Karp, Nicholas Zamiska, La repubblica tecnologica. Come l’alleanza con la Silicon Valley plasmerà il futuro dell’Occidente, tr. it. di Chiara Rizzo e Pietro Del Vecchio, Silvio Berlusconi Editore, Milano 2025.
[2] Henry Kissinger, Eric Schmidt, Daniel Huttenlocher, L'era dell'intelligenza artificiale. Il futuro dell'identità umana, tr. it. Di Aldo Piccato, Mondadori, Milano 2023.
[3] Edward Said, Orientalismo, tr. it. di Stefano Galli, Feltrinelli, Milano 2001.
[4] Ray Kurzweil, La singolarità è vicina, tr. it. di Virginio Sala, Apogeo Edizioni, Milano 2008.
[5] Aristotele, Politica e Costituzione di Atene, tr. it. a cura di Carlo Augusto Viano, UTET, Torino 2013, in particolare Politica, Libro VII.
[6] Michael Polanyi, La conoscenza personale. Verso una filosofia post-critica, tr. it. a cura di Enrico Riverso, Rusconi, Milano 1990.
L'etica dei fisici sulle armi nucleari - Prima parte
Questo articolo ci è stato gentilmente concesso da Antonino Drago, Professore Ordinario di Storia della Fisica (in pensione) presso l’Università Federico II di Napoli, membro della rete Transcend di Galtung e primo presidente del Comitato ministeriale per la Difesa civile non armata e nonviolenta. Nel suo percorso, il professor Drago analizza il rapporto tra i fisici e l'etica, prima e dopo "la bomba", e i diversi atteggiamenti e strategie che i fisici hanno adottato - e ancora adottano - di fronte ai problemi etici che il lavoro può generare. Pubblichiamo l'articolo in tre "puntate", l'ultima delle quali uscirà i concomitanza ad un seminario, organizzato da Controversie, in cui interverrà lo stesso professor Drago.
1. Introduzione
Il progresso tecnologico ha reso sempre più artificiale la vita quotidiana dell'essere umano. Se in passato l'etica era chiara, l'introduzione di oggetti artificiali che pervadono anche la vita intima di una persona ha generato innumerevoli dilemmi etici le cui risposte non sono codificate da alcuna autorità, se non dal modo comune e corrente di vivere le nuove situazioni. Ma questa etica ha incontrato grandi pericoli senza precedenti. Tra questi il pericolo dell'autodistruzione dell'umanità, già previsto dopo il bombardamento delle due città giapponesi, Hiroshima e Nagasaki. Questo impressionante pericolo ha messo in discussione l'etica dell'intera popolazione mondiale, ma in primo luogo la coscienza dei fisici che hanno contribuito a costruire armi così catastrofiche. Dopo questo, altri pericoli simili sono stati generati dal continuo progresso della scienza e della tecnologia. Ogni volta che sorge un nuovo pericolo, la popolazione e i suoi leader cercano le migliori risposte personali e soluzioni globali per quel caso particolare, partendo da zero perché manca un organismo etico globale. È quindi importante riflettere sulle risposte etiche dei diretti responsabili, i fisici, e delle istituzioni politiche al primo grande pericolo, quello nucleare.
Questa esperienza storica può suggerire molte lezioni su come affrontare le successive e le prossime. Innanzitutto, insegna che gli scienziati non sono esseri sovrumani, sebbene abbiano studiato e applicato una materia quasi incomprensibile, la scienza e, in particolare, la fisica; ma hanno problemi etici paragonabili a quelli dei profani e inoltre possono essere anche più deboli in materia di etica rispetto alla gente comune. Pertanto, per quanto riguarda i problemi etici, la popolazione deve evitare un rispetto reverenziale per una categoria sociale che spesso si presenta come illuminata e superintelligente. Deve piuttosto instaurare forti relazioni con gli esperti al fine di suggerire soluzioni comuni ai problemi etici generati dalla ricerca scientifica.
2. I fisici, l'etica e la nascita delle armi nucleari
L'opinione diffusa tra i fisici sul proprio lavoro è che esso non riguardi l'etica; essi amano dedicarsi alle loro affascinanti ricerche. Questa valutazione deriva da una visione rousseauiana della ricerca scientifica, secondo la quale essa è intrinsecamente buona e il male possibile proviene dalla società.
Robert Merton (Merton 1938; Merton 1973) descrive l'etica degli scienziati come caratterizzata da quattro imperativi interconnessi: universalismo, comunismo (tra scienziati), disinteresse e dubbio sistematico. La loro etica è legata a uno spirito tradizionalmente religioso, tanto da essere definita un'etica puritana.
Ma la società non è una semplice somma di individui; essa comprende anche le istituzioni sociali. Tenendo conto di quest'ultimo punto di vista, Max Weber (1918) distingue due tipi di etica: quella a livello personale, l'etica della convinzione, che è l'etica che ogni uomo riceve dalle sue convinzioni personali, e l'etica della responsabilità, un'etica i cui primi obblighi sono quelli prescritti dall'istituzione sociale a cui si appartiene (se considerata in senso negativo, questa etica è chiamata etica machiavellica).1
Entrambi gli autori considerano la ricerca scientifica un'impresa eticamente positiva, perché rappresenta in termini razionali il progresso dell'umanità. Inoltre, Weber descrive la modernità come un processo di razionalizzazione secolare, promosso principalmente dal progresso scientifico; quindi, l'etica del ruolo professionale di uno scienziato è la più positiva possibile, poiché promuove direttamente la razionalità all'interno della vita sociale. Di fatto, la maggior parte degli scienziati antepone la propria razionalità alla propria etica.
Tuttavia, una valutazione della scienza deve innanzitutto separare la scienza pura dalla scienza applicata. La scienza pura, essendo il risultato diretto della ragione umana, dà solo beni, a parte alcuni suoi risultati, ottenuti con metodi inappropriati o maliziosi; il compito di evitarli è un onere che non spetta agli scienziati, ma ai governi.
Nel XX secolo diverse e potenti istituzioni hanno interagito con gli scienziati. Ad esempio, già l'evento della prima guerra mondiale ha spinto alcuni scienziati a intervenire pubblicamente secondo la loro etica di responsabilità nei confronti dei propri Stati.2 Nella seconda guerra mondiale gli scienziati, su richiesta dello Stato, hanno accettato di lavorare in una gigantesca impresa militare a favore dei nazisti (in Germania e Giappone) e contro di essi (al di fuori della Germania). Sono entrati improvvisamente in un'impresa patriottica abbracciando le motivazioni dello Stato in guerra. Negli Stati Uniti il Progetto Manhattan 1939-1947 (Jungk 1958; Rhodes 1986) mirava a costruire la prima arma nucleare con un budget di 2 miliardi di dollari. L'obiettivo politico dell'impresa era quello di creare una politica internazionale di deterrenza attraverso la costruzione di un'arma che avesse una capacità distruttiva senza precedenti, in grado di annientare una grande popolazione. La razionalità degli scienziati li portò a sperare in una politica governativa razionale, durante e dopo la guerra. Il progetto riunì 130.000 lavoratori, tra cui migliaia di scienziati, anche i più eminenti al mondo (ad esempio Fermi, Oppenheimer, Bohr, Szilard, ecc.). Questi fisici accettarono di lavorare collettivamente in un'impresa diretta dai militari; accettarono inoltre il segreto militare e una vita segreta.
Il Progetto Manhattan ha cambiato bruscamente la storia degli scienziati, della ricerca scientifica e dell'umanità. Come sono cambiate le caratteristiche dell'etica degli scienziati? Come è cambiata la separazione tra scienza pura e scienza applicata?
In seguito, inaspettatamente, gli scienziati hanno dovuto affrontare nuovi problemi etici. Dopo che questo progetto si è rivelato un successo (test di Alamagordo, 16 luglio 1945), una controversia sull'uso di armi terrificanti ha diviso il gruppo di scienziati del Progetto Manhattan. Si doveva distruggere un'intera città con un'arma nucleare o no? Questo atto è sicuramente vietato sia dall'etica di convinzione degli scienziati che dal diritto di guerra; è tuttavia consentito dall'etica della responsabilità degli scienziati rispetto alla ricerca scientifica o all'etica della difesa degli Stati democratici contro i nazisti?
Pochi anni dopo iniziò una corsa agli armamenti nucleari. Essa coinvolse un numero sempre maggiore di scienziati in lavori professionali nei laboratori militari. Riguardo all'etica della responsabilità, la decisione di sostenere questa corsa agli armamenti era una decisione corretta o no? Dopo il Progetto Manhattan, la ricerca scientifica, come "una gallina dalle uova d'oro", continuò a ricevere dai governi ingenti finanziamenti, diventando così un'impresa colossale. In che misura una tale crescita quantitativa della scienza ha danneggiato la sua crescita qualitativa? Gli scienziati istituzionalizzati sono rimasti capaci di giudizi indipendenti? La scienza era ancora la forza motrice neutrale del progresso dell'umanità, o no? Gli scienziati erano ancora un gruppo sociale razionale e disinteressato che vegliava sul benessere dell'umanità, o il potere politico aveva subordinato il processo di razionalizzazione della vita sociale da parte degli scienziati a interessi particolari? Inoltre, dopo il Progetto Manhattan, ad altri scienziati è stato chiesto di diventare consulenti dei governi in materia di corsa agli armamenti, ovvero di suggerire i migliori miglioramenti tecnologici per un arsenale nucleare sempre più potente. Hanno promosso la pace internazionale o hanno piuttosto accettato di diventare servitori tecnici di una particolare potenza militare?3
3. Come gli eventi nucleari hanno cambiato l'etica dei fisici
Consideriamo ora l'etica professionale dello scienziato, ovvero l'etica del ruolo che egli svolge all'interno della sua istituzione e più in generale nella società. Per rispondere agli eventi eccezionali del periodo bellico, molti scienziati, in nome della loro etica della responsabilità, hanno aderito al Progetto Manhattan. Ma in questo modo hanno cancellato la distinzione tra scienza pura e scienza applicata. Inoltre, hanno accettato di essere organizzati collettivamente come in una fabbrica; è stata la nascita della "grande scienza", dove il lavoro di uno scienziato non era più simile a quello di un artigiano, ma a una particolare ruota di un grande meccanismo fortemente legato allo Stato (De Solla Price 1963).
Inoltre, inventando e costruendo tali armi, hanno negato le caratteristiche fondamentali dell'etica mertoniana dello scienziato, poiché hanno rinunciato a i) l'universalità della scienza - hanno abbracciato la particolare politica internazionale (la deterrenza nucleare) dei loro governi; ii) l'atteggiamento comunitarista - hanno accettato una vita segreta che li separava sia dalla società civile che dagli altri scienziati nel mondo; infatti, in ogni paese il gruppo di scienziati si è lanciato in una cinica competizione con i gruppi di scienziati di altri paesi; iii) il disinteresse - gli scienziati hanno dedicato tutti i loro sforzi al raggiungimento di un obiettivo militare di un governo che li finanziava massicciamente; iv) il dubbio sistematico - non avevano alcun dubbio sulle questioni politiche della loro impresa; anche quegli scienziati che avvertivano il pubblico del pericolo nucleare volevano comunicare verità assolute. Pertanto, il modello etico di Merton dello scienziato individuale non era più adeguato a rappresentare l'etica degli scienziati del secondo dopoguerra (Vadacchino 2002).
Inoltre, la nascita della grande scienza ha trasformato la loro etica della responsabilità da quella di un piccolo gruppo o di un laboratorio a quella di un'impresa sociale; ora dovevano rispondere a grandi istituzioni sociali (vedi ad esempio Weisskopf 1983). L'etica della responsabilità di uno scienziato che perseguiva questa impresa tendeva a mettere a tacere l'etica dei principi.
Weber aveva previsto anche un possibile risultato negativo del processo di razionalizzazione nella società: l'uomo poteva essere rinchiuso in una "gabbia di ferro" (1930, p. 181). La costruzione di armi nucleari ha portato l'umanità al risultato peggiore. Dopo la sperimentazione delle armi nucleari sulle città giapponesi, era evidente a tutti che la distruzione dell'umanità era possibile. Questa possibile distruzione ha rappresentato per la prima volta un'assurdità dell'etica della responsabilità di uno scienziato. Era manifestamente assurdo che questo tipo di etica potesse ammettere una distruzione che coinvolgesse anche l'istituzione sociale (la ricerca scientifica) che prescrive questo tipo di responsabilità. Inoltre, era assurdo che il processo di razionalizzazione durato molti secoli potesse ammettere, attraverso la fine dell'umanità, la fine del processo di razionalizzazione stesso. Ogni essere umano dotato di ragione deve ammettere queste assurdità.4 Queste due assurdità hanno suggerito ancora una volta in modo sorprendente l'etica della convinzione, il cui principio fondamentale - non uccidere mai - è apparso ancora una volta saggio nel consigliare che le conseguenze a lungo termine dell'uccisione possono essere imprevedibili.
4. L'acquiescenza collettiva di gran parte dei fisici alla nuova situazione etica
Durante il Progetto Manhattan l'unico problema di alcuni scienziati era di natura individuale: liberarsi dal segreto militare. Consideriamo la risposta di Edward Teller all'appello di Leo Szilàrd (Petizione Szilàrd 1945) contro la pianificazione di un bombardamento nucleare sulle città giapponesi:
Questa è l'unica causa per la quale mi sento in diritto di fare qualcosa: la necessità di sollevare il segreto [militare] almeno per quanto riguarda le questioni generali del nostro lavoro. A mio avviso, ciò avverrà non appena la situazione militare lo consentirà. (Teller 1945)
In altri termini, il primo e unico obiettivo di Teller era quello di riconquistare l'universalità della sua ricerca scientifica; egli si sentiva responsabile solo della libera ricerca scientifica.
Dopo il Progetto Manhattan, il reclutamento di scienziati per il lavoro militare è cresciuto notevolmente senza ostacoli (ad eccezione degli anni intorno al 1968).5 L'opinione comune dei fisici riguardo agli scienziati che lavorano nei laboratori militari è stata espressa pubblicamente dal segretario italiano dell'USPID (Unione Scientifica Italiana per il Disarmo):
Chi è coinvolto nei processi di progettazione, costruzione e modernizzazione delle armi a difesa del proprio Paese non è necessariamente un guerrafondaio. Infatti, o si riesce a invertire l'intero meccanismo, oppure non è concepibile che, fintanto che la sicurezza [nazionale] è legata al potere militare, sia possibile fermare questo volano della modernizzazione e dell'arricchimento degli arsenali nucleari (Lenci 2003).
NOTE:
1 Ricordiamo che la rivoluzione francese fu promossa e sostenuta da un gran numero di scienziati dell'epoca. Secondo il sociologo Ben-David (1971), la subordinazione degli scienziati al potere politico è iniziata dopo il fallimento di questa rivoluzione. Fu la borghesia emergente a introdurre il curriculum formale nelle università come unico percorso corretto per accedere al mondo della scienza, ovvero la carriera universitaria come unico percorso per essere riconosciuti come scienziati da una "comunità di pari scienziati", le società scientifiche (la prima delle quali fu la British Association for the Advancement of Science, fondata nel 1830) e il controllo della ricerca universitaria attraverso i suoi finanziamenti.
2 Si veda l'aberrante manifesto dei 93 scienziati a sostegno della proposta di guerra della Germania (Manifesto dei Novantatre, 1914).
3 Queste questioni sono già state presentate in (Drago, Salio 1983) e (Drago 1985). Naturalmente, i problemi di cui sopra si applicano solo agli scienziati occidentali, poiché gli scienziati dell'URSS erano costretti a partecipare a una politica generale che pretendeva di compiere un salto storico verso una nuova era per l'intera umanità, ottenuta grazie al progresso scientifico dell'URSS. Pertanto, in questi scienziati l'etica della responsabilità rispetto alla loro ricerca scientifica era identificata con l'etica della responsabilità rispetto alla politica del governo. Solo il fisico Kapitza si oppose alla costruzione di armi nucleari da parte dell'URSS. (Jungk 1958, cap. XV, sez. IV).
4 Qualche anno dopo Jonas (1978) teorizzò una nuova etica basata sull'imperativo di evitare questa assurdità. (Drago 2010) presentò un'etica più generale.
5 Successivamente, nel 1983, un'analisi accurata di tutti i contratti militari negli Stati Uniti ha dato come risultato che il 48±4% di tutti i fisici lavorava nella ricerca militare (Woollett 1983).
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
Alfven H (1981) "Human IQ versus Nuclear IQ", Bull. Atomic Scientists, gennaio, pp. 4-5.
Ben-David J. (1971), The Scientists' Role in Society, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.
Calogero F. (1983), "Scienziati e armi nucleari", Sapere, luglio.
De Solla Price D. (1963), Little Science, Big Science, New York, Columbia U.P.
Drago A. (1985), Scienza e Guerra. La responsabilità degli scienziati, Napoli, CUEN,
Drago A. (1996), "Scienza", in Dizionario di Teologia della Pace, in L. Lorenzetti (ed.), Bologna, EDB, pp. 151-163.
Drago A. (2010), “Un’etica biblica da età matura del mondo”, Riv. Teologia Morale, n. 165, genn.-mar., 71-84.
Drago A., Salio G. (1983), Scienza e Guerra. I fisici contro la guerra nucleare, Torino, EGA.
Einstein A. (1937), New York Times. 1937.
Manifesto Einstein-Russell (1955): https://it.wikipedia.org/wiki/Manifesto_Russell-Einstein
Feld B.T: (1982), “The year of appeals”, Bull. Atomic Scientists, dicembre, pp. 6-9.
Frank Report (1945), http://blog.nuclearsecrecy.com/2012/01/11/weekly-document-9-the-uncensored-franck-report-1945-1946/
Ionno Butcher S. (2005), The Origins of the Russell-Einstein Manifesto”, Pugwash History series n. 1, ”
https://pugwashconferences.files.wordpress.com/2014/02/2005_history_origins_of_manifesto3.pdf
Jonas H. (1985) Il principio di responsabilità (orig. 1979), U. Chicago P., Chicago.
Jungk R. (1958), Brighter than a Thousand Suns: A Personal History of the Atomic Scientists, New York, Harcourt Brace.
Lenci F. (2003), “Carlo Bernardini e l'Unione Scienziati Per il Disarmo (USPID)”, PRISTEM Newsletter, http://matematica-ld.unibocconi.it/interventi/carlobernardini/bernardini2005.htm
Lenci F. (2004), ”Responsabilità della scienza nei confronti della pace e della guerra” http://www.parrocchiadipaterno.it/PDF/Pace%20-%20Lenci.pdf
Dichiarazione di Mainau (1955), https://en.wikipedia.org/wiki/Mainau_Declaration
Manifesto dei Novantatre (1914), ottobre
https://en.wikipedia.org/wiki/Manifesto_of_the_Ninety-Three
Merton R. K. (1938), “Science, Technology and Society in Seventeenth Century England”, Osiris, Vol. 4, pp. 360-632.
Merton R. K. (1973), The Sociology of Science, Chicago., U. Chicago P..
Nickerson S: (2013), “Taking a Stand: Exploring the Role of the Scientists prior to the First Pugwash Conference on Science and World Affairs, 1957”, Scientia Canadensis, 36, 2, pp. 63-87.
Panofsky W.K.H. (1981), “Science, Technology and the Arms Race,” Physics Today, giugno, 32-41.
Rhodes R. (1986) The Making of Atom Bomb, New York, Schuster.
Rotblat J. (1985), "Leaving the Bomb Project" (Abbandonare il progetto della bomba). Bulletin of Atomic Scientists, agosto, pp. 16-19.
Petizione di Szilard (1945), Petizione al Presidente degli Stati Uniti,
http://www.dannen.com/decision/45-07-17.html.
Teller E. (1945), "Letter to Szilard", 4 luglio ,
http://www.atomicarchive.com/Docs/ManhattanProject/SzilardTeller2.shtml
Vadacchino M. (2002), "La morale degli scienziati e la bomba atomica"
http://cisp.unipmn.it/files/pubblicazioni/08-Vadacchino-Morale-e-scienziati.pdf
Ventura T. (2005), “Einstein’s Antigravity”,
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_antigravity01.htm
Weber M. (orig. 1918), "La scienza come vocazione", in Gerth H.H. e Wright Mills C. (a cura di) (1958), Da Max Weber: Saggi di sociologia, Oxford, Oxford U. P., pp. 129-56.
Weber M. (1930), L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, New York, Routledge.
Weinberg A. S. (1985), "Sanctifying Hiroshima", Bull. Atomic Scientists, 41, ottobre 1985, p. 34.
Weisskopf V.F. (1983), "Los Alamos anniversary: "We meant so well"", Bull. At. Sci., 39, agosto-settembre, pp. 24-26.
Woollett E.L. (1980): "Physics and Modern Warfare: The Awkward Silence", American J. Physics, 48, febbraio, 105-117.
Recensione di "Oltre la tecnofobia, il digitale dalle neuroscienze all’educazione" - Quarta parte
Dopo un a sintetica recensione del libro Oltre la Tecnofobia (qui), una critica al concetto di onlife e della rimozione dell’infanzia (qui), la disamina del concetto di dipendenza da internet e l’idea pedagogica che sia vietato vietare (qui), Simone Lanza con questa quarta e ultima parte, conclude il confronto con le tesi del libro, affrontando gli ultimi luoghi comuni: l’idea di progresso tecnologico lineare, le paure per le tecnologie, il carattere fortemente ideologico del libro.
a sintetica recensione del libro Oltre la Tecnofobia (qui), una critica al concetto di onlife e della rimozione dell’infanzia (qui), la disamina del concetto di dipendenza da internet e l’idea pedagogica che sia vietato vietare (qui), Simone Lanza con questa quarta e ultima parte, conclude il confronto con le tesi del libro, affrontando gli ultimi luoghi comuni: l’idea di progresso tecnologico lineare, le paure per le tecnologie, il carattere fortemente ideologico del libro.
Qui puoi scaricare il contributo completo.
TECNOLOGIA O TECNOLOGIE?
Con la quinta critica vorrei iniziare a porre qualche domanda sulle parole usate nel titolo stesso di Oltre la tecnofobia. Il termine “tecnofobia” è incluso in alcuni dizionari con il significato di “avversione per la tecnologia”. Ma esiste la Tecnologia? O forse ne esistono molte? Gli autori ne parlano troppo spesso al singolare.
Il XVIII secolo ha rappresentato il grande momento di espansione di attrezzi e utensili, presentati ancora nell’Enciclopedia, non senza ripetizioni, in base ai loro usi umani (i mestieri), e non alle caratteristiche intrinseche degli oggetti. Con la rivoluzione industriale si diffusero nuove tecnologie produttive che destarono non poche preoccupazioni, perché, a differenza dell’utensile che aiutava l’artigiano (prolungandone per così dire la mano), le nuove tecnologie raramente erano alleate dell’operaio, anzi spesso si sostituivano a lui.[1] Pertanto le paure per alcune tecnologie potrebbe spesso essere molto più recenti di quello che si creda e le smisurate reazioni a favore o contro sarebbero più il riflesso della nostra società industriale. In ogni caso la storia ci insegna che non esiste una sola Tecnologia, ma tante tecnologie, spesso alternative, negli ultimi secoli selezionate forse più per interessi di mercato che in base a qualità intrinseche.[2]
Ma quindi alcune paure per alcune tecnologie non possano essere fondate? Quando si parla della Tecnologia, si tratta di prendere o lasciare, o si ha fiducia o si ha paura: l’atteggiamento verso la tecnologia sembrerebbe qualcosa di molto religioso, una sorta fede nella Storia dell’Umanità verso il Progresso. Nella visione di Oltre la tecnofobia il mondo si evolverebbe in modo unilineare, benché con qualche balzo: “la storia dell’homo sapiens è una progressiva esternalizzazione delle nostre abilità” (p.102), anzi è persino una evoluzione delle tecnologie cognitive “dall’invenzione del fuoco agli smartphone” (p.22): una sola linea retta, che separa gli umani tra favorevoli (ottimisti) e contrari (nostalgici). Platone (nostalgico) sarebbe stato contrario alla scrittura, anzi Platone avrebbe anticipato la critica al cellulare poiché rifiutò la scrittura: “Platone era stato profetico” (p.128-30). Siccome gli autori sanno bene che Platone non rifiutava la scrittura ma affidava l’insegnamento e i pensieri più importanti al dialogo, mi limito piuttosto a contestare la logica argomentativa: se qualcuno è contrario alla scrittura ipso facto è contrario al cellulare (e viceversa) perché la Tecnologia o si prende o si rifiuta, non si può mai accogliere qualche tecnologia rifiutandone altre. La Tecnologia è sempre singolare e la tecnofobia ne indica l’avversione.
Forse sarebbe più utile chiedersi se oggi le tecnologie siano tutte da prendere o se come società (democratica) possiamo anche sceglierle. Ma soprattutto forse la domanda giusta (visto che il libro avrebbe velleità pedagogiche) non è tanto se prenderle o rifiutarle quanto “da che età introdurle ai più piccoli”? Scegliere le tecnologie in base ai valori sociali condivisi non è proprio ciò che ha fatto per decine di migliaia di anni l’homo sapiens?[3] Proporne un uso con delle regole sociali per ciascuna età non è ciò che ha sempre fatto ogni società con i coltelli? È lecito scegliere tra le varie tecnologie oppure la tecnologia è un destino? E per fare queste scelte la paura non ci può proprio essere d’aiuto? A tutte queste domande il libro risponde in modo semplificatorio che la tecnologia è Una e Indivisibile e che sia necessario andare oltre questa atavica paura per essa.
ESISTONO PAURE LEGITTIME PER LE TECNOLOGIE?
Arriviamo così a un altro luogo comune che questo libro rinforza: come tutte le paure anche quella per la tecnologia è una emozione negativa. Ma se esistono tante tecnologie perché non è lecito che alcune destino paure e altre speranze? Inoltre, per andare dritti alla radice del titolo: avere paura è davvero una emozione così negativa? La paura non è, al contrario, anche un aiuto per anticipare i pericoli? É così errato avere paura che le nuove generazioni vengano svezzate davanti a uno schermo? É così risibile avere paura che la propria figlia frequenti siti web che promuovono l’anoressia (comunità proAna)? É così sbagliato avere paura che Amazon faccia le sue ricerche di mercato per costruire i magazzini proprio laddove la popolazione giovanile è meno alfabetizzata e meno sindacalizzata? É così misero avere paura che le nuove IA possano provocare dipendenze ancora maggiori dei social network? Non è proprio lecito avere paura che sempre più milioni di euro vengano ceduti da risorse pubbliche a industrie digitali?
Se si volesse andare oltre le paure forse bisognerebbe prima ascoltarle, comprenderle, descriverle. Infine, non sempre il rifiuto delle tecnologie è dovuto solo a paure. Uno studio molto interessante ha ripercorso i motivi per cui nelle scuole statunitensi non si siano mai diffuse in tutto il XX secolo tecnologie come cinema, TV e radio nonostante le forti pressioni dall’alto. La risposta è che non erano considerate dagli insegnanti validi strumenti di apprendimento.[4] Quindi non tutte le paure per le tecnologie sono risibili e non tutti i rifiuti per alcune tecnologie sono dovuti a paure.
Il presupposto più forte di Oltre la tecnofobia è quello più nascosto, ovvero che ogni paura verso ogni tecnologia sia infondata. Tuttavia, non una pagina è dedicata a spiegare cosa sia la paura, e nemmeno si nomina la nomofobia, una delle più diffuse, quella di rimanere senza cellulare. La paura però non è un’emozione umana negativa, poiché aiuta la concentrazione della mente. La paura dà consapevolezza ed è ciò che permette di darci il giusto coraggio per affrontare i pericoli. Nella mia esperienza a stretto contatto con le paure di genitori e insegnanti per le tecnologie digitali, credo di poter dire che oggi una delle paure più grandi sia quella di parlare pubblicamente degli effetti negativi sulla vita familiare (benché siano osservati quotidianamente). Ogni discorso pubblico deve iniziare con questa frase: “io non sono contrario alle tecnologie” oppure “non voglio certo demonizzare le tecnologie”. Si tratta di una devozione fobica verso la tecnologia che il filosofo tedesco Anders ha descritto come “vergogna prometeica”: “non c’è nulla di più scabroso oggi, nulla che renda una persona prontamente inaccettabile quanto il sospetto che sollevi delle critiche nei confronti delle macchine”.[5] Il libro sostiene al contrario che si possono “liquidare le preoccupazioni legate alle tecnologie digitali come ansie convenzionali derivanti da atteggiamenti conservatori verso il progresso” (p.63). Mentre Anders è al centro del dibattito filosofico contemporaneo, il libro ripropone ancora l’antitesi Progresso e Conservazione del lontano XIX secolo. Ma si può davvero scrivere oggi un pamphlet oltre la tecnologia senza ascoltare le paure che le famiglie vivono oggi per alcune precise tecnologie senza essere ideologici?
UNA VISIONE IDEOLOGICA
Gli autori hanno definito la “tecnofobia umanista” una “delle influenti ideologie del giorno d’oggi” (pp. 88-89). Il termine ideologia è di derivazione marxista ma nel gergo accademico contemporaneo ideologico è il contrario di scientifico. Ideologico è tutto ciò che introduce posizionamenti etici in un discorso sociale anziché restare rigorosamente neutro: “La scienza non dovrebbe essere prescrittiva, poiché il suo ruolo principale è quello di far luce sui fenomeni piuttosto che giudicarli” (p.67 ). Per Gramsci, al contrario, l’ideologia è il posizionamento all’interno della società rispetto ai rapporti di sfruttamento capitalistico, rapporti a cui non ci si può sottrarre. Inoltre Gramsci odiava l'indifferenza che “opera potentemente nella storia”. Siamo sicuri che questo pamphlet faccia luce sui fenomeni piuttosto che giudicarli? Alla fine questo libro prende una posizione, proprio per l’ostentato oggettivismo scientifico, poiché il posizionamento etico non si deduce dall’epistemologia ma la precede. Questo libro infatti non si schiera contro chi cerca di operare in modo diverso dall’industria digitale di oggi? Perché tutto questo accanirsi contro le famiglie che fanno dei patti per difendersi dall’invasione dell’industria digitale sulla pelle delle nostre bambine? Perché questo accanirsi insieme a Lancini ad accusare i genitori che sono invece le prime vittime di questa industria digitale senza scrupoli? Perché evitare di “incolpare la tecnologia digitale” (p.67) come fosse un essere umano da difendere?
É abbastanza ovvio che gli oggetti tecnologici non siano né colpevoli né innocenti e che le responsabilità siano solo umane: ma perché in tutto il libro non viene spesa una parola su chi queste tecnologie le possiede, le progetta e le usa come mezzi per arricchirsi con videogiochi, social network, pornografia, etc...? Il vizio più grande del libro è l’apparenza di oggettività scientifica da cui deborda un attacco continuo alle vittime: chi cerca di dar regole allo strapotere delle Big Tech. Così come nel XIX secolo in nome del Progresso c’era chi difendeva lo sfruttamento del lavoro minorile, oggi abbiamo trovato chi per la stessa incondizionata fede nella Tecnologia, difende il potere di sfruttamento delle Big Tech.
Spesso, spiegava sempre Gramsci, ciò che accade nella storia avviene non tanto perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Così l'ostentato ottimismo spesso non è altro che un modo di difendere la propria pigrizia, le proprie irresponsabilità, la propria volontà di non fare nulla di fronte a quanto accade. Ed era precisamente in questa forma di fatalismo che Husserl vedeva nel 1936 l’origine della crisi delle scienze europee: nell’oggettivismo della matematizzazione, nell’assenza di prescrizioni e nella distanza dal mondo della vita. È proprio heideggeriano l’orizzonte teorico del pensiero di Oltre la tecnofobia: poiché non si danno speranze ad altre tecnologie, si finisce per far credere che la Tecnologia sia un Destino anziché una scelta umana. Tra gli autori portati come testimoni mi sembra proprio però che né Benjamin, né Stiegler, né Freire, né Debord, fossero dell’idea che bisognasse abitare farmacologicamente la catastrofe causata dalle Big Tech. Direi piuttosto che hanno passato l’intera vita a lottare contro chi, con le tecnologie, ha sfruttato gran parte dell’umanità a partire dai suoi figli più piccoli.
NOTE
[1]Il XVIII secolo vedeva con favore la sostituzione della forza animale, quando la macchina a vapore sostituisce il cavallo. Le cose cambiano con la Rivoluzione Industriale a proposito della quale Simondon notava come l’alienazione non fosse un dato solo economico e giuridico di estraneità ai mezzi di produzione, ma un dato psicologico e fisiologico di percezione della mancanza di prolungamento dello schema corporeo. Infatti, per tutti gli illuministi e per Marx stesso “la frustrazione dell’uomo inizia con la macchina che sostituisce l’uomo” (Simondon, Del modo di esistenza degli oggetti tecnici), essa infatti più che far risparmiare lavoro al lavoratore per lo più fa risparmiare soldi al capitalista. È quindi con l'arrivo della macchina utensile nella Rivoluzione Industriale che si pone la questione della tecnologia (Technologie) da distinguere dalla tecnica (Technik). La tecnologia è tutta moderna e implica l’analisi delle forme elementari in cui si scompone il movimento del corpo umano, un logos incorporato nell’utensile e mosso da una macchina. Comporta un’oggettiva conoscenza dei processi produttivi, integrata dalla precisa oggettività delle scienze naturali: nella tecnologia non deve rimanere spazio per la scelta autonoma della mano umana.
[2]Da parte mia sono un entusiasta fautore di automobili con guida automatizzata che non superino mai i limiti (ops che parolaccia tecnofobica!) di velocità, obbligatoriamente disponibili solo (ops un altro divieto!) in carsharing e solo fuori dalle città.
[3]La storia tecnologica dell’Homo sapiens è sempre meno descritta in termini lineari, bensì sempre più spesso è ricostruita privilegiando l’evoluzione a spirale, ramificata, pluriversa, se non persino ciclica: cf. Graeber, Wengrow, L'alba di tutto. Una nuova storia dell'umanità (2021) o Diamond, Collasso, Come le società scelgono di morire o vivere (2005). L’evoluzione tecnologica della nostra civiltà sarebbe in questo quadro una eccezione.
[4]Cuban, Teachers and Machines, The Classroom Use of Technology Since 1920 (1982).
[5]Anders L'uomo è antiquato (1956). Anders parlava propriamente di antiquatezza dell'essere umano (Die Antiquiertheit des Menschen). Sulle rivalutazioni di Anders nel dibattito filosofico contemporaneo cf. la rivista “aut aut”, n. 397/2023 “L’uomo è antiquato? Günther Anders e la scena attuale”.
Il vero frutto della COP30: il fondo per la salvaguardia delle foreste
Non era difficile immaginare come sarebbe andata a finire la COP30. È andata come le riunioni degli anni precedenti: dichiarazioni finali con impegni generici e non cogenti sulla riduzione dell’uso dei combustibili fossili.
Un risultato deludente?
Sì, se si considerano gli obiettivi che si erano dati storicamente i Paesi che fanno parte dell’UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), in particolare durante la COP21 del 2015, quella che viene ricordata come “Accordi di Parigi”.1
No, invece, se lo si vede dal punto di vista dei Paesi che pur facendo parte dell’UNFCCC basano la loro economia sull’energia da fonti fossili; sia i Paesi produttori ed esportatori di petrolio, che i Paesi, come la Cina e l’India, che - per sostenere la loro crescita economica - tuttora non possono fare a meno di bruciare ogni anno milioni di tonnellate di carbone e petrolio (le emissioni di Cina più India sono pari al 37% del totale mondiale2).
Ma che ci siano forti resistenze politiche agli impegni cogenti è un fatto che non può stupire, nessuno vuole rinunciare al benessere economico (acquisito o da acquisire) in nome della transizione green.
E dire che quest’anno la sede della COP era a Belém, città brasiliana scelta simbolicamente come porta di accesso all’Amazzonia, sotto attacco da decenni per utilizzare il suo legname e, soprattutto, terra per coltivazioni e pascoli (per il mondo ricco).
Se i risultati in termini di impegno nella riduzione dell’uso di combustibili fossili e quindi di immissione di gas climalteranti in atmosfera sono stati deludenti, rileviamo comunque un risultato potenzialmente importante ma che è già fonte di polemiche e controversie.
Parliamo della costituzione di un fondo per la difesa delle foreste: il TFFF, Tropical Forests Forever Facility. La creazione di questo fondo è stata fortemente voluta e spinta dal presidente brasiliano Lula, appunto come strumento finanziario indispensabile per la salvaguardia delle foreste tropicali, a cominciare dall’Amazzonia stessa. L’idea che sta alla base di questa decisione è che serve una visione globale della gestione dei suoli da difendere dall’antropizzazione: dalle foreste, all’agricoltura, ai pascoli.
Proteggere le foreste è strategico. La loro importanza per lo stoccaggio della CO₂ è fondamentale e, specularmente, i numerosissimi disastrosi roghi che devastano ogni anno milioni di ettari in ogni parte del mondo, provocano l’immissione di enormi quantità di biossido di carbonio in atmosfera. L’esatto opposto di ciò che le foreste possono fare in positivo per il pianeta.
Il concept progettuale del fondo era già stato presentato durante la COP28 ma è appunto in questa COP30 che lo strumento è nato ufficialmente, per creare un vantaggio economico per i Paesi che proteggono o ripristinano le foreste e la biodiversità, trasformando la tutela della natura in un’opzione economicamente competitiva rispetto alla sua distruzione.
Il fondo si propone di raccogliere risorse molto ingenti. Al momento del lancio, gli impegni di spesa dei Paesi partecipanti ammontavano a circa 5,5 miliardi di dollari, ma l’obiettivo dichiarato è di arrivare a 125 miliardi.
L’obiettivo principale del fondo è, quindi, quello di creare un flusso costante e continuo di denaro per ogni ettaro di foresta preservata o ripristinata.
Attenzione però: il fondo non destinerà i 125 miliardi di dollari (per adesso esistenti solo come impegno) direttamente nelle attività di salvaguardia; il capitale sarà investito sui mercati globali in attività finanziarie a basso rischio (titoli di Stato, obbligazioni di grandi enti…) e punta a ricavare circa 4 miliardi di dollari all’anno di interessi. Sono quei 4 miliardi che verranno destinati alla missione del fondo.
Si tratta quindi di un investimento finanziario che preserva il capitale e utilizza gli interessi generati per realizzare l’attività ad impatto ambientale e sociale.
Ma a chi arriverebbe questo flusso di denaro? Il 20% sarebbe destinato alle popolazioni locali e indigene, per garantire un improvement sociale per la loro vita e come riconoscimento del loro ruolo di difensori della foresta. L’altro 80% è destinato al manejo forestal, ovvero alla gestione forestale sostenibile che garantisce, appunto, la difesa e la riforestazione. Va ricordato però che le regole di distribuzione sono ancora in fase di definizione; al momento queste percentuali rappresentano solo un obiettivo dichiarato, non un meccanismo operativo consolidato, e a molti commentatori sembra che la quota destinata alle popolazioni locali dovrebbe essere più elevata.
I sostenitori del TFFF lo presentano come un passo avanti concreto di giustizia ambientale e sociale e, quindi, verso il raggiungimento degli obiettivi di Parigi. Con questo piano la conservazione naturale viene remunerata in modo sistematico e duraturo, rendendo la tutela un’opzione economicamente competitiva rispetto alla deforestazione.
Attualmente sono coinvolti cinquanta Paesi, Italia compresa, e diciannove fondi sovrani, ma si pensa a un allargamento a tutti i Paesi dell’UNFCCC per un impegno veramente globale a favore della conservazione degli ambienti naturali e contro la crisi climatica.
Ad oggi il finanziamento dei progetti a difesa delle foreste, i cosiddetti progetti REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), avviene attraverso l’emissione di crediti di carbonio; titoli che rappresentano la rimozione di una tonnellata di CO₂ e che vengono acquistati sul mercato obbligatorio (grandi aziende inquinatrici, ad esempio le siderurgiche) o sul mercato volontario (aziende che acquistano per senso di responsabilità e per motivi reputazionali).
È chiaro che il TFFF sarebbe un passo avanti perché renderebbe il finanziamento costante nel tempo e non legato all’andamento di singoli progetti, e perché sgancerebbe il finanziamento stesso dalla logica dell’emissione dei crediti di carbonio che tante discussioni e polemiche ha creato in questi anni.
Tutto bene, quindi?
Presto per dirlo, ma sono arrivate immediatamente anche molte critiche. Il problema che segnalano molti osservatori è il pericolo di un eccesso di dipendenza della tutela naturale da meccanismi finanziari; meccanismi che hanno i loro centri decisionali nei Paesi economicamente forti. Si teme quindi una posizione di subalternità dei Paesi in via di sviluppo, dove invece sono presenti le grandi foreste da preservare3.
L’altro tema di discussione è che le regole di distribuzione dei fondi sono ancora tutte da scrivere e c’è scetticismo sulla possibilità di realizzare una distribuzione equa delle risorse in base alle reali necessità dei territori.
Tuttavia non si può non considerare che anche a fronte di queste legittime perplessità, il TFFF può diventare uno strumento di salvaguardia della natura più efficace rispetto a quanto si è visto fino ad oggi, anche perché ci libererebbe dal meccanismo di emissione dei crediti di carbonio come fonte di finanziamento. Meccanismo che continua ad essere estremamente controverso nel calcolo della CO₂ rimossa e nei conseguenti aspetti finanziari.
La comunità impegnata a dar vita a questo strumento è chiamata a un grande sforzo per determinare regole chiare, trasparenti e che impediscano attività di greenwashing.
Quindi, se il TFFF si rivelerà uno strumento efficiente e giusto, potremo dire che la COP30 sarà stata molto più utile di quanto sia sembrato a fine lavori.
Ma per capire se sarà così ci vorranno anni.
NOTE:
1 L’obiettivo principale della COP21 era di mantenere l’innalzamento della temperatura globale del pianeta entro 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali
2 Fonte Euronews
3 Qualcuno potrebbe chiedersi perché sia il TFFF, sia i progetti REDD, riguardino solo le foreste tropicali (Amazzonia, Africa, Sud est asiatico) e non già anche le foreste boreali, come le foreste siberiane e canadesi. Il motivo è duplice: da un lato le foreste tropicali sono quelle maggiormente sottoposte a deforestazione per motivi economici; in Siberia e Canada ci sono stati negli ultimi anni gravissimi incendi che hanno distrutto milioni di ettari ma si è trattato di incendi in parte anche dolosi ma non provocati con l’intenzione di destinare ad altro uso le parti di foreste bruciate. Il secondo motivo è che si tratta di foreste che insistono su Paesi economicamente forti che non hanno bisogno di aiuti finanziari per la gestione delle stesse.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
- Valori.it – Come funziona il Tropical Forest Forever Facility (TFFF)
- Wired – Dalla COP 30 può nascere la vera alternativa all’economia della deforestazione
- COP30 Official Website
- Sapereambiente – Dalla Cop30 il fondo per la conservazione delle foreste tropicali
- Project Drawdown – What to know about the Tropical Forest Forever Facility from COP30
La cultura occidentale non è mai esistita - L’alba di tutto di Graeber e Wengrow
1 - Il mito dell’Illuminismo
Esistono libri di intelligenza contagiosa, in cui l’audacia delle tesi e la felicità dell’argomentazione sembrano poter contaminare anche il lettore, e promettere un futuro meno assopito nell’inerzia dei pregiudizi e della noia accademica. L’alba di tutto di David Graeber e David Wengrow appartiene senz’altro a questo manipolo di capolavori, con l’invito a ripensare le categorie di modernità, di democrazia, di barbarie, di organizzazione, di potere – ma soprattutto a rigettare la fede nell’esistenza di una «cultura occidentale», la cui natura giustificherebbe ogni altra distinzione, classificazione, e l’intera epistemologia delle scienze sociali. In effetti il riesame coincide con una ricusazione delle differenze tra la civiltà che gli europei hanno sviluppato sul continente (ed esportato ovunque con la colonizzazione) – e le forme di vita frequentate dalle popolazioni cui assegnamo qualche tipo di minorità, che le rende adatte agli studi di etnologia.
L’Illuminismo è la frattura storica che assegnerebbe all’Occidente alla sua posizione straordinaria nel mondo e nella storia, perché avrebbe reso la nostra civiltà l’unica ad aver ucciso il suo Dio e ad essere sopravvissuta al delitto, con una volontà di potenza accresciuta, e persino con un’autocoscienza più intensa. La fine dell’egemonia religiosa avrebbe avviato la legittimazione della scienza, del potere politico, delle tecniche, solo sul fondamento della sola razionalità umana: avrebbe scisso la neutralità della logica e dell’osservazione empirica da un lato – e gli interessi, le finalità pragmatiche dell’individuo e della collettività dall’altro lato. La lucidità di questo sguardo, purificato dai pregiudizi e dalle pressioni dell’utilità sociale, permetterebbe alle nostre scienze sociali di osservare le altre culture (e naturalmente anche la nostra) con un’obiettività che nemmeno loro possiedono su se stesse.
Il primo obiettivo di Graeber e Wengrow è denunciare la narrazione sull’Illuminismo come una mitologia patologica, paragonabile a quelle che diagnostichiamo alle altre etnie. Il metodo consiste in una rilettura degli autori Settecenteschi, alla ricerca delle ragioni per cui dalla metà del secolo il dibattito sull’origine della diseguaglianza tra gli uomini, e quello sulla libertà individuale, diventano tanto pressanti. L’indagine è radiologica, individua l’ossatura delle argomentazioni originali, e la nervatura di trasmissione delle idee, al di sotto dei pregiudizi con cui i commentatori successivi hanno rivestito le dichiarazioni di Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu. L’esame critico delle istituzioni politiche europee attraverso gli occhi di stranieri, dagli amerindi ai persiani, è stato un genere letterario per tutto il Settecento: ma i suoi contenuti non devono essere intesi come prodotti di finzione. La pubblicistica dei frati missionari che hanno accompagnato gli eserciti spagnoli, francesi e britannici nella colonizzazione delle Americhe, quella dei gesuiti che hanno esplorato l’Oriente – la presenza in territorio europeo di ambasciatori delle tribù indigene d’oltreoceano – hanno contaminato il pensiero dei philosophes con idee non rispettose della teologia politica, delle istituzioni feudali e delle loro estensioni assolutistiche; il contagio si è propagato con il dibattito sulla separazione dei poteri dello stato, l’infiammazione dell’opinione pubblica contro i privilegi dell’aristocrazia, la decapitazione del re, l’elaborazione dei codici napoleonici, le convulsioni rivoluzionarie attraverso tutto il continente.
2 - Il mito delle origini
Ma il fine di Graeber e Wengrow è proprio quello di riportare alla luce il brulichio di esperienze culturali animate da una coscienza laica, da un’esperienza politica raffinata, da una complessità concettuale sull’organizzazione sociale, sui fondamenti di legittimazione del potere e della ricerca della verità, che si sono sviluppate al di fuori (e prima) dell’Europa illuministica. Le prodezze del politologo wendat Kondiaronk inaugurano un’anamnesi di fonti dimenticate e di nuove scoperte archeologiche, che sollecita una diagnosi differenziale rispetto alle tesi di Hobbes sulla condizione di guerra di tutti contro tutti nello «stato di natura», e alla storia evolutiva che Rousseau ha raccontato nel Discorso sull’origine della diseguaglianza (e che tutti hanno continuato a ripetere per oltre due secoli).
Il filosofo ginevrino riconosce senza reticenza che la sua ricostruzione non si fonda su alcuna prova empirica; ma l’impianto di fondo della sua favola non è mai stato contestato. L’uomo delle origini giacerebbe inerte presso le radici degli alberi che possono alimentarlo, privo di linguaggio, di pensiero e di società, dedito alla soddisfazione dei bisogni primari con il minor dispendio possibile di energia. La razionalità avrebbe fatto irruzione (insieme alla coscienza della mortalità, agli interessi sessuali e sociali, alla tecnica e alle funzioni verbali) nell’istante in cui imitazione e vocazione di perfezionamento hanno corrotto la natura umana e hanno avviato la sua decadenza. Libertà e uguaglianza sarebbero proprietà solo delle comunità più antiche, limitate a pochi individui e ad una struttura priva di articolazione funzionale e di necessità politiche. La complessità inoculata dall’agricoltura e dalle tecniche di canalizzazione delle acque, di gestione dei magazzini per le scorte, avrebbe provocato la remissione della democrazia comunitaria e la degenerazione verso le gerarchie degli imperi autoritari. L’evoluzione avrebbe condotto alla schiavitù e alla degradazione morale, a causa della corruzione dei costumi – effetto collaterale dell’articolazione sociale.
3 - Creatività politica
Al contrario, Graeber e Wengrow scoprono una creatività politica che scardina la complessità dei bisogni e delle azioni collettive dalla struttura del potere. Le comunità hanno sempre elaborato una comprensione esplicita della loro configurazione sociale, e della costituzione che legittima l’autorità di chi esercita il potere: probabilmente una delle meno consapevoli è stata proprio quella europea del Medioevo, che ha subito la tirannia di feudatari e imperatori, e che ha creduto nei principi della teologia politica. L’interpretazione dei reperti archeologici, con nuove domande e nuovi dati, permette di distillare una nuova comprensione delle società amerinde e orientali, dove la proliferazione delle forme di vita e la tassonomia delle identità politiche hanno tentato ibridazioni di ogni genere. Gli uomini non hanno rispettato i confini della differenza linguistica, della distanza geografica, della differenza di abitudini tecniche e alimentari, per sentirsi parte dello stesso popolo: le generalità dell’antenato totemico hanno permesso a uomini e donne di ottenere accoglienza fraterna presso gruppi dislocati anche dall’altra parte del continente Al contempo, la mancanza di infrastrutture di comunicazione di massa ha impedito ovunque, a qualunque forma di tiranno, di raggiungere con il suo potere assoluto individui distanti anche solo qualche chilometro dalla sua dimora.
Peraltro la configurazione stessa delle comunità, e del loro coordinamento politico, è stata modellata da esigenze di vario tipo: molte popolazioni hanno obbedito a due ordinamenti diversi ogni anno, secondo cadenze stagionali, disperdendosi in piccoli gruppi durante il periodo propizio per la caccia, e riunendosi in città o villaggi nel periodo dei raccolti. Hanno anche abbracciato, e poi abbandonato, tecniche che la narrazione di Rousseau dispiega in un ordine storico sequenziale e irreversibile – come è accaduto per l’agricolutura, che diverse civiltà del Medio Oriente e delle Americhe hanno prima esercitato, poi trascurato per recuperare strategie economiche fondate sulla caccia e sulla raccolta.
Persino l’autorità andrebbe ripensata in modo radicale, dal momento che all’investitura divina dovrebbero sostituirsi altre modalità di legittimazione, spesso riconducibili a qualche forma di talento, come l’abilità agonistica (che include anche, ma non solo, l’uso delle armi). L’aristocrazia degli Olmechi amava farsi ritrarre in tenuta da giocatore di palla, e ha consegnato questa cultura competitiva a bassorilievi che sono giunti fino a noi. In generale la dedizione alla combattività ha plasmato tutte le civiltà oligarchiche, e il peso della loro visione del mondo deve essere stata all’origine non della formazione – ma più spesso, della dissoluzione di città e di interi regni. La diaspora della popolazione di aree urbane e di percorsi commerciali può essere motivata dal bisogno di sottrarsi al controllo e alle pratiche di violenza con cui i gruppi nobiliari si sono sovrapposti alle organizzazioni precedenti; la gente ha preferito tornare a condizioni di autorganizzazione diverse (stagionali, totemiche, repubblicane), ignorando il precetto dello schema evolutivo di Rousseau, che le assegnerebbe ad una fase più antica, e disgregando regni e imperi. Le città sono un prodotto dell’immaginazione, non conglomerati di abitazioni, e la Teotihuacan priva di un governo secoli fa, come la Milano lottizzata di oggi, si estendono sul progetto e sulla visione del mondo in cui crediamo; la distribuzione in classi può essere l’effetto del gioco, dello sport, della conoscenza, della ritualità, senza essere per forza una mappatura della distribuzione del potere coercitivo.
La verità, di cui i reperti archeologici sono solo dei sintomi, rimarrà forse insondabile per sempre. Ma l’esercizio diagnostico di Graeber e Wengrow è prima di tutto una terapia contro l’inerzia della nostra immaginazione intellettuale. Combatte l’atrofia concettuale con cui ripetiamo la stessa storia sull’evoluzione della civiltà, delle tecniche, della politica e dell’economia; è un integratore di ipotesi e di informazioni che rianima un modello di umanità più intelligente e più affezionata alla libertà, alla ricerca della felicità, rispetto a quello che si è sclerotizzato nel mondo in cui noi ci siamo condannati a sopravvivere: quello dove «non ci sono alternative» al nichilismo del lavoro fine a se stesso, dell’arricchimento fine a se stesso, della fine della storia. Ma un universo dove non si attende più un futuro, che non sia la ripetizione vegetativa del presente, non ha nemmeno un passato da ricordare: è per questo che soffriamo la nevrosi della favola di Rousseau, senza cercare di uscirne. Il merito di Graeber e Wengrow è di aver tentato una cura, con uno scavo entusiasmante che attraversa ogni angolo del mondo, e che sollecita la nostra curiosità a far rifluire energie concettuali dove il pensiero era rimasto paralizzato, irrigidendosi nella fede della corrispondenza tra evoluzione tecnica e configurazione politica, dell’irreversibilità del percorso storico, della permanenza dell’umanità in un’infanzia della ragione, da cui solo l’Illuminismo europeo ci avrebbe educato a crescere. Gli uomini sono sempre stati adulti, e hanno sempre saputo scegliere l’alternativa migliore per loro: con buona pace della signora Thatcher, è ora che torniamo a esserlo anche noi.
A confronto con il pensiero di Platone: la memoria e la sua corruzione nell’era digitale.
A giugno di quest’anno Controversie ha organizzato un seminario in forma di tavola rotonda sul tema dell’ontologia dell'intelligenza Artificiale. Durante il dibattito è emersa la possibilità che i grandi modelli linguistici (LLM) si possano affermare – tra le diverse applicazioni che già si intravedono – come una sorta di bibliotecario con pretese di universalità. Questa ipotesi è ben delineata da A. Colamedici e S. Arcagni, nel loro libro L'algoritmo di Babele. Storie e miti dell'intelligenza artificiale (Solferino Libri, 2024) e suggerita tra le righe da Luca Sofri "Intelligenze artificiali" tra virgolette, nel suo blog Wittgenstein.
La biblioteca universale, la biblioteca fantastica che contiene tutto ciò che è stato scritto e che potrà essere scritto, è un tema che – in maniera ricorrente – prende forma nelle riflessioni di filosofi e letterati, da Leibniz allo scrittore Kurd Laßwitz, detto anche Velatus, fino ad ossessionare Jorge Borges (La Biblioteca di Babele) e a ispirare l’imprenditore Brunello Cucinelli, che nel 2022 annuncia la realizzazione di una “sua” biblioteca universale, a Solomeo, dedicata ai lavoratori delle sue aziende.
Il tema della biblioteca è strettamente connesso con quello della memoria; ritrovare un passo di un libro, di un autore richiede di averne memoria e di riuscire a situare questo scampolo di memoria nello spazio della propria biblioteca mentale e, solo successivamente, a ritrovare la collocazione di quell’autore o di quel libro all’interno della propria libreria o di una biblioteca istituzionale o pubblica.
Ecco, una potenziale funzione dei LLM è proprio di fare da contenitore molto ben indicizzato di grandi quantità di conoscenza, e di trovarle e metterle a disposizione degli utenti in modo ragionato e selettivo, su richiesta espressa in linguaggio naturale. E, proprio per la loro capacità di gestire volumi enormi di informazioni in tempi ragionevoli, può tendere a quel grado di infinito sotteso dall’espressione “universale”.
A contrasto con questa idea e prospettiva, vi proponiamo una riflessione di Fabio Talloru sulla memoria e su Platone, che per la memoria e la sua rilevanza nel pensiero umano aveva un debole.
-----
Se ancora oggi Platone viene inquadrato come filosofo sradicato dalla concretezza del mondo e proiettato nell’Iperuranio, ciò è dovuto perlopiù alla ormai superata (ma ancora presente) visione diffusa dalla formazione scolastica ordinaria. Invece, la filosofia di Platone è profondamente radicata nel mondo fisico e materiale.
Ѐ noto a tutti che per Platone vi sia una memoria di genere immortale, la quale provvede alla reminiscenza (anamnesis) degli oggetti intelligibili. Meno noto e poco esplicito nei dialoghi è invece l’altro genere, quello “mortale” (non è questo il termine platonico), inteso come proprio della condizione incarnata dell’Anima immortale in un vivente (zoòn).
La Memoria (mneme) è una delle facoltà dell’anima, quella di imprimere, tracciare o racchiudere nella forma di ricordo (hypomnema) le informazioni che otteniamo da oggetti incontrati attraverso l’esperienza empirica. Essa è l’insieme di ciò che si è sedimentato nell’anima a partire dalle sensazioni memorabili, prodotte dall’esperienza che facciamo di oggetti che esistono fisicamente nel mondo empirico (il processo completo è esposto nel discorso fisiologico contenuto nel Timeo1).
Il tema che ci interessa indagare in questo articolo è quello della “volatilità” del sapere in Platone, per produrre nuovi spunti di riflessione che siano utili nel dibattito odierno.
Ri-memorazione e memoria mortale.
La reminiscenza (anamnesis) è un’operazione prodotta dalla sola Anima immortale. Più propriamente essa è una forma del ri-memorare oggetti visti nella condizione disincarnata. L’operazione dell’apprendimento (mathesis) di nozioni avviene, invece, durante la vita e il contenuto di una memoria “mortale” (il ricordo) può dissolversi irrimediabilmente. La memoria nella sua totalità cessa definitivamente la propria esistenza con la morte del vivente che lo possiede, perciò con lo scioglimento dei vincoli tra l’anima e il corpo.
In primo luogo possiamo affermare l’esistenza di una memoria “mortale” nel pensiero di Platone per almeno due ragioni:
- non ci è pervenuta nessuna traccia diretta, testimonianza indiretta o qualsiasi forma di accenno a proposito della possibilità di reminiscenza di ricordi appartenenti a vite passate - come invece è presente nelle dossografie pitagoriche2, che Egli conosceva e custodiva gelosamente nella propria biblioteca;
- nei dialoghi che affrontano problemi legati sia alla reminiscenza che alla metempsicosi, troviamo l’idea che a ogni nuova incarnazione debba esservi un “reset” della memoria in relazione alla vita empirica (si veda nello specifico il “Mito di Er”3)
Durevolezza delle forme della conoscenza.
Parrebbe anche che, sul piano mortale, le conoscenze pratiche e dell’esperienza empirica siano più durevoli rispetto a quelle epistemologicamente superiori (“scientifiche”) del filosofo o del matematico - i quali hanno come proprio oggetto ultimo gli intelligibili.
Questo lo si può dedurre in particolare da un passo del prologo drammaturgico del Timeo. Qui Crizia il Giovane riporta un racconto che apprese da bambino, nel quale Solone incontrò in Egitto un sacerdote che così affermava:
«“Siete tutti giovani d’animo (voi greci) [...] perché non avete nelle vostre anime nessuna opinione antica trasmessa attraverso una tradizione che proviene dal passato né alcun sapere ingrigito dal passare del tempo».
Prosegue poi con la motivazione di questa brevità della memoria collettiva che imputa ai greci:
«ogni cosa viene registrata, fin dall’antichità, nei nostri templi e conservata alla memoria», mentre in Grecia «a intervalli regolari di tempo, come una malattia, torna il flusso del cielo che vi inonda e non lascia illesi fra voi che gli illetterati e i nemici delle Muse (gli incolti), sicché ricominciate nuovamente dal principio, come tornati giovani». Per di più, aggiunge il sacerdote: «nel corso di molte generazioni, i sopravvissuti sono morti senza aver fissato la loro voce nella scrittura». (Tim. 22 d – e)
In questo passo possiamo individuare almeno sei punti di riflessione ancora validi nel contesto d’oggi:
- la scrittura esprime qui il suo ruolo di strumento tecnico corruttibile ma preservabile dalla distruzione, perciò tramandabile;
- la scrittura è uno strumento tecnico ausiliario, che richiede una stabilità materiale continuativa della società per essere mantenuto e motivato nell’uso ordinario;
- il vivente mortale, se non ha né la possibilità né la premura di tramandare il prodotto della propria conoscenza, non conserverà un sapere collaudato da mettere a disposizione dei posteri;
- la condizione del dopo-catastrofe è analoga a un “momento zero” della memoria mortale, un “cominciare nuovamente da principio” simile a quello di un'anima incarnata;
- i saperi pratici “degli illetterati e degli incolti” sopravvivono più facilmente rispetto a quelli di filosofi e scienziati; sono inoltre propedeutici a porre le basi di quella stabilità materiale e tecnica che rende possibile l’accumulo del sapere;
- l’accumulo di un sapere avanzato e complesso, come quello “scientifico” (episteme), non è necessario alla vita, ma è un “in più”.
Platone nei suoi dialoghi ci indica anche che, quando si sia memorizzata un’informazione, la sua durevolezza dipenderà non solo dalle condizioni in cui il suo proprietario la custodisce e preserva, ma anche da come egli l’ha ottenuta. Ad esempio, Crizia il Giovane racconta una storia di cui ha acquisito un ricordo “vivido”, in quanto giovane, attento e partecipativo nel momento del suo apprendimento4. Un caso diverso è invece quello di Fedro che, nel dialogo omonimo, deve confrontarsi con un’opera scritta che necessita di rileggere più volte per ricordarla “alla lettera” al fine di poter tenere il proprio discorso5 basato su di essa.
Nel primo caso, quello di Crizia, la qualità del ricordo è dovuta alle caratteristiche che contraddistinguono il momento in cui egli ha appreso un’informazione, ossia la pregnanza dell’esperienza di apprendimento dei fanciulli. Nel secondo caso, quello di Fedro, la qualità della formazione del ricordo sarà dovuta all’ausilio di strategie mnemotecniche, quali la rilettura e la ripetizione a voce alta.
Conclusioni e domande aperte.
Per concludere, il problema della conservazione, del tramandare e della possibile perdita della memoria (nel senso più ampio che comprende storie, tradizioni, tecniche e conoscenze) è un fenomeno oggi ancora più complesso. In particolare se guardiamo al fenomeno di progressiva sostituzione dei mezzi “tradizionali” di trasmissione dell’oralità e della scrittura manuale in favore della digitalizzazione dell’informazione.
Quante tipologie e forme di “memoria” abbiamo a oggi sviluppato e quali si stanno depotenziando o stanno scomparendo?
Quante forme della scrittura possediamo e quali competenze sono necessarie per farne uso?
Quanti livelli di linguaggio e quante forme di linguaggio esistono per la sola codificazione informatica dell’informazione?
Quali i pericoli a cui si espone la loro conservazione?
Ai cataclismi menzionati dal sacerdote egizio incontrato da Solone, evidentemente ancora presenti e comunque imprevedibili quali si aggiungono oggigiorno?
Ovviamente, sono queste tutte domande complesse che richiedono risposte altrettanto articolate. Ad esempio, per i supporti di archiviazione digitale, da cui oramai dipendiamo largamente, sono deleteri i fenomeni elettrici, magnetici ed elettromagnetici, i quali sono tutti in grado di cancellare, corrompere o rendere inaccessibili, se non addirittura irrecuperabili, le informazioni registrate.
L'informazione digitale e la sua memorizzazione quanto sono volatili? Quanto durevoli? Quanto sono "delicate"?
La stessa obsolescenza delle tecnologie e delle tecniche di conservazione e riproduzione dell’informazione, giorno per giorno avvia verso la fine la riproducibilità delle precedenti forme di “memoria”, sia collettiva che individuale (foto, video, documenti, scansioni di immagini, etc.). Gli attuali dispositivi che possediamo saranno sempre meno reperibili con l’avanzare di nuove tecnologie e dei relativi sistemi che ne permettono il funzionamento?
I dispositivi attualmente in uso, per quanto collaudati, non saranno un giorno più compatibili con quelli più avanzati, per protocolli di scrittura e lettura?
Saranno reperibili le tecnologie di giunzione che permettono di interfacciare fisicamente vecchi e nuovi dispositivi di archiviazione di memoria?
Le tecnologie di traduzione e conversione reciproca tra vecchi e nuovi protocolli di archiviazione dell’informazione saranno ancora implementate sui nuovi dispositivi o saranno ancora reperibili e adoperabili?
Quali altre problematiche sono riscontrabili o sono di imminente larga diffusione?
La memoria è un affare complesso, sia individuale che collettivo.
NOTE:
1 Tim. 42 d - segg. e 69 c - segg.
2 Centrone, B. 1996, Introduzione a i pitagorici, Editori Laterza, Roma-Bari, pp. 52-61
3 Resp. 614 b - 621 d
4 Tim. 26 b
5 Phaedr. 228 a