Il 30 di luglio scorso, la federazione internazionale di atletica – World Athletics – ha annunciato un nuovo criterio per definire chi può partecipare, come femmina, alle massime gare nella categoria femminile. Vi proponiamo una ricostruzione – a cura di Alessio Panella – dei tentativi fatti, dagli anni ’60 in poi, per stabilire un criterio di distinzione tra maschio e femmina nelle gare di atletica. Ricostruzione che chiude introducendo l’attuale controversia su questo tema.
Così riporta il sito della federazione internazionale di atletica leggera. Il nuovo regolamento è in vigore dal 1° settembre 2025 ed è già stato applicato ai Campionati Mondiali di Tokio che iniziano il 13 settembre.
Il comunicato stampa continua: «Tutti gli atleti che desiderano competere nella categoria femminile ai Campionati del Mondo sono tenuti a sottoporsi a un test irripetibile per il gene SRY, una approssimazione affidabile per determinare il sesso biologico».
Il punto centrale di questa nota della W.A. è la frase «determinare il sesso biologico» come criterio di partecipazione.
Il presidente della W.A., il britannico Sebastian Coe, ne spiega in termini molto chiari il senso del criterio: «per partecipare nella categoria femminile alle competizioni di più alto livello si deve essere biologicamente femmina», e il principio che lo anima: «La filosofia che ci sta a cuore nell’atletica mondiale è la protezione e la promozione dell’integrità dello sport femminile. È importante, in uno sport che cerca costantemente di attrarre più donne, che queste [le donne, ndr] si avvicinino allo sport convinte che non esista un soffitto di cristallo biologico. Il test per confermare il sesso biologico è un passo molto importante per garantire che ciò avvenga».
Proviamo, ora a capire il processo storico, iniziato negli anni ‘60, che ha portato a questa decisione della federazione mondiale.
È – infatti – dagli anni ’60 che i test genetici e biologici per determinare il sesso nelle competizioni sportive, hanno suscitato un acceso dibattito etico, medico e giuridico.
I primi test vengono introdotti dalla IAAF – International Association of Athletics Federations (ora World Athletics) e dal CIO – Comitato Olimpico per “verificare” il sesso femminile a per contrastare i sospetti che ci fossero maschi che gareggiavano nelle categorie femminili. Le “verifiche” prevedono l’ispezione fisica e il test del cariotipo, ossia l’esame cromosomico per determinare il carattere dei geni principali, XX per le femmine, XY per i maschi) e risultano – oggi – invasive, umilianti e scientificamente riduttive.
Il caso di Maria José Martínez-Patiño, ostacolista spagnola con caratteri inter-sessuali e affetta da sindrome di Morris, negli anni ’80, è emblematico. Il test con ispezione sessuale, effettuato nel 1983, la “certifica” come femmina; ma nel 1985 è squalificata perché il test cariotipico rileva il carattere maschile con la presenza del cromosoma 46, XY.
Segue la “riabilitazione”, con la restituzione della licenza IAAF, nel 1988, grazie alla difesa del genetista Albert de la Chapelle, che fa leva sul carattere «inaccurato e discriminatorio» del criterio adottato dalla federazione.
Questo caso mette in luce la complessità del tema del sesso biologico e la necessità di superare criteri binari.
Nel 2009, Caster Semenya – mezzofondista e velocista sudafricana, due volte campionessa olimpica e tre volte mondiale degli 800 metri piani – anche lei con cromosoma 46,XY – viene costretta dalla World Athletics a ridurre con dei farmaci i propri livelli di testosterone per continuare a gareggiare nelle discipline femminili.
La questione porta a una serie di ricorsi, fino alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2021, che riconosce una violazione dei diritti fondamentali.
Nel 2023–2024 la World Athletics introduce nuove norme che escludono dalla categoria femminile le atlete con “disordini dello sviluppo sessuale” (DSD) e livelli di testosterone superiori a una soglia prestabilita, anche se legalmente riconosciute donne; e, oggi, il criterio che si afferma è quello della genotipizzazione (test del gene SRY ritenuto il “fattore interruttore” che determina il sesso maschile nei mammiferi) per identificare il sesso biologico alla nascita, non solo i livelli ormonali.
Secondo molti eticisti, l’eccessiva fiducia nella genetica per determinare qualcosa di complesso come il sesso è mal riposta, perché l’identità di genere, il sesso legale, e la performance sportiva non si riducono a un singolo gene o ormone.
Inoltre, sotto il profilo della riservatezza, costringere una persona a rivelare il proprio profilo genetico può violare la privacy genetica, esporla a discriminazioni e causare gravi impatti psicologici.
La controversia ha diverse sfaccettature: da un lato studiose come Katrina Karkazis (antropologa e bioeticista, professoressa di Sessualità e di Studi sulle Donne e sul Genere all’Amherst College) sostengono che queste politiche sono forme di sorveglianza del corpo femminile, che generano un conflitto tra la garanzia di una competizione “giusta” e quella dell’inclusione; dall’altra parte, i critici sostengono che atlete con DSD o varianti intersessuali abbiano un vantaggio “ingiusto”; altri ancora ribattono che la diversità biologica fa parte dello sport, come l’altezza nel basket o la VO₂ max nel ciclismo.
A coronamento della controversia, va ricordato che non esistono test comparabili per uomini con caratteristiche biologiche straordinarie.
Il tentativo di definire criteri di distinzione crea un filtro selettivo solo per le donne, alimentando – in un modo o nell’altro – discriminazioni sistemiche.
Di fatto, le policies introdotte dal CIO per regolamentare le gare sono principalmente orientate alla sicurezza ed equità delle competizioni. L’inclusione o altri criteri politici e sociali non sono prioritari e restano contemplati nella definizione delle categorie (i.e. Olimpiade, Paralimpiade, Uomo, Donna).
Tuttavia, questo orientamento della giurisprudenza sportiva non è adeguatamente sostenuto dalle Federazioni, alle quali il CIO ha demandato dal 2020 la definizione e attuazione degli specifici criteri di eleggibilità di atleti e atlete, con il risultato che sono numerosi i casi controversi e contestati, con sentenze altrettanto equivoche e non abbastanza definite per stabilire un chiaro orientamento di principio
Ad esempio, Lia Thomas è una nuotatrice transgender che ha gareggiato e vinto titoli NCAA. Ha mosso denuncia al Court of Arbitration for Sport (CAS), cercando di far dichiarare invalide le regole della federazione nuoto sull’accesso alle competizioni. Il CAS ha stabilito che Thomas non aveva lo “status” necessario (essere membro di USA Swimming etc.) per opporsi formalmente alle regole; quindi, non è stato accolto il ricorso. Nulla ha detto circa il merito del ricorso. Nel 2022 la World Aquatics ha introdotto regole che escludono le donne transgender che abbiano attraversato anche solo una parte della pubertà maschile nella categoria femminile. Le regole della World Athletics richiedono che atlete con DSD, per competere nelle gare femminili di media distanza, abbassino il testosterone sotto le soglie definite (es. < 2.5 nmol/L) per un certo periodo.
Imane Khelif e Lin Yu-Ting, iscritte nella categoria femminile ai Campionati Mondiali di box 2023 sono state giudicate non “idonee” da parte della International Boxing Association (IBA) per motivi di criteri di genere (tests di “eligibilità di genere”). Tuttavia, l’IOC ha poi autorizzato la loro partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, sostenendo che esse soddisfano i requisiti
Nel 2024 un gruppo di 26 accademici ha pubblicato uno studio critico verso il Framework del CIO su equità, identità di genere e variazioni del sesso. Sostengono che il framework “non garantisce sufficientemente la correttezza per le donne” e che non considera adeguatamente gli effetti permanenti della pubertà maschile che non sarebbero annullabili solo abbassando il testosterone. Questo ha alimentato dibattiti su come le federazioni determinano i criteri (testosterone, uso di prove scientifiche, presunzione di vantaggio, ecc.)[1].
CONCLUSIONE
Alla luce di queste controversie, non sembra possibile, ma dannoso e discriminante, utilizzare il sesso biologico come elemento chiave per decidere l’eliggibilità di atlete e atleti in una o nell’altra categoria.
Questo finché gli organi supremi di governo dello sport e la Commissione Etica della Comunità Europea non abbiano chiarito quale sia l’orientamento di principio a cui affidare la decisione. Sarebbe anche necessaria una validazione senza ombra di dubbio dei criteri e dei test scientifici. In ultimo, andrebbero definite le procedure di applicazione – chi può fare ricorso e in base a quale principio – e le condizioni di compatibilità dei principi di discernimento con i diritti fondamentali della persona.
Autore
-
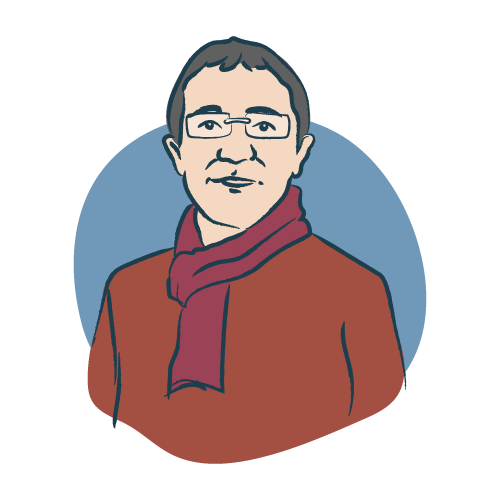
Ingegnere elettronico, manager in una multinazionale, matematico e scrittore. Cerca l’intelligenza nell’intelligenza artificiale. E forse la trova: o tutto è intelligenza oppure niente lo è.
Leggi tutti gli articoli
