In questo luglio stanco, in cui ogni mattina sentiamo discorsi di politici e intellettuali prevedibili dalla prima all’ultima parola, in cui si perpetua il rito avvilente delle finte sfide fra tribù politiche, un fatto nuovo c’è.
È la ribellione di alcuni ragazzi/e che si stanno rifiutando di sostenere l’esame orale alla Maturità. Questo è oggettivamente un qualcosa che non si era mai visto, un fatto su cui riflettere.
Sui media, la reazione alla notizia è stata abbastanza omogenea e improntata alla disapprovazione, altrettanto dicasi nei commenti delle persone (vedi social e commenti agli articoli).
In definitiva, con diversi gradi di aggressività, la società ha preso male questa piccola (nei numeri) ribellione.
Commenti che parlavano di atti di arroganza o di vittimismo narcisistico; pochissima apertura a provare a capire i perché.
Si può intuire che il fenomeno sia tutt’altro che secondario da un particolare; la reazione quasi rabbiosa, carica di astio, del ministro competente.
Quella reazione può far pensare che quei tre ragazzi abbiano dato vita – probabilmente in modo del tutto inconsapevole – a un atto politico, mettendo in discussione una “istituzione”, un architrave del sistema pedagogico-educativo su cui si basa la nostra società.
Quindi, a maggior ragione, è opportuno cercare di capire invece che arroccarsi sullo status quo.
C’è stato subito un intervento interessante del sociologo Nicola Ferrigni dell’Università della Tuscia e direttore dell’Osservatorio “Generazione Proteo”.
Questo l’inizio di un suo intervento (che si può facilmente trovare su internet – inserire fonte):
“Quanto accaduto al liceo Fermi di Padova e al liceo Galilei di Belluno non è un semplice gesto di rifiuto. Due studenti hanno scelto, in modo diverso ma altrettanto chiaro, di non sostenere il colloquio orale dell’esame di maturità. Non per superficialità o disinteresse, ma per inviare un messaggio forte e simbolico su come oggi tanti giovani vivono la scuola: con distanza, con fatica, a volte con rassegnazione. Una scuola che valuta ma non ascolta, che misura ma non riconosce. È una protesta simbolica, silenziosa, profondamente pacifica. Ed è proprio per questo che colpisce. Perché si impone senza rumore, ma con forza. Perché non cerca la ribalta, ma lascia un segno duraturo.” (N.d.R. gli studenti poi sono diventati tre).
Ma la critica al sistema scolastico selettivo di certo non è nuova, se leggiamo Don Milani:
“La scuola è fatta per dare a tutti le stesse opportunità, non per premiare chi già sa”.
Don Milani vedeva nella scuola uno strumento di formazione che lavorasse per mettere tutti i ragazzi nelle stesse condizioni di apprendimento e il lavoro dell’insegnate doveva essere molto mirato al raggiungimento di questo scopo; un processo che non doveva portare a una valutazione selettiva ma valutazione formativa, ovvero attraverso lo scambio docenti – studenti, questi potessero colmare lacune e vuoti.
Oppure Pasolini, la cui vita è stata sempre profondamente intrecciata nel rapporto con i ragazzi delle periferie, che parlava della scuola come luogo di omologazione, di appiattimento del pensiero, di mancanza di respiro critico, di libertà solo apparente, funzionale al perpetuarsi del dominio delle classi sociali al potere.
Sono passati molti anni dagli interventi di Don Milani, di Pasolini e di tanti altri che hanno cercato di cambiare nel profondo il modo di concepire l’insegnamento, eppure non sembra che le cose siano migliorate. È diminuita la severità degli insegnati (i quali, anzi, spesso si devono difendere da alunni e famiglie), è diminuito anche il carico di apprendimento per gli studenti, e quindi lo sforzo, ma tutto ciò che denunciavano Milani e Pasolini, ovvero le disuguaglianze educative, la selettività iniqua, il non insegnamento di un reale pensiero critico, sono ancora temi irrisolti.
Molto interessante anche la critica fatta da Luca Ricolfi e Paola Mastracola in tempi più recenti. In sintesi essi sostengono che la presunta “democratizzazione” della scuola, che si è concretizzata in un abbassamento del livello qualitativo, favorisce proprio quei ragazzi che vengono da contesti sociali privilegiati e che possono accedere per altri canali ad un’istruzione superiore. E questo blocca ancor di più il famoso “ascensore sociale”.
——-
Tuttavia, c’è un altro aspetto della “piccola rivolta” che sembra molto interessante, guardando oltre alla critica nei confronti del sistema di formazione e di giudizio scolastici.
In questa ribellione si intravedono – da parte di questa generazione di poco più che adolescenti di tutto il mondo – il rifiuto della società della competizione e degli evidenti segni di insofferenza verso la società che stiamo lasciando loro, che questa generazione di poco più che adolescenti – in tutto il mondo – stia dando palesi segni di insofferenza verso la società come gliela stiamo lasciando, credo sia evidente.
Serve, forse, ricordare le bande di teppisti giovanili che vogliono tutto e subito e rifiutano obblighi e doveri? Oppure, ricordare gli hikkimori, che certo non sono un fenomeno solo giapponese? O ripensare a Greta e al suo enorme seguito? Movimenti che vanno molto al di là della sola lotta ai cambiamenti climatici.
La verità è che il capitalismo, da anni, sembra aver imparato ad ammantarsi di un bel packaging (sì, certo, non è solo apparenza) e parla di etica, responsabilità sociale, sostenibilità. Ma poi quel che conta è sempre il profitto e la remunerazione del capitale, a tutti i costi. E per ottenere profitto c’è la competizione sui mercati: tra Stati, tra aziende, tra le persone. Da questo schema non si scappa. E ci sono regole da seguire (sempre più complesse) e percorsi da portare a termine, senza deroghe.
A questo, sembra che si stiano ribellando questi ragazzi.
Le società inquadrano, gli individui si adeguano, ma sotto sotto scorre un fiume carsico. Il fiume della voglia di libertà, della voglia di una vita senza lacci, forse anche di una salvifica “irresponsabilità”. E ogni tanto questo fiume si riaffaccia alla superfice e fa esplodere momenti di ribellione.
È stato così alla fine degli anni ’60, quando i movimenti studenteschi e gli hippy hanno scatenato una dura contestazione negli USA contro una società bigotta, retriva, chiusa, ottusa.
Come non ricordare le rivolte nelle università americane, contro la guerra in Vietnam, contro l’apartheid, ma soprattutto contro il conformismo asfissiante.
Come non ricordare gli studenti di tutto il mondo con in mano L’uomo a una dimensione di Herbert Marcuse, brandito come un’arma contro la società repressiva?
Jimi Hendrix che suona una versione distorta e acida di Star and Stripes sul palco di Woodstock davanti a decine di migliaia di ragazzi e ragazze che ballano seminudi nei prati devastati, è il simbolo più potente di questa sete di rivolta dal grigio opprimente e ottuso.
In America la rivoluzione hippy è finita rapidamente nel nulla e in Europa il ‘68 si è altrettanto rapidamente trasformato da una rivoluzione libertaria (ricordate? L’immaginazione al potere…) in una drammatica battaglia politica che nulla aveva di libertario, anzi, era la sua negazione.
Il fiume carsico è tornato a scorrere in profondità, la gente è tornata nei ranghi, ha ricominciato a pensare alla carriera, ai soldi, alla stabilità e quant’altro. Da conquistarsi con le buone o con le cattive.
Ma forse quei due ragazzi e quella ragazza che si sono rifiutati di fare l’orale alla Maturità sono solo un primo segnale che il fiume sta tornando in superfice.
Gli anni ’60 dell’illusione libertaria ebbero i loro cantori letterari: da Kerouac a Ginsberg, da Burroughs a Corso, tutti autori che sono stati il supporto culturale e immaginifico di una generazione che voleva cambiare completamente la realtà.
Suona bene chiudere con le parole sferzanti di una poesia di Lawrence Ferlinghetti:
“The world is a beautiful place to be born into if you don’t mind some people dying all the time or maybe only starving some of the time which isn’t half so bad if it isn’t you.”
Chissà se chi ha deriso senza appello quei tre ragazzi si renderà conto che quel rifiuto è molto più di un capriccio.
——-
Dopo alcune settimane dalla “piccola protesta”, riteniamo che sia il caso di aggiungere qualche appunto:
- Da un sondaggio organizzato da Unicef – Unisona emerge che il fenomeno della competizione è minoritario, meno del 20% degli studenti intervistati dichiara che a scuola ci sia un clima competitivo, contro una maggioranza che dice di sentirsi stressata, inadeguata o insicura, soprattutto a causa delle aspettative dei genitori, dell’immagine di ipercompetizione trasmessa dal mondo del lavoro, e del carico di studio.
- Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Valditara, ai primi di settembre, tra le novità introdotte per l’esame di maturità, ha reintrodotto l’obbligatorietà dell’esame orale, dando seguito a quanto detto ai primi di luglio: «Se un ragazzo non si presenta all’orale, o volontariamente decide di non rispondere alle domande dei docenti, […] perché vuole ‘non collaborare’ o vuole ‘boicottare’ l’esame, dovrà ripetere l’anno»
- L’analisi più dettagliata delle dichiarazioni degli studenti sembrano rivelare – più che i caratteri di una protesta strutturale – fenomeni di insoddisfazione personale sui giudizi o sul clima scolastico.
Contiamo di fare delle analisi più approfondite e sistematiche, con l’aiuto di esperti di scuola e di insegnamento, seguendo la traccia che propone Vittorio Pentimalli: «resto dell’idea che quei rifiuti a sostenere l’esame siano un segnale: debole, minimo, ma da non sottovalutare. C’è molta brace che cova sotto le ceneri».
Autore
-
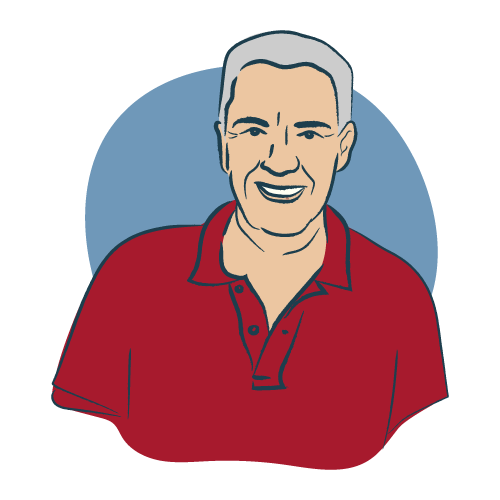
Professionista della comunicazione, esperto di ricerche sociologiche e di mercato, scrittore, pubblicista. E’ sempre acuto e non ti fa passare nulla che non sia convincente.
Leggi tutti gli articoli
