Le teorie del complotto, quarta parte – I miti della scienza intonsa e della politica senza bias
Questa è la quarta puntata della riflessione avviata due settimane fa. (prima parte, seconda parte, terza parte). Qui ci parliamo del fatto che una scienza intoccata, intonsa, libera da vincoli e condizionamenti, e quindi guidata solo dalla pura curiosità intellettuale, non è altro che un mito, alimentato anche dalla credenza che possa dirimere le questioni in una maniera scevra da pregiudizi. Il testo completo è stato pubblicato come prefazione al volume Matthieu Amiech, “L’industria del complottismo. Social network, menzogne di stato e distruzione del vivente” (Edizioni Malamente, 2024).
Elisa Lello.
IL MITO DELLA SCIENZA INTONSA
Se quella appena vista – la scienza può venire corrotta e strumentalizzata – è la ragione in fondo più facile da individuare tra quelle che dovrebbero indurci alla prudenza nel mettere la scienza al centro della politica, il problema è però decisamente più complesso. Perché il punto è che non è solo quando è corrotta, o volutamente strumentalizzata, che la scienza è influenzata da valori, interessi economici o politici, condizionamenti di tipo culturale, sociale o religioso. Anzi, in ogni sua fase – dalla scelta del tema, a quella dei metodi e della prospettiva, fino alla produzione e interpretazione dell’evidenza empirica – la produzione di conoscenza scientifica è condizionata da fattori altri, extra-scientifici. Molte/i colleghe/i all’interno delle scienze sociali, per parlare del mio campo disciplinare, rivendicano la propria identità di ricercatrici/tori militanti partendo proprio dalla consapevolezza che la posizione di chi fa ricerca non possa essere neutrale e dall’acquisizione che ogni sapere non possa che essere “situato”. Anche e forse soprattutto quello che si pretende oggettivo. Quello di una scienza intoccata, intonsa, libera da vincoli e condizionamenti, e quindi guidata solo dalla pura curiosità intellettuale, non sarebbe che un mito, come fa notare Sarewitz (1996), sulla scia di lunghe tradizioni di ricerca in diverse discipline.
Un mito pericoloso, tra l’altro: perché mentre certi tipi di condizionamento vengono stigmatizzati e destano scandalo (per esempio, le ricerche che dimostrano l’innocuità del fumo passivo o di certi pesticidi, di cui risulti la sponsorizzazione a opera delle lobby dei rispettivi settori), altre forme di influenza non meno importanti non destano alcun allarme, anzi sono naturalizzate come parte del normale così vanno le cose. Per esempio, il fatto che gli investimenti per la ricerca si concentrino nelle direzioni dove si addensano importanti interessi del complesso militare-industriale (per esempio, la costruzione di armi, la digitalizzazione, l’IA) lasciando sprovvisti aree e filoni di indagine che pure sarebbero più rispondenti alle esigenze di vita di ampi settori della popolazione mondiale; o la sproporzione di investimenti nella ricerca medica a favore di patologie che colpiscono i paesi più ricchi e bianchi rispetto a quelli più poveri e abitati da maggioranze con altre gradazioni del colore della pelle. Ecco: proprio il mito di una scienza intonsa, non condizionata, “pura”, impedirebbe, sottolinea ancora Dotson (2021), l’avviarsi di un dibattito circa le misure che potrebbero continuare a condizionare, ma questa volta in modo più democratico, equo ed emancipativo, la produzione della conoscenza scientifica. Per esempio, aprendo una discussione su quali aree e filoni di ricerca serve effettivamente privilegiare, e su chi sia chiamato a prendere decisioni in merito; o favorendo la partecipazione di scienziati e cittadini di paesi del Sud del mondo nell’elaborazione dell’agenda di ricerca. E molti altri esempi potrebbero seguire.
I BIAS INTRODOTTI DALLA PRETESA DI UNA POLITICA SENZA BIAS (SCIENTIZZATA)
La credenza fasulla e insidiosa che dovremmo aggredire è dunque quella secondo cui ci sarebbe una netta separazione tra scienza e politica, laddove è vero piuttosto il contrario, cioè che è difficile capire dove l’una finisca e l’altra inizi. Anche perché proprio questa falsa credenza costituisce il presupposto della crescente scientizzazione della politica (Pielke 2005) – da qui discendono le aporie e contraddizioni che questa pone.
Con scientizzazione della politica si intende la tendenza che si va affermando sempre più a descrivere controversie che contemplano aspetti sociali, etici e politici in termini esclusivamente scientifici; pretendendo che una scienza suppostamente oggettiva possa dirimere le questioni in una maniera scevra da pregiudizi (unbiased): meglio, dunque, di quanto farebbe quel vecchio e screditato arnese della politica, ambito della ricerca di sintesi e compromessi.
Se è vero che la ricerca scientifica può essere di utilità nell’elaborazione delle politiche, il punto è mettere a fuoco le criticità che si aprono qualora si decida di mettere la scienza al centro della politica e dei processi decisionali. Per iniziare, se è facile dire che è la scienza che deve decidere, le cose si complicano quando ci chiediamo quali expertise mobilitare, o quali discipline. È evidente come la controversia legata agli OGM – di vecchia o di nuova generazione che siano – venga letta in modo differente, e dia quindi risposte sempre scientifiche ma diverse e contrapposte, a seconda se utilizziamo le lenti dell’ingegneria genetica o quelle dell’ecologia (Dotson 2021). Altro effetto nefasto della scientizzazione della politica è la tendenza a marginalizzare conoscenze differenti da quelle degli esperti. Il non tenere conto, per esempio, che persone che non hanno titoli di studio specifici in un determinato campo detengano conoscenze, expertise, informazioni che possono essere non visibili alla disciplina scientifica degli esperti di turno, eppure decisamente rilevanti. Nella storia dei disastri e delle nocività industriali è una costante la denuncia, da parte delle popolazioni colpite, del diffondersi anomalo di patologie che vengono a lungo screditate come mera “aneddotica” (o isteria e fobia, dalla “radiofobia” dei cittadini di Černobyl, alle patologie delle vittime del piombo e dell’amianto… e che dire della mancanza di sorveglianza attiva e quindi di dati affidabili sull’epidemia di “nessuna correlazione” recente?)[1] dagli esperti di turno, e che saranno poi riconosciute come fondate e reali solo molto più tardi, solitamente quando è troppo tardi.
Infine, la scientizzazione in sé introduce a sua volta bias e distorsioni. Perché induce a dare importanza solo agli aspetti che più facilmente possono essere analizzati, misurati e tradotti in numeri e grafici.[2] Un punto, questo, di cui dovremmo essere consapevoli sia per imparare a maneggiare le narrative del potere, sia – e questo forse è ancora più cruciale, e meno evidente, ci torno in chiusura – nel mettere a punto le nostre risposte e resistenze.
Per esempio, basare le decisioni politiche sugli OGM (o sui TEA) su una valutazione puramente scientifica della loro pericolosità accertata per la salute umana o per l’ambiente significa far slittare verso i margini altre questioni che non sono certo meno importanti. Significa, per esempio, non vedere né prendere in considerazione i diritti dei coltivatori biologici, o delle società tradizionali o indigene, a coltivazioni non contaminate e alla conservazione, trasmissione e scambio non monetario di sementi tradizionali. Significa preferire la via del soluzionismo tecnologico – manteniamo il modello agroindustriale che mina la biodiversità e impone abuso di diserbanti e pesticidi e poi tamponiamo (forse) il problema creando varietà che ne richiedano minori quantità – anziché mettere in discussione il modello di agricoltura che è all’origine di quei problemi. Significa marginalizzare valutazioni circa la perdita di autonomia – e quindi la dipendenza sempre più forte dalle multinazionali, la diminuzione del numero di aziende e la concentrazione della proprietà etc. – che queste tecnologie impongono al settore, assestando l’ennesimo colpo ferale all’agricoltura contadina, che poi è la stessa direzione verso cui spinge la digitalizzazione dell’agricoltura 4.0.[3] E significa escludere qualunque possibilità di discutere circa la desiderabilità della visione del mondo che è sottesa a quelle tecnologie.
Ma anche il riduzionismo climatico può essere individuato come esempio. Se quella che attraversiamo è una crisi ecologica estremamente complessa, data dall’intrecciarsi di più dimensioni dell’inquinamento – dell’aria, delle acque superficiali e delle falde, del suolo, luminoso, elettromagnetico… – con i cambiamenti climatici, con la perdita di biodiversità e con questioni come il consumo e l’impermeabilizzazione del suolo, le nocività industriali, le servitù e l’industria militari, l’agroindustria, il sistema della logistica e della distribuzione (eccetera), è arduo mettere a punto strumenti di misurazione così come è politicamente scomodo e complicato elaborare risposte: perché queste, per essere efficaci, non possono eludere l’intreccio con la dimensione sociale né evitare di mettere al centro della critica il modello di sviluppo e quindi l’idea stessa di crescita.
Di fronte a tutto questo, isolare invece il cambiamento climatico dal suo contesto ambientale e sociale è una strategia che, se da una parte si presta meglio all’elaborazione di indicatori quantitativi, parametri e scenari predittivi che possano fungere da base per politiche evidence-based, dall’altra supporta una narrativa utile a un capitalismo che sussume nella sua logica di espansione perpetua la crisi ecologica stessa. Non solo la crisi ecologica non basta a mettere in discussione l’espansione capitalista: essa diventa un pretesto per la creazione di nuovi mercati e per dare nuovo slancio all’estrattivismo dipinto di green.
NOTE
[1] Un aspetto rilevante di questa vicenda è relativo ai cambiamenti nelle procedure e negli algoritmi utilizzati in seno all’OMS per rilevare il nesso di causalità tra vaccini ed effetti avversi, un tema trattato da Osimani e Ilardo (2022).
[2] Per di più, la colonizzazione da parte dell’industria degli ambiti di governance della scienza fa sì che il principio di precauzione venga scalzato da quello di innovazione: in questo modo, l’onere della prova slitta dall’industria verso coloro che dovrebbero dimostrare la pericolosità di sostanze e prodotti. L’assenza di evidenza del danno diventa così evidenza della sua assenza (Lello e Saltelli 2022).
[3] Si veda il contributo de l’Atelier Paysan, Agricoltura 4.0 e nuovi OGM: la tecnoscienza all'assalto del vivente, 1 novembre 2023, <www.laterratrema.org>.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Anonimo (2022), Manifeste conspirationniste, Parigi, Seuil.
Attwell K., Smith D.T. (2017), Parenting as politics: social identity theory and vaccine hesitant communities, “International Journal of Health Governance”, 22(3): 183-98.
Bazzoli, N., Lello, E. (2022), The neo-populist surge in Italy between territorial and traditional cleavages, “Rural Sociology”, 87(1): 662-691.
Bordignon, F. (2023), Alternative science, alternative experts, alternative politics. The roots of pseudoscientific beliefs in Western Europe, “Journal of Contemporary European Studies”, 31(4): 1469-1488.
Bucchi, M., Neresini, F. (2002), Biotech remains unloved by the more informed, “Nature”, 416: 261.
Chalmers J. (2017), The transformation of academic knowledges: understanding the relationship between decolonizing and indigenous research methodologies, “Socialist Studies”, 12(1): 97-116.
Coniglione, F., eds. (2010), Through the mirrors of science. New challenges for knowledge-based societies, Heusenstamm, Ontos Verlag.
Consigliere, S. (2020), Favole del reincanto: molteplicità, immaginario, rivoluzione, Roma, DeriveApprodi.
de Sousa Santos, B., Nunes, J. A., Meneses, M.P. (2022), Opening up the canon of knowledge and recognizing difference, “Participations”, 32(1): 51-91.
Dentico, N., Missoni, E. (2021), Geopolitica della salute: Covid-19, OMS e la sfida pandemica, Soveria Mannelli, Rubbettino.
Dotson, T. (2021). The divide: how fanatical certitude is destroying democracy, Cambridge, MIT Press.
Foucart, S., Horel, S., Laurens, S. (2020), Les gardiens de la raison: enquête sur la désinformation scientifique, Parigi, La Découverte.
Gigerenzer, G. (2015), Imparare a rischiare: come prendere decisioni giuste, Milano, Cortina.
Goldenberg, M. (2016), Public misunderstanding of science? Reframing the problem of vaccine hesitancy, “Perspectives on Science”, 24(5): 552-81.
Goldenberg, M.J. (2021), Vaccine hesitancy: public trust, expertise, and the war on science, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.
Grignolio, A. (2016), Chi ha paura dei vaccini?, Torino, Codice.
Harambam, J. (2021), Against modernist illusions: why we need more democratic and constructivist alternatives to debunking conspiracy theories, “Journal for Cultural Research”, 25(1): 104-122.
Harambam, J., Aupers, S. (2015), Contesting epistemic authority: conspiracy theories on the boundaries of science, “Public Understanding of Science”, 24(4): 466-480.
Jasanoff, S. (2021), Knowledge for a just climate, “Climatic Change”, 169(3): 1-8.
Kahneman, D. (2012), Pensieri lenti e veloci, Milano, Mondadori.
Keren, A. (2018), The public understanding of what? Laypersons’ epistemic needs, the division of cognitive labor, and the demarcation of science, “Philosophy of Science”, 85(5): 781-792.
Lello, E. (2020), Populismo anti-scientifico o nodi irrisolti della biomedicina? Prospettive a confronto intorno al movimento free vax, “Rassegna Italiana di Sociologia”, 3: 479-507.
Lello, E., Raffini, L. (2023), Science, pseudo-science, and populism in the context of post-truth. The deep roots of an emerging dimension of political conflict, “Rassegna Italiana di Sociologia”, 4: 705-732.
Lello, E., Saltelli, A. (2022), Lobbismo scientifico e dirottamento dello spazio pubblico, in E. Lello, N. Bertuzzi (eds.), Dissenso informato. Pandemia: il dibattito mancato e le alternative possibili, Roma, Castelvecchi, 187-203.
Lolli, A. (2023), Il complottismo non esiste o Miseria dell’anticomplottismo, in M.A. Polesana, E. Risi (eds.), (S)comunicazioni e pandemia. Ricategorizzazioni e contrapposizioni di un’emergenza infinita, Milano-Udine, Mimesis, 239-271.
Nunes, J. A., Louvison, M. (2020), Epistemologies of the South and decolonization of health: for an ecology of care in collective health, “Saude e Sociedade”, 29(3): e200563.
Osimani, B., Ilardo, M.L. (2022), “Nessuna correlazione”. Gli strumenti per la valutazione del nesso causale tra vaccinazione ed evento avverso, in E. Lello, N. Bertuzzi (eds.), Dissenso Informato. Pandemia: il dibattito mancato e le alternative possibili, Roma, Castelvecchi, 167-186.
Pielke, R.A.J. (2005), Scienza e politica, Roma-Bari, Laterza.
Quijano, A. (2005), Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina, in A colonialidade do saber: etnocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas, Buenos Aires, Clacso, 117-142.
Reich, J.A. (2014), Neoliberal mothering and vaccine refusal: imagined gated communities and the privilege of choice, in “Gender and Society”, 28(5): 679-704.
Sarewitz, D. (1996), Frontiers of illusion: science, technology, and the politics of progress, Philadelphia, Temple University Press.
Saurette, P., Gunster S. (2011), Ears wide shut: epistemological populism, argutainment and Canadian conservative talk radio, “Canadian Journal of Political Science”, 44(1): 195-218.
Schadee, H.M.A., Segatti, P., Vezzoni C. (2019), L’apocalisse della democrazia italiana: alle origini di due terremoti elettorali, Bologna, Il Mulino.
Smith, P.J., Chu, S.Y., Barker, L.E. (2004), Children who have received no vaccines: who are they and where do they live?, “Pediatrics”, 114(1): 187-95.
Steinberg, T. (2006), Acts of God: the unnatural history of natural disaster in America, Oxford, Oxford University Press.
Taussig, M.T. (1986), Shamanism, colonialism, and the wild man: a study in terror and healing, Chicago, University of Chicago Press.
Wei, F., Mullooly, J.P., Goodman, M., McCarty, M.C., Hanson, A.M., Crane, B., Nordin, J.D. (2009), Identification and characteristics of vaccine refusers, “BMC Pediatrics”, 9(18): 1-9.
Wu Ming 1 (2021), La Q di Qomplotto. QAnon e dintorni. Come le fantasie di complotto difendono il sistema, Roma, Alegre.
Ylä-Anttila, T. (2018), Populist knowledge: post-truth repertoires contesting epistemic authorities, “European Journal of Cultural and Political Sociology”, 5(4): 356-388.
Zagzebski, L.T. (2012), Epistemic authority: a theory of trust, authority, and autonomy in belief, Oxford, Oxford University Press.
Zografos, C., Robbins, P. (2020), Green sacrifice zones, or why a green new deal cannot ignore the cost shifts of just transitions, “One Earth”, 3(5): 543-546.
Le teorie del complotto, terza parte - Che si tratti di ossessione per la verità?
Questa è la terza puntata della riflessione avviata due settimane fa. (prima parte, seconda parte). Qui ci interroghiamo sulla corrente, ed epidemica, ossessione per la verità scientifica e per i (presunti) deficit cognitivi dei rispettivi oppositori politici, malattia che colpisce entrambi i fronti degli schieramenti politici. Il testo completo è stato pubblicato come prefazione al volume Matthieu Amiech, “L’industria del complottismo. Social network, menzogne di stato e distruzione del vivente” (Edizioni Malamente, 2024).
Elisa Lello.
ROVESCIANDO LA PROSPETTIVA: E SE IL PROBLEMA FOSSE INVECE L'OSSESSIONE PER LA VERITÀ?
Un rovesciamento di prospettiva dalle potenzialità decisamente più fertili ci viene indicato da Dotson (2021), quando, rifiutando l’intera lettura basata sull’avvento dell’era della post-verità, suggerisce che il problema non sia tanto che le persone trascurerebbero i fatti privilegiando pregiudizi e opinioni soggettive, ma consista proprio nella corrente, epidemica, ossessione per la verità scientifica.
La malattia contemporanea da cui ben pochi di noi possono sinceramente dirsi immuni, che provoca polarizzazioni estreme e mette a repentaglio ogni possibilità di confronto democratico, consisterebbe, nella sua prospettiva, proprio nell’abitudine a dare per scontato che solo una fazione – la propria, ovviamente – sia quella in grado di pensare razionalmente e con la scienza a supporto delle proprie tesi. Quindi l’altra, inevitabilmente, è in errore, s-ragiona, è in preda a deliri, allucinazioni e alle “buche” del complottismo. È così che siamo diventati ossessionati dai (presunti) deficit cognitivi dei nostri oppositori politici.
Una malattia, questa, che colpisce entrambi i fronti degli schieramenti politici: come le persone preoccupate per i cambiamenti climatici accusano i cosiddetti “negazionisti” di ignoranza e anti-scienza, specularmente chi contesta la matrice umana o l’emergenzialità della questione climatica si richiama a ricerche scientifiche ritenute più affidabili per dimostrare che la scienza mainstream sarebbe prona a interessi politici/economici e rea di soffocare il dissenso interno alla comunità scientifica. Tuttavia, questo atteggiamento così sprezzante e liquidatorio è particolarmente prevalente nelle retoriche liberal nei confronti dei conservatori, perché si sa, «the facts have a liberal bias» (Dotson 2021, p. 42): i fatti tenderebbero cioè per loro stessa natura a dare ragione ai progressisti.
Questo atteggiamento mentale, che viene indicato come scientismo politico, ha come corollario il diagnostic style of politics di cui parla lo storico Ted Steinberg (2006, cit. in Dotson 2021, p. 43), ovvero la tendenza a liquidare il dissenso politico come conseguenza di deficit cognitivi o problemi psicologici. In questo modo, il dissenso non è più dissenso: non più posizioni differenti e contrapposte con cui cercare un dialogo o esplorare, almeno, margini di compromesso. Anzi, la possibilità stessa del compromesso diventa un anatema. Perché con quella gente non si può, né si deve, ragionare. In questo modo il fanatismo scientista mina la democrazia, o almeno – suggerirei, ritenendo la democrazia già ampiamente minata di suo – compromette ulteriormente qualunque possibilità di confronto democratico e pure di trattazione con un’ambizione minima di approfondimento dei temi di cui si parla.
Nel trattare quindi in modo meno superficiale e sbrigativo del rapporto complesso tra scienza, “ignoranza” e politica, al cui interno inevitabilmente il tema del complottismo si inserisce, occorre tenere presente almeno tre questioni principali.
LA CORRUZIONE DELLA SCIENZA
La prima, per certi versi la più evidente – anche se tutt’altro che evidente è la portata delle sue conseguenze – ragione per cui dovremmo essere cauti di fronte al “l’ha detto la scienza, e quindi se non sei d’accordo sei ignorante”, riguarda la possibile strumentalizzazione della scienza a opera di interessi industriali e politici. Matthieu Amiech vi dedica opportuno spazio, riferendosi in particolare al bel libro di Foucart, Horel e Laurens, Les guardiens de la raison (2020). Ciò che mi preme mettere a fuoco qui è come sono cambiate le strategie di lobbismo politico: la fase dei “mercanti del dubbio”, quando le multinazionali reclutavano ricercatori e scienziati per produrre conoscenza scientifica solida, cioè capace di mettere in dubbio la credibilità delle ricerche che dimostravano la pericolosità dei loro prodotti, è ampiamente superata.[1] Oggi, infatti, gli interessi dell’industria, e in particolare quelli delle industrie maggiormente nocive, sono sostenuti in nome della scienza e della sostenibilità; come, cioè, se fossero non i desiderata delle corporations, ma verdetti oggettivi della scienza che finalmente ci permettono di superare le parzialità dell’opinione e le fallacie della politica. La professionalizzazione dell’influenza digitale fa poi sì che, grazie a raffinate tecniche di inbound marketing, a ribadire le ragioni dell’industria camuffate da verità scientifiche inattaccabili non siano solo scienziati, politici o celebrità, bensì persone (quasi) comuni, che ci appaiono più credibili perché disinteressate, cioè sinceramente interessate solo a difendere e valorizzare il ruolo della scienza nel dibattito pubblico. È un gioco di specchi, che fa sì che al green/pink/ethics-washing oggi si aggiunga l’insidia del participatory-washing: la sottile arte di far passare gli interessi del settore industriale come se fossero verità scientifiche e per giunta sostenute dal basso, un tappeto di erba sintetica (in inglese astroturf, il termine tecnico per designare questa strategia) a simulare l’erba vera (grassroots, cioè le rivendicazioni popolari, di movimento, genuinamente dal basso).[2]
Credo che non abbiamo ancora preso consapevolezza della portata del problema: della potenza, cioè, con cui il combinato disposto di questi meccanismi consolida ulteriormente il potere delle élite tecnocratiche e parallelamente indebolisce i movimenti e le proteste dal basso, delegittimandoli e sottraendo loro le loro stesse parole.
Perché nel momento in cui movimenti genuinamente emancipativi, grassroots, si battono contro ciò che veste i panni di una scienza addirittura legittimata e richiesta dal basso, le loro parole ancora più facilmente potranno venire negate come forme di partecipazione e invece fraintese, e liquidate, come semplice fatto di ignoranza e complottismo. Siamo consapevoli, giustamente, della repressione sempre più feroce che si abbatte contro chi protesta: fatichiamo invece a scorgere come il dissenso sempre più spesso venga prima ancora sterilizzato a monte, delegittimato sul piano semantico, e quindi non visto, scambiato per altro. Ma la delegittimazione semantica rafforza e giustifica la repressione legislativa e giudiziaria: perché, in fondo, se non è dissenso ma solo odiosa ignoranza, perché scomodarsi a denunciare la sproporzionalità di idranti, misure di privazione della libertà, sanzioni o se a chi protesta viene negato l’accesso al proprio conto bancario (come accaduto con il Freedom Convoy canadese)…?
«Qual è la differenza tra la verità e una teoria del complotto? Tra gli otto e i nove mesi». Questa battuta, che secondo gli estensori del Manifeste circolava all’interno dell’OMS (p. 34), richiama causticamente l’intervallo di tempo che troppe volte è intercorso tra la dismissione di posizioni minoritarie o critiche come mero complottismo e la constatazione che forse queste contenevano qualcosa di più di qualche «nucleo di verità», per riprendere l’espressione coniata da Wu Ming 1 (2021). Peccato che quegli otto-nove mesi siano anche l’intervallo di tempo fatale, quello in cui si sarebbe potuto discutere e agire, e chissà forse anche imprimere un diverso corso agli eventi. Se solo l’etichettamento delle critiche come “complottismo”, e spesso dell’intera controversia come “roba da complottisti”, non avesse reso impraticabile il terreno – troppo alto il rischio di essere scambiati per complottisti, meglio parlare d’altro – minando ogni possibilità di critica e dibattito. Così che la consapevolezza, se arriva, arriva troppo tardi. Quando ormai l’ennesima “innovazione” è diventata elemento del paesaggio del new normal, e indietro non si torna.
Un esempio emblematico è quello della protesta contro i TEA (Tecniche di evoluzione assistita), culminata nel recente episodio di Mezzana Bigli (Pavia), dove il gesto dei falciatori notturni di una coltura sperimentale di riso promossa dall’Università di Milano è stato oggetto di un coro unanime di attacchi dal mondo politico, scientifico e “ambientalista”, che l’hanno dipinto come esito di oscurantismo anti-scientifico, ignoranza e addirittura terrorismo. Impedendo così non solo il riconoscimento della dignità di azione politica a quel gesto, ma sbarrando anche la strada allo svilupparsi di un dibattito intorno a un tema che infatti oggi non mobilita che uno sparuto gruppo di coraggiose/i attiviste/i, laddove non più di vent’anni fa intorno agli OGM una certa compattezza del mondo ambientalista era stata capace di imprimere una svolta significativa sul corso degli eventi.[3]
Ma molti altri esempi possono essere individuati, nel Sud globale, dove i saperi contadini e le resistenze ai programmi di modernizzazione ecologica – targati Monsanto e sostenuti dai filantrocapitalisti alla Bill Gates – diventano superstizioni anti-moderne da estirpare. Nel Sud come nel Nord del mondo, le resistenze contro gli impatti devastanti della corsa ai minerali necessari per la transizione green e digitale, così come le proteste contro le speculazioni legate alle rinnovabili, devono oggi vedersela non più solo con la vecchia accusa di egoismo Nimby, ma anche con lo stigma di essere contro la scienza, negazionisti, ignoranti. Infine, come non evocare l’occasione persa conseguente all’incapacità di cogliere l’importanza (e di rispondere alla domanda di tematizzazione pubblica, prima che sia troppo tardi) di alcune questioni sollevate dalle proteste contro la gestione pandemica – dai rischi dell’ipermedicalizzazione a quelli dell’identità digitale e della sorveglianza tecnologica. Un’occasione persa che è difficile non attribuire all’ansia di non provare nemmeno a parlare di ciò di cui parlano “i complottisti”.
NOTE
[1] È salutare ricordare che è proprio così che nasce la nozione di sound science: introdotta dall’industria del tabacco, per screditare la trash science (scienza spazzatura) prodotta dalla ricerca indipendente e accademica che metteva in luce la pericolosità del fumo passivo.
[2] Ne abbiamo parlato in modo più articolato in Lello e Saltelli (2022).
[3] Per di più, la colonizzazione da parte dell’industria degli ambiti di governance della scienza fa sì che il principio di precauzione venga scalzato da quello di innovazione: in questo modo, l’onere della prova slitta dall’industria verso coloro che dovrebbero dimostrare la pericolosità di sostanze e prodotti. L’assenza di evidenza del danno diventa così evidenza della sua assenza (Lello e Saltelli 2022).
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Anonimo (2022), Manifeste conspirationniste, Parigi, Seuil.
Attwell K., Smith D.T. (2017), Parenting as politics: social identity theory and vaccine hesitant communities, “International Journal of Health Governance”, 22(3): 183-98.
Bazzoli, N., Lello, E. (2022), The neo-populist surge in Italy between territorial and traditional cleavages, “Rural Sociology”, 87(1): 662-691.
Bordignon, F. (2023), Alternative science, alternative experts, alternative politics. The roots of pseudoscientific beliefs in Western Europe, “Journal of Contemporary European Studies”, 31(4): 1469-1488.
Bucchi, M., Neresini, F. (2002), Biotech remains unloved by the more informed, “Nature”, 416: 261.
Chalmers J. (2017), The transformation of academic knowledges: understanding the relationship between decolonizing and indigenous research methodologies, “Socialist Studies”, 12(1): 97-116.
Coniglione, F., eds. (2010), Through the mirrors of science. New challenges for knowledge-based societies, Heusenstamm, Ontos Verlag.
Consigliere, S. (2020), Favole del reincanto: molteplicità, immaginario, rivoluzione, Roma, DeriveApprodi.
de Sousa Santos, B., Nunes, J. A., Meneses, M.P. (2022), Opening up the canon of knowledge and recognizing difference, “Participations”, 32(1): 51-91.
Dentico, N., Missoni, E. (2021), Geopolitica della salute: Covid-19, OMS e la sfida pandemica, Soveria Mannelli, Rubbettino.
Dotson, T. (2021). The divide: how fanatical certitude is destroying democracy, Cambridge, MIT Press.
Foucart, S., Horel, S., Laurens, S. (2020), Les gardiens de la raison: enquête sur la désinformation scientifique, Parigi, La Découverte.
Gigerenzer, G. (2015), Imparare a rischiare: come prendere decisioni giuste, Milano, Cortina.
Goldenberg, M. (2016), Public misunderstanding of science? Reframing the problem of vaccine hesitancy, “Perspectives on Science”, 24(5): 552-81.
Goldenberg, M.J. (2021), Vaccine hesitancy: public trust, expertise, and the war on science, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.
Grignolio, A. (2016), Chi ha paura dei vaccini?, Torino, Codice.
Harambam, J. (2021), Against modernist illusions: why we need more democratic and constructivist alternatives to debunking conspiracy theories, “Journal for Cultural Research”, 25(1): 104-122.
Harambam, J., Aupers, S. (2015), Contesting epistemic authority: conspiracy theories on the boundaries of science, “Public Understanding of Science”, 24(4): 466-480.
Jasanoff, S. (2021), Knowledge for a just climate, “Climatic Change”, 169(3): 1-8.
Kahneman, D. (2012), Pensieri lenti e veloci, Milano, Mondadori.
Keren, A. (2018), The public understanding of what? Laypersons’ epistemic needs, the division of cognitive labor, and the demarcation of science, “Philosophy of Science”, 85(5): 781-792.
Lello, E. (2020), Populismo anti-scientifico o nodi irrisolti della biomedicina? Prospettive a confronto intorno al movimento free vax, “Rassegna Italiana di Sociologia”, 3: 479-507.
Lello, E., Raffini, L. (2023), Science, pseudo-science, and populism in the context of post-truth. The deep roots of an emerging dimension of political conflict, “Rassegna Italiana di Sociologia”, 4: 705-732.
Lello, E., Saltelli, A. (2022), Lobbismo scientifico e dirottamento dello spazio pubblico, in E. Lello, N. Bertuzzi (eds.), Dissenso informato. Pandemia: il dibattito mancato e le alternative possibili, Roma, Castelvecchi, 187-203.
Lolli, A. (2023), Il complottismo non esiste o Miseria dell’anticomplottismo, in M.A. Polesana, E. Risi (eds.), (S)comunicazioni e pandemia. Ricategorizzazioni e contrapposizioni di un’emergenza infinita, Milano-Udine, Mimesis, 239-271.
Nunes, J. A., Louvison, M. (2020), Epistemologies of the South and decolonization of health: for an ecology of care in collective health, “Saude e Sociedade”, 29(3): e200563.
Osimani, B., Ilardo, M.L. (2022), “Nessuna correlazione”. Gli strumenti per la valutazione del nesso causale tra vaccinazione ed evento avverso, in E. Lello, N. Bertuzzi (eds.), Dissenso Informato. Pandemia: il dibattito mancato e le alternative possibili, Roma, Castelvecchi, 167-186.
Pielke, R.A.J. (2005), Scienza e politica, Roma-Bari, Laterza.
Quijano, A. (2005), Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina, in A colonialidade do saber: etnocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas, Buenos Aires, Clacso, 117-142.
Reich, J.A. (2014), Neoliberal mothering and vaccine refusal: imagined gated communities and the privilege of choice, in “Gender and Society”, 28(5): 679-704.
Sarewitz, D. (1996), Frontiers of illusion: science, technology, and the politics of progress, Philadelphia, Temple University Press.
Saurette, P., Gunster S. (2011), Ears wide shut: epistemological populism, argutainment and Canadian conservative talk radio, “Canadian Journal of Political Science”, 44(1): 195-218.
Schadee, H.M.A., Segatti, P., Vezzoni C. (2019), L’apocalisse della democrazia italiana: alle origini di due terremoti elettorali, Bologna, Il Mulino.
Smith, P.J., Chu, S.Y., Barker, L.E. (2004), Children who have received no vaccines: who are they and where do they live?, “Pediatrics”, 114(1): 187-95.
Steinberg, T. (2006), Acts of God: the unnatural history of natural disaster in America, Oxford, Oxford University Press.
Taussig, M.T. (1986), Shamanism, colonialism, and the wild man: a study in terror and healing, Chicago, University of Chicago Press.
Wei, F., Mullooly, J.P., Goodman, M., McCarty, M.C., Hanson, A.M., Crane, B., Nordin, J.D. (2009), Identification and characteristics of vaccine refusers, “BMC Pediatrics”, 9(18): 1-9.
Wu Ming 1 (2021), La Q di Qomplotto. QAnon e dintorni. Come le fantasie di complotto difendono il sistema, Roma, Alegre.
Ylä-Anttila, T. (2018), Populist knowledge: post-truth repertoires contesting epistemic authorities, “European Journal of Cultural and Political Sociology”, 5(4): 356-388.
Zagzebski, L.T. (2012), Epistemic authority: a theory of trust, authority, and autonomy in belief, Oxford, Oxford University Press.
Zografos, C., Robbins, P. (2020), Green sacrifice zones, or why a green new deal cannot ignore the cost shifts of just transitions, “One Earth”, 3(5): 543-546.
Le teorie del complotto, seconda parte - Il populismo epistemologico e le sue aporie
Questa è la seconda puntata della riflessione avviata la settimana scorsa. Qui ci interroghiamo sulle ragioni del crescente scetticismo popolare verso la - o meglio, verso una parte della - scienza, mettendo in evidenza i limiti e le contraddizioni delle risposte oggi largamente prevalenti nel dibattito pubblico e in quello accademico, incentrate sulla post-verità, sul populismo e sulla divisione del lavoro scientifico. Il testo completo è stato pubblicato come prefazione al volume Matthieu Amiech, “L’industria del complottismo. Social network, menzogne di stato e distruzione del vivente” (Edizioni Malamente, 2024).
Elisa Lello.
IL POPULISMO EPISTEMOLOGICO E LE SUE APORIE
Del resto quelle letture sbrigative che riducono il problema all’analfabetismo funzionale e all’ignoranza del popolo trovano pieno supporto nelle chiavi di lettura prevalenti nel dibattito accademico, che sono decisamente significative. Vediamole.
Molta elaborazione accademica sul tema ha preso le mosse dall’accettazione pressoché acritica della categoria di post-verità. Si è così sviluppata un’ampia letteratura che spiega come siamo entrati in un’era nuova, in cui le persone tendono ad attribuire peso a emozioni e sentimenti più che alla razionalità, a credenze soggettive più che a dati oggettivi, a opinioni più che a fatti, a discorsi seduttivi più che a spiegazioni analitiche, alle esperienze dirette e al senso comune dell’uomo/donna della strada più che a generalizzazioni e astrazioni.[1] Molti lavori hanno così introdotto concetti come quelli di pseudo-science o troll-science (Ylä-Anttila 2018), al punto che l’intero dibattito tende a ruotare intorno ai perni del populismo epistemologico (Saurette e Gunster 2011) e del science-related populism (Mede e Schäfer 2020).
Si parte cioè da un concetto, quello di populismo, per poi stirarlo in modo che il classico risentimento popolare verso le élite finisca per abbracciare, insieme ai detentori del potere politico ed economico, anche università, esperti, istituzioni scientifiche e sapere accreditato. Il problema è che già nella sua accezione propriamente politica, l’uso corrente del concetto di “populismo” appare problematico: in una fase in cui è difficile trovare un partito/leader che non faccia ricorso a strategie e registri discorsivi “populisti”, quella categoria tende a perdere la sua utilità analitica, e piuttosto ad ampliare, di converso, la sua valenza normativa (Schadee et al. 2019; Bazzoli e Lello 2022). Diventa, cioè, un modo per tenere insieme e distinguere tutti quegli attori politici che non piacciono (al mainstream), perché alternativi – o presunti tali – ad esso; e, al contempo, per scaricare la responsabilità di mutamenti e terremoti elettorali sgraditi (sempre ai partiti tradizionali) sugli elettori, che voterebbero partiti populisti perché sono diventati gretti, ignoranti e razzisti, o nella versione più edulcorata – ma la sostanza non cambia – per la rabbia e la frustrazione di essere stati abbandonati, impoveriti, espropriati. In ogni caso, la responsabilità è degli elettori, che non agiscono in base a ragioni ragionevoli ma sarebbero agiti da pulsioni di rabbia e frustrazione. Isolando in questo modo le élite e i partiti tradizionali di centro sinistra e centro destra da qualunque dovere di auto-critica rispetto al loro essersi trasformati in oligarchie intercambiabili in difesa degli interessi del capitalismo estrattivista nelle sue diverse facce.
Lo stesso esito che è possibile rinvenire nel populismo legato alla scienza, o epistemologico: in fondo, un modo per spiegare le critiche e la crescente diffidenza popolare verso le istituzioni del sapere accreditato facendo leva su questa stessa rabbia “irrazionale”, psicopatologica, nutrita da patetiche nostalgie dell’eden perduto, esentando quelle stesse istituzioni dal doversi porre domande scomode, ma molto serie, circa la propria crescente autoreferenzialità e sulle ragioni profonde che ne stanno intaccando credibilità e prestigio.
Poco importa se queste letture auto-assolutorie basate su populismo e post-verità aprono contraddizioni evidenti. Una principale: come è possibile che proprio la diffusione della scolarizzazione e l’accresciuta facilità di accesso a fonti di informazione scientifica abbiano prodotto crescente sfiducia nella scienza stessa e il proliferare dei complottismi?
Anche perché, nel frattempo, assistiamo al recupero surrettizio del vecchio Deficit Model, risalente agli anni Ottanta dello scorso secolo e ormai superato da decenni di studi nell’ambito della filosofia e sociologia della scienza e degli STS (Bucchi e Neresini 2002; Coniglione 2010). Quel modello assumeva che le critiche popolari verso le innovazioni tecnoscientifiche fossero riconducibili all’ignoranza del pubblico e alla sua incapacità di capire il metodo scientifico. Secondo quella visione paternalista della cittadinanza, è dunque sufficiente comunicare meglio le innovazioni che si intende introdurre e promuovere l’alfabetizzazione scientifica per superare resistenze e diffidenze popolari.
E invece, proprio oggi che l’accesso a PubMed e SciHub, la fruizione di programmi di divulgazione scientifica e l’apprendimento quanto meno dei rudimenti del metodo si sono democratizzati quanto mai prima, monta la diffidenza popolare verso la scienza: com’è possibile?[2]
Da notare, per inciso, che il recupero di una teoria anacronistica come il Deficit Model costituisce il pilastro “teorico” del burionismo, ovvero di quel modo – altrettanto fuori dal tempo – di concepire la relazione tra scienza e società massimamente rappresentato, in Italia, dall’autoproclamatosi paladino della lotta in difesa della scienza contro le fake news. Eppure, proprio il fatto che le perplessità verso le politiche vaccinali o l’adesione a medicine alternative siano derubricabili a questione di «asini raglianti» è, questa sì, una fake news, come dimostra una consolidata tradizione di studi che ha chiarito le differenti ragioni per cui la scienza debba essere democratica. Riassumendole: primo, perché non è plausibile né fondato ri(con)durre le ragioni di critica e perplessità all’ignoranza, e anzi quelle ragioni vanno prese in considerazione, visto che le innovazioni tecnoscientifiche in discussione andranno a ricadere sulla vita dei cittadini non-esperti, che quindi devono avere voce in capitolo (Coniglione 2010). E, secondo, perché il coinvolgimento dei non esperti nella produzione scientifica è fondamentale per conseguire risultati che avranno maggiori probabilità di godere di legittimazione sociale, dunque di essere accettati socialmente (Jasanoff 2021), ma che saranno anche di migliore affidabilità e qualità da un punto di vista propriamente conoscitivo (Harambam 2021, Dotson 2021).
Ancora più improbabili, quasi acrobatici, sono i tentativi di darsi una spiegazione nei casi in cui l’analisi empirica individui atteggiamenti critici verso le innovazioni tecnoscientifiche più diffusi presso settori sociali che difficilmente possono essere sospettati di essere affetti da ressentiment populista in conseguenza di disagio sociale o impoverimento; né che possano essere liquidati come ignoranti o incapaci di comprendere il metodo scientifico a causa di presunti deficit culturali.
Prendiamo, ancora, il caso della esitanza vaccinale, che diverse ricerche hanno rilevato essere maggiormente diffusa all’interno di segmenti sociali che possono contare sia su redditi che su livelli di istruzione più elevati della media (per es., Smith et al. 2004; Wei et al. 2009; Lello 2020), tanto che in alcuni casi se ne è parlato come di una scelta legata a situazioni di privilegio (Reich 2014). E non a torto, perché, come fa notare Goldenberg (2021), se dubbi e perplessità sono diffusi nei diversi gradini della scala sociale, sono però soprattutto le persone che possono fare affidamento su più risorse – economiche, culturali, relazionali etc. – quelle più attrezzate per sostenere i costi (economici e non solo) conseguenti alla scelta di non rispettare le prescrizioni vaccinali previste per sé (nel caso del Covid-19) o e/o per i propri figli (nel caso delle vaccinazioni pediatriche).
Ebbene: in questi casi, si tende a fare ricorso (per es.: Grignolio 2016) a spiegazioni complesse e contorte, facendo leva sulla teoria della razionalità limitata di Kahneman (2012) e sugli studi di Gigerenzer (2015), per cui l’abbondanza informativa non porta necessariamente a compiere scelte ottimali. Ma anche in questo modo non si riesce a spiegare perché mai proprio le persone più acculturate dovrebbero anche essere le più sprovviste delle risorse necessarie per distinguere tra fake news e notizie attendibili, finendo così per diventare addirittura vittime privilegiate delle «trappole cognitive» e dei vari bias (distorsioni, pregiudizi) che vengono associati a modelli cognitivi chiusi e dogmatici.
Ogni genere di piroetta, insomma, pur di non riconoscere l’ovvio. Cioè, che assistiamo ormai da anni, a livello di organizzazioni sovranazionali deputate all’elaborazione delle strategie di global health, a un impoverimento esiziale del concetto di salute, che si è tanto assottigliato da arrivare a coincidere sempre più con quello di immunizzazione; e che tale impoverimento dipende da motivazioni di ordine politico ed economico, più che da ragioni scientifiche (Dentico e Missoni 2021). È dall’assenza di dibattito e trasparenza sulle commistioni tra ricerca e finanziamenti privati che occorrerebbe partire per trovare spiegazioni più plausibili dell’esitanza vaccinale e delle proteste ad essa correlate, più che dalla post-verità o dai deficit cognitivi. Tanto più che sono diverse le ricerche empiriche (Goldenberg 2016) che da tempo mostrano come dietro all’esitanza vaccinale e alle proteste conseguenti non ci sia anti-scienza, bensì una richiesta di apertura della black box – cioè di chiarire gli intrecci tra scienza, politica e interessi – insieme a una domanda di più ricerca indipendente e di coinvolgimento nella definizione delle linee di indagine scientifica (per esempio, orientando i finanziamenti sulla ricerca sugli effetti avversi e sulle variabili soggettive che incidono sulla probabilità del loro manifestarsi).
Più raffinata – e ancora più significativa, nell’economia del nostro ragionamento – la posizione di quegli studiosi che, avendo potuto constatare, sulla base di ricerche statistiche, come un aumento dell’esposizione all’informazione scientifica non “protegga” di per sé le persone da teorie pseudoscientifiche e complottiste, invocano una maggiore enfasi, nelle scelte comunicative, sull’importanza della «divisione del lavoro scientifico» tra specialisti e profani. Si tratterebbe, cioè, di fornire alle persone comuni «ragioni preventive» (Zagzebski 2012) perché queste possano credere nelle affermazioni degli esperti. Come sostiene Keren (2018), «una migliore comprensione dei contenuti scientifici, non accompagnata da una comprensione appropriata della divisione del lavoro cognitivo, potrebbe tentare alcune persone comuni a basare le proprie credenze su questioni scientifiche sulle loro proprie valutazioni delle evidenze scientifiche più che sull’autorità degli esperti».[3] Occorre, cioè, spiegare alle persone che devono credere agli esperti a scatola chiusa, e diffidare delle proprie pericolosissime capacità di pensiero critico.
Sulla stessa linea, solo portate più esplicitamente alle loro conseguenze, le posizioni, riprese in un noto articolo del “New York Times”, di Micheal Caulfield, un esperto di Digital Literacy.[4] Il modo in cui ci è stato insegnato a usare il pensiero critico – consultando, comparando, soppesando diverse fonti informative per approfondire un tema, risalendo alle fonti primarie, senza fermarci alla prima apparenza – sarebbe, sostiene l’accademico, essenzialmente sbagliato e del tutto inadatto di fronte al caos informativo prodotto da Internet. Perché tentare di ragionare con la propria testa può rivelarsi pericoloso e controproducente. Inoltre, la nostra attenzione è una merce rara, che dobbiamo imparare a spendere saggiamente. Quindi, siccome sarebbe lungo e faticoso costruirsi una propria opinione su questioni controverse – e si sa, il tempo è denaro – meglio evitare di fare ricorso a fonti primarie e soprattutto evitare come la peste il pericolo di prestare ascolto a più campane. Meglio limitarsi a una ricerca di 15 secondi (riporto letteralmente) che si riduce al googlare un nome o una parola chiave: se – senza leggere, bene inteso, lo studioso ci intima di limitarci allo scrolling – da questa edificante attività si ricava una maggioranza di titoli che asseriscono che quella persona o teoria non è credibile, ci si deve fermare qui. Il metodo ha anche un nome, SIFT.[5] E si basa sulla premessa del tutto oggettiva secondo cui l’informazione più credibile è quella che troviamo in cima alla pagina della ricerca su Google (…). L’unità didattica che serve a insegnarlo – di sei ore, che effettivamente dovrebbero essere più che sufficienti – è stata adottata da decine di università negli Stati Uniti e in alcune scuole superiori canadesi. L’orgoglio del metodo è che il fact-checking basato su SIFT deve portare a esprimere un giudizio sulla veridicità o meno di una teoria, o sull’attendibilità di un personaggio pubblico, in 30, 60 o 90 secondi. Rivelatori anche i presupposti psicologici su cui si basa: i diffusori di conspiracy theories avrebbero successo perché cercano di lusingare le capacità intellettive delle persone comuni trattandole come adulti che potrebbero – non a caso si parla di informational hybris – (ambire a) capire ciò di cui si parla e ragionare con la propria testa: manco fossero esseri senzienti. Ma no, non ce la puoi fare, se conservi qualche autonomia critica inevitabilmente cadi nella rabbit hole. Per contrastare quell’attraente ma fallace lusinga, allora il metodo SIFT cerca a sua volta di adularti, ma lo fa ricordandoti che il tuo tempo e la tua attenzione sono preziosi: dicendoti insomma che, anche se sei tonto e meriti di essere trattato come un bambino (o meglio come nessun bambino andrebbe trattato), ciononostante “Tu vali”. Ti rimette, insomma, al tuo posto, nell’unico ruolo che puoi legittimamente reclamare: quello di consumatore. E alla fine del corso, tra gli apprezzabili “risultati di apprendimento”, si nota che nelle discussioni è meno probabile che gli studenti ricorrano a ragionamenti motivati. Che sollievo, eh?
NOTE
[1] È un tema che abbiamo affrontato in modo articolato e critico in Lello e Raffini (2023)
[2] Un’ipotesi interessante che può rispondere a questo (apparente) paradosso, radicalmente alternativa rispetto alle letture focalizzate sulla post-verità, è quella della democratizzazione del boundary work, sviluppata da Harambam e Aupers (2015), secondo cui alla radice della crescente critica popolare verso il sapere esperto e scientifico non ci sarebbe tanto l’ignoranza quanto il fatto che, proprio per via delle maggiori possibilità di accesso alla conoscenza scientifica, i conflitti anche radicali intorno a questioni epistemologiche e metodologiche escano dalla torre d’avorio delle professioni deputate alla produzione di conoscenza e trovino una via per essere dibattuti e combattuti anche tra i non-specialisti, in contesti della vita quotidiana. Ne abbiamo parlato in modo più analitico in Lello e Raffini (2023).
[3] Keren (2018), citato in Bordignon (2023), traduzione e corsivi miei.6 Charlie Warzel, Don’t go down the rabbit hole, “New York Times”, 18 febbraio 2021, <https://www.nytimes.com>.
[4] Charlie Warzel, Don’t go down the rabbit hole, “New York Times”, 18 febbraio 2021, <https://www.nytimes.com>.
[5] Acronimo dei 4 principi/fasi del metodo: 1) Stop. 2) Investigate the source. 3) Find better coverage. 4) Trace claims
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Anonimo (2022), Manifeste conspirationniste, Parigi, Seuil.
Attwell K., Smith D.T. (2017), Parenting as politics: social identity theory and vaccine hesitant communities, “International Journal of Health Governance”, 22(3): 183-98.
Bazzoli, N., Lello, E. (2022), The neo-populist surge in Italy between territorial and traditional cleavages, “Rural Sociology”, 87(1): 662-691.
Bordignon, F. (2023), Alternative science, alternative experts, alternative politics. The roots of pseudoscientific beliefs in Western Europe, “Journal of Contemporary European Studies”, 31(4): 1469-1488.
Bucchi, M., Neresini, F. (2002), Biotech remains unloved by the more informed, “Nature”, 416: 261.
Chalmers J. (2017), The transformation of academic knowledges: understanding the relationship between decolonizing and indigenous research methodologies, “Socialist Studies”, 12(1): 97-116.
Coniglione, F., eds. (2010), Through the mirrors of science. New challenges for knowledge-based societies, Heusenstamm, Ontos Verlag.
Consigliere, S. (2020), Favole del reincanto: molteplicità, immaginario, rivoluzione, Roma, DeriveApprodi.
de Sousa Santos, B., Nunes, J. A., Meneses, M.P. (2022), Opening up the canon of knowledge and recognizing difference, “Participations”, 32(1): 51-91.
Dentico, N., Missoni, E. (2021), Geopolitica della salute: Covid-19, OMS e la sfida pandemica, Soveria Mannelli, Rubbettino.
Dotson, T. (2021). The divide: how fanatical certitude is destroying democracy, Cambridge, MIT Press.
Foucart, S., Horel, S., Laurens, S. (2020), Les gardiens de la raison: enquête sur la désinformation scientifique, Parigi, La Découverte.
Gigerenzer, G. (2015), Imparare a rischiare: come prendere decisioni giuste, Milano, Cortina.
Goldenberg, M. (2016), Public misunderstanding of science? Reframing the problem of vaccine hesitancy, “Perspectives on Science”, 24(5): 552-81.
Goldenberg, M.J. (2021), Vaccine hesitancy: public trust, expertise, and the war on science, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.
Grignolio, A. (2016), Chi ha paura dei vaccini?, Torino, Codice.
Harambam, J. (2021), Against modernist illusions: why we need more democratic and constructivist alternatives to debunking conspiracy theories, “Journal for Cultural Research”, 25(1): 104-122.
Harambam, J., Aupers, S. (2015), Contesting epistemic authority: conspiracy theories on the boundaries of science, “Public Understanding of Science”, 24(4): 466-480.
Jasanoff, S. (2021), Knowledge for a just climate, “Climatic Change”, 169(3): 1-8.
Kahneman, D. (2012), Pensieri lenti e veloci, Milano, Mondadori.
Keren, A. (2018), The public understanding of what? Laypersons’ epistemic needs, the division of cognitive labor, and the demarcation of science, “Philosophy of Science”, 85(5): 781-792.
Lello, E. (2020), Populismo anti-scientifico o nodi irrisolti della biomedicina? Prospettive a confronto intorno al movimento free vax, “Rassegna Italiana di Sociologia”, 3: 479-507.
Lello, E., Raffini, L. (2023), Science, pseudo-science, and populism in the context of post-truth. The deep roots of an emerging dimension of political conflict, “Rassegna Italiana di Sociologia”, 4: 705-732.
Lello, E., Saltelli, A. (2022), Lobbismo scientifico e dirottamento dello spazio pubblico, in E. Lello, N. Bertuzzi (eds.), Dissenso informato. Pandemia: il dibattito mancato e le alternative possibili, Roma, Castelvecchi, 187-203.
Lolli, A. (2023), Il complottismo non esiste o Miseria dell’anticomplottismo, in M.A. Polesana, E. Risi (eds.), (S)comunicazioni e pandemia. Ricategorizzazioni e contrapposizioni di un’emergenza infinita, Milano-Udine, Mimesis, 239-271.
Nunes, J. A., Louvison, M. (2020), Epistemologies of the South and decolonization of health: for an ecology of care in collective health, “Saude e Sociedade”, 29(3): e200563.
Osimani, B., Ilardo, M.L. (2022), “Nessuna correlazione”. Gli strumenti per la valutazione del nesso causale tra vaccinazione ed evento avverso, in E. Lello, N. Bertuzzi (eds.), Dissenso Informato. Pandemia: il dibattito mancato e le alternative possibili, Roma, Castelvecchi, 167-186.
Pielke, R.A.J. (2005), Scienza e politica, Roma-Bari, Laterza.
Quijano, A. (2005), Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina, in A colonialidade do saber: etnocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas, Buenos Aires, Clacso, 117-142.
Reich, J.A. (2014), Neoliberal mothering and vaccine refusal: imagined gated communities and the privilege of choice, in “Gender and Society”, 28(5): 679-704.
Sarewitz, D. (1996), Frontiers of illusion: science, technology, and the politics of progress, Philadelphia, Temple University Press.
Saurette, P., Gunster S. (2011), Ears wide shut: epistemological populism, argutainment and Canadian conservative talk radio, “Canadian Journal of Political Science”, 44(1): 195-218.
Schadee, H.M.A., Segatti, P., Vezzoni C. (2019), L’apocalisse della democrazia italiana: alle origini di due terremoti elettorali, Bologna, Il Mulino.
Smith, P.J., Chu, S.Y., Barker, L.E. (2004), Children who have received no vaccines: who are they and where do they live?, “Pediatrics”, 114(1): 187-95.
Steinberg, T. (2006), Acts of God: the unnatural history of natural disaster in America, Oxford, Oxford University Press.
Taussig, M.T. (1986), Shamanism, colonialism, and the wild man: a study in terror and healing, Chicago, University of Chicago Press.
Wei, F., Mullooly, J.P., Goodman, M., McCarty, M.C., Hanson, A.M., Crane, B., Nordin, J.D. (2009), Identification and characteristics of vaccine refusers, “BMC Pediatrics”, 9(18): 1-9.
Wu Ming 1 (2021), La Q di Qomplotto. QAnon e dintorni. Come le fantasie di complotto difendono il sistema, Roma, Alegre.
Ylä-Anttila, T. (2018), Populist knowledge: post-truth repertoires contesting epistemic authorities, “European Journal of Cultural and Political Sociology”, 5(4): 356-388.
Zagzebski, L.T. (2012), Epistemic authority: a theory of trust, authority, and autonomy in belief, Oxford, Oxford University Press.
Zografos, C., Robbins, P. (2020), Green sacrifice zones, or why a green new deal cannot ignore the cost shifts of just transitions, “One Earth”, 3(5): 543-546.
Le teorie del complotto, prima parte - Tra populismo, scientizzazione della politica e disincanto del mondo
Quella che segue è la prima di cinque puntate di un testo sul complottismo, indagato al crocevia tra populismo, scientizzazione della politica e disincanto del mondo. Il testo originale è stato pubblicato come prefazione al volume di Matthieu Amiech, "L'industria del complottismo. Social network, menzogne di stato e distruzione del vivente" (Edizioni Malamente, 2024). Elisa Lello
--------
Scrivo queste pagine durante un soggiorno a Coimbra come pesquisadora (ricercatrice) visitante presso un Centro universitario che deve molto del suo prestigio a una importante tradizione di studi che ha avuto il merito di fare luce sul ruolo cruciale della dimensione epistemologica nei rapporti di dominio. In particolare, nel mettere sotto esame critico il ruolo che la scienza occidentale ha avuto nel legittimare e implementare le forme della dominazione coloniale storica – e che continua a esercitare attraverso la colonialità (Quijano 2005) – alla luce del fatto che il modo in cui vediamo e descriviamo il mondo determina anche i modi in cui pensiamo sia possibile, o non possibile, agire su di esso per trasformarlo. Una tradizione che si è dunque concentrata sull’epistemologia come strumento di potere, che spoglia la scienza della sua pretesa neutralità mostrando come questa risponda ai rapporti di forza in campo e questi contribuisca a consolidare, marginalizzando, invisibilizzando o ridicolizzando modi altri di stare al mondo, di conoscerlo e rappresentarlo (Chalmers 2017; Nunes e Louvison 2020; Santos et al. 2022).
Eppure, anche in un contesto come questo, quando mi capita di raccontare a colleghe/i i temi intorno cui gravitano i miei studi durante questi ultimi anni – essenzialmente: movimenti sociali e tecnoscienze, i rapporti tra politica e scienza, tra critica sociale e complottismo, tra epistemologia e populismo – quasi sempre mi imbatto in reazioni a cui sono fin troppo abituata. Dopo sorrisi e attestazioni di quanto tutto questo sia interessante, quella che mi si cerca (senza successo) di proporre è una complicità fondata sull’indignazione, e sullo scherno, a partire da qualche aneddoto che invariabilmente vorrebbe dimostrare quanto ci sia gente, là fuori – e, ça va sans dire, soprattutto tra chi ha orientamenti conservatori – così irrimediabilmente ignorante e anti-scientifica che ha completamente perso il lume della ragione, che crede in teorie strampalate, risibili e complottiste, e come è possibile che costoro abbiano diritto di parola e, quel che è peggio, pure di voto.
La mia perplessità, ma a volte è quasi scoramento, nasce non solo dal constatare la mancanza di qualunque cautela nel trattare del rapporto tra scienza, “ignoranza” e politica – ancor di più qui, appunto. Ma anche dal vedere come si tratti quasi sempre di ricercatrici/tori che si autodefiniscono militanti, di sinistra, che rivendicano un’attenzione estrema all’inclusività nelle pratiche e nel linguaggio quando si parla di identità di genere, orientamenti sessuali o body-shaming, eppure tutta questa inclusività, sensibilità e attenzione letteralmente svaniscono quando si è di fronte a opinioni non del tutto allineate, per esempio, sulla crisi eco-climatica o, a maggior ragione, quando si tratta di scelte sanitarie. Non solo svaniscono: peggio, troppo spesso si trasformano in un disprezzo profondo, antropologico, che apre la porta a battute feroci, che rivolte ad altre categorie desterebbero, giustamente, scandalo e reazioni ben sicure di sé. Il tutto senza poi indugiare troppo sulla eterogeneità delle critiche né sulle ragioni che vengono mosse, appunto, dai non allineati; senza interrogarsi sulla complessità delle questioni che pongono e che tutti ci dovremmo porre. Ci si accontenta invece, troppo spesso, di alzare steccati identitari per frapporre una distanza netta tra sé e gli “altri”: anti-vax, antiscientifici, trumpiani, complottisti, negazionisti, terrapiattisti. Un po’ tutti in odore di estrema destra e fascismo.
Sollevando, con ciò, contraddizioni che gridano giustizia, ma che raramente vengono affrontate. Per iniziare col piede giusto, prendiamo la sineddoche per eccellenza del vasto panorama del complottismo: gli odiatissimi “anti-vax”, categoria che finisce per catalizzare indignazioni, ironie e disprezzo, nonché solitamente inclusiva di chiunque per qualunque ragione abbia dubbi sulle politiche pandemiche. Bene, l’avere (più di) qualcosa da ridire sul fatto che le linee politiche essenziali che hanno guidato la gestione globale del Covid-19 siano state scritte da CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness) – Fondazione B. & M. Gates, DARPA (NATO) e Wellcome Trust – è una posizione in perfetta continuità con ciò che denunciava il “movimento dei movimenti” tra Seattle e Genova al volgere del millennio e con ciò che qualunque movimento di sinistra variamente intesa dovrebbe ancora combattere oggi: com’è possibile che questa posizione non solo non sia più (percepita come) coerente con ideali di sinistra ed emancipativi, ma sia addirittura diventata patologica e pure fascista?
Poi, però, in questi stessi ambienti accademici (come in molti della militanza di sinistra) ci si straccia le vesti di fronte all’“onda nera” che travolge Europa e Stati Uniti, spesso, ancora una volta, con studi che, se finalmente prendono in considerazione il ruolo delle “emozioni”, il più delle volte lo fanno per dare una spiegazione tendenzialmente psico-patologica del voto a destra, che lascia a intendere quanto sia invece “razionale” quello progressista.
Sono convinta che ci sia un nodo da affrontare, qui. E che questo nodo abbia a che fare con ciò che impedisce un dialogo tra sinistra e classi popolari, dove la prima non fa nulla per dissimulare il suo disprezzo verso i valori e i modi di vita delle seconde proprio mentre si dispera perché queste non le tributano più i loro consensi e preferiscono cercare e inseguire altre narrative.
Ma è un nodo che riguarda anche l’accademia. La quale, muovendosi lungo percorsi in fondo molto simili, denuncia con tanta veemenza quanta superficialità i pericoli delle fake news e del complottismo, malattie che ovviamente contagerebbero di preferenza il “popolino”, e nel contempo si allarma di fronte alla perdita di credibilità delle “autorità epistemiche consolidate”, cioè università e istituzioni scientifiche, agli occhi (di parti rilevanti) del popolo stesso. Tendendo però a liquidare ogni problema, come vedremo, attraverso le interpretazioni auto-assolutorie del populismo, politico ed epistemologico, e della post-verità.
Per questi motivi credo sia importante affrontare in modo serio, finalmente, un tema come quello del complottismo, di ciò che lo produce, delle dinamiche storiche in cui si inserisce, e di ciò che esso stesso alimenta. E, in questo senso, il libro di Matthieu Amiech, come cercherò di evidenziare nelle prossime pagine, fornisce parecchi elementi preziosi, illuminanti. Quello che invece farò io, in queste pagine, sarà provare a introdurre il tema partendo dall’individuare aporie e contraddizioni nelle sue interpretazioni oggi largamente prevalenti (da parte del giornalismo, ma anche della sinistra e del sapere accademico), per poi contestualizzarlo all’interno del più ampio problema del rapporto tra scienza e politica, rintracciandone alcune connessioni con la scientizzazione della politica e con il disincanto del mondo.
In questo percorso, seguirò principalmente il filo argomentativo del libro; cercherò però anche di intessere un dialogo tra questo e alcune ricerche e pubblicazioni che ho portato avanti negli ultimi anni, con amici/he e colleghi/e, su temi affini o contigui; e con varie altre letture recenti. Tra queste, in particolare, si potranno riconoscere le impronte significative del Manifeste conspirationniste (Seuil 2022), di The divide: how fanatical certitude is destroying democracy (di Taylor Dotson, MIT Press 2021) e di Favole del reincanto: molteplicità, immaginario, rivoluzione (di Stefania Consigliere, Derive Approdi 2020).
INIZIAMO A SFATARE QUALCHE LUOGO COMUNE
Cosa c’è dunque che non va in quelle reazioni così frequenti e automatiche? Cosa non funziona in quelle diagnosi che in modo così lineare, e semplice, individuano quasi tutti i problemi dell’oggi nell’ignoranza e nell’“analfabetismo funzionale” che rende il popolo (o comunque sempre “gli altri”) facile preda di fake news e complottismo?
Proviamo a sollevare qualche velo. Un primo problema è dato dal focalizzarsi su una fotografia istantanea senza tenere in considerazione come siamo arrivati a questo punto. Quando invece occorrerebbe partire dalla presa di consapevolezza, suggerita da Frédérique Lordon e ripresa da M. Amiech, della colpevole confisca del dibattito pubblico che ha sistematicamente privato la cittadinanza della possibilità e dei mezzi per capire le forze storiche che la dominano e per partecipare ai processi decisionali che disegnano gli scenari in cui dovrà vivere. Il complottismo, in questa prospettiva, appare piuttosto come sintomo di un’espropriazione, e come rifiuto, al tempo stesso e nonostante tutto, ad abdicare alla volontà di capire, di darsi una spiegazione.
Ci imbattiamo, continuando a sollevare qualche velo, nell’inadeguatezza e nella parzialità dell’informazione offerta dalle testate del mainstream, che in maniera crescente e accelerata negli ultimi anni si è intrecciata con dinamiche di militarizzazione del confronto, conformismo, censura e autocensura, dove su troppi temi i punti di vista dissonanti vengono immediatamente respinti come fake news, in un dibattito chiuso prima ancora di averlo aperto. Il complottismo, dunque – o meglio, l’etichettamento di posizioni critiche come complottiste – usato come arma politica per screditare il dissenso. Ma questa stigmatizzazione di posizioni minoritarie non si limita al piano verbale: come nel caso dei vaccini (per ora), ha legittimato soluzioni autoritarie nel segno dell’esclusione, della privazione di diritti essenziali, della separazione della cittadinanza tra meritevoli e non, sulla base dell’adesione e dell’obbedienza. È chiaro, e pure un’abbondante letteratura scientifica lo dimostra, che questo tipo di scelte – sia comunicative che politiche e legislative – determina un effetto boomerang (Attwell e Smith 2017; Goldenberg 2021), provocando la rottura della sfera pubblica come luogo di confronto di habermasiana memoria e, quindi, radicalizzazione delle posizioni (da entrambe le parti però, anche se si tende a dimenticarlo). Ma, tra chi viene escluso, si tratta di molto di più: di un senso di crescente estraniazione dal sistema di valori dominante e dalle sue categorie di lettura della realtà, di vissuti di lacerazione profonda e sofferta di legami e appartenenze, di «continenti percettivi che si allontanano, di forme di vita che diventano inconciliabili» (Manifeste, p. 31). Da qui occorre partire per capire come mai, a volte, si possa anche passare da una salutare diffidenza verso le narrazioni del potere alla convinzione, più problematica, che “tutto ciò che ci è stato insegnato è falso”.
Se solleviamo un altro velo, ci imbattiamo questa volta nella superficialità che conduce a un classismo evidentemente ignaro di sé. Quando parliamo di persone, e magari studiose/i, di sinistra, colpisce lo sbrigativo appiattimento sulle categorie ipersemplificanti e stigmatizzanti introdotte dal giornalismo mainstream (anti-vax, complottista e tutte le altre richiamate sopra). Soprattutto perché sono diversi gli studi che hanno invitato a uno sguardo più attento e cauto quando si parla di “complottismo”. Sottolineando, innanzitutto, come questo tenda a proliferare dove lo scostamento tra la realtà esperita dalle persone e la sua rappresentazione da parte di media e istituzioni supera una soglia critica. Il complottismo – o quello che molti definiscono con questa categoria, comunque problematica – prospera, insomma, sulle bugie delle élite. E ancor prima, sul non detto: prospera, cioè, laddove questioni che hanno un peso cruciale sulle nostre vite non diventano oggetto di un dibattito pubblico, aperto e capace di dare cittadinanza e legittimità ai diversi punti di vista.[1] Che è come dire, rovesciando la prospettiva, che sempre più spesso i presunti “complottisti” sono (lasciati) i soli a trattare, con mezzi e risorse eterogenei, questioni assolutamente vitali: dalle tecnologie 5(6)G all’impatto della più generale digitalizzazione della società, dal transumanesimo alle politiche sanitarie emergenziali.
E poi, soprattutto: chi decide quali teorie sono complottiste? Cosa distingue una teoria sociale critica da una conspiracy theory? Puntando l’attenzione sulle traiettorie seguite delle teorie sociali, Pelkmans e Machold (2011) mostrano come siano quelle promosse e sostenute dalle classi subalterne quelle che, con maggiore probabilità, finiranno per essere etichettate come complottiste. Non è insomma questione di fondatezza o razionalità, poiché non è agevole né forse possibile individuare criteri di distinzione su un mero piano epistemologico. Alla fine, la differenza la fanno i rapporti di potere. Tanto che una teoria del complotto, se sostenuta da attori in posizioni di potere, difficilmente sarà riconosciuta e ricordata come tale, anche qualora ne venga chiaramente dimostrata l’infondatezza, la strumentalità, talvolta la portata nefasta dei risultati (classico l’esempio delle “armi di distruzione di massa” suppostamente detenute da Saddam Hussein).
Del resto, a proposito di classismo, non ha destato le reazioni che avrebbe meritato la presa fortissima che ha recentemente acquisito, sugli scambi comunicativi di tutti i giorni, l’idea per cui solo chi ha un titolo di studio specifico sia titolato a parlare. Frutto avvelenato (uno dei tanti) del burionismo. Eppure, una tale idea è stata accolta e fatta propria, anche, o forse soprattutto, a sinistra. Senza la minima preoccupazione di quanto ciò significasse legittimare il silenziamento di quanti non hanno un titolo di studio elevato, il che poi sottende evidenti implicazioni di classe e giustizia sociale; né di quanto, in questo modo, si alimenti acriticamente la logica pericolosa per cui tanto si riserva il potere di decidere agli “esperti”, quanto inevitabilmente si spinge verso la depoliticizzazione delle questioni, restringendo lo spazio del dissenso e del confronto (ci tornerò più avanti).
Ma continuiamo a scavare. Siamo sicuri che sia (solo) il complottismo il problema? Non sarebbe urgente problematizzare anche, o forse soprattutto, quello che alcuni hanno battezzato il “dispositivo anti-complottista” e le sue implicazioni politiche?[2] Un’operazione, questa, che svolge il Manifeste conspirationniste, mostrando le vicende storiche che legano strettamente le origini della retorica anti-complottista – quindi fin da Karl Popper – con la genesi del neoliberalismo e del suo There Is No Alternative. Se tentare di produrre una intelligibilità storica del corso degli eventi è una presunzione fatale; se chiunque tenti di dire qualcosa su questo mondo che questo non dica già da sé oltrepassa i suoi diritti epistemologici: allora, non resta che adattarvisi. La funzione del dispositivo anti-complottista è fin dalle sue origini, questa la tesi degli autori, quella di legittimare l’ordine sociale esistente, ambendo a riservare per sé la facoltà di cospirare.
NOTE
[1] Cfr. Pelkmans e Machold (2011), Lagalisse (2020); sul tema del prosperare del complottismo sulle bugie dei potenti si può vedere anche la mia intervista a Erica Lagalisse, Teorie della cospirazione e critica sociale. Come il complottismo prospera, non sempre a torto, sulle bugie delle élite, “Malamente”, n. 20, gennaio 2021, p. 47-62, <https://rivista.edizionimalamente.it>.
[2] In Italia se ne è occupato per es. Lolli (2023)
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Anonimo (2022), Manifeste conspirationniste, Parigi, Seuil.
Attwell K., Smith D.T. (2017), Parenting as politics: social identity theory and vaccine hesitant communities, “International Journal of Health Governance”, 22(3): 183-98.
Bazzoli, N., Lello, E. (2022), The neo-populist surge in Italy between territorial and traditional cleavages, “Rural Sociology”, 87(1): 662-691.
Bordignon, F. (2023), Alternative science, alternative experts, alternative politics. The roots of pseudoscientific beliefs in Western Europe, “Journal of Contemporary European Studies”, 31(4): 1469-1488.
Bucchi, M., Neresini, F. (2002), Biotech remains unloved by the more informed, “Nature”, 416: 261.
Chalmers J. (2017), The transformation of academic knowledges: understanding the relationship between decolonizing and indigenous research methodologies, “Socialist Studies”, 12(1): 97-116.
Coniglione, F., eds. (2010), Through the mirrors of science. New challenges for knowledge-based societies, Heusenstamm, Ontos Verlag.
Consigliere, S. (2020), Favole del reincanto: molteplicità, immaginario, rivoluzione, Roma, DeriveApprodi.
de Sousa Santos, B., Nunes, J. A., Meneses, M.P. (2022), Opening up the canon of knowledge and recognizing difference, “Participations”, 32(1): 51-91.
Dentico, N., Missoni, E. (2021), Geopolitica della salute: Covid-19, OMS e la sfida pandemica, Soveria Mannelli, Rubbettino.
Dotson, T. (2021). The divide: how fanatical certitude is destroying democracy, Cambridge, MIT Press.
Foucart, S., Horel, S., Laurens, S. (2020), Les gardiens de la raison: enquête sur la désinformation scientifique, Parigi, La Découverte.
Gigerenzer, G. (2015), Imparare a rischiare: come prendere decisioni giuste, Milano, Cortina.
Goldenberg, M. (2016), Public misunderstanding of science? Reframing the problem of vaccine hesitancy, “Perspectives on Science”, 24(5): 552-81.
Goldenberg, M.J. (2021), Vaccine hesitancy: public trust, expertise, and the war on science, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.
Grignolio, A. (2016), Chi ha paura dei vaccini?, Torino, Codice.
Harambam, J. (2021), Against modernist illusions: why we need more democratic and constructivist alternatives to debunking conspiracy theories, “Journal for Cultural Research”, 25(1): 104-122.
Harambam, J., Aupers, S. (2015), Contesting epistemic authority: conspiracy theories on the boundaries of science, “Public Understanding of Science”, 24(4): 466-480.
Jasanoff, S. (2021), Knowledge for a just climate, “Climatic Change”, 169(3): 1-8.
Kahneman, D. (2012), Pensieri lenti e veloci, Milano, Mondadori.
Keren, A. (2018), The public understanding of what? Laypersons’ epistemic needs, the division of cognitive labor, and the demarcation of science, “Philosophy of Science”, 85(5): 781-792.
Lello, E. (2020), Populismo anti-scientifico o nodi irrisolti della biomedicina? Prospettive a confronto intorno al movimento free vax, “Rassegna Italiana di Sociologia”, 3: 479-507.
Lello, E., Raffini, L. (2023), Science, pseudo-science, and populism in the context of post-truth. The deep roots of an emerging dimension of political conflict, “Rassegna Italiana di Sociologia”, 4: 705-732.
Lello, E., Saltelli, A. (2022), Lobbismo scientifico e dirottamento dello spazio pubblico, in E. Lello, N. Bertuzzi (eds.), Dissenso informato. Pandemia: il dibattito mancato e le alternative possibili, Roma, Castelvecchi, 187-203.
Lolli, A. (2023), Il complottismo non esiste o Miseria dell’anticomplottismo, in M.A. Polesana, E. Risi (eds.), (S)comunicazioni e pandemia. Ricategorizzazioni e contrapposizioni di un’emergenza infinita, Milano-Udine, Mimesis, 239-271.
Nunes, J. A., Louvison, M. (2020), Epistemologies of the South and decolonization of health: for an ecology of care in collective health, “Saude e Sociedade”, 29(3): e200563.
Osimani, B., Ilardo, M.L. (2022), “Nessuna correlazione”. Gli strumenti per la valutazione del nesso causale tra vaccinazione ed evento avverso, in E. Lello, N. Bertuzzi (eds.), Dissenso Informato. Pandemia: il dibattito mancato e le alternative possibili, Roma, Castelvecchi, 167-186.
Pielke, R.A.J. (2005), Scienza e politica, Roma-Bari, Laterza.
Quijano, A. (2005), Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina, in A colonialidade do saber: etnocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas, Buenos Aires, Clacso, 117-142.
Reich, J.A. (2014), Neoliberal mothering and vaccine refusal: imagined gated communities and the privilege of choice, in “Gender and Society”, 28(5): 679-704.
Sarewitz, D. (1996), Frontiers of illusion: science, technology, and the politics of progress, Philadelphia, Temple University Press.
Saurette, P., Gunster S. (2011), Ears wide shut: epistemological populism, argutainment and Canadian conservative talk radio, “Canadian Journal of Political Science”, 44(1): 195-218.
Schadee, H.M.A., Segatti, P., Vezzoni C. (2019), L’apocalisse della democrazia italiana: alle origini di due terremoti elettorali, Bologna, Il Mulino.
Smith, P.J., Chu, S.Y., Barker, L.E. (2004), Children who have received no vaccines: who are they and where do they live?, “Pediatrics”, 114(1): 187-95.
Steinberg, T. (2006), Acts of God: the unnatural history of natural disaster in America, Oxford, Oxford University Press.
Taussig, M.T. (1986), Shamanism, colonialism, and the wild man: a study in terror and healing, Chicago, University of Chicago Press.
Wei, F., Mullooly, J.P., Goodman, M., McCarty, M.C., Hanson, A.M., Crane, B., Nordin, J.D. (2009), Identification and characteristics of vaccine refusers, “BMC Pediatrics”, 9(18): 1-9.
Wu Ming 1 (2021), La Q di Qomplotto. QAnon e dintorni. Come le fantasie di complotto difendono il sistema, Roma, Alegre.
Ylä-Anttila, T. (2018), Populist knowledge: post-truth repertoires contesting epistemic authorities, “European Journal of Cultural and Political Sociology”, 5(4): 356-388.
Zagzebski, L.T. (2012), Epistemic authority: a theory of trust, authority, and autonomy in belief, Oxford, Oxford University Press.
Zografos, C., Robbins, P. (2020), Green sacrifice zones, or why a green new deal cannot ignore the cost shifts of just transitions, “One Earth”, 3(5): 543-546.
La valutazione oggettiva non esiste - È sempre guidata da una teoria (soggettiva) sottostante…
Si sente spesso pronunciare l’espressione “valutazione oggettiva”. Essa viene commissionata e richiesta a studiose, consulenti e valutatrici. In realtà tale espressione è un ossimoro. Perché la valutazione è sempre soggettiva. Forse, il vero pericolo è che diventi soltanto arbitraria. Ma a questo ci sono rimedi.
Le esperte e studiose serie di valutazione (non le praticone) lo sanno bene. E da molto tempo, ormai.
Cito solo tre approcci di importanti autori e autrici, che fin dagli anni ’80 hanno tematizzato questo aspetto, in polemica con la valutazione di impianto positivista e sperimentale:
- la valutazione realistica (Realistic Evaluation) di Ray Pawson e Nick Tilley
- la valutazione guidata dalla teoria (Theory-Driven Evaluation) di Chen e Rossi
- la valutazione basata sulla teoria (Theory Based Evaluation) di Carol Weiss
Il tratto comune a questi tre approcci è mostrare (e teorizzare) come la valutazione sia sempre guidata da una teoria sottostante, e quindi basata sia su assunti epistemologici ma anche di conoscenze di senso comune.
Vediamo un esempio illuminante che ci proviene dall’economia
Il valore di una professione
La New economics foundation (Nef) è un istituto di ricerca, consulenza e idee innovative (think tank) composto da una cinquantina di economiste, famose per aver portato nell'agenda del G7 e G8 (a fine anni duemila) temi quali il debito internazionale.
Nel 2009 si proposero di condurre una ricerca sul valore delle professioni, che adottasse però una prospettiva diversa (da quelle tradizionali). Tale prospettiva aveva lo scopo di “collegare gli stipendi al contributo di benessere che un lavoro porta alla comunità".
Come spiegarono nella stessa introduzione della ricerca, "abbiamo scelto un nuovo approccio per valutare il reale valore del lavoro. Siamo andati oltre la considerazione di quanto una professione viene valutata economicamente e abbiamo verificato quanto chi la esercita contribuisce al benessere della società. I principi di valutazione ai quali ci siamo ispirati quantificano il valore sociale, ambientale ed economico del lavoro svolto dalle diverse figure".
--------
In altre parole, se si modificano i criteri teorici, culturali, ideologici (ma questa è una scelta, una decisione, un atto soggettivo), avremmo risultati di ricerca molto diversi.
Il Nef calcolò così il valore economico di sei diversi lavori, tre pagati molto bene e tre molto poco, introducendo nuovi criteri e abbandonando i vecchi (soggettivi anche loro, ovviamente).
Il risultato fu sorprendente e rovesciava le gerarchie tradizionali.
Ad esempio, comparando un operatore ecologico e un fiscalista, il Nef concludeva che il primo contribuisce con il suo lavoro alla salute dell'ambiente grazie al riciclo delle immondizie, mentre il secondo danneggia la società perché studia in che modo far versare ai contribuenti meno tasse. Quindi il primo dovrebbe essere pagato molto di più e il secondo molto di meno (per usare un eufemismo).
Lo stesso vale, dicono al Nef, per i banchieri che prosciugano la società e causano danni all'economia globale.
In generale, esaminando “il contributo sociale del loro valore, abbiamo scoperto che i lavori pagati meno sono quelli più utili al benessere collettivo".

Conclusione che certamente approverebbero i due uomini in giallo, ma anche Wim Wenders, visto che con il suo ultimo film Perfect Days (2023) fa un biopic di un addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Shibuya (uno dei 23 quartieri speciali di Tokyo), quasi un eroe dei nostri tempi.
Le economiste del Nef sono molto chiare: “il nostro studio vuole sottolineare un punto fondamentale e cioè che dovrebbe esserci una corrispondenza diretta tra quanto siamo pagati e il valore che il nostro lavoro genera per la società. Abbiamo trovato un modo per calcolarlo e questo strumento dovrebbe essere usato per determinare i compensi".
Per cui, la valutazione è primariamente un problema teorico.
Solo secondariamente diventa un problema tecnico.
Proprio l’opposto di quello che molte scienziate ci dicono, e continueranno a (men)dire…
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Chen H. T. (1990), Theory driven Evaluation, Thousand Oaks: Sage.
Chen H. T. e Rossi P. H. (1981), The multi-goal, theory-driven approach to evaluation. A model linking basic and applied social science, in “Social Forces”, 59, pp. 106-22.
Pawson R. e Tilley N. (1997), Realistic evaluation, London: Sage.
Weiss C. H. (1995), Nothing as Practical as Good Theory: Exploring Theory-Based Evaluation for Comprehensive Community Initiatives for Children and Families, in Connell J. P., Kubisch A. C., Schorr L. B. e Weiss C. H. (a cura di), New Approaches to Evaluating Community Initiatives. Vol. 1 Concepts, Methods, and Contexts, The Aspen Institute, Washington (DC), pp. 65-92.
Weiss C. H. (1997a), How can Theory-Based Evaluation make greater headway? in “Evaluation Review”, 4, pp. 501-524.
Weiss C. H. (1997ab), Theory-based evaluation: past, present, and future, in “New Directions for Evaluation”, 76, pp. 41-55,
Weiss C. H. (1998), Evaluation. Methods for studying programs and policies, Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall, 1998.
Avanti verso il nulla - Sul futurismo nichilista contemporaneo (prima parte)
La nave
ha anche un motore
e avendo un motore
non sa dove va ma continua a andare
(Giorgio Gaber, La nave, 1974)
Cosa diremmo di una persona che, magari a causa di un trauma o di un lutto, vivesse concentrata sul passato e rifiutasse di vivere il presente e fosse del tutto chiusa alla dimensione del futuro? Certo, che non sta bene. Non si può vivere decentemente così. E di una che, specularmente, fosse proiettata esclusivamente verso il futuro e le future realizzazioni, incapace di vivere nel presente, e di tenere in conto a maggior ragione delle esperienze del passato? Anche in questo caso, diremmo che soffrirebbe, che non sarebbe in grado di godere della vita, la quale in fondo è fatta di una serie di momenti presenti. Se fossimo in un contesto di psicologia individuale potremmo parlare nel primo caso di un disagio dovuto a una forma di malinconia, nel secondo a una forma di euforia maniacale.
Spostandoci sul terreno del carattere sociale,[1] abbiamo da una parte un orientamento “passatista”, fissato cioè a un passato ritenuto in quanto tale preferibile e incline, dunque, al misoneismo (al rifiuto cioè di ogni novità), tipico delle società preindustriali; dall’altro un orientamento futuro-centrico, “futurista”, altrettanto nevroticamente fissato all’esaltazione del dileguare di ogni cosa in favore di un “nuovo” in quanto tale certamente migliore. Quest’ultimo è propriamente il carattere dell’epoca che viviamo in particolare nelle società più avanzate, segnate dal predominio dispotico di un potere che è insieme tecnico e capitalistico. Il dogma di oggi dice che «il futuro è il posto migliore»;[2] ed è di tale dogma, non meno contestabile per il fatto di essere… moderno, che si parlerà in questo articolo.
Il documento da cui propongo di prendere le mosse è la fulminante dichiarazione dell’ingegnere informatico Yann LeCun, capo del team di Meta (il nuovo nome di Facebook) che si occupa di intelligenza artificiale, nel corso di un’intervista rilasciata a un quotidiano italiano: «Mi affascina il futuro. Del presente mi interessa capire solo gli sbagli e come superarli».[3] Una frase che può essere considerata un “concentrato” di un più generale modo di rapportarsi alla temporalità che la società attuale suggerisce e impone ogni giorno nel suo «monologo elogiativo» permanente.[4] Il dirigente di Meta, che risponde in questo modo alle caute preoccupazioni espresse dall’intervistatore sulle prospettive dell’IA, com’è chiaro, non dichiara solo di essere affascinato dal futuro, ma di trascurare e disprezzare il presente (del passato naturalmente neppure parla), in quanto – sembra di capire – unicamente luogo di passaggio verso l’unica meta interessante, appunto il futuro. Ma c’è un problema: quella meta, una volta divenuta presente (ogni futuro di oggi è il presente di domani), ricadrà nello stesso disinteresse, in favore del futuro di domani. E in verità una meta non c’è neppure: c’è solo quella che potremmo chiamare una fuga senza fine verso il nulla, o «furia del dileguare» – per usare una espressione hegeliana[5] – per la quale ogni momento presente non vale che in quanto preparazione di un momento futuro, che sarà ovviamente migliore, e così via all’infinito.
Ha osservato il filosofo tedesco-coreano Byung-Chul Han, in un bel libro dedicato alla Scomparsa dei riti, che «oggi al tempo manca una struttura stabile. Non è una casa, bensì un flusso incostante: si riduce a una mera sequenza di presente episodico, precipita in avanti». (La scomparsa dei riti. Una topologia del presente, Milano, Nottetempo, 2021, p. 13).
Si procede, dunque, sempre “avanti” e sempre più rapidamente, in un fenomeno di accelerazione sociale che è oggetto di crescente attenzione da parte delle scienze sociali.[6] In questo illimitato e davvero scriteriato procedere, nessun valore, nessun obiettivo, nessuna condizione desiderabili debbono essere posti, perseguiti, mantenuti; l’unica cosa che conta e che deve esistere, l’unico punto di riferimento per il nostro agire, è il costante flusso delle merci, ma anche delle esperienze, delle tecniche, delle forme di vita:[7] una condizione, dunque, realmente nichilista.
È una dinamica che era stata a suo tempo già individuata da Marx, che pure non si era soffermato sugli esiti nichilistici qui indicati, quando aveva rilevato che «il movimento del capitale è senza misura» (Marx K., Il capitale, libro I, a cura di Delio Cantimori, Roma, Editori Riuniti, 1974, p. 185).
-------------
In questa modalità di rapporto con il tempo, che nasce nel quadro della modernità capitalistica e della sua complessiva rimodulazione dell’esperienza e della vita sociale, accade – secondo quanto sottolineato trent’anni fa da Giacomo Marramao – che «la prospettiva tende progressivamente a fagocitare l’esperienza» (Giacomo Marramao, Minima temporalia. Tempo spazio esperienza, Milano, Il Saggiatore, 1990, p. 108), potendosi parlare di vera e propria «propensione nichilista» (cit. p. 104) della modernità. Mi pare tuttavia evidente che è l’ultima fase della modernità, quella apertasi negli ultimi decenni, a rendere egemone e “totalitaria” tale propensione. E l’accelerazione dell’innovazione tecnologica in molti ambiti, in quello informatico in particolare, ha avuto in questo un ruolo determinante.
Ha osservato a questo proposito Gabriele Balbi, in un notevole recente pamphlet sulla ideologia digitale, che «il tempo storico ideale per la rivoluzione digitale è proprio il futuro, anche perché nel presente viene sempre raccontata come incompleta, come un processo in continua evoluzione, come una trasformazione che non ha né può avere una fine predefinita» (Balbi G., L’ultima ideologia. Breve storia della rivoluzione digitale, Roma-Bari, Laterza, 2022, p. 64-65). Non sorprende, allora, che un recentissimo saggio sulle prospettive dell’applicazione dell’intelligenza artificiale si dichiari in copertina – programmaticamente – una Apologia del futuro (De Biase L, Apologia del futuro. Quello che il domani può fare per noi, Roma, LUISS University Press, 2024).
Il tempo dell’era digitale, in effetti, è proprio un tempo della precarietà e dell’incompletezza, foriero inevitabilmente di ansia e di senso di inadeguatezza, forse proprio di quella «vergogna prometeica» indicata da Günther Anders come il portato principale e perturbante della nostra epoca di dominio della tecnica industriale (fa parte di essa non solo il sentirsi inferiori in potenza alle macchine, ma anche, insieme, il sentirsi troppo lenti rispetto alle velocità macchiniche).[8]
Non mancano del resto alcuni sintomi addirittura clamorosi di tale deriva, se pensiamo per esempio a certi esiti obiettivamente antiumanistici propri di quelle visioni della rivoluzione digitale che si dichiarano post- o transumaniste. Così per esempio Hans Moravec, uno dei profeti del transumanismo, poteva affermare già vent’anni fa, in relazione agli imminenti sviluppi delle nanotecnologie e dell’intelligenza artificiale, con un misto di fatalismo e di entusiasmo: «l’uomo biologico si troverebbe naturalmente spinto fuori dall’esistenza, poiché una specie sopravvive raramente a uno spazio ostile che presenta un grado di evoluzione superiore» (cit. in Paul Virilio, Ce qui arrive, Paris, Éditions Galilée, 2002, tr.it. Milano, Cortina, 2002, p. 19-20).
Al venir meno di ogni valore, di ogni capacità di identificare dei fini razionali nello sviluppo sociale, si accompagna come si vede, in non pochi casi, il rifiuto della umanità stessa. O meglio quella che – se si pensa a certo dibattito oggi molto in voga sull’IA – si potrebbe definire una voglia matta di dimissioni dall’umano.
-------------
In ogni caso, quel che qui mette conto sottolineare è che nella visione attuale dovremmo affidarci con sicurezza all’impersonale flusso delle cose, alle asserite leggi dello sviluppo tecno-scientifico, sicuri che esse siano apportatrici di beneficio generale. Una visione del mondo e della storia non solo falsa, dal momento che postula una natura neutrale e deterministica dello sviluppo tecnologico (come se esso non fosse attraversato dalla storia, dal conflitto degli interessi, dalle dinamiche economiche, da influssi culturali ecc.), ma chiaramente finalizzata a radicare nelle coscienze dei contemporanei un senso di stupido ottimismo e di cieca fiducia verso l’organizzazione sociale presente. Una pedagogia dell’apatia e della passività, in definitiva.
L’adesione a questo “regime di temporalità” implica infatti l’adesione al modello economico e sociale dominante, a quello che un sociologo italiano, Mauro Magatti, ha definito «capitalismo tecno-nichilista», ovvero un modello in cui la razionalità strumentale e l’imperativo del profitto hanno riassorbito senza residui ogni altro criterio.[9] Tale modello, che si forma a partire dall’ultimo quarto del Novecento, prima negli Stati Uniti poi in Europa, non ha più molto a che fare con il vecchio capitalismo “weberiano” (lavoro, disciplina, impegno, attaccamento alla proprietà…), ma è piuttosto un capitalismo del desiderio e della seduzione, nonché della liberazione attraverso la tecnica. Un capitalismo che promette all’individuo una generalizzata libertà (di natura peraltro fantastica e delirante) un po’ da tutto: dal lavoro faticoso, dalla politica, dalle relazioni sociali e sentimentali, ora perfino – nelle tecno-utopie postumaniste, come si vedeva poc’anzi – dalla materia e dalla biologia stesse. Ma navigando in questo insieme di… “liberazioni” da ogni radicamento, è l’umano stesso che abdica a se stesso, l’individuo stesso, apparentemente celebrato, che finisce per precipitare appunto nel nulla.
Sulla dimensione realmente nichilistica del capitalismo contemporaneo (cioè dove per nichilismo non si intende una ideologia o una dottrina, ma appunto una configurazione socio-culturale reale) è intervenuto nei suoi ultimi anni il filosofo Aldo Masullo (1923-2020):
«la condizione del nostro odierno esistere esige non tanto una discussione sull’essenza del nichilismo, quanto un’esplorazione di effettivi stati di nichilismo. (…) Uno dei sintomi è la profonda trasformazione dei nostri rapporti con il tempo. Oggi la velocizzazione dei cambiamenti (travolgente esito tecnologico), l’accelerazione del quotidiano, l’immediatezza del repentino, insomma il dissolversi della durata nel delirio di eventi puntiformi, esaltano l’istantaneo senza ragione e il vuoto del presente».[10]
Particolarmente radicato in ambito scientifico-tecnologico,[11] questo approccio alla temporalità dilaga in realtà in ogni campo della vita odierna (sempre più permeato del resto dalla macchina tecno-scientifica e dalle sue “esigenze”), spingendoci tutti in una dimensione di accelerazione permanente i cui effetti in termini di disagio crescente sono ormai oggetto di un’ampia letteratura sociologica, psicoanalitica, antropologica ecc.,[12] oltre ad essere stati denunciati nella celebre enciclica Laudato si’ di Papa Francesco con parole molto lucide.[13]
-------------
In un piccolo saggio dedicato al concetto di Futuro, Marc Augé ha rimarcato il nesso che nella percezione attuale del futuro ricopre la dimensione (tipica di società industriali avanzate e consumistiche) della “innovazione”: quest’ultima – sosteneva l’antropologo francese scomparso nel 2023 – costituisce un vero e proprio «fatto sociale totale», secondo la celebre definizione di Marcel Mauss, poiché «riguarda simultaneamente tutti gli aspetti della società e fa appello a tutti i suoi attori» (Augé M., Futuro, Torino, Bollati Boringhieri, 2012, p. 81).[14] È insomma un futuro-come-innovazione quello che risulta oggi socialmente egemone, un futuro come costante susseguirsi di novità (proprio come l’industria capitalistica deve perennemente presentare nuove merci, vere o presunte non importa), un futuro meramente quantitativo. Un futuro che – dicono molti osservatori – finisce per farsi fagocitare da se stesso, e dunque un futuro che, paradossalmente, si auto sopprime in favore di un eterno presente (così François Hartog, su cui si tornerà, che parla infatti di «presentismo» per indicare l’attuale «regime di storicità»)[15].
È chiaro che stiamo parlando di quale idea di progresso sia oggi dominante; ovvero di come questa idea, così intimamente legata a tutta la vicenda della modernità occidentale, si configuri nella società industriale avanzata di oggi (o forse dovremmo dire, per essere à la page, società digitale). Se questa furia “futuristica” di cui abbiamo parlato appare oggi così dominante e in sostanza accettata è anche perché il mito del progresso è uno di quelli cui, nel disincantamento generalizzato, ancora crediamo (paradossi del postmodernismo? Forse…). Ma, giunto a questo punto, per non abusare della pazienza del lettore, rimando alla seconda parte di questo articolo. Stay tuned.
NOTE
[1] Uso qui il concetto di “carattere sociale” come inteso tra gli altri da Erich Fromm, per esempio, in Beyond the chains of illusion. My encounter with Marx and Freud (1962), tr.it. Marx e Freud, Milano, il Saggiatore, 1968, p. 75-92. Vedi anche la voce Carattere sociale, in Luciano Gallino, Dizionario di sociologia, Torino, Utet, 2014 (1.ed. 1978), p. 94-96.
[2] Così, dovendo proporre una serie di scritti e discorsi di Barack Obama al termine del suo secondo mandato presidenziale, una grande casa editrice italiana decide di intitolare il volume che li raccoglie: Barack Obama, Il futuro è il posto migliore. Il 44. Presidente degli Stati Uniti in parole sue, prefazione di Walter Veltroni, Milano, Rizzoli ETAS, 2017.
[3] La dichiarazione del manager di Meta si trova in: Pierluigi Pisa, Arriva la nuova IA di Meta. “Imparerà da sola, penserà e proverà emozioni umane”, “la Repubblica”, 14 giugno 2023, p. 32-33.
[4] L’espressione si deve a Guy Debord, nella Società dello spettacolo (1967): «Lo spettacolo è il discorso ininterrotto che l’ordine presente tiene su se stesso, il suo monologo elogiativo» (Guy Debord, La società dello spettacolo, in Id., La società dello spettacolo. Commentari sulla società dello spettacolo, introduzione di Carlo Freccero e Daniela Strumia, Milano, Baldini & Castoldi, 2019, p. 71-72).
[5] Il concetto di «furia del dileguare» [die Furie des Verschwindens], coniato da Hegel nella Fenomenologia dello spirito (Cfr. G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, vol. II, trad. di Enrico De Negri, Firenze, La Nuova Italia, 1963, p. 129) con riferimento agli esiti utopistico-estremistici della Rivoluzione francese (dove alla «libertà assoluta» non resta che «l’operare negativo» che non s’acquieta mai, producendo catastrofi politiche), viene qui adottato per indicare la pulsione intima dell’Occidente capitalistico, che lo spinge (ci spinge) ad operare solo in senso negativo e dissolvente, senza alcun costrutto sensato ed equilibrato.
[6] Mi limito qui a citare Hartmut Rosa, Accelerazione e alienazione. Per una teoria critica del tempo nella tarda modernità, Torino, Einaudi, 2015.
[7] Osservava David Harvey, in un saggio ormai di riferimento su questi temi, The condition of postmodernity (1990): «La dinamica di una società “usa e getta”, come l’hanno definita scrittori come Alvin Toffler, cominciò a diventare evidente durante gli anni Sessanta. Significava qualcosa di più del semplice buttar via una cera quantità di prodotti (…); significava buttar via valori, stili di vita, relazioni stabili, e l’attaccamento alle cose, agli edifici, ai luoghi, alle persone, ai modi ereditati di fare ed essere» (David Harvey, La crisi della modernità, Milano, il Saggiatore, 1993, p. 349).
[8] Cfr. Günther Anders, L’uomo è antiquato.1. Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, p. 37-120.
[9] Cfr. Magatti M., Libertà immaginaria. Le illusioni del capitalismo tecno-nichilista, Milano, Feltrinelli, 2009.
[10] Nell’intervista il grande filosofo italiano riassumeva le tesi del suo Stati di nichilismo, Roma-Napoli, Paparo, 2016.
Ricordiamo che, nella filosofia italiana contemporanea, sostenitori della tesi del nichilismo come condizione storico-sociale del modo di produzione capitalistico sono stati Costanzo Preve, in particolare in Il convitato di pietra. Saggio su marxismo e nichilismo (Milano, Vangelista, 1991), e Massimo Bontempelli, La conoscenza del bene e del male, Pistoia, CRT, 1998.
[11] Giampietro Gobo ha sottolineato di recente su questo blog come l’accelerazione sociale dominante sia dannosa per la stessa attività scientifica: cfr. Giampietro Gobo, Quando la pazienza è più produttiva della fretta. Sull’esistenza di un nuovo pianeta, “Controversie”, 07/05/2024,
[12] Cfr. Hartmut Rosa, Accelerazione e alienazione, cit.
[13] «La continua accelerazione dei cambiamenti dell’umanità e del pianeta si unisce oggi all’intensificazione dei ritmi di vita e di lavoro, in quella che in spagnolo alcuni chiamano “rapidación” (rapidizzazione). Benché il cambiamento faccia parte della dinamica dei sistemi complessi, la velocità che le azioni umane gli impongono oggi contrasta con la naturale lentezza dell’evoluzione biologica» (Papa Francesco, Laudato si’. Lettera enciclica sulla cura della casa comune, commenti di Bruno Bignami, Luis Infanti de la Mora, Vittorio Prodi, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2015, p. 19).
[14] Nelle società attuali – osserva ancora Augé – «potremmo dire che ormai siamo capaci di definire il nostro rapporto con lo spazio e il tempo, cioè con l’elemento essenziale dell’attività simbolica che definisce l’essenza dell’uomo e dell’umanità, solo attraverso artefatti messi a punto dall’industria e fatti circolare su mercato» (ivi, p. 78).
[15] Cfr. François Hartog, Regimi di storicità. Presentismo e esperienze del tempo, Palermo, Sellerio, 2007.
Perché l’astensionismo… “fa bene” ai partiti, specie a quelli più grandi
Nei giorni scorsi si sono sentiti accorati appelli bipartisan ad andare a votare.
E diversi quotidiani hanno presentato con preoccupazione il fenomeno (crescente) dell’astensionismo, il quale (secondo loro) “agitava i partiti”, “incombeva sul voto”, sul quale “pendeva la mannaia dell’astensione”.
Insomma, sembravano tutti allarmati per l’astensionismo.
In realtà l’astensionismo giova ai partiti, soprattutto a quelli più grandi. Infatti, meno persone vanno a votare e più essi si rafforzano.
Sembra un’affermazione assurda, un’enormità; invece (dati alla mano) è perfettamente plausibile.
Già il sociologo Niklas Luhmann, più di quarant’anni fa (Soziale Systeme, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1984. Trad. it. Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale, Bologna, Il Mulino, 1990), sosteneva che il consenso era strutturalmente una risorsa scarsa nelle democrazie occidentali. Per cui non valeva la pena di dannarsi tanto nell’ottenerlo, perché scarso comunque sarebbe restato. In altre parole, si può benissimo governare… con poco consenso.
Passiamo ora ai dati.
Diverse leader di partito, nelle scorse ore, hanno esultato per essere aumentate di qualche punto percentuale. Ad esempio il PD nelle elezioni europee precedenti (2019) aveva ottenuto il 22,74%; ora, invece, il 24,08%: un punto in mezzo in più. Che diventano ben 5 rispetto alle ultime elezioni politiche (19,04%).
Ma se andiamo a vedere i valori assoluti (avvertenza che si impara alla prima lezione di un qualsiasi corso di statistica), scopriamo che i voti per i partiti più grandi sono calati, e anche di molto. In altre parole, i voti calano ma le percentuali aumentano. E i politici (e i giornalisti) guardano solo le seconde, dimenticando (furbizia? malafede? ignoranza?) i primi.
Non ci credete? Date un’occhiata alla tabella:
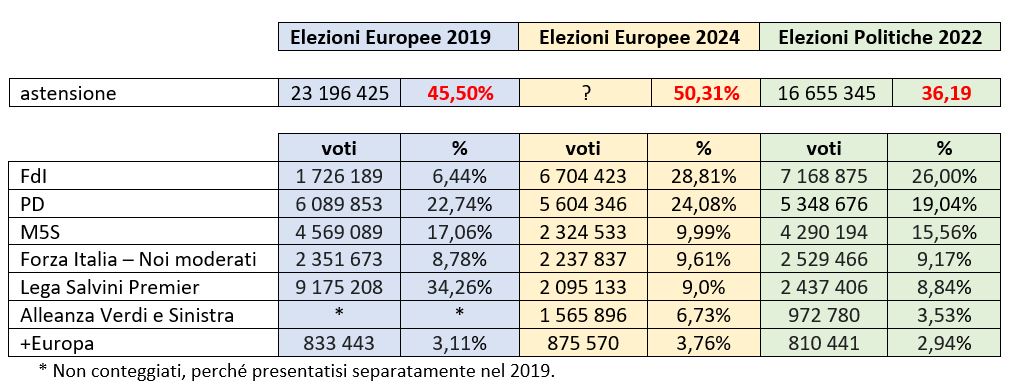
(Fonti dati: Elezioni Europee 2019, Elezioni Europee 2024, Elezioni Politiche 2022)
Così può capitare che FdI perda quasi mezzo milione di voti rispetto alle Politiche di due anni fa, ma salga miracolosamente del quasi 3%. Che il PD prenda soltanto 250mila voti in più rispetto alle Politiche ma faccia un balzo del 5%; e che ne perda quasi mezzo milione rispetto alle scorse europee ma salga di 1 punto e mezzo. Che la Lega e Forza Italia perdano rispettivamente 340mila e 291mila voti rispetto alle Politiche, ma salgano di qualche decimo.
Invece questo non succede con i partiti minori (vedasi +Europa), che quando perdono voti, perdono anche decimi percentuali.
Facciamo un ragionamento per assurdo: se alle prossime elezioni vanno a votare solo 10 persone su 1000 aventi diritto, e queste danno 3 voti a FdI, 3 al PD, 2 al M5S, 1 alla Lega e 1 Forza Italia, questi partiti prenderanno rispettivamente il 30%, 30%, 20%, 10% e 10%, pur avendo perso tutto l’elettorato e con un’astensione pari al 99%.
Perché, diversamente dai sondaggi, dove i ‘non so’ si espungono (giustamente) dalle percentuali finali — non si può attribuire un’opinione a chi dice di non averla — nelle elezioni questo non avviene: il voto viene attribuito anche a chi non vota [1].
E questo viene fatto presupponendo una distribuzione (partiticamente) omogenea delle astenute. Ma così assolutamente non è: coloro che non vanno a votare sono tendenzialmente le persone più critiche nei confronti del sistema politico (e non solo le “indifferenti” o qualunquiste, che potrebbero essere equamente distribuite).
Quindi non è vero che 1 vale 1. Al contrario: l’1 del votante (con alti tassi di astensionismo) vale molto di più. Con il 50% di astensionismo, vale 2. E con un ipotetico 99% di astensionismo vale quasi 100!
In questo modo le elezioni sono (matematicamente) delle ponderazioni, degli artifizi, delle manipolazioni aritmetiche.
Per cui 10 votanti (l’1%) contano come il 100% e si distribuiscono i 76 seggi europarlamentari. In questo caso (assurdo), gli eletti sarebbero più dei votanti… cioè qualche eletto non sarebbe andato a votare…
Allora è chiaro perché i partiti più grandi (quelli sopra il 10%) non hanno interesse a combattere seriamente l’astensionismo. Perché se anche porta a loro meno voti, alza però le loro percentuali. E sono queste (malauguratamente) quelle che contano.
Per cui colei/colui che non va a votare, fa (indirettamente) il gioco dei partiti più grandi.
Perché il suo non-voto se lo prendono lo stesso…
NOTE
[1] Nei sondaggi l’astensionista corrisponde alla nonrespondent, persona che non ha voluto partecipare al sondaggio. In questi casi la sondaggista interviene in due modi: 1) con una “riserva”, cioè sostituendo la nonrispondente con un'altra (socio-demograficamente) simile a lei; oppure, 2) con una “ponderazione”, cioè attribuendo (mediante un coefficiente) fittiziamente l’opinione media di quelle che hanno risposto (nel senso di aver partecipato al sondaggio) a coloro che non l’hanno fatto. Ma entrambe queste operazioni hanno dei limiti e, soprattutto, la ponderazione è sconsigliata quando il fenomeno nonresponse supera il 50% (come nel caso di queste ultime elezioni europee). Per un approfondimento: Gobo, G. (2015), La nuova survey. Sondaggio discorsivo e approccio interazionale, Roma, Carocci, pp. 201-202.
Scienze sociali in scena: un rapporto fecondo tra sociologie e teatro
«Il teatro è così infinitamente affascinante perché è così casuale. È come la vita…»
(Arthur Miller)
Teatro, persona, maschere, ruoli e palcoscenico… Sono da sempre interconnessi. Non è un caso se nel linguaggio comune vi siano molti riferimenti al teatro: «il ruolo di genitore», «le persone hanno molte maschere», «è calato il sipario», e così via.
Anche nelle scienze sociali vi sono molti riferimenti a questa realtà: dal concetto stesso di rappresentazioni sociali, all’approccio drammaturgico dello scienziato sociale Erving Goffman (1945, The Presentation of Self in Everyday Life) che analizza le istituzioni sociali, quelle della vita quotidiana e quelle professionali, come vere e proprie rappresentazioni teatrali, in cui gli individui sono considerati come degli attori e che, a seguito di un periodo variabile e differente di preparazione in un contesto sociale definito retroscena, interpretano pubblicamente dei ruoli, in un altro spazio pubblico, ovvero la ribalta. Anche in un’altra disciplina di grande interesse, si ha un forte richiamo al teatro, ossia l’antropologia teatrale che analizza le interazioni degli individui e/o delle collettività all’interno di una forma di drammatizzazione organizzata. Quindi diventano interessanti i rapporti dell’attore teatrale/sociale con i gesti e le parole portati in scena. Uno degli studiosi più importanti di questa sub-disciplina, Eugenio Barba (1993, La canoa di carta) la definisce come «lo studio del comportamento scenico pre-espressivo che sta alla base dei differenti generi, stili, ruoli e delle tradizioni personali o collettive».
A partire da queste premesse (intrecciate sia con il mio bagaglio culturale e di ricerca, che a sua volta interseca antropologia, criminologia e sociologia, che con la mia passione per l’arte, il teatro e il cinema) è nato il progetto di divulgazione scientifica in chiave teatrale, Scienze sociali in scena.
Gli obiettivi del progetto
Il progetto, dunque, ha diversi obiettivi: innanzitutto quello di trasmettere gli elementi caratterizzanti le scienze sociali di cui mi occupo attraverso il teatro, inteso come uno dei migliori strumenti per acquisire conoscenza; al tempo stesso affrontare i problemi della società contemporanea; ma soprattutto accomunare l’esperienza della ricerca scientifica e il mondo delle arti sceniche attraverso uno scambio reciproco di saperi e di sostegno per la divulgazione scientifica con una impostazione e un linguaggio alla portata di tutti.
Il logo
L’identità di una qualsiasi entità, per affermarsi, necessita innanzitutto di simboli. Proprio per queste ragioni il logo ingloba le tante “dualità” che sottendono questo progetto. Innanzitutto, i colori: il bianco e il nero, come richiamo sia alle zone di luce ed ombra dell’agire umano, ma anche correlati alla contrapposizione tra il retroscena e la ribalta, ma più in generale si riferiscono alle varie forme di ambivalenza che accompagnano l’uomo. I simboli: sulla sinistra sono presenti le classiche maschere che rappresentano il teatro, ma hanno anche un altro significato, ovvero quello proposto da Jung che «prende in prestito il termine dal latino Persōna Persōnam, ovvero la maschera che gli attori solevano indossare durante le rappresentazioni sceniche. La Persona era solo un riflesso dell’immagine del personaggio interpretato dall’attore, ne riprendeva i lineamenti, lo caratterizzava, lo inseriva in un ruolo». A destra, invece, ritroviamo un network, e quindi una simbologia che richiama l’attitudine umana di entrare in relazione con i suoi simili.
La strutturazione di Scienze sociali in scena
Il progetto ha una strutturazione particolare. Innanzitutto, si apre con dei video con sottofondo musicale, da me realizzati, perché ho anche l’hobby, seppur del tutto amatoriale, del video editing. Questa fase ha un duplice compito: sia di creare un’atmosfera densa e volta ad attirare l’attenzione, ma al tempo stesso, essere una vera e propria scenografia visuale. Dopodiché inizia la fase teatrale propriamente detta, in cui vengono interpretati passaggi delle mie ricerche, ma anche eventuali personaggi analizzati. Si tratta di un momento essenziale, perché ha il compito di portare lo spettatore “all’interno” della tematica trattata.
Il passo successivo consiste nella fase intervista al personaggio, il cui scopo consiste nel mostrare come si conduce un’intervista dal punto di vista delle scienze sociali, per far comprendere come sia complicato rimanere, per esempio, avalutativi rispetto a determinate tematiche; ma, al tempo stesso, è utile per dare il via all’ultima fase ossia quella dell’analisi di tutto ciò che è stato portato in scena, con un linguaggio semplice ed accessibile, in modo tale da trasmettere forme di conoscenza utili non solo ai fini dell’evento, ma anche nella vita quotidiana.
Curiosità
Scienze sociali in scena interseca le scienze sociali non solo con la recitazione, ma anche con l’arte. Infatti, un elemento centrale di questo progetto sono sia la realizzazione di fotografie, che la presenza di installazioni artistiche in scena, in linea con la tematica trattata.
Il progetto [1] è totalmente autonomo e autofinanziato, perché i realizzatori credono che soltanto nell’autonomia si possa erogare un prodotto di ricerca libero da qualsiasi forma di influenza politica, economica, o di altra natura.
In questo modo, è possibile che si rafforzi la figura del divulgatore teatrale: ossia uno scienziato sociale in grado di trasmettere il proprio sapere, la propria esperienza sul campo, i propri prodotti scientifici nel contesto teatrale.
Speriamo che questo progetto possa avere una crescente attenzione e impatto in diversi contesti ed ambiti, ricordando sempre che nel grande teatro della vita, cerchiamo sempre le sedie dello stupore, dell'innovazione, della diversità e perché no anche del sano dissidio... Si tratta di sedute quasi sempre libere... Quelle dell'ovvio, invece, sono già tutte occupate.
NOTE
[1] A questa avventura partecipano: Anna Rotundo (per la fotografia, le installazioni artistiche e, in collaborazione con me, l’adattamento delle mie ricerche in chiave teatrale); Maria Novella Madia (attrice); lo staff tecnico (Rita Rotundo e Arturo Obizzo), l’autore di questo post.
Il progetto è stato inaugurato a Catanzaro, con l’adattamento teatrale del Cannibalismo questioni di genere e serialità, e ha ottenuto un numero elevatissimo di presenze!
Per approfondimenti, si può fare riferimento alle pagine Facebook e Instagram.
Sono già in fase di programmazione altri eventi sotto l’effige di Scienze sociali in scena.
Perché il progetto di un’Unione Europea è fallito - Un'analisi socio-linguistica
Tra qualche giorno, metà di noi si appresterà ad andare a votare per il rinnovo del Parlamento Europeo.
Metà perché, nella tornata precedente, non andò a votare il 49% degli aventi diritto, con rilevanti differenze tra i singoli Stati che compongono l’Unione Europea: la palma d’oro (si fa per dire) dell’astensionismo andò alla Slovacchia (75%); l’Italia si collocò poco sotto la media europea (45%); il più “virtuoso” il Belgio (11%). E per questa tornata i sondaggi danno l’astensionismo in aumento.
Le politologhe, nel corso degli anni, hanno indicato diverse cause. Prima fra tutte, la “crisi della rappresentanza”. Per cui l’astensionismo alle elezioni europee è in linea con una tendenza più generale, che tocca anche gli Stati nazionali, le elezioni regionali e locali.
Ma c’è anche un’altra ragione. Più profonda. E l’averla trascurata sin dall’inizio ha decretato il fallimento dell’intero progetto dell’Unione Europea. Tracollo che nessun curatore fallimentare ha ancora certificato, ma che (a me) pare evidente nelle pratiche dei singoli Stati e dei partiti presenti in essi.
Non sono un politologo o un sociologo politico. Per cui le mie riflessioni non nascono da quelle competenze (che non ho) ma da un’analisi socio-linguistica (approccio che insegno nei miei corsi).
Le grandi potenze
L’Unione Europea aspira ad essere una grande potenza, al pari degli USA, Cina, Russia. Altre nuove (potenziali) grandi potenze si stanno affacciando: Brasile, India, e forse Mondo Arabo.
Cos’hanno in comune queste grandi potenze che l’Unione Europea non ha? Una lingua comune.
In questi Paesi, le persone possono (potenzialmente) intendersi perché (quasi) tutte parlano l’inglese, il cinese, il russo, il portoghese, l’hindi e l’arabo moderno standard (che non è mai madrelingua di nessuna arabofona, ma il suo apprendimento avviene seriamente nella scuola). In India, paese con una grandissima diversità culturale, pur avendo ventuno lingue a livello dei singoli stati federati, ha sempre la possibilità di usare l’hindi oppure l’inglese (come lingua ufficiale sussidiaria).
Senza una lingua comune non può esistere a lungo uno Stato o una Confederazione. Si dissolverà a breve.
Ci sono ovviamente delle (piccole) eccezioni: la Svizzera non ha una lingua comune; tuttavia, quando due svizzere si incontrano parlano in francese oppure in tedesco (lingue che hanno imparato seriamente a scuola).
Una lingua comune
Nella (breve) storia dell’Unione Europea non ci sono mai stati tentativi seri di dotare questa federazione di una lingua comune. I tentativi seri sono andati in altre direzioni: legislative (leggi comuni), economiche (mercato comune), politiche (parlamento europeo). Per cui si è ritenuto (in modo miope) più importante costruire una moneta comune (l’euro) piuttosto che una lingua comune. Decisioni guidate da un pensiero solo razionale, che si scontra con le caratteristiche delle culture.
A suo tempo, le decisore politiche avevano davanti a sé almeno due strade per costruire una lingua comune: puntare su una lingua pianificata (l’esperanto) oppure adottare una lingua commerciale (l’inglese).
La prima, sviluppata tra il 1872 e il 1887 dal medico e linguista polacco Ludwik Lejzer Zamenhof, aveva “lo scopo di far dialogare i diversi popoli cercando di creare tra di essi comprensione e pace con una seconda lingua semplice, ma espressiva, appartenente all'umanità e non a un popolo. Un effetto di ciò sarebbe stato quello di proteggere gli idiomi "minori", altrimenti condannati all'estinzione dalla forza delle lingue delle nazioni più forti. Per questo motivo l'esperanto è stato ed è spesso protagonista di dibattiti riguardanti la democrazia linguistica (…) Dopo rapida espansione del movimento esperantista in molti Paesi, esso subì vari duri colpi nel corso della Prima guerra mondiale, ma soprattutto nella Seconda guerra mondiale a causa di Hitler, che riteneva l'esperanto la lingua degli ebrei (Zamenhof era ebreo), ma anche nella Russia di Stalin (e più recentemente, nell'Iraq di Saddam Hussein). Nel secondo dopoguerra (eccetto dove gli esperantisti erano ancora perseguitati) il movimento riprese vigore, ma subendo la forza a livello internazionale del francese prima e soprattutto dell'inglese poi, data la forza e l'influenza degli Stati Uniti d'America sulla scena internazionale”.
Oggi l’esperanto, nonostante i tanti proclami e risoluzioni dell’UNESCO, non sembra aver nessuna possibilità.
A questo punto, potrebbe essere l’inglese ad assumere il ruolo di lingua unificante.
Tuttavia, nell’Unione Europea solo il 10-20% parla l’inglese in modo fluente (requisito necessario per intendersi reciprocamente) e per lo più sono persone altamente scolarizzate.
Se l’Unione Europea facesse ora un investimento serio scolasticamente, forse tra 50 anni avremmo una federazione con una lingua comune, come le grandi potenze. Ma a parte il fatto che, con la velocità dei cambiamenti attuali, è inimmaginabile un tempo di attesa così lungo, ci sono molte forze che remano contro questo progetto (che comunque sarebbe discutibile, dal sapore neo-coloniale): le popolazioni degli Stati membri (in primis francesi e italiane) non sono così innamorate di questa lingua, anzi sono abbastanza restie ad impararla; inoltre, lo stato membro (UK) in cui l’inglese è madrelingua ha da poco… abbandonato l’Unione. Una beffa.
Le conseguenza dell'assenza di una lingua comune
La mancanza di una lingua comune, la base principale su cui intavolare una discussione, uno scambio di idee, una comprensione reciproca, rinforza le identità nazionali. E, a cascata, produce tante conseguenze nefaste. Che sono un po’ sotto l’occhio di tutte:
- 3 parlamenti (Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo) al posto di 1 solo;
- la possibilità di veto da parte di uno stato membro (e come se la Florida avesse potere di veto alle decisioni internazionali degli US);
- nessuna politica estera comune su conflitti come (ad esempio) Libia, Bielorussia, Grecia-Turchia, Israele-Palestina; ad eccezione (chissà per quanto?) dell’Ucraina-Russia). In quei conflitti gli Stati membri appoggiano contendenti diversi, a tal punto che pochi giorni fa Spagna e Irlanda hanno riconosciuto lo Stato della Palestina (l’avrebbe fatto la Florida?);
- nessuna politica militare comune (ogni Stato dell’UE si arma e vende armi per conto proprio);
- nessuna politica fiscale comune (regimi fiscali diversi a Malta, Irlanda, Paesi Bassi… — questo, a onor del vero, avviene anche negli US);
- nessuna politica commerciale comune (ogni Stato UE compete con gli altri per vendere i propri prodotti e stipula contratti commerciali in modo indipendente);
- ecc.
Per cui l’Unione Europea, come progetto culturale, è fallita.
Rimane il progetto economico, legislativo e politico. Ma senza una lingua comune sarà sempre in affanno e non potrà competere con le altre grandi potenze.
Io comunque, a scanso di equivoci, andrò a votare.
P.S. Ho usato il femminile sovraesteso, “per vedere l’effetto che fa”.
Il “doppio click”, ovvero l’atteggiamento blasé nel turismo e nella scienza
«Si riscosse sentendosi quasi chiamato e interrogato dalle ultime parole di Settembrini, ma, come quando quest’ultimo aveva voluto costringerlo solennemente a decidersi fra “Oriente e Occidente”, atteggiò il viso all’espressione di chi pone riserve e non si vuole arrendere, e tacque. Spingevano tutto all’estremo, quei due, come è forse necessario quando si viene ai ferri corti, e litigavano accaniti per un’alternativa suprema, mentre a lui sembrava che nel mezzo, tra le esagerazioni contestate, tra il retorico umanesimo e la barbarie analfabeta, ci doveva pur essere quello che si potrebbe chiamare l’umano». (Mann T. (1924), La montagna incantata, Corbaccio, Milano, 2015, p. 500)
Fra i personaggi più straordinari della letteratura possiamo annoverare sicuramente Lodovico Settembrini e Leo Naphta, i due precettori di Hans Castorp, il protagonista de La montagna incantata di Thomas Mann.
In questo romanzo di formazione infatti, il giovane ingegnere tedesco è costantemente sollecitato sul profilo intellettuale da queste due figure che – con fenomenale, e a tratti assurda, coerenza – lo invitano a scegliere fra visioni del mondo radicalmente contrapposte: da un lato, il massone italiano lo esorta ad abbracciare i valori illuministici del progresso, il culto della ragione, l’universalismo cosmopolita, l’arte classica e il liberalismo; dall’altro, il gesuita est-europeo lo spinge verso il socialismo, la relatività esistenziale del sapere e la sintesi idealista del corpo e della mente, sulla falsariga delle dottrine radicali teocratiche del medioevo.
La ricostruzione degli elementi e dei valori culturali propri di questi due personaggi, e dei loro partiti idealtipici, è talmente precisa e dettagliata, così completa nella presentazione fattane dall’autore, da far nascere costantemente dubbi nel lettore a proposito delle proprie convinzioni personali, una volta che queste vengono adeguatamente ricondotte a quello che Fleck[1] chiamerebbe il loro “stile di pensiero” originario.
Non solo, ma lo portano anche a dissociarsi dall’integralismo con cui i due personaggi difendono le proprie posizioni, talmente esasperato da sfidarsi a duello per affermarle nei confronti del rispettivo avversario.
La genialità e l’attualità dell’opera di Mann, a 100 anni dalla pubblicazione del libro, sta nel fatto che Settembrini e Naphta sono personaggi di fantasia, assolutamente improbabili, pur essendo caratterizzati ciascuno come un insieme di elementi di dettaglio estremamente reali e storicamente ben definiti. Altro che il Signore degli Anelli!
Piuttosto, suggerisce l’autore, è secondo un’ambigua convivenza di “ragione” e “sentimento” che l’uomo moderno, l’ingegnere - e noi che ci impersoniamo in lui - verosimilmente costruisce il proprio percorso di vita: come un coacervo di idee eterogenee, e talvolta in conflitto.
Per esempio, un accostamento inusuale è quello che associa la formazione della cosmologia moderna – nel senso antropologico di insieme di codici che definiscono e regolano l’ordine sociale – alla nascita del turismo, avvenuta fra il XVIII e il XIX secolo.
Infatti, nelle scienze sociali e nel senso comune si tende, generalmente, a derubricare superficialmente l’argomento, come se fosse meno rilevante della razionalizzazione, dell’individualizzazione e di altri cambiamenti di natura politica ed economica avvenuti nello stesso periodo (del resto, abbiamo giusto un paio di settimane di ferie l’anno purtroppo).
Eppure, come mostra lo storico Alain Corbin, nel suo libro L’invenzione del mare (Corbin A. (1988), Le territoire du vide. L’Occident et le désir de rivage, 1750-1840, Flammarion, Paris), all’emergere della prassi del turismo deve essere assegnato un ruolo di primaria importanza, poiché essa istituisce ex abrupto il movimento di ricerca verso l’ignoto, e lo consolida come consuetudine sociale che poi va sempre più generalizzandosi nel corso del tempo.
Il mare, dice appunto provocatoriamente, è stato inventato nel periodo contemporaneo, poiché precedentemente non esisteva, come, ad esempio, secondo il Verbo, esso non è nemmeno previsto nel giardino dell’Eden.
La società “pre-moderna” (qualunque cosa voglia dire questo ambiguo concetto) è una società esclusivamente di pianura, che acquisisce il “desiderio di riva”, la volontà di esplorare i territoires du vide, come un fatto inedito, saldato alla pratica di distinzione sociale dei rampolli dei ceti emergenti di quel periodo che, un po’ come Darwin alle Galapagos, Malinowski nelle Trobriand o Booth negli slum della Londra vittoriana, tenevano dei diari a proposito delle loro “robinsonate”, le gite esplorative delle coste e delle isole ignote che visitavano nel tempo libero.
Quello turistico è quindi, per prendere in prestito un’espressione bourdieusiana, un principio di visione e divisione sociale, un modo di vedere e organizzare la società, un tipo di sguardo sulle cose, una maniera di arrangiarle da un punto di vista materiale, che certamente è concomitante all’industrializzazione, ai processi di democratizzazione e secolarizzazione.
All’affermarsi del turismo possono essere quindi ricondotte tutta una serie di biforcazioni di cui ancora oggi ci avvaliamo: come quella fra natura e cultura, che rispecchia la suddivisione dello spazio in luoghi antropizzati e incontaminati; come la ripartizione economicista fra l’utile (il lavoro) e l’inutile (lo svago); e come la suddivisione dei ruoli sociali in essenze che appartengono, da un lato, ad un tempo passato - quello della campagna, o delle terre esotiche[2], immobili e unicamente da conservare e visitare come reliquie (è sempre, maledettamente, vietato toccare!), e dall’altro ad un futuro appropriabile, ma già ipotecato, quello della città - che chiede di essere imitata, stabilendo la direzione, ma senza offrire reali speranze.
Ma soprattutto[3] al turismo deve essere associato il nuovo modo in cui determiniamo ciò che è vero e ciò che è falso: tutti sanno benissimo che, quando un qualcosa è “per turisti”, significa che è “inautentico, fasullo, o ingannevole”, e che solo i “veri viaggiatori” sanno distinguere e apprezzare ciò che invece è “autentico”.
Come dice Goffman, nel mondo moderno - in cui la struttura della società supera in estensione e per differenziazione quella familiare e comunitaria, dove la verità rimane nettamente distinta dalla menzogna, come il giorno dalla notte - è attraverso un’ipertrofia di apparati di intermediazione, tutta una serie di dispositivi e costruzioni, che viene assemblato l’ordine sociale.
Nella società contemporanea, la verità è una messa in scena, che deve essere costantemente performata, ed è sempre esposta al rischio di fallire[4] .
Le verità di cui ci avvaliamo sono sempre artefatte, ma, ciononostante, questo ci suona come un paradosso.
Il palcoscenico dove avvengono le rappresentazioni, infatti, lo consideriamo come un piano sostanzialmente illusorio e sovrastrutturale rispetto al retroscena che nasconde (con buona pace dei cuochi che non possono più tirarsi le padelle, visto che ora tutte le cucine sono a vista). La mediazione implica quindi l’istituzione di due dimensioni, una front region e una back region, dove la prima sarebbe come un manto di apparenze che avvolge la vera essenza delle cose nascoste della seconda: «hai finito con le chiacchiere e i sofismi? Vai al sodo, lascia parlare i fatti!».
Come epitomato dal flâneur di Baudelaire, il turismo ha affermato un modo di esistenza che ci spinge ad assegnare un valore al disinteresse, ad apprezzare il mondo e a considerarlo tanto più veritiero quanto più è libero ed irresponsabile nei confronti di un sistema di media, come se questi non operassero altro che distorsioni: si dimentica così della sua massima più famosa, perché ciò che vediamo nelle immagini da cartolina è sempre la meta, e mai la strada per arrivarci.
Mentre solo l’accesso diretto, come quello che pare procurarci il “doppio click” del mouse, consentirebbe una vera esperienza delle cose; poco importa poi che una ricerca scientifica disponga di strumenti e finanziamenti e un'altra solo della buona volontà, la natura è lì in ogni caso!
Come sentenzia Latour, noi moderni siamo incapaci di pronunciare con una sola emissione di voce la frase “è costruito, perciò deve essere vero”[5] .
Tuttavia, dice Cézanne, «guarda la montagna, una volta era fuoco!», troppo concentrati dalla vetta, ci dimentichiamo infatti che la strada per arrivarci dipende dalla nostra formazione, e il sentiero che sapremo aprirci sarà molto diverso se siamo guide alpine attrezzate o escursionisti domenicali, ma non necessariamente uno sarà più vero dell’altro. Piuttosto, essi differiranno nel grado di realtà che saranno in grado di mobilitare e trasformare a proprio vantaggio.
Così, conclude ironicamente Latour: «L’etnologo trova sempre comica l’eterna lamentela inventata dalla critica: “poiché accediamo alle cose conosciute tramite un percorso, questo significa che queste cose sono inaccessibili e inconoscibili di per sé”. Vorrebbe rispondere: “ma di cosa ti lamenti, visto che comunque puoi accedere ad esse?” “Sì” – continuano a piagnucolare – “ma ciò significa che non le cogliamo ‘in sé stesse’, non vediamo come sarebbero ‘senza di noi’. “Bene, ma visto che vuoi approcciarle, se vuoi che siano come sono ‘senza di te’, perché non smettere semplicemente di provare a raggiungerle?” Ancora in modo più lagnoso; “perché così non avremmo alcuna speranza di conoscerle”. Sospira esasperato l’etnologo: “è come se vi congratulaste con voi stessi che c’è un percorso per il monte Aiguille, ma poi vi lamentaste che vi ha permesso di arrampicarvi fino in cima…” La critica si comporta sempre come i turisti blasé, che vorrebbero sempre raggiungere i territori più incontaminati senza difficoltà, e senza incappare in altri turisti». (Latour B. (2013), An Inquiry into Modes of Existence. An Anthropology of the Moderns, Harvard University Press, p. 85)
NOTE
[1] Cfr. Fleck L. (1935), Genesis and Development of a Scientific Fact, Foreword by T. S. Kuhn, The University of Chicago Press.
[2] Cfr.: Said E. W. (1978), Orientalism, Pantheon Books, New York
[3] MacCannell D. (1976), The Tourist: A New Theory of the Leisure Class, Schocken Books, New York.
[4] Oltre alla ripartizione fra il mondo della pianura e il clima dell’altitudine, per dirla con Mann - come ha intuito Dean MacCannell, in uno dei più importanti saggi di antropologia del secolo scorso ; Cfr.: Goffman E. (1959), The Presentation of Self in Everyday Life, Doubleday, Garden City
[5] Cfr. Latour B. (2013), An Inquiry into Modes of Existence. An Anthropology of the Moderns, Harvard University Press.










