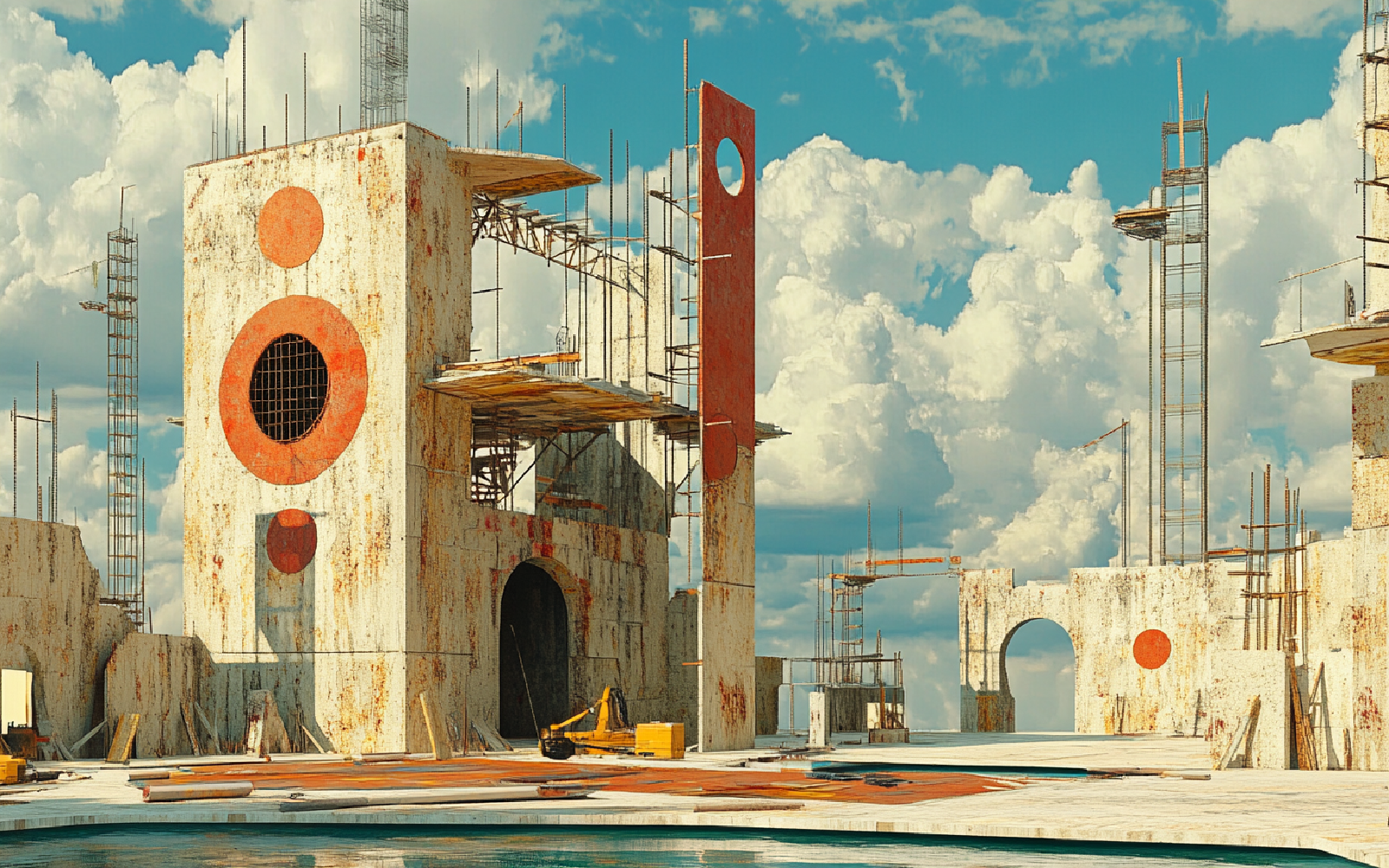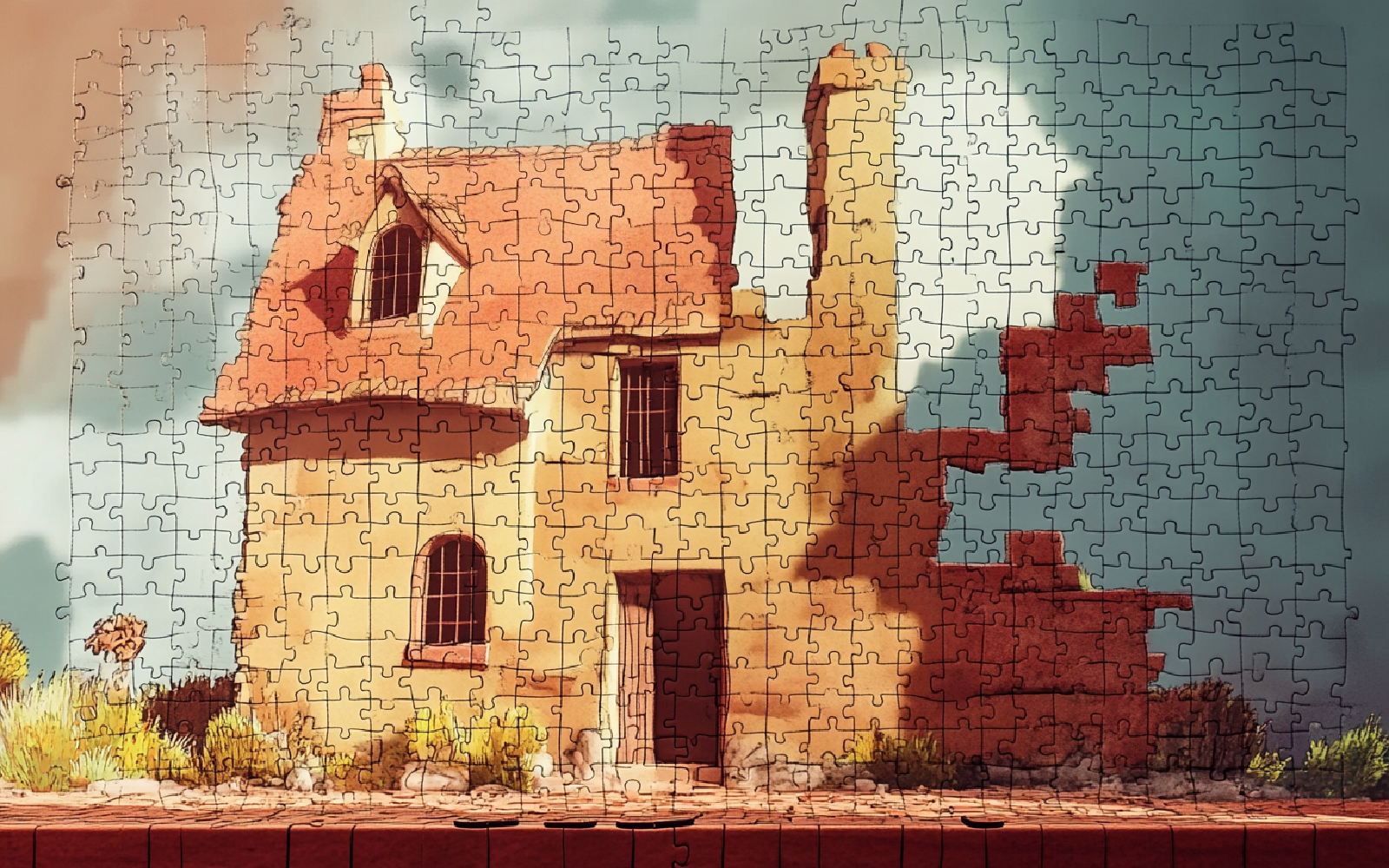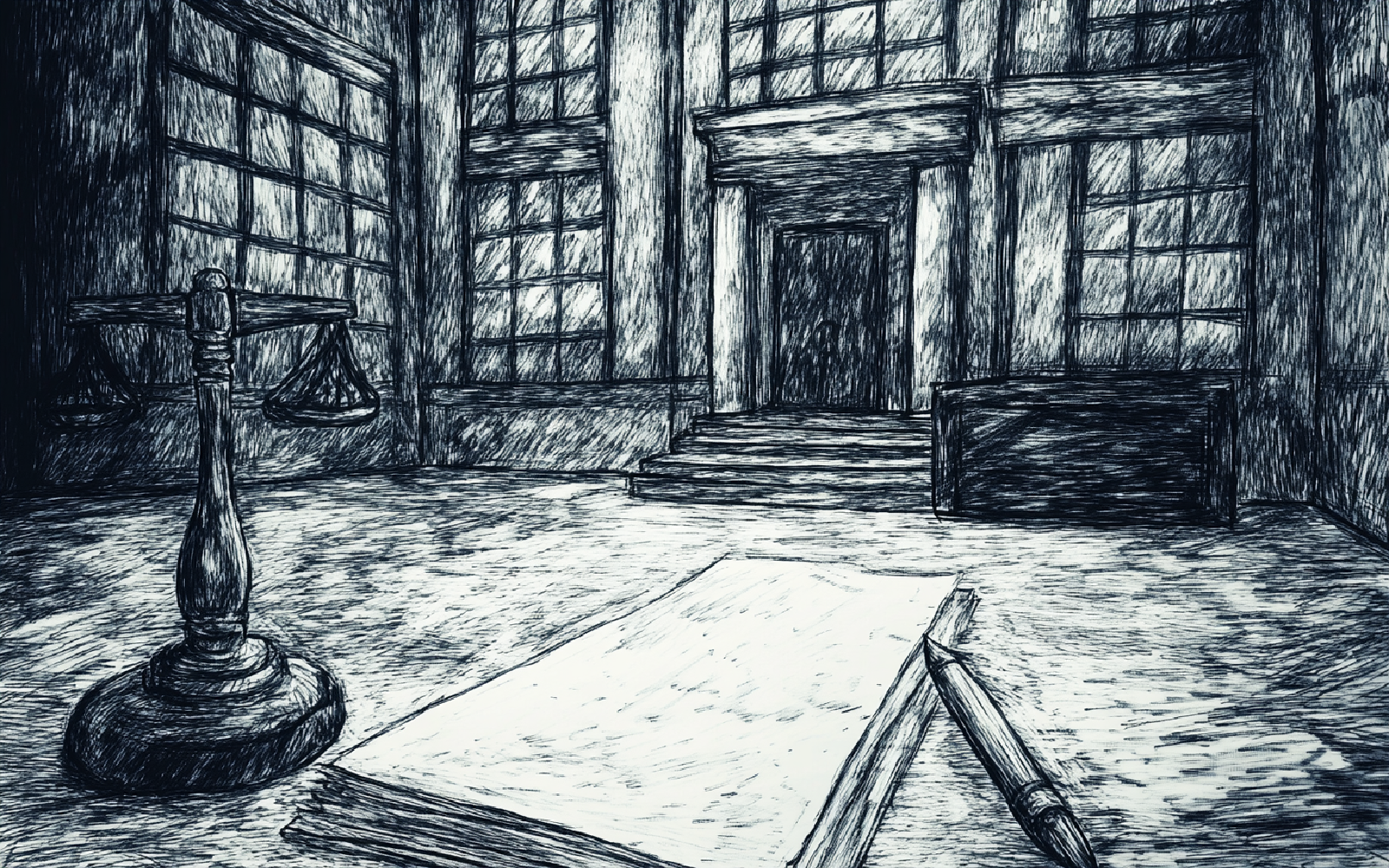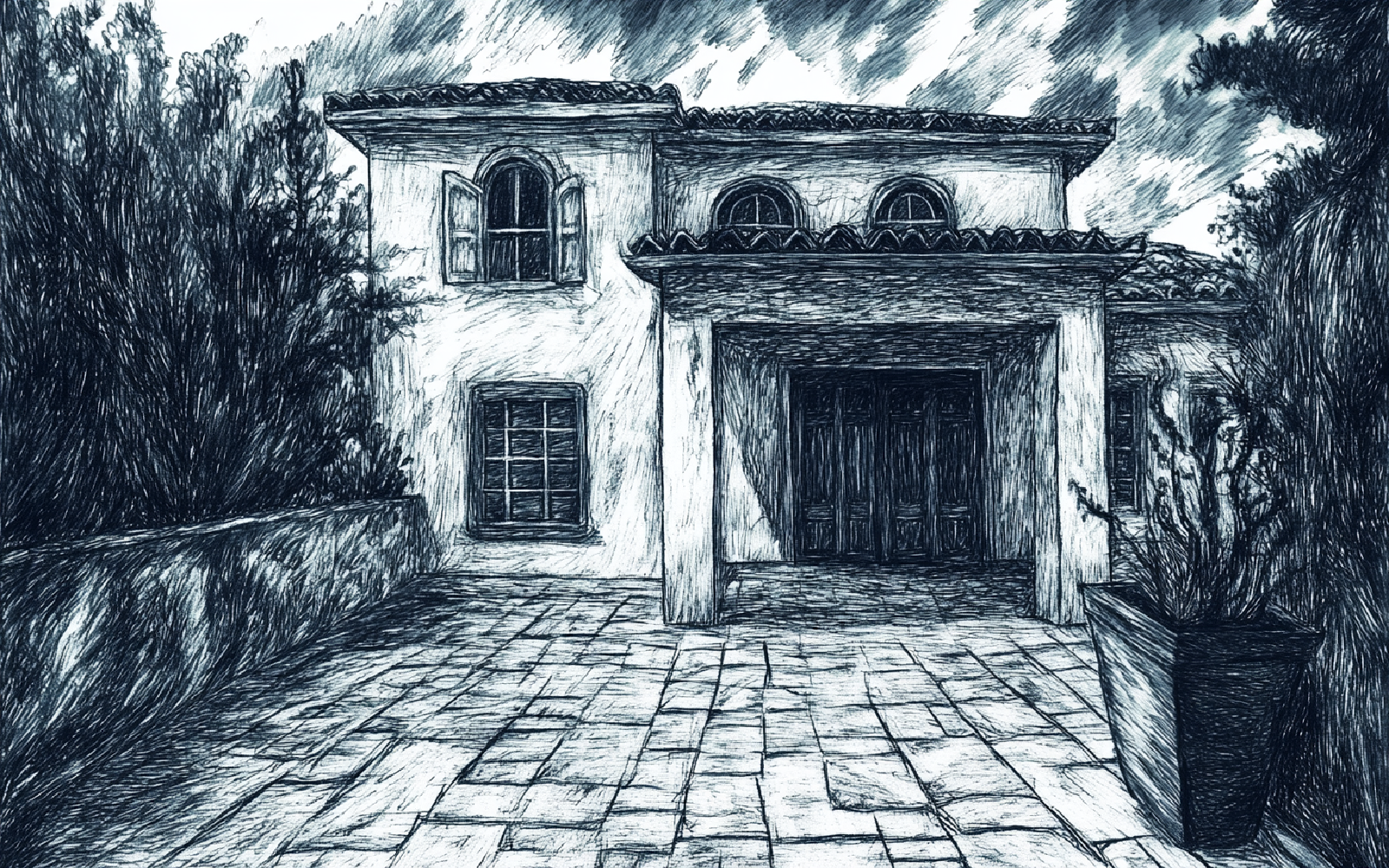Decalogo Latouriano – Il pensiero meno noto di Bruno Latour, Terza parte
La prima e la seconda parte del percorso latouriano hanno toccato:
- il legame profondo tra oggetti della scienza e società, in cui – secondo Latour – sono i primi a spiegare la seconda (il sociale, la società e la sociologia)
- la critica di Latour alle sociologie interpretative, all’empirismo storico, al riduzionismo e –ovviamente – al positivismo, dichiarandosi però “oggettivista”, “realista” e “relativista” nello stesso tempo.
- il costruzionismo
- il concetto di attante
In questa terza e ultima parte analizzeremo:
- i concetti di micro e macro, riferiti alla società e alla relazione tra locale e globale
- il metodo dell’Actor-Network Theory (ANT)
e proveremo a concludere il percorso.
Tracciando, prima, una serie di associazioni tra i diversi argomenti, da applicare a esempi reali, fino a dare qualche suggerimento su come studiare in modo innovativo anche i temi più controversi. Aggirando le banali e insensate distinzioni tra scientifico e anti-scientifico, scienza e pseudoscienza, ortodosso e eterodosso.
5. IL MICRO E IL MACRO
Anche su questo tema, Latour è stato (in parte) originale, profondo e contro-intuitivo. Perciò, praticamente inascoltato.
- “La società non è il grande tutto ‘in cui’ ogni cosa è incastonata. La società è ciò che viaggia ‘attraverso’ ogni cosa, calibrando le connessioni e offrendo alle entità che incontra un'occasione di commensurabilità”.
- “Né globale, né locale hanno di per sé un’esistenza concreta. Tranne che quando vengono connessi momentaneamente dai ‘connettori’”.
- Per cui, occorre combattere "il pregiudizio che le interazioni locali siano più concrete".
- Invece, “l'azione è dislocata. L'azione sempre imprestata, distribuita, suggerita, influenzata, dominata, tradita, tradotta (…) non appartiene a nessun luogo specifico”.
- Perciò, "l'interazione faccia-a-faccia non è un punto di partenza plausibile per tracciare le connessioni sociali”.
- “Non dobbiamo considerare che il macro inglobi il micro, ma che il micro sia composto di una proliferazione di entità incommensurabili — ciò che Tarde chiamava ‘monadi’ — che stanno semplicemente prestando uno dei loro attributi, una ‘facciata di se stessi’. Il piccolo regge il grande. O, piuttosto il grande potrebbe in qualsiasi momento sprofondare di nuovo nel piccolo da cui è emerso e a cui ritornerà”.
- Seguendo la lezione di Tarde, “il grande (Stati, organizzazioni, mercati) è un’amplificazione, ma anche una semplificazione del piccolo”.
- “Come dimostra la storia economica recente, le grandi decisioni sono meno razionali di quelle piccole”. E, sempre seguendo Tarde, “c’è generalmente più logica in una frase che in un discorso, più in un singolo discorso che in una successione o un gruppo di discorsi; ve n’è più in un rito speciale che in un intero credo, in un articolo di legge che in un intero codice, in una particolare teoria scientifica che nell'intero corpo della scienza; e ve n’è più in una singola opera eseguita da un operaio che nella somma della sua condotta”.
- "le cose, i quasi-oggetti e gli attaccamenti sono il vero centro del mondo sociale; non l’agente, la persona, il membro o il partecipante, né la società o i suoi simulacri (...) la società è la conseguenza dell'associazione e non la sua causa”.
- “Non fissatevi con il capitalismo, ma nemmeno rimanete bloccati sullo schermo della trading room: seguite le connessioni, seguite gli attori stessi”.
- Anche se non si può trascurare "l'importanza dei siti locali che fabbricano strutture globali, non si può dire che un luogo sia più grande di un altro luogo, ma si può affermare che alcuni beni beneficiano di connessioni molto più sicure con molti più luoghi".
- Le ‘grandi’ narrazioni possono essere prodotte in questi luoghi ‘locali’.
- Questo approccio laturiano, evoca molto il sociologo statunitense Randall Collins, con la sua teoria delle catene di interazione rituale (di ispirazione goffmaniana).
6. METODO ANT
- Secondo Latour, "lo studio delle innovazioni e delle controversie è uno dei luoghi privilegiati in cui gli oggetti possono essere mantenuti più a lungo nel loro ruolo di mediatori visibili, distribuiti e formalizzati nei resoconti, prima di diventare intermediari apparentemente invisibili e asociali”.
- Latour distingue tra “mediatori” e “intermediari”. Non è una distinzione ergonomicamente felice per la comprensione del suo pensiero, ma (in breve) significa che un mediatore è un ente che trasforma, fa far cose agli altri, che influenza (senza causarla) l’azione degli altri. Un intermediario, invece, un ente passivo. Tuttavia, questi non sono ruoli prestabiliti: un mediatore, in una certa occasione, può diventare intermediario; e viceversa. “Incidenti, guasti e scioperi: all'improvviso intermediari silenziosi diventano mediatori a tutti gli effetti; persino gli oggetti che un minuto prima sembravano del tutto automatici, autonomi e privi di agenti umani sono ora circondati da folle di umani pesantemente equipaggiati che si muovono freneticamente”. Così, “persino i più umili e antichi strumenti di pietra ritrovati nella Gola di Olduvai in Tanzania sono stati trasformati dai paleontologi in mediatori responsabili dell'evoluzione dell'uomo moderno”.
- Per cui il metodo ANT si focalizza sulla “traduzione”: una connessione che veicola trasformazioni, una relazione che non veicola causalità, ma induce la coesistenza di due mediatori.
- Latour confessa che actor-network theory è un’espressione goffa, fonte di enorme confusione. E ne propone diverse, che però hanno avuto scarso successo: ‘sociologia della traduzione’, ‘ontologia dell’attante-rizoma’, ‘sociologia dell’innovazione’, sociologia delle associazioni (o assologia). Tuttavia, è bene mai dimenticare, che “la rete è un concetto, non una cosa là fuori. E’ uno strumento” euristico.
- Per cui, “nutrirsi di controversie costituisce un metodo molto più sicuro” di molti altri usati dalle sociologie convenzionali, le quali “credono in un solo tipo di aggregati sociali, pochi mediatori e molti intermediari; per l’ANT, non esiste un tipo privilegiato di aggregato sociale, bensì un numero infinito di mediatori e la loro trasformazione in intermediari fedeli non è la regola, ma un'eccezione rara”. Questo è uno dei motivi per cui l’ANT “è chiaramente in contrasto con il programma esplicitamente asimmetrico di Weber, che segue una definizione dei mezzi e fini completamente in contrasto con la nozione di mediatori”.
- Inoltre, sempre a differenza delle sociologie convenzionali, “la presenza del sociale deve essere dimostrata di volta in volta, non può mai essere semplicemente postulata”. Le categorie sociologiche tradizionali (potere, società, capitalismo, cultura, identità, genere, classi ecc.) sono “il risultato finale di un processo, e non un serbatoio, una scorta o un capitale che automaticamente fornirà una spiegazione”.
- E, contro un facile determinismo sociologico, esemplifica: “sì, Einstein ha conosciuto una gioventù turbolenta e ha definito la sua teoria ‘rivoluzionaria’ e ‘relativista’, ma ciò non vi conduce fino in fondo al suo uso dell'equazione di Maxwell, solo nei suoi pressi; sì, Pasteur era in qualche modo reazionario e adorava l'imperatrice Eugenia, ma ciò non vi porta molto lontano nella comprensione della sua batteriologia, anche se questi fattori non sono privi di legami col suo rifiuto, per esempio della teoria della generazione spontanea".
- E, facendo sobbalzare sulla sedia il nuovo materialismo, afferma che "la metafisica empirica è ciò a cui conducono le controversie sulla agency, poiché esse popolano incessantemente il mondo di nuove forze e, altrettanto senza sosta, contestano l'esistenza di altre. Questione cruciale diviene allora come esplorare la metafisica degli attori”.
7. TRACCIARE ASSOCIAZIONI
Proviamo, allora, a raccogliere le tessere del puzzle laturiano e a ricomporlo, per individuare una procedura, un percorso, un tragitto metodologico per fare ricerca à la Latour:
- individuare i luoghi delle controversie, dove avviene la fabbricazione dei fatti e la presenza al contempo di proto-fatti;
- seguire i fatti nel corso della loro produzione e “moltiplicare i siti in cui non sono ancora divenuti freddi e abitudinari matters of fact”;
- “esiste soltanto scienza del particolare (...) più dettagli, voglio più dettagli. Dio è nei dettagli, come tutto il resto, compreso il diavolo, diceva Tarde”;
- “si creano gruppi, si esplorano agency e gli oggetti ricoprono un ruolo. Queste sono le tre prime fonti di indeterminazione su cui ci basiamo, se vogliamo seguire il fluido sociale nelle sue forme sempre mutevoli e provvisorie”;
- lo shuttle della Columbia in un istante si è trasformato “dal più complicato dispositivo umano mai assemblato a una pioggia di detriti che si abbatteva sul Texas”; ci si renderà conto della rapidità con cui gli oggetti ribaltano la loro modalità di esistenza”;
- la definizione di ogni gruppo implica anche la compilazione di una lista di anti-gruppi, all’interno di forme di amicizia e inimicizia;
- "non c'è gruppo senza un qualche addetto al reclutamento (…) Nessun gregge di pecore senza un pastore e il suo cane, il suo bastone, le sue pile di certificati di vaccinazione, la sua montagna di scartoffie per ottenere le sovvenzioni dell'UE”;
- occorre “non definire in anticipo il tipo di aggregati sociali che potrebbero fornire il contesto di tutte queste mappe”;
- “gli aggregati sociali non sono oggetto di una definizione ostensiva - come lo sono per esempio tazze, gatti e sedie che si possono additare con l'indice –, ma soltanto di una definizione performativa. Esisterebbero in virtù dei differenti modi in cui si asserisce che esistano”;
- per definizione performativa si intendono "pratiche necessarie per mantenere costanti i gruppi e i contributi fondamentali delle risorse di cui dispone l’osservatore stesso (...) non si può fare a meno di cercare veicoli, attrezzi, strumenti e materiali in grado di produrre una tale stabilità ";
- “se un ballerino smette di danzare, la danza è finita. Nessuna inerzia porterà avanti lo spettacolo. Ecco perché ho dovuto introdurre la distinzione tra ostensivo e performativo”;
- ricercare i mediatori e intermediari, secondo la definizione sopra riportata, concependo l'esistenza di relazioni (ad es.) tra pescatori oceanografi, satelliti e capesante, relazioni tali da far fare agli altri cose inaspettate…
- “le capesante fanno fare cose ai pescatori così come le reti immerse nell'oceano offrono alle capesante l'occasione di attaccarsi alle reti o l'oceanografo mette insieme pescatori e capesante raccogliendo dati (...) il sociale torna sotto forma di associazione (...) seguendo il principio secondo cui tutti gli attori che stiamo per schierare potrebbero essere associati in modo tale da far agire gli altri (...) generando trasformazioni manifestate dai numerosi eventi inattesi innescati negli altri mediatori che li seguono lungo la catena. È ciò che ho chiamato il ‘principio di irriduzione’;
- “un pastore e il suo cane vi ricordano le relazioni sociali ma, quando vedete il suo gregge dietro un recinto di filo spinato, vi chiedete dove siano finiti il pastore e il suo cane — tuttavia, se le pecore rimangono a pascolare nel prato, e perché il filo spinato sostiene l'abbaiare del cane. Non v'è dubbio che siate divenuti pantofolai piantati davanti alla tv grazie soprattutto al telecomando che vi permette di fare zapping da un canale all'altro (…) Provate voi stessi: buttatelo via e vedrete quanto tempo passerete andando avanti e indietro dal divano alla tv”.
- “non c’è nessuno strumento, nessun mezzo, solo mediatori e intermediari;
- evitare “una subitanea accelerazione della descrizione” ricorrendo a parole quali “società”, “potere”, “struttura”, “contesto”;
- l’ANT è una scienza lenta, “come la molteplicità di obiezioni e oggetti di cui bisogna rendere conto seguendo: le catene di associazioni, i mediatori che brulicano a ogni passo, le quattro fonti di incertezza (o indeterminazione)”.
- Per cui: “1) non gruppi, ma raggruppamenti; 2) l’azione è superata; 3) anche gli oggetti possiedono agency; 4) matter of concerns.
Queste quattro fonti devono essere affrontate coraggiosamente, una dopo l'altra; se ne manca una, l'intero progetto crolla”; - “si comincia con assemblaggi, che sembrano vagamente familiari, e si finisce con altrettanti assemblaggi completamente inediti. Il tracciamento delle connessioni sociali è particolarmente complesso”;
- “occorre sempre ampliare la gamma di attori all'opera”;
- “l’ANT non ha semplicemente il compito di stabilizzare il sociale per conto degli attori, ma ‘scoprire’ i nuovi attori inattesi emersi più di recente;
- “il relativismo è un modo di galleggiare sui dati, non di affogarci dentro”;
- “le controversie non sono semplicemente una seccatura da tenere a bada”;
- “la soluzione alle crisi del relativismo e spingersi sempre più lontano nella relatività”;
- “definirei un buon resoconto sociologico, un resoconto che traccia una rete, una catena di azioni in cui ogni partecipante è trattato come mediatore a tutti gli effetti, in cui tutti gli attori fanno qualcosa”;
- quando facciamo le interviste, ascoltiamo le persone che parlano, osserviamo i loro commenti, occorre evitare di “ascoltare distrattamente queste produzioni contorte e ignorare i termini più strani, barocchi e idiosincratici offerti dagli attori. Quando un criminale dice ‘non è colpa mia, ho avuto pessimi genitori’, i sociologici dicono che ‘la società ha lo reso un criminale’ o che ‘sta cercando di sfuggire alla colpevolezza personale, diluendola nell'anonimato della società’. Tuttavia, il criminale non ha detto nulla di simile. Ha semplicemente detto ‘ho avuto pessimi genitori’”;
- “non dobbiamo sostituire a un'espressione sorprendente, ma precisa, il ben noto repertorio della sociologia convenzionale”;
- “Avremo il coraggio di non sostituire un'espressione sconosciuta con una ben nota?”.
Se un pellegrino dice “sono giunto in questo monastero perché la Vergine Maria mi ha chiamato”, dobbiamo prenderlo sul serio e non sostituire subito “l'agency della Vergine con l’illusione”, il pretesto, l’infatuazione ecc. come farebbero i sociologi tradizionali; - parlando di amore, i poemi sono pieni del "corteo ininterrotto di angeli, cherubini, putti e frecce, la cui esistenza oggettiva, sì oggettiva, dovrebbe anche essere presa in considerazione";
- dobbiamo “rispettare la metafisica di un mugnaio”, così sorprendentemente ben descritta dallo storico italiano Carlo Ginzburg ne Il formaggio e i vermi…
- “l’ANT è semplicemente la teoria sociale che ha scelto di affidarsi agli indigeni, ai locali, non importa in quali bizzarri imbrogli metafisici essi ci conducono”;
- “sebbene non sappiamo mai con certezza chi e cosa ci faccia agire, le ragioni le possiamo trovare nei resoconti degli attori. Le agency sono sempre presentate in un resoconto (account).
8. CON LATOUR, OLTRE LATOUR
Ora, a mio avviso, con queste indicazioni metodologiche, si possono studiare in modo innovativo, serio e documentato tutti i temi che si vogliono, anche quelli più controversi, come (ad es.) l’esitazione vaccinale, i movimenti no TAV o no 5G, le pazienti che si affidano a cura omeopatiche, coloro che credono nelle scie chimiche, le persone critiche nei confronti delle cause antropiche dei cambiamenti climatici ecc.
Evitando di emulare le giornaliste e le esperte di tutto, lasciando alle sociologhe convenzionali (la “sociologia del sociale”, la chiamerebbe Latour) il pesante bagaglio di termini e concetti stucchevoli come ‘populismo’, anti-scientifico’, ‘pseudoscienza’, ‘destra e sinistra’, ‘vero/falso’ ecc. che poco hanno di empirico e molto pregiudizio.
Come ricorda Latour, “non spetta agli scienziati sociali risolvere le controversie”, dire chi ha ragione o torto, chi sono le babbee che credono alle fake news e chi sono le intelligenti che, invece, si fidano del parere delle esperte che decorano i talk show. Perché, la sociologa ANT non è una intellettuale organica o, come scrive Latour, “un intellectuel engage”.
Peccato, però, che egli non abbia avuto il coraggio o la voglia di dirle quelle cose, prima di morire…
BIBLIOGRAFIA
Berger, Peter L. (1963), trad. it. Invito alla sociologia, Venezia: Marsilio.
Descola, Philippe (2005), trad. it. Oltre natura e cultura, Milano: Cortina, 2014.
Fleck, Ludwik (1935), trad. it. Genesi e sviluppo di un fatto scientifico, Bologna: Il Mulino
Ginzburg, Carlo (1976), Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del Cinquecento, Torino, Einaudi.
James, William (1890), trad. it. Principi di Psicologia, Milano: Società Editrice Libraria, 1909.
Latour, Bruno (2005), tr. Riassemblare il sociale, Milano: Meltemi, 2022.
Sloterdijk, Peter (1998), trad. it. Sfere / Bolle vol. 1, Milano: Meltemi 2009.
Sloterdijk, Peter (1999), trad. it. Sfere / Globi vol. 2., Milano Cortina, 2014.
Sloterdijk, Peter (2004), trad. it. Sfere / Schiume vol. 3., Milano: Cortina, 2015.
Tarde, Gabriel (1894), La logique sociale, Paris: Alcan.
Decalogo Latouriano – Il pensiero meno noto di Bruno Latour, Seconda parte
Nella prima parte di questo percorso attraverso le parti meno note e utilizzata dell’approccio di Bruno Latour al sociale, alle scienze e alle tecnologie, ho affrontato:
- il legame profondo tra oggetti della scienza e società, in cui – secondo Latour – sono i primi a spiegare la seconda (Il sociale, la società e la sociologia) e
- la critica di Latour alle sociologie interpretative, all’empirismo storico, al riduzionismo e – pare fin troppo ovvio – al positivismo, dichiarandosi “oggettivista”, “realista” e “relativista” nello stesso tempo.
Questa seconda parte del percorso è dedicata al costruzionismo di Latour e al concetto di attanti.
3. IL COSTRUZIONISMO
- Secondo Latour, le espressioni “costruttivismo sociale” e “costruzione sociale dei fatti scientifici” sono state infelici, un’autentica sciagura. Infatti il termine ‘sociale’ (che come abbiamo visto sopra, lui vuole abolire) si è prestato a tanti malintesi e la parola ‘costruzione’ ha scatenato una confusione ancor più grande.
- Egli confessa: “ci siamo resi conto che, per altri colleghi delle scienze sociali e naturali, la parola ‘costruzione’ significava qualcosa di completamente diverso da ciò che il senso comune aveva considerato fino ad allora. Dire che qualcosa era ‘costruito’ significava, nella loro mente, che qualcosa non era vero".
- Ma, "nessun scienziato di laboratorio si è mai confrontato con un oggetto ‘dato’ indipendentemente dal lavoro necessario per ‘renderlo visibile’; quindi perché comportarsi come se l’alternativa tra ‘realismo’ e ‘costruttivismo’ fosse interessante?”.
- “Sebbene il costruttivismo fosse per noi sinonimo di più realismo, siamo stati acclamati dai nostri colleghi come se avessimo finalmente dimostrato che ‘persino la scienza è una balla’! (...) Senza volerlo, il costruttivismo era divenuto sinonimo del suo opposto: la decostruzione”.
- Latour ha sempre voluto evitare l’espressione ‘costruttivismo sociale’: “come una repubblica socialista o islamica è l'opposto di una repubblica, aggiungere l'aggettivo ‘sociale’ a ‘costruttivismo’ snatura completamente il suo significato. In altre parole, il ‘costruttivismo’ non deve essere confuso con il ‘costruttivismo sociale’ che ne è l'opposto (…) Il ‘costruttivismo sociale’ implica sostituire ciò di cui è fatta questa realtà con qualche altra cosa, il sociale di cui sarebbe ‘realmente’ composta”.
4. GLI ATTANTI
- Secondo Latour occorre dire addio alla nozione di ‘attore’, come soggetto in carne ed ossa. Infatti, “bisogna assemblare un gran numero di agency affinché un attore diventi un individuo”.
- Usando un parallelo (che però Latour non fa nel suo libro, ma che mi sembra in linea con il suo pensiero) potremmo dire che mentre le genetiste affermano che ognuna di noi è unica grazie al suo DNA, le sociologhe invece potrebbero sostenere che ciascuna di noi è diversa perché nessuna ha avuto le stesse interazioni sociali.
- William James potrebbe essere d’accordo, perché secondo Latour egli “ha magnificamente dimostrato, che è moltiplicando le connessioni con l'esterno che c'è qualche possibilità di comprendere come la nostra interiorità sia stata composta. Bisogna sottoscrivere un gran numero di soggettivatori per divenire un soggetto. Per cui nessuno sa quante persone sono simultaneamente all'opera in un dato individuo”.
- Inoltre, Latour ammette che “usiamo il termine ‘non-umani’ in mancanza di un termine migliore; ma in realtà questa espressione è priva di senso perché dobbiamo elevare gli oggetti al rango di attori a pieno titolo”.
- E indispettito, puntualizza: “L’ANT non è - ripeto, non è – l’istituzione di qualche assurda simmetria tra umani e non umani (…) l’ANT non è interessata soltanto a liberare gli attori umani dalla prigione del sociale, ma a offrire anche agli oggetti naturali l'occasione di sfuggire all’angusto isolamento a cui il primo empirismo condanna le matters of fact (cioè quelle che vengono considerate cose, condizioni o stati permanenti). Infatti, in accordo con l’antropologo francese Philippe Descola, egli insiste: "dobbiamo ricordare che essere una matter of fact non è un modo di esistenza ‘naturale’, ma, stranamente, un antropomorfismo. Cose, sedie, gatti, tappeti e buchi neri non si comportano mai come matters of fact”.
- Il positivismo è sbagliato politicamente, perché ha ridotto troppo in fretta le matters of concerns (processi, stati transitori, movimenti) a matters of facts, e senza un giusto processo”. E, come ANT, "il nostro tocco distintivo consiste semplicemente nel sottolineare i meccanismi di stabilizzazione, al fine di contrastare la trasformazione prematura di matters of concern in matters of fact”.
- Anche se lui, l’ha più volte ripetuto, non ha alcuna simpatia per le sociologie interpretative, tuttavia si oppone a una atteggiamento naturalista perché “gli oggetti potrebbero sembrare un po’ più complicati, multipli, complessi e intricati di quanto gli ‘oggettivisti’ vorrebbero farci credere”.
- Gli oggetti sono fatti di strati multipli, esattamente come sono le persone. Per cui “tutta questa opposizione tra ‘punto di vista’ e ‘nessun luogo’ la si può completamente dimenticare. E pure questa differenza tra ‘interpretativo’ [ermeneutica] e ‘oggettivista’. Se si possono avere punti differenti su una statua, è perché la statua stessa è in tre dimensioni e ci permette di muoversi intorno a essa”. Infatti, “nessun edificio è mai visibile in toto, in qualsiasi punto della sua costruzione e del suo utilizzo”.
- “E’ la cosa stessa che può dispiegare la sua molteplicità, il che consente di apprenderla a partire da diversi punti di vista prima di essere eventualmente unificata in una fase successiva a seconda delle capacità del collettivo”.
- “Questa è anche la linea di demarcazione tra il postmodernismo e l’ANT, che considera la molteplicità una proprietà delle cose, e non solo degli umani che interpretano le cose”.
- A tal proposito, Latour critica i sociologi che “per ritagliarsi una piccola nicchia, hanno abbandonato all’inizio del XIX secolo, le cose e gli oggetti agli scienziati e agli ingegneri”.
BIBLIOGRAFIA
Berger, Peter L. (1963), trad. it. Invito alla sociologia, Venezia: Marsilio.
Descola, Philippe (2005), trad. it. Oltre natura e cultura, Milano: Cortina, 2014.
Fleck, Ludwik (1935), trad. it. Genesi e sviluppo di un fatto scientifico, Bologna: Il Mulino
Ginzburg, Carlo (1976), Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del Cinquecento, Torino, Einaudi.
James, William (1890), trad. it. Principi di Psicologia, Milano: Società Editrice Libraria, 1909.
Latour, Bruno (2005), tr. Riassemblare il sociale, Milano: Meltemi, 2022.
Sloterdijk, Peter (1998), trad. it. Sfere / Bolle vol. 1, Milano: Meltemi 2009.
Sloterdijk, Peter (1999), trad. it. Sfere / Globi vol. 2., Milano Cortina, 2014.
Sloterdijk, Peter (2004), trad. it. Sfere / Schiume vol. 3., Milano: Cortina, 2015.
Tarde, Gabriel (1894), La logique sociale, Paris: Alcan.
Il tempo schermo - La contesa dell’attenzione
Che cosa succede all'attenzione quando stanno tanto tempo davanti a uno schermo?
Sembra che bambini e bambine siano più calmi e più attenti, ma è davvero così? Il tipo di attenzione che viene mobilitata davanti allo schermo non è la stesso che si mobilita nella lettura di un libro o nel dover maneggiare degli oggetti fragili. Gli studi scientifici dell’ultimo secolo ci spiegano molto di come funzionino i processi attenzionali, e gli studi di questo secolo sul tempo schermo ci spiegano non solo perché lo schermo non sviluppa l’attenzione utile a scuola, ma perché limiti il potenziale di apprendimento umano specialmente nei primi mille giorni di vita ma in generale in tutto il periodo dello sviluppo se l’uso è intenso, come consigliato ormai da pediatri di molte parti del mondo, compresa la Società Italiana di Pediatria.
Gli effetti del tempo schermo includono anche l'esposizione agli schermi indiretti. Da ormai una ventina d’anni gli studi hanno misurato l’impatto degli schermi nella diminuzione delle interazioni verbali, non verbali e di gioco nei primi quattro anni con diversi studi sperimentali su coppie di genitori con bambino che restavano con lo schermo spento e con lo schermo acceso in diverse situazioni. Registrati i comportamenti, si è scoperto che lo schermo diminuiva le interazioni verbali e non verbali e l’attenzione focalizzata su dei giocattoli, aumentando invece le interruzioni di gioco (Anderson e Pempek, 2005). Più recenti esperimenti hanno osservato che i genitori che usano lo smartphone in presenza dei loro bambini durante dei pranzi hanno una minor interazione (rispetto ai genitori che non lo usano) cioè disattivano il canale attenzionale non verbale (Radesky et al. 2014). Il fatto di ricevere attenzione e di prestare attenzione sono infatti fenomeni collegati perché nell’infanzia lo sviluppo dell’attenzione congiunta (dai 6 ai 24 mesi) è il prerequisito per lo sviluppo del linguaggio.
Per capire meglio l’effetto negativo dello schermo è utile soffermarsi sulla distinzione tra comprensione e apprendimento. Un video permette la comprensione di parole e contenuti già noti e già appresi ma molto difficilmente, e con molte condizioni particolari, ma soprattutto rarissimamente nei primi sei anni di vita, il video facilita l’apprendimento di parole e ne abilità nuove. Nei primi tre anni un bambino esplora con i cinque sensi il mondo circostante, prende con le mani, porta alla bocca, ascolta e usa tutti i suoi sensi per apprendere. Soprattutto però impara attraverso il fenomeno dell’attenzione congiunta, o joint attention, che è la capacità di coordinare l’attenzione tra due persone e un oggetto o evento, richiedendo un impegno continuo di entrambi. Questo processo è stato ampiamente studiato poiché rappresenta un indicatore dello sviluppo psicomotorio infantile, oltre a predire la qualità delle relazioni di attaccamento e delle interazioni sociali future. Il biologo Michael Tomasello la descrive come la capacità specie specifica, cioè propriamente umana, alla base del linguaggio, della cooperazione, della morale umana. Per svilupparsi, l’attenzione congiunta si basa su elementi fondamentali come l’aggancio oculare, il contatto visivo e la "sintonizzazione degli affetti" (Stern), prerequisiti essenziali per le capacità comunicative e per lo sviluppo della teoria della mente — la capacità, tipica di un bambino di quattro anni, di comprendere il punto di vista di un’altra persona (Aubineau et al., 2015). La forma più avanzata, l’attenzione congiunta coordinata, implica che il bambino si impegni attivamente sia con un adulto sia con un oggetto.
Negli ultimi vent’anni molti dati sono stati inoltre stati raccolti per descrivere il video deficit effect, indicando come gli schermi possano ostacolare l'apprendimento, a partire dall'apprendimento fonetico e linguistico nei primi quattro anni. Sebbene tramite schermi si possano comprendere alcuni contenuti adeguati all'età (specialmente con l'aiuto dei genitori) diverso è il caso dell’apprendimento (che è un passo ulteriore rispetto alla mera comprensione di una storia) perché l'attenzione è profondamente diversa di fronte a un altro essere umano: dal vivo o in presenza si attiva l’attenzione emotiva, multisensoriale. L’attenzione mobilitata dagli schermi è molto spesso di tipo bottom-up: è la medesima mobilitata in tutti gli animali di fronte a forti luci e suoni, di fronte a pericoli. Diversi neuroscienziati distinguono un’attenzione di tipo top-down (dal centro alla periferia), da una botton-up (dalla periferia al centro). L’individuo è attraversato continuamente da stimoli esterni e interni difficili da distinguere, dove l’attenzione è letteralmente contesa all’interno dell’individuo: “L’attenzione si orienta spontaneamente verso elementi naturali esterni più attraenti come le pubblicità o i video-schermi” (Lachaux 2012, p. 249). L’attenzione viene contesa da diverse forze, da diversi oggetti, ma è lecito parlare di attenzione esogena , quando prevale lo stimolo esterno, e attenzione endogena, quando prevale lo stimolo interno – una sorta di “controllo volontario dell’attenzione”. Sicuramente cosa sia esattamente l’attenzione – che non è la volontà - non è facile da stabilire e gli approcci socio-antropologici ci ricordano la costruzione sociale di tale dimensione (Campo 2022).
In ogni caso disponiamo di numerosi studi che rilevano una correlazione tra l'uso precoce e prolungato degli schermi e problemi di attenzione successivi. Quello di Tamana del 2019 è uno dei più citati studi longitudinali: ha esaminato circa 2500 bambini/e canadesi dai 3 ai 5 anni, evidenziando come un tempo schermo superiore alle 2 ore giornaliere aumentasse il rischio di problemi di attenzione negli anni successivi. La relazione tra l'uso degli schermi e il disturbo da deficit di attenzione (ADHD) è stata messa in discussione nonostante già Christakis avesse evidenziato la presenza di una correlazione tra un’alta esposizione agli schermi e un alto rischio di problemi di linguaggio e di attenzione (Christakis, 2005, 2007). La maggior parte degli studi di neuropsicologia evidenzia cause epigenetiche per il disturbo da deficit di attenzione, nonostante l'aumento globale delle diagnosi negli ultimi vent'anni; in generale tra gli specialisti c’è molta resistenza a parlare di cause ambientali per ADHD anzi gli schermi vengono ancora spesso prescritti spesso nelle prognosi di bambini con DSA o con diagnosi di ADHD. L’idea che un tempo schermo precoce e prolungato possa aumentare i rischi di generici problemi di attenzione o patologie diagnosticate come ADHD è però avanzata da studi recenti sempre più inclini a considerare tale uso come un fattore significativo. Anche uno studio longitudinale di Madigan ha concluso che sono gli schermi a causare i problemi di attenzione e non viceversa: una maggiore quantità di tempo schermo a 24 mesi d’età è stata associata a prestazioni più scarse nei test di valutazione successivi. Analogamente, un maggiore tempo trascorso davanti allo schermo a 36 mesi è stato correlato a punteggi più bassi nei test dello sviluppo cognitivo a 60 mesi. L’associazione inversa, invece, non è stata osservata (Madigan et al., 2019). Un recente metastudio (Eirich et al., 2022) segnala la correlazione tra un uso precoce e prolungato degli schermi e i successivi problemi di attenzione in bambini/e di età pari e inferiore a un anno nella maggior parte degli studi esaminati.[1]
Le app e gli algoritmi che alimentano la fruizione degli schermi sono progettati deliberatamente per mantenere i bambini attaccati agli schermi il più a lungo possibile, non per fornire programmi educativi. Questo è descritto molto bene dai formatori dei vettori commerciali denominati app, come si può evincere dal brillante saggio di uno di questi formatori, Nir Eyal. L’aumento dell'impulsività e la cattura dell’attenzione sono gli obiettivi dichiarati dagli agenti del marketing che per tale fine mettono a disposizione piattaforme gratuite: quando bambini e bambine anziché fare i compiti o leggere o giocare fra loro passano ore davanti allo schermo questi proprietari delle app aumentano i loro profitti. Basta guardare chi sono le persone più ricche al mondo e l’incidenza del pubblico giovanile. Incapaci di mantenere la concentrazione su attività prolungate i “bambini digitali” sono sempre più esigenti e conformati in materia di consumi.
Sempre più esperti sollevano il dubbio se la “generazione digitale” non stia affrontando un problema specifico. Anche senza una dimostrazione di causalità con l'ADHD, il tempo schermo è un fattore che amplifica l’impulsività, la disattenzione e la distraibilità. Dopo il Covid-19, molti insegnanti segnalano uno stato diffuso di distraibilità permanente. Le prove si accumulano, e ignorare il fenomeno non aiuta a iniziare a risolvere il problema. Si parla sempre più spesso di “attenzione frammentaria” per descrivere questa nuova sfida educativa e sociale o altri termini quali: “attenzione disrupted” (interrotta e distratta), “attenzione parziale continua”, “attenzione spezzetata”. Non è certamente quella virtù propria del multitasking attribuita a torto ai “nativi digitali” con il concetto equivoco di “iperattenzione”, che trasformava i bambine/i iperattive/i e impulsive/i in bambine/i capaci di nuove “qualità attentive” (Hayles). Dobbiamo prendere atto che gli schermi stanno precludendo la possibilità di sviluppare un’attenzione umana cooperativa e congiunta. L’isolamento e la disgiunzione dell’attenzione non ha un impatto solo cognitivo ma anche emotivo e relazionale. Non siamo di fronte a una generazione ansiosa, ma a una generazione oppressa. Gli schermi schermano le relazioni, si frappongono tra uno sguardo e l’altro, interrompono l’attenzione congiunta.
In conclusione gli schermi amplificano negativamente tutte le dimensioni dell’attenzione. Un uso prolungato e precoce agisce su un ampio spettro, amplificando disattenzione (causata da stanchezza), distrazione (stimoli esterni), distraibilità (tendenza acquisita a distrarsi) e, in casi estremi, disabilità attentiva (ADHD). Ridurre il tempo schermo, invece, migliora l’attenzione e i risultati scolastici. Molti insegnanti con anni di esperienza segnalano un declino significativo nelle capacità attentive degli studenti. È come se su questo pianeta fosse arrivato un pifferaio magico e i nostri bambini e bambine non potessero fare a meno di seguirlo con in mano il loro cellulare. Questo pifferaio ha aumentato il tempo schermo nell’infanzia, ma ha diminuito il tempo di sonno, il tempo di lettura e soprattutto il tempo di gioco, e altre temporalità essenziali per l’apprendimento.
Ma è davvero così? Le famiglie ricche e figli e le figlie di ingegneri della Silicon Valley vengono protette/i e non abbandonate/i davanti agli schermi.
Questo fenomeno è molto più diffuso nelle classi povere. E allora non è forse lecito parlare di una vera e propria contesa dell’attenzione? È forse venuto il tempo di prendere consapevolezza per riportare l’attenzione al centro dei processi educativi senza delegarlo al tempo schermo.
NOTE
[1] Per una ampia bibliografia il testo tradotto in italiano più completo è Desmurget M. (2020) Il cretino digitale. Difendiamo i nostri figli dai veri pericoli del web, Rizzoli, Milano. Mi sia permesso rimandare al mio saggio: L’attenzione contesa, come il tempo schermo modifica l’infanzia, Armando, Roma.
Gli algoritmi del Covid-19 – Un caso di tecnocrazia?
La gestione della pandemia SARS-CoV-2 è stata, molto probabilmente, un caso emblematico di tecnocrazia, in cui la politica ha abdicato al suo ruolo di decisione per il bene pubblico a favore delle competenze tecnoscientifiche, in particolare mediche ed epidemiologiche, e delle linee di comportamento dettate dal Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla Protezione Civile[1] e, spesso, con scarsissima o nessuna trasparenza.
L’algoritmo studiato dal CTS, nell’aprile del 2020, per misurare l’andamento del contagio e valutare se procedere con la fase di riaperture sembra essere un esempio lampante di questa tecnocrazia: è uno strumento complesso e fortemente tecnico, “detta” - di fatto – al governo quali comportamenti tenere e, infine, è rimasto praticamente celato all’interno dei decreti, non ne è stata data alcuna pubblicità né è stato possibile discuterne democraticamente
Proverò, in questo articolo, a far conoscere e ad esaminare criticamente i contenuti di questo algoritmo, e in quello successivo (che sarà pubblicato da Controversie la prossima settimana) a mostrare quale sia stato il suo ruolo e se, in questo caso, la politica abbia effettivamente ceduto la mano alla tecnoscienza. Con, forse, qualche sorpresa.
INQUADRAMENTO STORICO
Siamo alla fine di aprile del 2020, a un mese e mezzo dalla dichiarazione di pandemia di Covid-19[2], la situazione pandemica – datata 26 aprile – nel mondo e in Italia è questa:
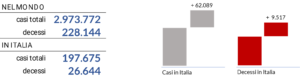
Il picco di contagi[3] è stato registrato da pochi giorni, il 20 aprile, e per la prima volta dall'inizio dell'epidemia, l'Italia registra una diminuzione nel numero degli “attualmente positivi”: 20 in meno del giorno precedente, per un totale di 108.237. Anche i ricoveri e le terapie intensive sono in calo; dalla prima settimana di aprile, infatti, i contagi giornalieri seguono una curva sensibilmente discendente, come si può vedere dal grafico del bollettino di “Aggiornamento nazionale, 28 aprile 2020”[4]
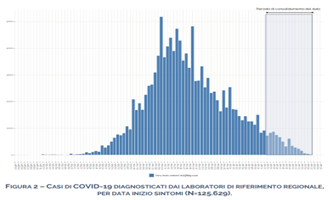 Lo stesso sembra valere – pur con tutte le cautele di attribuzione delle cause – per il numero di decessi. Sono segnali che suggeriscono che le misure contro la diffusione del virus prese dal Governo stiano funzionando, come dice Giuseppe Conte – Presidente del Consiglio dei Ministri del governo giallo-rosso[5] - nella conferenza stampa del 26 aprile: “stiamo riuscendo a contenere la diffusione della pandemia”.[6]
Lo stesso sembra valere – pur con tutte le cautele di attribuzione delle cause – per il numero di decessi. Sono segnali che suggeriscono che le misure contro la diffusione del virus prese dal Governo stiano funzionando, come dice Giuseppe Conte – Presidente del Consiglio dei Ministri del governo giallo-rosso[5] - nella conferenza stampa del 26 aprile: “stiamo riuscendo a contenere la diffusione della pandemia”.[6]
L’interpretazione di questo segnale orienta la prospettiva di attivazione della cosiddetta Fase 2, cioè della progressiva riapertura delle attività produttive, pur mantenendo ancora restrizioni rigorose per evitare una contestuale ripresa della diffusione del contagio.
Il Presidente del Consiglio Conte annuncia[7] che, a partire dal 4 maggio - posto che la curva dei contagi mantenga il trend decrescente – inizierà la Fase 2, caratterizzata, a grandi linee, dalla progressiva riapertura delle attività produttive e commerciali, dall’allentamento di alcune delle restrizioni e dallo sblocco dei cantieri[8].
Che si mantenga il trend decrescente è, quindi, la condizione per procedere con la fase di alleggerimento delle misure di contenimento del contagio.
UN ALGORITMO PER MISURARE L’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA
Questa condizione di trend decrescente della curva dei contagi diventa, quindi, oggetto di un problema di misurazione il più possibile oggettiva, sulla base della quale il governo possa prendere delle decisioni, se è possibile passare alla Fase 2, se si può restare in Fase 2 una volta effettuata la transizione, oppure se è il caso di tornare al livello di massimo rigore, quello del lockdown (Fase 1).
Serve uno strumento di valutazione del contagio e delle possibilità di contrastarlo in termini puntuali e di andamento. Ossia momento per momento e potendo confrontare nel tempo dei valori puntuali.
Questo strumento di misurazione è contenuto in parte nell’Allegato 10 al DCPM 26 aprile 2020 “Principi per il monitoraggio del rischio sanitario” e in parte nell’allegato DM3042020 al Decreto 30 aprile 2020 del Ministero della Salute.
Si tratta di 21 indicatori di processo e di risultato, ossia criteri di valutazione puntuale[9] dello stato delle cose con delle soglie di allerta per singolo indicatore o per gruppi di indicatori. Sulla base dei valori degli indicatori sono predisposti inoltre due algoritmi. Il primo restituisce il livello di rischio puntuale, il secondo la Fase più opportuna per quelle condizioni di rischio. Fase da intendersi come il grado di rigore delle misure di contenimento, determinata in modo esplicito e apparentemente deterministico e oggettivo.
Il processo di valutazione prevede, quindi,
- la misurazione di almeno 16 indicatori con frequenza per lo più settimanale
- il confronto con i valori precedenti per comprendere se il trend è favorevole o meno per il passaggio alla fase meno rigorosa
- l’elaborazione di una parte questi andamenti in un primo sub-algoritmo che restituisce la probabilità della minaccia sanitaria, ossia quanto è probabile che si verifichi una «trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2» e di una altra parte degli andamenti in un secondo sub-algoritmo che restituisce l’impatto, «ovvero la gravità della patologia con particolare attenzione a quella osservata in soggetti con età superiore a 50 anni»
- la combinazione di probabilità (di trasmissione) e di impatto (gravità della diffusione) in una matrice a doppia entrata per determinare il livello di rischio;
- infine, l’elaborazione degli indicatori e degli andamenti nel secondo algoritmo, indica “cosa fare”, ossia se sia possibile passare alla Fase 2[10]
Per comprendere il funzionamento degli algoritmi, è opportuno fare tre approfondimenti: il primo sugli indicatori, il secondo sul senso attribuito dal Ministero della Salute al livello di rischio calcolato con il primo algoritmo e il terzo sul funzionamento dell’algoritmo che determina se sia possibile passare alla Fase 2.
INDICATORI DELL’ANDAMENTO DEL CONTAGIO E DEI PROCESSI DI CONTENIMENTO
Gli indicatori coinvolti nello strumento di misurazione sono raggruppati in tre gruppi, il primo, di 6 indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio dei contagi:
- in particolare, della disponibilità delle date di inizio - dei casi sintomatici, dei ricoveri in ospedale e dei trasferimenti in terapia intensiva - e della presenza del dato del comune di residenza
Il secondo gruppo di 6 indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti, che comprende:
- dati quali la percentuale di tamponi positivi (sul totale di tamponi effettuati), i tempi trascorsi tra inizio dei sintomi, diagnosi ed eventuale isolamento;
- e dati che riguardano la consistenza del personale dedicato al tracciamento dei contatti, al monitoraggio dei contatti stretti - idealmente allineati agli standard
raccomandati a livello europeo - e alla percentuale di indagini epidemiologiche sui casi tracciati.
Il terzo gruppo, infine, di 9 indicatori di risultato relativi alla stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari che contano – il dettaglio qui sembra essere necessario:
- il numero di casi riportati alla Protezione Civile, alla sorveglianza sentinella COVID-net e alla sorveglianza integrata COVID-19 (per data diagnosi e per data inizio sintomi);
- il numero di nuovi focolai di trasmissione;
- il numero di nuovi casi di infezione per Regione non associati a catene di trasmissione note;
- due indicatori sull’Rt calcolato[11], per data inizio sintomi e per data di ospedalizzazione;
- il numero di accessi al PS con quadri sindromici riconducibili a COVID-19;
- il tasso di occupazione delle Terapie Intensive per pazienti COVID-19;
- il tasso di occupazione dei posti letto totali per pazienti COVID-19.
I primi 12 indicatori dovrebbero misurare quanto l’apparato sanitario è in grado di avere un quadro preciso del contagio, delle diagnosi, della gestione dei contatti; si potrebbero considerare, quindi, dei meta-indicatori della validità della misurazione.
Solo gli ultimi 9, invece, fanno riferimento alla dimensione effettiva del contagio, della trasmissione e della capacità delle strutture locali e regionali di farvi fronte.
SENSO DEL PRIMO ALGORITMO DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
I due sub-algoritmi di determinazione della probabilità e dell’impatto della minaccia di trasmissione incontrollata sono molto semplici e ne riporto di seguito lo schema[12] del Comitato Tecnico Scientifico:
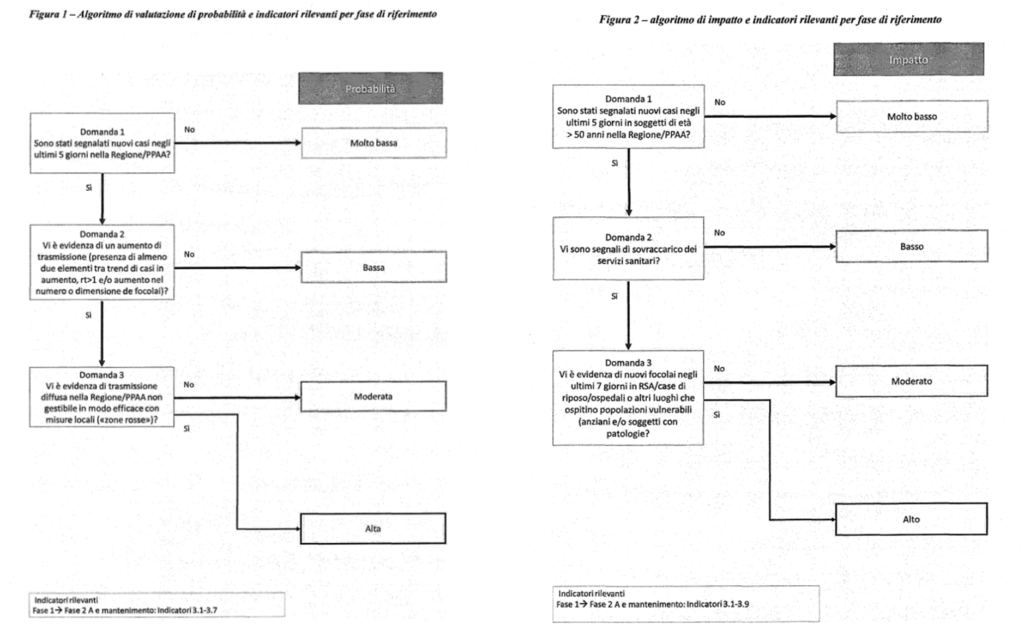
Lo stesso vale per la matrice di determinazione del rischio che combina i livelli di probabilità e di impatto[13]:
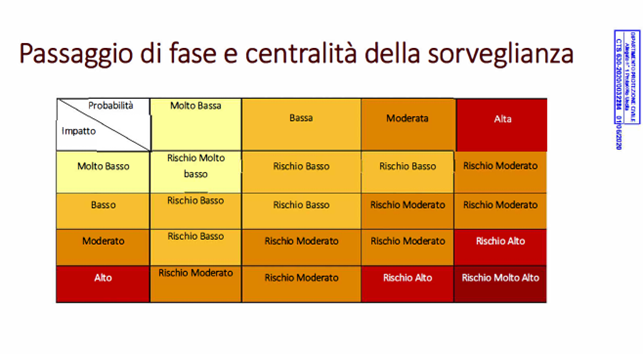 Questa valutazione del rischio non concorre direttamente alla determinazione della possibilità di passare alla Fase 2 (o di restarci, una volta effettuata la transizione) ma ha esclusivamente il senso di sistema di allerta, per attivare la “marcia indietro” dalla Fase 2 verso un inasprimento delle «misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive» in caso di «rischio alto/molto alto» o di «rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto».
Questa valutazione del rischio non concorre direttamente alla determinazione della possibilità di passare alla Fase 2 (o di restarci, una volta effettuata la transizione) ma ha esclusivamente il senso di sistema di allerta, per attivare la “marcia indietro” dalla Fase 2 verso un inasprimento delle «misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive» in caso di «rischio alto/molto alto» o di «rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto».
In questo quadro funzionale, il Decreto del 30 aprile sottolinea che. se non è possibile misurare gli indicatori alla base dell’algoritmo, la valutazione del livello di rischio va considerata elevata[14].
ALGORITMO DI VALUTAZIONE PER LA TRANSIZIONE ALLA FASE 2
Questo secondo algoritmo – allegato 10 al DCPM del 26 aprile 2020 e definito nel Decreto come strumento per individuare il rischio sanitario[15] – impone, perché sia possibile la transizione alla Fase 2, che:
- siano presenti gli standard minimi di qualità della sorveglianza epidemiologica nella Regione – ossia che almeno per il 50% dei casi segnalati siano disponibili la data di inizio dei sintomi o del ricovero (in terapia intensiva e non) e l’indirizzo di domicilio[16]
- la trasmissione di COVID-19 nella Regione (o zona) sia stabile o in decremento – ossia che gli indicatori del terzo gruppo siano in miglioramento o stabili (il numero di casi segnalati e il numero di focolai di trasmissione siamo in diminuzione, l’ Rt sia ≤ 1)
- siano soddisfatti «gli altri criteri» di valutazione, che comprendono il livello di saturazione delle strutture ospedaliere, standard e di terapia intensiva, la abilità di testare i casi sospetti, la prontezza operativa e la disponibilità di risorse per il tracciamento dei contatti (che possono essere ricondotti al secondo gruppo di indicatori)
Se tutti questi criteri sono soddisfatti, il Decreto dice che è possibile allentare le misure di contenimento dei contagi e iniziare un primo passo di normalizzazione, la Fase 2A (oppure mantenere le condizioni della Fase 2A e attendere più serenamente[17] l’arrivo dei vaccini sicuri e affidabili).
----------------
La transizione avvenne, per mano del Presidente del Consiglio Conte, con decisione di realizzare il piano di riaperture dal 4 maggio 2020 in poi.
Ma, come vedremo nel seguito, forse gli algoritmi di valutazione – vuoi per alcune aree di debolezza e di inconsistenza sia interna che contestuale - ebbero un ruolo meno importante del previsto in questa decisione.
NOTE
[1] «Con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020, è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il superamento dell’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus. Il Comitato è composto da esperti e qualificati rappresentati degli Enti e Amministrazioni dello Stato.» Ministero della Salute, Portale Covid 19
[2] «Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus», OMS, Health topics, Coronavirus disease (COVID-19)
[3] Dati Epicentro-ISS e grafiche da Cose che noi umani, Lab24, 2021 (https://lab24.ilsole24ore.com/storia-coronavirus/)
[4] Epidemia COVID-19 Aggiornamento nazionale, 28 aprile 2020 – ore 16:00, Epidemia COVID-19
Aggiornamento nazionale 28 aprile 2020 – ore 16:00 (https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-Covid-19_28-aprile-2020.pdf)
[5] Il governo cosiddetto Conte II è sostenuto da una coalizione di forze di centro-sinistra che comprende il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, Liberi E Uguali (LEU) - lista elettorale nata dall'alleanza tra i partiti Articolo Uno, Sinistra Italiana e Possibile - e Italia Viva, più una serie di piccole entità politiche, sempre di centro-sinistra; Le altre forze che appoggiano il governo Conte II nel primo semestre del 2020 sono: il Movimento Associativo Italiani all'Estero e – in forma di appoggio esterno, il Partito Socialista Italiano, il Südtiroler Volkspartei, l’ Union Valdôtaine, il Partito Autonomista Trentino Tirolese, Centristi per l’Europa, Centro Democratico e Sicilia Futura
[6] Fase due, conferenza stampa del Presidente Conte, YouTube - Palazzo Chigi, Canale ufficiale del Governo italiano (26 aprile 2020, https://www.youtube.com/watch?v=tXxQBLNZZqA)
[7] Il discorso di Conte del 26 aprile ricorda che non si può abbassare la guardia e che l’attenzione alle misure di sicurezza deve essere ancora mantenuta: «evitare il rischio che il contagio si diffonda […] come lo puoi fare? non bisogna mai avvicinarsi, bisogna rispettare distanze in sicurezza almeno un metro, questo è fondamentale e, guardate, anche nelle relazioni familiari con i parenti bisogna stare attenti». Ibidem.
[8] La tematica delle attività produttive è lo snodo della tensione tra governo e opposizioni. Ne ho parlato diffusamente nella mia tesi magistrale.
[9] Puntuale va inteso come: in un determinato momento, tipicamente quello della misurazione
[10] La versione più generale dell’algoritmo contenuta nell’Allegato 10 al DPCM 26 aprile 2020 comprende anche i passaggi alla fase 2B o “Transizione avanzata”, sulla base dei medesimi criteri ma di cui non sono esplicitate le soglie obiettivo, e del passaggio alla Fase 3, di ripristino (si può pensare: delle condizioni di normalità), subordinata all’«accesso diffuso a trattamenti e/o ad un vaccino sicuro ed efficacie». Ma anche questa è un’altra storia.
[11] Numero di riproduzione netto, ossia numero medio di infezioni trasmesse da ogni individuo infetto nel tempo, cfr. R0, Rt: cosa sono, come si calcolano?, Istituto Superiore di Sanità. Sulla consistenza e validità del Rt come strumento di misura della trasmissione ci sono state ampie polemiche, cfr., ad esempio, Wired 5 maggio 2021, Corriere della Sera, 11 maggio 2021
[12] Fonte: Verbale n. 83, 29 maggio 2020, Riunione del Comitato Tecnico Scientifico, Dipartimento della Protezione Civile
[13] Cit.
[14] «Se non sarà possibile una valutazione [degli indicatori, NdA] secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di una situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile», Decreto 30 aprile 2020 del Ministero della Salute
[15]«rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10», DCPM del 26 aprile 2020
[16] La soglia del 50% vale per le prime tre settimane di maggio 2020; successivamente la soglia sarà innalzata al 60%.
[17] Il valore della “serenità” è uno di quelli che costituiscono la scala assiologica del governo Conte, cfr. Gianluca Fuser, Le scelte morali del governo italiano durante la prima parte della crisi pandemica del 2020, Tesi Magistrale, Scienze Filosofiche, Università degli Studi di Milano, 2024
Il tempo schermo e i suoi impatti educativi sull’infanzia
Le tecnologie digitali non sono né buone né cattive, ma nemmeno neutre. Il concetto di "tempo schermo”, benché sia poco diffuso in Italia, gode di un ampio uso in ambito internazionale ed è particolarmente adatto per comprendere gli effetti di un’esposizione precoce e prolungata su bambine/i. Il tempo schermo è l’insieme delle ore trascorse davanti a uno schermo, indipendentemente dal tipo di contenuto o dal tipo di dispositivo (connesso o meno a internet) sia esso smartphone, televisione, tablet o qualsiasi altro schermo. Il concetto permette quindi di non guardare solo alle tecnologie digitali “recenti” e includere la “vecchia” televisione, anche perché con l’arrivo delle smart Tv la distinzione è sempre più sfumata. Paradigmatico è oggi You Tube che è sia un canale televisivo, sia una app di smartphone, sia una piattaforma di internet, ed è seguitissimo da piccoli/e.
Oggi, la presenza di schermi in ogni casa è significativa: in una famiglia occidentale media (di quattro persone) ci sono dieci schermi; si tratta di diversi dispositivi, per lo più connessi a internet, che caratterizzano un vero e proprio “ambiente schermo" in cui i bambini crescono. Questa disponibilità di schermi – per lo più accesi e visti anche in modo indiretto – contribuisce a modellare l’ambiente, il ritmo di vita, gli stimoli e le stesse attività quotidiane, con impatti misurabili anche in termini di minore parole ricevute e prodotte e maggiori interruzioni di attenzione focalizzata.
IMPATTO DEL TEMPO SCHERMO SULLO SVILUPPO FISICO E MENTALE
L'aumento del tempo schermo riduce drasticamente altre temporalità essenziali nell’infanzia, come il tempo di sonno, di gioco libero, di interazione sociale; riduce il tempo trascorso all'aria aperta e il tempo della lettura. Gli studi in letteratura scientifica confermano che il tempo schermo ha un impatto sia diretto sia indiretto su questi tempi, i quali sono fondamentali per l’apprendimento e lo sviluppo delle capacità cognitive, sociali e sullo stesso sviluppo psicofisico, soprattutto nei primi cinque anni di vita, per i quali l’OMS consiglia il meno tempo schermo possibile, in particolare zero minuti nei primi due anni.[1]
È importante chiarire però che non è corretto affermare che il tempo schermo abbia sempre un impatto negativo sullo sviluppo psicofisico: fattori come il contesto familiare, il tipo di contenuti fruiti e le differenze individuali di bambini/e giocano un ruolo cruciale nel determinare l’entità dell’effetto. D’altro canto, il tempo schermo precoce (prima dei cinque anni) e prolungato (superiore alle due ore giornaliere dopo i cinque anni) è certamente un fattore di rischio, poiché aumenta le probabilità di riscontrare problemi di vario tipo. È anche opportuno precisare che i dati mostrano che gran parte del tempo schermo nei bambini da 0 a 8 anni è impiegato per la visione di brevi video (73%) o videogiochi (16%), e quindi, al netto di eccezioni, minoranze e contesti specifici, il tempo schermo non è un tempo dedicato a contenuti adeguati all’età, ad app effettivamente educative o dedicate a un uso creativo.
Le principali associazioni pediatriche a livello mondiale, basandosi su una vasta letteratura scientifica, sottolineano come il tempo schermo influenzi aspetti fondamentali dello sviluppo, quali la vista, l’alimentazione, il rischio di sovrappeso e, soprattutto, il sonno; nell’area cognitiva influisce negativamente su attenzione, linguaggio, memoria e quindi capacità scolastiche. Inoltre, sono stati riscontrati effetti relazionali come ansia, depressione, isolamento sociale, cyberbullismo, dipendenze che sollevano preoccupazioni per il benessere mentale a lungo termine. Benché nei prossimi anni possano divenire tra gli effetti più preoccupanti, sono ancora poco studiati gli effetti sulla intimità, affettività e sessualità dovuti a una esposizione precoce a video pornografici (l’età media si sta abbassando spaventosamente persino sotto i dieci anni), al punto che in Spagna si parla di Generación Porno.
Il mio interesse di ricerca si concentra sui rischi legati all’esposizione precoce e prolungata agli schermi in bambine/i, dalla nascita fino alla fine della scuola primaria, dove insegno. Sono anni in cui si apprendono le cose essenziali per la vita, ma anche anni vulnerabili: sono anni in cui si sviluppano le capacità cognitive alla base della carriera scolastica, nei primi quattro anni il linguaggio orale, fino a dieci la letto-scrittura.
La psicologia dell’età dello sviluppo ci spiega che l’attenzione e il linguaggio si possono sviluppare solo con una relazione umana; il tempo schermo non solo non sviluppa queste capacità ma spesso lo rallenta[2] Infatti in assenza del cosiddetto "co-viewing" – ovvero la visione congiunta dei contenuti e il dialogo costante con l’adulto su ciò che si sta vedendo e facendo – l’apprendimento tramite schermi risulta non solo limitato ma anche limitante poiché intacca i prerequisiti di apprendimento, rendendo l’attenzione più frammentata. Un’intera linea di esperimenti nota come il video deficit effect spiega proprio come l’apprendimento (non la comprensione) sia migliore con la presenza umana, mentre risulti molto arduo se non persino assente, quando è mediato dagli schermi. Il "co-viewing" è considerato una condizione essenziale per garantire che i bambini traggano un beneficio educativo reale da questi dispositivi, riducendo gli effetti negativi. Per fare in modo che si possa apprendere tramite gli schermi fino all’inizio della scuola primaria è caldamente consigliata la presenza e la mediazione adulta, non solo nella scelta dei contenuti ma proprio nell’attività di ascolto e interazione. Il che è in palese contraddizione con quanto fanno oggi gli adulti, che danno gli schermi proprio per essere separati (o non disturbati) dai bambini.
LE SETTE CARATTERISTICHE DEL TEMPO SCHERMO
Il tempo schermo si caratterizza per lo più per alcune caratteristiche che derivano dal suo far parte dei mezzi di comunicazione di massa con le relative evoluzioni digitali del XXI secolo. Benché si possano fare usi creativi e attivi del digitale, e la Media Education ne descriva una infinità, essi rimangono “potenzialità” auspicate, perché la realtà è meno edulcorata di come questa disciplina di norma ce la presenta; le salienze del tempo schermo possono essere sintetizzate in sette punti che ne indicano la tendenza:
- Sedentarietà. La caratteristica principale del tempo schermo è la sedentarietà. Il movimento di mani e piedi è essenziale nei primi anni di vita per lo sviluppo del cervello, mentre il tempo schermo smaterializza il corpo immobilizzandolo. La mancanza di attività fisica associata all’uso prolungato degli schermi può influenzare negativamente lo sviluppo fisico e cognitivo del bambino.
- Deprivazione Sensoriale. Il tempo schermo è limitato quasi esclusivamente alla visione, deprivando la stimolazione multisensoriale di cui il bambino ha bisogno (tatto, olfatto, gusto e anche l’ascolto della parola nella misura in cui i dialoghi sono spesso inutili). Recenti studi oftalmologici hanno inoltre osservato che l’uso precoce di piccoli schermi può portare a un aumento della miopia in bambini/e e dello strabismo con ulteriori effetti negativi persino sulla capacità di lettura e di equilibrio.
- Convergenza Digitale. La convergenza digitale, ovvero il fatto che un dispositivo sia contemporaneamente telefono, telegrafo, macchina fotografica, e la possibilità di utilizzare lo stesso contenuto (per es. un videogioco, una partita di calcio, ecc…) su diversi dispositivi (televisione, tablet, smartphone), comporta il precipitare di ogni esperienza nel tempo schermo, con una fruizione continua e spesso priva di interruzioni lunghe, pervasiva e difficilmente limitabile.
- Illimitatezza. Le piattaforme digitali sono progettate per offrire contenuti in maniera continua, senza una "fine" naturale, tramite algoritmi che rilevano e si adattano alle preferenze dell’utente, incentivando un uso prolungato dello schermo.
- Divertissment. La maggior parte delle app e dei contenuti rivolti ai bambini è pensata principalmente per il divertissment, termine francese che designa il distrarre, il divertire, l’intrattenere. Non hanno scopo principalmente educativo. Questo tipo di intrattenimento punta alla "distrazione" eterodiretta, cioè a una gestione dell’attenzione orientata a trattenere il bambino davanti allo schermo divertendolo, che è esattamente il contrario della salutare distrazione propria al fantasticare della rêverie.
- Spettacolarità e isolamento. Il tempo schermo è spesso una fruizione individuale, che comporta l'isolamento sociale perché ciascuno ha il suo schermo; limita le attività di gruppo e le interazioni faccia a faccia, limitando così lo sviluppo di abilità sociali cruciali.
- Cronofagia. Il tempo schermo distorce la percezione del tempo. Bambini e adolescenti spesso non riescono a controllare il tempo trascorso davanti agli schermi, con un impatto negativo sulla gestione del tempo. Questo effetto è stato definito filosoficamente "cronofagia", ovvero la capacità di “divorare” il tempo.
In aggiunta, studi recenti indicano che l’esposizione precoce e prolungata agli schermi è associata a una diminuzione delle capacità attentive richieste in ambito scolastico. L’attenzione stimolata dagli schermi è di tipo "bottom-up", cioè orientata alla cattura immediata dell’attenzione tramite stimoli visivi, allarmi o segnali di pericolo, piuttosto che alla concentrazione sostenuta. Questo tipo di attenzione, studiato dalla psicologia cognitiva, può essere associato alla progettazione di app e piattaforme che utilizzano meccanismi per incentivare l’uso prolungato, perseguendo finalità commerciali più che educative.
QUALCHE CONCLUSIONE
È importante essere consapevoli che più ci si avvicina alla nascita più gli studi concordano sulla negatività degli effetti, a prescindere dai contenuti. Il fenomeno della disgiunzione dell’attenzione è forse il più importante. L’attenzione è infatti un prerequisito della trasmissione culturale in ogni cultura ed è per questo che educatori ed educatrici di tutto il mondo hanno individuato l’attenzione come la fonte dei processi di apprendimento. Come vedremo nel prossimo numero, la relazione pedagogica si basa su processi attentivi, ma negli esseri umani l’attenzione si sviluppa principalmente per vie extracorticali ed è predittiva dello sviluppo del linguaggio umano e delle capacità simboliche. L’attenzione cioè si sviluppa anche a livello biologico grazie all’aggancio oculare con altri simili tramite la condivisione di intenzionalità e il fenomeno da tempo noto di attenzione congiunta.
NOTE
[1] Cfr. World Health Organization (Who) (2019), Guidelines on Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep for Children Under 5 Years of Age, Genève; cf. Grollo M., Zanor S., Lanza S., et al. (2022), Pediatri custodi digitali, la prima guida per i pediatri di famiglia sull’educazione digitale familiare dalla nascita, IAM Edizioni, Udine.
[2] Per una ampia bibliografia si veda: Desmurget M. (2020) Il cretino digitale. Difendiamo i nostri figli dai veri pericoli del web, Rizzoli, Milano. Mi sia permesso rimandare al mio saggio: in corso di pubblicazione: L’attenzione contesa, come il tempo schermo modifica l’infanzia, Armando, Roma.
Decalogo Latouriano - Il pensiero meno noto di Bruno Latour, Prima parte
Questo è un dono alle tante laturiane[1] superficiali e distratte, che hanno preso di Bruno Latour (1947-2022) solo gli aspetti più eclatanti (come mettere sullo stesso piano umani e non-umani, l’agency degli oggetti, il messaggio apparentemente post-moderno ecc.), affinché diventino laturiane profonde, meticolose e convinte. Tirato per la giacca da tante (postmoderniste, sociologhe interpretative, nuove materialiste, decostruzioniste ecc.), Latour è stato infatti un personaggio poliedrico, contraddittorio, escapologico. Per cui, è lui a essere il primo responsabile dei tanti fraintendimenti della sua opera.
Al fine di recuperare la parte meno utilizzata del suo messaggio e del suo metodo, propongo una collezione del suo pensiero, così come delineato ne Riassemblare il sociale (2005), diviso in sette sezioni:
- Il sociale, la società e la sociologia
- Una critica agli altri approcci e tradizioni di ricerca
- Il costruzionismo
- Gli attanti
- Il micro e il macro
- Il metodo ANT: come tracciare associazioni
- Con Latour, oltre Latour
In questo primo post affronteremo i primi due.
1. IL SOCIALE, LA SOCIETÀ E LA SOCIOLOGIA
- Il “sociale” non è un dominio particolare. Per cui di un fenomeno non esiste una spiegazione sociale, accanto a quella psicologica, economica, culturale ecc.
- Per questo motivo, la scienza (o meglio, un contenuto scientifico) non può essere spiegata dal suo contesto sociale. Anzi, è proprio il contrario: è il contenuto scientifico che spiega la società. Sono gli oggetti della Scienza che possono spiegare il sociale.
Non bisogna, però, essere deterministi, e convenire che nemmeno il contenuto scientifico deve essere usato per spiegare i componenti delle relazioni sociali. Il tema è quindi molto più complesso: possiamo dire che la scienza lega le varie entità in modo scientifico.
- Per cui il “sociale”, agli occhi dell'Actor-Network Theory (ANT), è un movimento assai peculiare, di riassociazione e riassemblaggio di tutte le entità che attraversano un campo d’azione. Cogliere questo movimento è compito dello studioso. Tuttavia, per farlo, egli deve sviluppare una sensibilità particolare, che consiste nel potenziare il nostro “senso del movimento”, ovvero nell’acquisire “il senso del sociale”. Infatti, i fisiologi hanno mostrato che, perché una percezione abbia luogo sono necessari continui movimenti e aggiustamenti: se non c'è movimento, non c'è sensazione. Con l'assenza di movimenti sopraggiunge un offuscamento dei sensi. Lo stesso vale per il ‘senso del sociale’: se lo studioso non è capace di vedere nuove associazioni, non sarà nemmeno in grado di vedere il sociale.
- Il compito dello studioso è quindi il tracciamento di nuove associazioni (configurazioni), fra forze sino ad allora inassociate.
- Nel fare questo, occorre quindi tener ben presente che la società non esiste. Esistono solo i raggruppamenti, il collettivo, che è il progetto di assemblaggio di entità nuove non ancora riunite; inoltre bisogna mettere in luce l’eterogeneità di attanti molto diversi fra loro, i quali si mescolano come “una squadra di operai che costruisce un muro di mattoni: le loro strade si separano di nuovo solo dopo che il muro è stato completato. Tuttavia, mentre lo si costruisce, non c'è dubbio che siano collegate. Come? Sarà la ricerca di determinarlo”
- Bisogna riconoscere appieno chi e che cosa partecipa all’azione, includendo anche le “masse mancanti” di entità non-umane. Infatti, gli aggregati (associazioni che hanno una forma, seppur momentanea) si muovono all'interno di fenomeni non formattati. Questo sfondo Latour lo chiama "plasma": esso è astronomicamente enorme per dimensioni e portata, un immenso repertorio di masse
- A tal fine, i termini e i concetti di “sociale” e “naturale” devono perciò essere accantonati. Perché i pesci e pescatori non si fronteggiano come ‘naturale’ e ‘sociale’, ‘oggetto’ e ‘soggetto’, ‘materiale’ e ‘simbolico’. Per Gabriel Tarde (1843-1904), ricorda Latour, non c’era alcuna ragione per separare il “sociale” umano da altre associazioni come gli organismi biologici o persino gli atomi. Il sociale, per Tarde, era un fluido in circolazione, e non organismo. Ogni cosa era una società e ogni fenomeno era un fatto sociale: società cellulari, società atomiche, società di astri. Tutte le scienze, pronosticava Tarde, sembrano destinate a divenire rami della sociologia.
2. UNA CRITICA AGLI ALTRI APPROCCI E TRADIZIONI DI RICERCA
- Latour si definisce “oggettivista”, dicendo di non avere alcuna simpatia per le “sociologie interpretative”, perché l'ANT non apprezza l’eccessiva enfasi data dai fenomenologi alle fonti umane dell’azione, e ignora completamente la lunga battaglia tra oggetto e soggetto. E invita alla lettura del filosofo tedesco Peter Sloterdijk che, con i tre volumi sui diversi tipi di sfere, ha offerto una nuova e potente metafora per uscire dalla dicotomia interno/esterno.
- Ciò non significa che dovremmo privarci del ricco vocabolario descrittivo della fenomenologia; semplicemente che dobbiamo estenderlo alle entità ‘non intenzionali’.
- Per cui bisogna ritornare all’oggetto. Nel rivendicare il proprio “realismo”, Latour però ne dà un’interpretazione diversa da quella tradizionale. Egli ritiene che l’oggettività non sia una proprietà privata dei positivisti. Anzi, condivide l’affermazione del microbiologoe filosofo polacco Ludwik Fleck (1896-1961): “più sociale c'è, più realismo c'è”.
- Latour accetta anche l’etichetta di “relativista”: “ma certo, cos'altro potrei essere?”, dice. In linea con quanto scriveva Peter L. Berger (1963) sul progetto di “alternanza”, ma senza mai citarlo, Latour sostiene che “per raggiungere l'oggettività, devo essere in grado di navigare da un quadro di riferimento all'altro, da un punto di vista all'altro. Senza questi spostamenti, sarai limitato al mio ristretto punto di vista per sempre”. La “relatività”, più che il relativismo, è la bussola dello studioso.
- Latour è quindi “oggettivista”, “realista” e “relativista” nello stesso tempo; una miscela originale che attribuisce nuovi significati a vecchi termini, che tuona contro l’empirismo tradizionale a favore di un nuovo empirismo.
- Infatti l'empirismo storico è stato “una resa piuttosto povera all'esperienza. Questa povertà, tuttavia non si supera allontanandosi dall'esperienza materiale per esempio in direzione della ‘ricca soggettività umana’, ma avvicinandosi alle forme di resistenza variegate che la materia ha da offrire”. Perché “artificialità totale e oggettività totale si muovono in parallelo”.
- “Non siamo più obbligati a combattere il riduzionismo aggiungendo alla descrizione qualche ‘aspetto’ umano, simbolico, soggettivo o sociale, perché il riduzionismo, tanto per cominciare, non rende giustizia ai fatti oggettivi. Quel che si potrebbe chiamare il primo empirismo è riuscito, per ragioni politiche, a oscurare i numerosi percorsi e deviazioni dell'oggettività e a ridurre in umani all'ombra di se stessi”, scrive Latour.
- Lungi dal ‘possedere oggettività’, “i positivisti somigliano piuttosto proprietari terrieri assenteisti, che sembrano non sapere cosa farsene dei loro latifondi”. Per cui, “il riduzionismo è un'impossibilità pratica, nella misura in cui gli elementi a cui si riduce un ‘livello superiore’ saranno tanto complessi quanto il ‘livello inferiore’. Se solo gli umani nelle mani di sociologi critici potessero essere trattati al pari delle balene in zoologia…” termina sconsolato Latour.
- E alla fine, uccide il padre: “devo finalmente congedarmi da Tarde (...) Egli ha mantenuto una definizione sostanziale e non relativista della sociologia”.
NOTE
[1] Uso il femminile sovraesteso.
BIBLIOGRAFIA
Berger, Peter L. (1963), trad. it. Invito alla sociologia, Venezia: Marsilio.
Descola, Philippe (2005), trad. it. Oltre natura e cultura, Milano: Cortina, 2014.
Fleck, Ludwik (1935), trad. it. Genesi e sviluppo di un fatto scientifico, Bologna: Il Mulino
Ginzburg, Carlo (1976), Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del Cinquecento, Torino, Einaudi.
James, William (1890), trad. it. Principi di Psicologia, Milano: Società Editrice Libraria, 1909.
Latour, Bruno (2005), tr. Riassemblare il sociale, Milano: Meltemi, 2022.
Sloterdijk, Peter (1998), trad. it. Sfere / Bolle vol. 1, Milano: Meltemi 2009.
Sloterdijk, Peter (1999), trad. it. Sfere / Globi vol. 2., Milano Cortina, 2014.
Sloterdijk, Peter (2004), trad. it. Sfere / Schiume vol. 3., Milano: Cortina, 2015.
Tarde, Gabriel (1894), La logique sociale, Paris: Alcan.
Intelligenza artificiale e creatività - Seconda parte: c’è differenza tra i pennelli e l’IA?
Qualche settimana fa avevamo iniziato una riflessione sull’interazione tra processo creativo artistico e Intelligenza Artificiale.
Ci eravamo chiesti se realizzare un’immagine con l’IA può essere definito come un atto creativo e abbiamo avuto le risposte di tre amici di Controversie, ognuno dalla propria ottica che deriva da un diverso percorso professionale e culturale (trovate le risposte nell’articolo pubblicato il 10 settembre scorso).
Riporto di seguito le conclusioni di quella prima riflessione:
“Non c’è dubbio che queste tre risposte siano estremamente stimolanti e che vi si possa rintracciare un minimo comune denominatore che le lega: l’idea che l’IA sia solo un mezzo, per quanto potente, ma che l’atto creativo resti saldamente appannaggio di colui che ha nel suo animo (umano) l’obiettivo concettuale.
Ottenere un risultato con l’IA si delinea, qui, come un vero atto creativo, che, però e ovviamente, non è detto che si trasformi in arte, ovvero in una manifestazione creativa in grado di dare emozione universale.
In termini più concreti: molti di noi, forse, potrebbero avere “nella testa” La notte stellata di Van Gogh (giusto per fare un esempio), ma la differenza tra la grandissima maggioranza di noi e il genio olandese è che non sapremmo neppure lontanamente “mettere a terra” questa intuizione.
Con l’IA, a forza di istruzioni che la macchina esegue, potremmo invece, avvicinarci al risultato di Vincent?”
La domanda che sorgeva spontanea, e a cui chiedo ai nostri amici un’ulteriore riflessione, è la seguente: Se così fosse, in che modo cambierebbe l’essenza stessa dell’artista?
Inserisco però un ulteriore elemento che deriva dall’aver letto la bella riflessione di Natalia Irza del 29 ottobre scorso su Controversie dal titolo “Il rating sociale tra digitale e moralità”.
Riporto testualmente un passaggio a mio avviso molto importante anche per il nostro ragionamento su processo creativo e IA. Scrive Irza:
“Per stabilire la verità su una persona, sono necessari strumenti umani. Lo stesso si può dire dell’uso dell’IA nell’arte: la pittura non è uguale alla composizione di colori, la musica non è uguale alla composizione di suoni, la poesia non è uguale alla composizione di parole. Senza la dimensione umana, che significa non solo l’operare algoritmi ma creare idee umane, l’arte cessa di essere arte.”
Aggiungo quindi una provocazione per i nostri amici chiamati a rispondere alla prima domanda, e cioè: dobbiamo quindi pensare che esisteranno in futuro due forme d’arte, una “analogica”, tradizionale, in cui l’essere umano si esprime attraverso strumenti controllati completamente dall’artista e una “nuova arte”, digitale, in cui l’autore si avvale di uno strumento che interviene nel processo creativo “aggiungendo” all’evoluzione concettuale dell’artista?
E quale sarà il livello di contaminazione fra queste due diverse situazioni?
Ecco le prime due risposte, scrive Diego Randazzo:
Quello che rende un artista tale è soprattutto il suo percorso. Un percorso interiore ed esteriore che lo porta a sviluppare una ricerca unica e indipendente. In assenza di tale percorso non vi può essere Arte, ma solo degli isolati appuntamenti con la tecnica.
Quindi, davanti alla possibilità di ricreare dei modelli digitali molto simili a capolavori storicizzati attraverso l’IA, non si può che riconoscere tale pratica come un tentativo, sicuramente curioso e sorprendente, ma molto lontano dalla definizione di Arte.
Non è un caso se utilizzo le parole tentativo e modello, che ne evidenziano l’approccio germinale, automatico e inconsapevole.
In altre parole, penso che la tensione verso la dimensione umana, a cui si riferisce Natalia Irza nell’articolo menzionato, sia necessaria e fondamentale. Del resto come possiamo capire in profondità un artista, senza conoscere qualche dettaglio, anche superficiale, della sua biografia? La Storia dell’Arte è punteggiata, da sempre, da questo binomio, indissolubile anche nel vischioso territorio dell’arte contemporanea: la pratica artistica come estensione e manifestazione della vita stessa degli artisti.
Pensiamo anche al potere del mercato odierno nel dare valore all’opera d’arte: oggi più che mai notiamo che sono le caratteristiche biografiche a fare da volano e non la qualità intrinseca dell’opera (vedi il successo della banana ‘Comedian’ di Cattelan).
Seguendo questo principio, dove la dimensione (e presenza) umana dell’artista sono sempre al centro, trovo assai difficile riconoscere valore nelle sperimentazioni con l’IA condotte dai non addetti ai lavori (non artisti?). Da considerare diversamente sono invece le incursioni degli artisti che utilizzano lo strumento dell’IA con consapevolezza e visione.
Infine di fronte alla possibile convivenza tra due tipologie di Arte (una totalmente analogica ed una totalmente mediata dallo strumento IA) nutro profondi dubbi; non ho mai creduto nella classificazione e scolastica separazione tra discipline, piuttosto credo nella ricerca della complementarità tra queste due modalità. Ad esempio, è molto stimolante l’uso dell’IA per creare ‘modelli e reference’, delle basi da cui partire e su cui innestare il gesto unico dell’autore. Tale gesto si può quindi esemplificare in una copia o rielaborazione analogica (manuale) dei modelli iniziali.
Facendo così, non solo ripercorriamo la storia dell’arte, seguendo il classico ed insuperato paradigma modello/rappresentazione, ma, contestualmente, attualizziamo il contesto: il modello da studiare e copiare non è più la realtà che ci circonda, ma una realtà mediata e spesso incontrollabile, formulata da un algoritmo.
Vorrei proseguire il discorso dando la parola ad Aleksander Veliscek, interessante artista sloveno, che attraverso i dettagli dei suoi affascinanti dipinti mette a punto proprio questa modalità, svelandoci le possibilità di un uso virtuoso ed intelligente dell’IA in pittura.
------------------------------
Ed ecco l’intervento di Aleksander Veliscek:
Penso che creare un’immagine con l’IA oggi può essere considerato un atto creativo, ma con una specificità: è una creatività mediata, e dove non necessariamente appartiene alla sensibilità di tutti gli artisti. Durante il workshop che ho curato quest’anno sul tema PITTURA e IMMAGINI I.A. a Dolomiti Contemporanee (ex stazione, Borca di Cadore), ho potuto constatare da parte di molti allievi-artisti un interessante dialogo tra chatGPT e gli autori.
Un esempio curioso era un artista che lavora in ambito astratto. Si è creato un confronto critico da entrambe le parti nella costruzione dell’immagine. Ne è risultato un pezzo indubbiamente riuscito. Spesso invece c’era un rigetto, in quanto le soluzioni proposte dalla I.A. erano banali e non riuscivano a centrare le sottili sfumature che l’artista cercava anche dopo lunghi tentativi.
È, così, evidente quanto l’essere umano giochi un ruolo essenziale nella progettazione e nell’interpretazione del risultato.
Quindi L’I.A., è sicuramente uno Strumento, sempre più potente e innovativo, ma non sostituisce l’immaginazione e il giudizio umano.
Invece come artista trovo più interessante capire l’aspetto ontologico. Le macchine intelligenti, pur essendo create dall’uomo, possono simulare comportamenti complessi che sembrano riflettere aspetti tipici dell’essere umano, come l’apprendimento, la creatività o persino l’autonomia. Tuttavia, queste simulazioni sono autentiche manifestazioni di “essere” o sono semplicemente imitazioni prive di sostanza?
Martin Heidegger, nel suo studio sull’essere, distingueva tra l’“essere autentico” e l’“essere per altri”. L’IA, in questo contesto, può essere vista come un “essere per altri”, progettata per servire scopi umani, ma incapace di una propria esperienza ontologica. Tuttavia, alcuni teorici suggeriscono che, con lo sviluppo di sistemi sempre più complessi, potremmo dover ripensare questa distinzione.
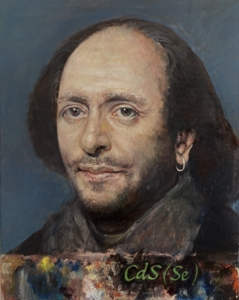 Un mio dipinto ad olio raffigurante William Shakespeare, dove l’effigie realistica del grande drammaturgo è stata creata con l’intelligenza artificiale combinando diverse fonti, partendo dalle incisioni, sculture e dipinti.
Un mio dipinto ad olio raffigurante William Shakespeare, dove l’effigie realistica del grande drammaturgo è stata creata con l’intelligenza artificiale combinando diverse fonti, partendo dalle incisioni, sculture e dipinti.
--------------------------------------
Queste due riflessioni sono certamente molto interessanti ma, tuttavia e inevitabilmente, non portano a risposte certe. Stiamo viaggiando, infatti, su un territorio privo di confini definiti, fluido e in rapido divenire.
Mi sembra si possa dire che ci sono due punti chiave nel ragionamento dei nostri due artisti: la centralità dell’uomo - con tutto il suo portato esistenziale - come attore primario e non sostituibile del processo artistico; e la contaminazione dei modi di fare arte, che per altro è cominciata ben prima dell’I.A..
Contaminazione che è un dato di fatto.
E quindi non è possibile una distinzione rigida (Diego usa la parola “scolastica”) tra arti “tradizionali” e arti in cui tecniche nuove e l’apporto potentissimo dell’I.A, irrompono nel processo creativo.
L’I.A. cambierà presto l’essenza di molti lavori; si pensi a cosa potrebbe diventare la giustizia se le sentenze dovessero passare dall’interpretazione dei fatti data da esseri umani a quelle, teoricamente neutrali, dell’IA (l’oggettività nell’interpretazione dell’agire umano non può esistere).
Forse tra pochi anni le domande che ci siamo posti in questa sede non avranno più senso, superate dalla prassi dell’utilizzo di nuove tecnologie in tutti i settori dell’agire umano, arte compresa.
Ma su questi punti aspettiamo anche il parere degli altri due amici del gruppo di questa discussione…
Legge 13 maggio 1978, n. 180 – Testo integrale
Comunemente, la legge n. 180 viene chiamata “legge Basaglia”; in realtà il suo estensore fu lo psichiatra e politico democristiano Bruno Orsini e Franco Basaglia non ne fu particolarmente soddisfatto – anche se la difese come impianto teorico ed ideologico, come dichiarò in una intervista fatta da Maurizio Costanzo:
«Non è importante tanto il fatto che in futuro ci siano o meno manicomi e cliniche chiuse, è importante che noi adesso abbiamo provato che si può fare diversamente, ora sappiamo che c'è un altro modo di affrontare la questione; anche senza la costrizione.»
La legge n. 180 nacque con un iter frettoloso: il progetto iniziale – che recepiva le istanze e le proposte di Franco Basaglia, del movimento di Psichiatria Democratica e di un numero non indifferente di psichiatri – prevedeva che la precedente legge che regolava il trattamento “dei matti” (Legge 14 febbraio 1904, n. 36 - Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati) fosse parzialmente abrogata attraverso un referendum e sostituita nell’ambito della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.
Tuttavia, il referendum rappresentava un rischio, perché il tema “dei matti” poteva essere sentito in modo controverso nella società, e la legge sul Sistema Sanitario avrebbe potuto avere tempi più lunghi del previsto. Il governo Andreotti optò, allora, per lo stralcio degli articoli che riguardavano i principali temi correlati ai manicomi e ne fece la legge n. 180, abrogando in buona parte (fatta esclusione per i temi economici e fiscali) la legge del 1904.
La “180” è una legge breve, molto sintetica, densa di contenuti e difficile da mettere in opera, soprattutto negli anni ’70.
Controversie ha ritenuto – per evitare che il dibattito viaggi sull’onda dei soli commenti e opinioni – di riportarla qui integralmente, insieme all’articolo 64 della legge n. 833/1978, istituiva del Sistema Sanitario Nazionale.
Legge 13 maggio 1978, n. 180
Sommario
Art. 1 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori
Art. 2 Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale
Art. 4 Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio
Art. 7 Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica
Art. 8 Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici
Art. 9 Attribuzioni del personale medico degli ospedali psichiatrici
Art. 10 Modifiche al codice penale
" Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1978, n. 133.
Art. 1 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti o istituzioni pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.
Art. 2 Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale.
Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie mentali. Nei casi di cui al precedente comma la proposta di trattamento sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel precedente comma.
Art. 3 Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale.
Il provvedimento di cui all'articolo 2 con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 e dalla convalida di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno e al consolato competente, tramite il prefetto. Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico di cui all'articolo 6 è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso. Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare. Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo. La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Art. 4 Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Sulla richiesta di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Art. 5 Tutela giurisdizionale.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 3, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio. Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero. Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo aver assunto informazioni e raccolte le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.
Art. 6 Modalità relative agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presìdi psichiatrici extra ospedalieri. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i trattamenti sanitari per malattie mentali che comportino la necessità di degenza ospedaliera e che siano a carico dello Stato o di enti e istituzioni pubbliche sono effettuati, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici di cui ai successivi commi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento agli ambiti territoriali previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuano gli ospedali generali nei quali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura. I servizi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo - che sono ordinati secondo quanto è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, per i servizi speciali obbligatori negli ospedali generali e che non devono essere dotati di un numero di posti letto superiore a 15 - al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale sono organicamente e funzionalmente collegati, in forma dipartimentale con gli altri servizi e presìdi psichiatrici esistenti nel territorio.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le istituzioni private di ricovero e cura, in possesso dei requisiti prescritti, nelle quali possono essere attuati trattamenti sanitari obbligatori e volontari in regime di ricovero. In relazione alle esigenze assistenziali, le province possono stipulare con le istituzioni di cui al precedente comma convenzioni ai sensi del successivo articolo 7.
Art. 7 Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni amministrative concernenti la assistenza psichiatrica in condizioni di degenza ospedaliera, già esercitate dalle province, sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle regioni ordinarie e a statuto speciale. Resta ferma l'attuale competenza delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'assistenza ospedaliera disciplinata dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, numero 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, comprende i ricoveri ospedalieri per alterazioni psichiche. Restano ferme fino al 31 dicembre 1978 le disposizioni vigenti in ordine alla competenza della spesa. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le regioni esercitano anche nei confronti degli ospedali psichiatrici le funzioni che svolgono nei confronti degli altri ospedali. Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, e comunque non oltre il 1° gennaio 1979, le province continuano ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione degli ospedali psichiatrici e ogni altra funzione riguardante i servizi psichiatrici e di igiene mentale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano e coordinano l'organizzazione dei presìdi e dei servizi psichiatrici e di igiene mentale con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio e attuano il graduale superamento degli ospedali psichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. Tali iniziative non possono comportare maggiori oneri per i bilanci delle amministrazioni provinciali. E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni neurologiche o neuropsichiatriche. Agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle amministrazioni provinciali o da altri enti pubblici o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza si applicano i divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. Ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali generali, di cui all'articolo 6, è addetto personale degli ospedali psichiatrici e dei servizi e presidi psichiatrici pubblici extra ospedalieri. I rapporti tra le province, gli enti ospedalieri e le altre strutture di ricovero e cura sono regolati da apposite convenzioni, conformi ad uno schema tipo, da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità di intesa con le regioni e l'Unione delle province di Italia e sentite, per quanto riguarda i problemi del personale, le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Lo schema tipo di convenzione dovrà disciplinare tra l'altro il collegamento organico e funzionale di cui al quarto comma dell'articolo 6, i rapporti finanziari tra le province e gli istituti di ricovero e l'impiego, anche mediante comando, del personale di cui all'ottavo comma, del presente articolo. Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 in sede di rinnovo contrattuale saranno stabilite norme per la graduale omogeneizzazione tra il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del personale degli ospedali psichiatrici pubblici e dei presidi e servizi psichiatrici e di igiene mentale pubblici e il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico delle corrispondenti categorie del personale degli enti ospedalieri.
Art. 8 Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici.
Le norme di cui alla presente legge si applicano anche agli infermi ricoverati negli ospedali psichiatrici al momento dell'entrata in vigore della legge stessa. Il primario responsabile della divisione, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con singole relazioni motivate, comunica al sindaco dei rispettivi comuni di residenza, i nominativi dei degenti per i quali ritiene necessario il proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio presso la stessa struttura di ricovero, indicando la durata presumibile del trattamento stesso. Il primario responsabile della divisione è altresì tenuto agli adempimenti di cui al quinto comma dell'articolo 3. Il sindaco dispone il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 e ne dà comunicazione al giudice tutelare con le modalità e per gli adempimenti di cui all'articolo 3. L'omissione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio. Tenuto conto di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 7 e in temporanea deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6, negli attuali ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, esclusivamente coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera.
Art. 9 Attribuzioni del personale medico degli ospedali psichiatrici.
Le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
Art. 10 Modifiche al codice penale.
Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 6 del codice penale sono soppresse le parole: "di alienati di mente". Nella rubrica dell'articolo 716 del codice penale sono soppresse le parole: "di infermi di mente o".
Nello stesso articolo sono soppresse le parole: "a uno stabilimento di cura o".
Art. 11 Norme finali.
Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 3-bis della legge 14 febbraio 1904, n. 36, concernente "Disposizioni sui manicomi e sugli alienati" e successive modificazioni, l'articolo 420 del codice civile, gli articoli 714, 715 e 717 del codice penale, il n. 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge restano in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale. Fino a quando non si provvederà a modificare, coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, sono fatte salve in materia di trattamenti sanitari obbligatori le competenze delle autorità militari, dei medici di porto, di aeroporto e di frontiera e dei comandanti di navi o di aeromobili.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Data a Roma, addì 13 maggio 1978
Leone - Andreotti - Bonifacio - Anselmi
Visto, il Guardasigilli: Bonifacio
STRALCIO DELLA LEGGE 833/1978
TITOLO III
Norme transitorie e finali
Art. 64 - Norme transitorie per l'assistenza psichiatrica.
La regione nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980 . Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente attività psichiatrica . È in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche. La regione disciplina altresì con riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità sanitarie locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e degli altri enti pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge provvedono, per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonché la destinazione dei beni e del personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi interessino più regioni, queste provvedono d'intesa. La regione, a partire dal 1° gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici di cui all'articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano sanitario regionale e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione per concorso di altro personale indispensabile al funzionamento di tali presidi. Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i servizi di cui al quinto comma dell'articolo 34 sono ordinati secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 , al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all'adozione e di provvedimenti delegati di cui all'art. 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 e dall'art. 7, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 . Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i divieti di cui all'art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri enti pubblici e dalle amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente prima dell'entrata in vigore della presente legge. Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , sono compresi gli infermieri di cui all'art. 24 del regolamento approvato con R.D. 16 agosto 1909, n. 615 . Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 6 della presente legge la regione provvede all'aggiornamento e alla riqualificazione del personale infermieristico, nella previsione del superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela della salute mentale delle unità sanitarie locali. Restano in vigore le norme di cui all'art. 7, ultimo comma, L. 13 maggio 1978, n. 180
Controcanto - Mario Tobino e la controversia con Basaglia
«I novatori social-psichiatrici».
(Per le antiche scale, 1982, Arnoldo Mondadori Editore)
Così, con questo linguaggio sorpassato e con evidente fastidio, Mario Tobino – psichiatra e scrittore che esercita nei manicomi dal 1939 al 1980 - chiama gli psichiatri che sostengono le proposte di Franco Basaglia e di Psichiatria Democratica.
Tobino rappresenta – di fatto - il controcanto alla rivoluzione basagliana e della Legge n. 180, controcanto che cerchiamo di far emergere analizzando la controversia con Franco Basaglia, che, nel 1978, si sviluppa sui quotidiani La Nazione e Paese Sera.
Alla fine del testo si trovano una Nota Biografica, una Bibliografia e le Note, che permettono di leggere le esatte parole usate da Tobino e da Basaglia.
LA CONTROVERSIA
Tra i due psichiatri, a pochi giorni dalla approvazione della Legge 180, si svolge una discussione pubblica, molto dura, dipanata sulla stampa in tre articoli: Lasciateli in pace, il manicomio è la loro casa, scritto da Tobino e pubblicato il 18 aprile su La Nazione; una intervista di Paese sera a Basaglia, Magliano, le false donne (4 maggio 1978); Dolorosa follia, ho udito la tua voce, di nuovo su La Nazione, 7 maggio.
(Ringraziamo la Fondazione Mario Tobino che ha messo a disposizione - dai propri archivi - le immagini dei tre articoli linkate sopra).
LASCIATELI IN PACE
Lasciateli in pace nasce dai dubbi sulla legge 180 e sulla presumibile difficoltà nel metterla in atto, preoccupazioni condivise con alcuni medici e paramedici di Maggiano. Il contenuto rilevante è nella seconda parte dell’articolo, nel dialogo tra lo psichiatra e l’infermiere Scipioni, in cui si enunciano i principi della carità continua e dell’assistenza amorevole, senza sosta, verso i malati e verso le loro esigenze. Scipioni si fa rappresentante dei timori sulla abolizione degli ospedali psichiatrici, decretata dalla legge in procinto di essere approvata.
La preoccupazione di Scipioni – e di Tobino, che sembra parlare attraverso l’infermiere – è per il destino dei tanti malati. Soprattutto quelli anziani e soli, che hanno vissuto per anni nel manicomio di Lucca e che – una volta dimessi per decreto – non avrebbero un posto dove andare. Per loro non ci sarebbe nessuna famiglia ad accoglierli, sarebbero lasciati all’abbandono e allo scherno, se non alla violenza, del mondo “libero”.
In sostanza, Tobino difende l’istituzione manicomiale come luogo di cura e di protezione per i malati di mente; una casa, per loro che una casa “fuori” non avrebbero più. È l’appello di un medico che ha vissuto tra i matti e per i matti, che adotta un criterio morale con al primo posto la dignità e l’individualità complessa di ogni singolo malato.
UNA RISPOSTA POLITICA
La risposta di Basaglia su Paese sera è durissima, quasi violenta, su un registro completamente diverso da quello di Tobino: egli accusa Tobino di ostacolare il progresso della psichiatria, di puntare sulla dimensione emotiva[1], di essere lui stesso demagogico e sprezzante quando definisce la nuova linea della psichiatria demagogia e moda.
In questa intervista, Basaglia attacca violentemente la psichiatria tradizionale e manicomiale, che ritiene essere al servizio del potere per controllare le persone emarginate, e accusa Tobino di essere al servizio del potere[2] con il suo articolo.
Il suo discorso è di carattere politico: Franco Basaglia sostiene[3] che carità continua e aspetto umano non abbiano alcun significato e che Tobino non affronti il discorso politico che sta dietro al tema della chiusura dei manicomi; egli oppone - alla dignità dell’individuo di cui parla Tobino – la dimensione antropologica molto più ampia, teoretica, della dignità dell’uomo[4]; nega la possibilità di dialogare con le posizioni altre, perché lo ritiene inutile e impossibile[5], nell’ottica di distruggere il potere.
A conclusione dell’intervista, denigra l’avversario per minarne l’autorevolezza, attaccando il romanzo Le libere donne di Magliano[6] che, a suo avviso, contiene solo falsità[7].
L’ULTIMO ATTO, TOBINO RISPONDE SULLO STESSO PIANO
Mario Tobino non può esimersi dal controbattere alle accuse di Basaglia e lo fa 3 giorni dopo, sul quotidiano toscano La Nazione, con l’articolo intitolato Dolorosa follia, ho udito la tua voce.
La controrisposta non è più né aneddotica né di piglio letterario, ma calata nello spazio analitico, teorico e metodologico. [8]
Dopo un breve preambolo di deviazione dei colpi diretti alla sua persona, va diritto ai punti che gli premono: la realtà di manicomi ben diversi dalle prigioni; l’effettiva esistenza della follia [9]; l’inopportunità della chiusura dei manicomi.
In risposta alla ideologizzazione del concetto di manicomio - prigione, Tobino ricorda che le esperienze “liberalizzanti” di Gorizia, di Colorno e di Trieste – dove ha operato Basaglia - non sono le uniche in Italia, ma ne esistono altre, altrettanto “aperte” e innovative; che lo stesso manicomio di Lucca[10] fu tra i primi ad aprirsi; che, a Lucca, i matti sono trattati con attenzione alle singole esigenze, sono liberi e girano tranquillamente, giocano a carte, lavorano allo spaccio, fanno riparazioni, sostituiscono i custodi.
Tobino ricorda - e fa appello alla memoria dello stesso Basaglia – le manifestazioni della follia, i deliri, le urla e le violenze; reali, innegabili, spesso difficilmente controllabili; la follia, secondo Tobino è questa, non la si può dimenticare.
Ed è solo grazie alla nuova chimica, all’alleanza con gli psicofarmaci[11], che si danno questi progressi: senza di essi non sarebbe stato possibile né controllare la follia – pur sopprimendo[12] una parte della personalità dei malati – né aprire i manicomi.
È l’ultimo tema, quello della chiusura dei manicomi[13], su cui Tobino pone l’accento più accorato e pone le domande critiche: dove andranno i malati che da anni vivono nei manicomi e che non hanno un luogo dove andare? Come saranno assistiti sul territorio dove le strutture ipotizzate dalla Legge non esistono, dove i reparti psichiatrici negli ospedali avranno al massimo 15 posti?
Di fatto, Tobino, affronta in modo esplicito la dimensione politica della follia e ne sottolinea l’esistenza puntuale, sociale e contestuale, chiamando in causa la fragilità dei dispositivi della Legge 180, l’impreparazione del tessuto sociale e la necessità di un posto per questi malati, di sapere che c’è un luogo adatto alla follia, seppure mascherata dalla chimica.
UNA ANALISI DELLA CONTROVERSIA
Ci sono elementi, tra quelli che emergono dalla controversia, per i quali si può intravedere una possibilità di conciliazione. È il caso della cancellazione dei trattamenti coercitivi e segreganti dei soggetti psichiatrici e dell’apertura nei confronti della società e della quotidianità, che sembrano essere obiettivi comuni a entrambi gli psichiatri.
Entrambi, inoltre, sembrano essere su una linea simile sulla modalità di gestione dei pazienti non più internati: Basaglia parla di diffusione della cura sul territorio, di somministrazione delle cure vicino a dove stanno i malati, di reinserimento; Tobino ipotizza l’ospedale come luogo di riferimento[14] per il malato; entrambi coinvolgono i pazienti in attività costruttive di laboratorio o di lavoro socialmente utile.
Nel focalizzare i principi, i criteri morali, che stanno alla base di questa etica della psichiatria, si possono trovare alcuni medesimi fondamentali: l’attenzione al malato, la cura e non la repressione, l’occupazione come mezzo per restituire un senso del tempo e dell’utilità sociale, la libertà di scelta sul ricovero e sulla presenza nel luogo di cura, il rapporto con il tessuto sociale.
Invece, sul punto dell’esistenza o meno della follia, non è possibile una composizione della controversia: Tobino, seppure non escluda del tutto l’origine sociale, ha una visione organica, fisiologica della follia, e accusa[15] Basaglia di credere che la chiusura dei manicomi cancelli ogni traccia della follia. Basaglia, infatti, la nega e nello stesso tempo, ne attribuisce la creazione alla società malata, al potere, per rinchiudere i disallineati, i disturbatori dell’ordine e dello sfruttamento[16].
Altro punto di dissidio insanabile è il tema della presenza e della forma delle strutture di cura, che coinvolge anche la visione politica delle due posizioni: Tobino non prescinde dalla necessità di un luogo dove i matti possano trovare – per periodi lunghi o brevi, più o meno volontariamente, in modo comunque aperto – riparo, protezione, cura e tranquillità[17]; e sottolinea l’assenza di preparazione dei territori, della popolazione e delle famiglie per la trasformazione dalle strutture accentrate a quelle diffuse; Basaglia, al contrario, non transige, insiste sulla necessità di distruggere l’istituzione manicomiale[18] e ribadisce la necessità della riforma, da farsi subito, in nome della «crescita politica, e quindi civile e culturale del paese».
VINCITORI
A volte le controversie scientifiche hanno un vincitore (come tra Pasteur e Pouchet[19], a metà del XIX secolo), a volte nessuno, a volte vincitori e vinti, ben oltre i contendenti.
In questo caso, la “vittoria” arride a Basaglia e alle proposte di Psichiatria Democratica[20], che vedono il parlamento prendere atto del lavoro fatto[21] e varare la legge 13 maggio 1978, n. 180.
Oltre che dalla condizione di possibilità fornita dai farmaci, questa vittoria è stata decretata:
- dal fatto che il progetto di riforma della psichiatria è nato e cresciuto nel mezzo degli anni ’70[22], in un contesto con cui condivideva lo stile di pensiero[23], il linguaggio[24] e le forme di espressione;
- dall’abilità degli innovatori nell’arruolare le forze politiche usando – appunto – concetti evocativi irrinunciabili in quegli anni: libertà dalle costrizioni, distruzione delle istituzioni, lotta contro il potere; e evocando la lotta anche contro chi resiste all’innovazione[25].
- dalla leva su elementi motivazionali anch’essi parte integrante della cultura rivoluzionaria di quegli anni, come il senso di colpa della “società”, rea della creazione e dell’espulsione della follia e dei folli[26].
ALTRI VINCITORI E MOLTI PERDENTI
Alla lunga, hanno vinto, dopo 20-30 anni, tutte le persone colpite da problemi psichiatrici – depressione, psicosi, schizofrenia – che hanno guadagnato il diritto a essere curati restando, almeno in parte, all’interno del proprio tessuto sociale (grazie al duro lavoro di chi quella legge[27] ha voluto interpretare e attuare e grazie alla diffusione e alla messa a punto dei farmaci antipsicotici).
Hanno perso, invece, i matti che vivevano dentro ai manicomi, progressivamente espulsi, poiché – scrivono Corbellino e Jervis nel 2008 – l’impossibilità di nuovi ricoveri negli ospedali psichiatrici genera una drammatica situazione di mancata assistenza per i malati critici[28].
Hanno perso anche le famiglie dei ricoverati e dei nuovi malati che, a causa della fretta della rivoluzione e dell’assenza di reali alternative alla struttura psichiatrica, si trovano sulle spalle tutto il carico della gestione, i sacrifici e le tragedie[29].
Hanno perso, più di tutti, alcune centinaia di malati che – dimessi dal manicomio – sono morti per suicidio o accidentalmente, per incapacità di vivere in un mondo ad essi ormai sconosciuto.
Dice lo psichiatra Cherubino Trabucchi[30] che si tratta di duemila – tremila persone.
MARIO TOBINO, NOTA BIOGRAFICA
Mario Tobino nasce a Viareggio nel 1910, si laurea in medicina nel 1936 e prende la specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali nel 1941, con una tesi sulla necessità di una rifondazione umanizzante della psichiatria contemporanea.
Esercita come psichiatra nei manicomi dal 1939 al 1980: ad Ancona, a Gorizia e a Firenze San Salvi (1939-1940), dal 1941 al 1980 nell’ospedale psichiatrico di Maggiano, in provincia di Lucca, dal 1948 come primario del reparto femminile. Nel 1944 partecipa alla guerra partigiana. Vive all’interno del manicomio – nelle stanze dei medici – fino quasi alla morte (1991).
La scrittura contende alla psichiatria il ruolo di principale occupazione. Dalla prima raccolta di poesie del 1934 a Una vacanza romana del 1992, Tobino pubblica 4 raccolte di poesie e 23 romanzi e raccolte di racconti. Di questi, almeno 4 sono incentrati sull’esperienza psichiatrica a Maggiano: Le libere donne di Magliano, Per le antiche scale (Premio Campiello 1972), Gli ultimi giorni di Magliano, Il manicomio di Pechino (Premio Strega 1990).
BIBLIOGRAFIA
M. Tobino, Lasciateli in pace, il manicomio è la loro casa, La Nazione, 18 aprile 1978
F. Basaglia, Magliano: Le false donne, Paese sera, 4 maggio 1978
M. Tobino, Dolorosa follia, ho udito la tua voce, La Nazione, 7 maggio 1978
M. Tobino, Le libere donne di Magliano, Arnoldo Mondadori Editore, 1963
M. Tobino, Per le antiche scale, Arnoldo Mondadori Editore, 1972
M. Tobino, Gli ultimi giorni di Magliano, Arnoldo Mondadori Editore, 1982; Ed. del 2019, Mondadori Libri
M. Tobino, Il manicomio di Pechino, Mondadori, 1990
health, volume 14, 1985, issues 1 and 2, The Unfinished Revolution in Italian Psychiatry: An International Perspective
https://doi.org/10.1080/
G. Corbellino - G. Jervis, La razionalità negata: psichiatria e antipsichiatria in Italia, Bollati-Boringhieri, 2008
F. Basaglia, F. Ongaro, A. Pirella, S. Taverna, La nave che affonda, Cortina, 2008
V. Furlanetto, Cento giorni che non torno – Storie di pazzia, di ribellione e di libertà, Laterza, 2024
V. Andreoli, Fratelli di Carmelo Samonà: il matto in casa, in Il matto di carta. La follia nella letteratura, BUR, 2008
S. Redaelli, Circoscrivere la follia, Mario Tobino, Alda Merini, Carmelo Samonà, Sub Lupa Academic Publishing, Warsaw, 2013
NOTE
[1] Basaglia parla di «equivoca pietà» e di «agire emotivo» (Magliano: Le false donne, Paese sera, 4 maggio 1978)
[2] «il suo scritto rende un grosso servizio al potere, su questo non si può discutere» (Cit.)
[3] «Tobino parla “di carità continua e aspetto umano”. Quale significato hanno oggi queste espressioni? Nessuno. Il discorso è politico e Tobino non lo affronta. Anzi, finge di non affrontarlo poiché tutta l’impostazione del suo articolo è politicizzata al massimo» (Cit.)
[4] «la dignità dell’uomo, di tutti gli uomini» (Cit.)
[5] «instaurare un dialogo comune, generale […] impresa impossibile poiché l’istituzione che vogliamo distruggere è il potere stesso e nessuno rinuncia senza lottare al suo potere» (Cit.)
[6] Romanzo che lo stesso Basaglia, in gioventù, aveva amato e considerato una sorta di trattato psichiatrico (cfr. Magliano: Le false donne, Paese sera, 4 maggio 1978
[7] «a Gorizia […] ho potuto verificare ogni cosa, controllare ogni sensazione. Era tutto falso» (Cit.)
[8] «non ho potuto non sorridere quando ho letto che sarei strumento del dominante potere. Da quasi quarant'anni vivo al manicomio di Lucca e in verità mai sono stato in relazione, a contatto con chi comanda, chi è dominante. Per anni e anni la mia vita si è svolta in compagnia dei malati; adesso la mattina il primo dialogo lo faccio allo spaccio, al loro spaccio, dove vado a prendere il caffè e poi ancora durante la giornata. Nel dopopranzo sono solito passeggiare qui intorno e molto spesso con malati mi accompagno, malati liberi, che se la girano tranquillamente. La sera, dopo cena, quante volte ho giocato con loro a carte e, lo giuro, mai, mai abbiamo insieme trescato col potere, mai ordimmo per difenderlo» (Dolorosa Follia, ho udito la tua voce, La Nazione, 7 maggio 1978)
[9] Come già visto, in tutta la sua produzione Mario Tobino usa in modo diretto i termini follia, malattia mentale, matto/matti, lasciando poco spazio agli eufemismi; da una parte può essere un retaggio del periodo in cui ha studiato ed esercitato, dall’altra possiamo considerarlo un modo per non dimenticare di cosa si parla in termini comuni.
[10] Tobino definisce l’ospedale psichiatrico di Maggiano «libero e umano» e ricorda che «con entusiasmo […] fummo tra i primi a tirare giù i muri di cinta, strappare le inferriate, aprire, dare luce» (M. Tobino, Dolorosa follia, ho udito la tua voce, La Nazione, 7 maggio 1978)
[11] «nel 1952, arrivarono gli psicofarmaci che riescono a velare, a intorpidire, a rendere apparentemente molli molti segni della pazzia» (Cit.);
[12] «Sono stati gli psicofarmaci a rivoluzionare i manicomi e non le loro teste. E nemmeno si domandano se la follia loro la conoscono, se ne saprebbero distinguere il volto, loro che l'hanno frequentata soltanto dopo l'avvento degli psicofarmaci, se ne sanno la violenza, la fantasia, l'orrore, l'inesprimibile immacolatezza, l'impenetrabile lutto. E neppure amano conoscere, per nulla sono ansiosi di valutare di quanto con i composti chimici la follia è stata offuscata, travestita, mascherata (ma non vinta); e a volte costretta a brancolare.
Neppure sorge loro l'inquietante interrogativo, l'as-sillo morale, se è giusto con gli psicofarmaci ottundere la personalità, arginare, imbavagliare, legare una delle più profonde, meravigliose, misteriose manifestazioni umane: la follia.» (Gli ultimi giorni di Magliano, p. 20)
[13] « fuori, come gli andrebbe? I cittadini, che hanno da lavorare, che trascinano i loro affanni, li ascolterebbero, li sopporterebbero? I cittadini debbono essere sensibilizzati ma io finora di questa sensibilizzazione non ho visto nessun progresso, se anche non è aumentato il sospetto» (M. Tobino, Dolorosa follia, ho udito la tua voce, La Nazione, 7 maggio 1978)
[14] «[Un luogo] dove ritornare, rifarsi vedere, venire […] a prendere le cure, […] un luogo dove si entra e si esce tranquillamente» (Cit.)
[15] «io credo che la follia esista e Basaglia invece mi pare che sia convinto che, chiusi i manicomi, svanisca la cupa malinconia, l’architettura della paranoia, le catene delle ossessioni» (Cit.)
[16] «La follia non esiste, non è mai esistita. Sono stati la Società, il Potere a crearla [...] hanno eretto i manicomi per rinchiudere chi disturbava il loro sfruttamento [...]» (F. Basaglia, F. Ongaro, A. Pirella, S. Taverna, La nave che affonda, Cortina, 2008)
[17] Tobino è autore, nel 1958 in tempi non sospetti, insieme a due giovani architetti, di un progetto di «un futuro ospedale psichiatrico, un ospedale per matti in armonia con le vicende dei savi, un istituto che avesse, dopo le sequele di cattiverie, dopo tanto sangue versato, un grano, appena un grano di più di bontà e tolleranza» (Gli ultimi giorni di Magliano, ed. 2019, p. 206); per avere un’idea del progetto: Mappe del progetto per l'Ospedale di Vicenza (Mario Tobino, Giorgio Ramacciotti, Piero Marello) (MTb.II.30.41), Mostre Virtuali Ficlit, #3508
[18] «I manicomi […] noi diciamo che si possono distruggere e lo abbiamo dimostrato in anni di lotta» (F. Basaglia, Magliano: Le false donne, Paese sera, 4 maggio 1978)
[19] Cfr. H.M. Collins, T. Pinch, Il Golem, Tutto quello che dovremmo sapere sulla scienza, Edizioni Dedalo, 1995
[20] https://it.wikipedia.org/wiki/Psichiatria_Democratica, https://www.psichiatriademocratica.org/
[21] «Sono perciò soddisfatto che il Parlamento abbia preso ufficialmente atto della lotta di questi anni» (F. Basaglia, Magliano: Le false donne, Paese sera, 4 maggio 1978)
[22] Cfr. Franco Basaglia e la legge 180: frammenti dello scenario sociale e politico, Controversie, 4 dicembre 2024
[23] Cfr. L. Fleck, Genesi e sviluppo di un fatto scientifico : per una teoria dello stile e del collettivo di pensiero, Il Mulino, 1983; L. Fleck, Stili di pensiero, La conoscenza scientifica come creazione sociale, a cura di F. Coniglione, Mimesis Edizioni, 2019
[24] scrive Tobino: «Si indicono di continuo le riunioni - qualsiasi scusa è buona - alle quali debbono assistere medici, infermieri e anche malati di mente […] Nelle riunioni si rimuginano le prossime salutari innovazioni, ciò che si è in procinto di operare per il trionfo della giustizia, lo smascheramento del Potere, la liberazione degli schiavi, dei martiri», (Gli ultimi giorni di Magliano, p. 19)
[25] «Tutti hanno paura: sanno che il potere, quello politico in primo luogo - quello che in molti casi li ha fatti assumere nell'ospedale -, è con la 180, e con questo i mezzi di comunicazione» (M. Zappella, Introduzione a Gli ultimi giorni di Magliano, ed. 2019)
[26] «La follia non esiste, non è mai esistita. Sono stati la Società, il Potere a crearla [...] hanno eretto i manicomi per rinchiudere chi disturbava il loro sfruttamento [...]» (Paese sera, Cit.)
[27] La legge n. 180 e il suo successivo incoroporamento nella legge istitutiva del Servizio Sanitari Nazionale, Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
[28] «La nuova legge rendeva immediatamente illegale ogni nuovo ricovero negli ospedali pubblici […] fattore principale che causò […] una drammatica – e talora tragica – carenza di assistenza per i nuovi pazienti affetti da disturbi mentali acuti e gravi» (G. Corbellino – G. Jervis, La razionalità negata: psichiatria e antipsichiatria in Italia, Bollati-Boringhieri, 2008)
[29] «gran parte del carico fu sostenuto dalle famiglie dei pazienti con grandissimi sacrifici e non poche vere tragedie» (Cit.)
[30] Gli ultimi giorni di Magliano, p. 258
Investire sulla relazione e sugli operatori - Intervista a Raffaella Bricchetti
L: Buongiorno Dott.ssa Bricchetti.
R: Buongiorno a Lei
L: Vorrei iniziare questa nostra chiacchierata chiedendole anzitutto se ci potesse raccontare qualcosa di Lei, di cosa fa. Per poter introdurre meglio i lettori nel vivo dell’intervista
R: Certo. Dunque, chi sono e cosa faccio... Sono laureata in filosofia specializzata in psicologia alla facoltà di Lettere e Filosofia con indirizzo psicologico all’Università Statale di Milano perché ai miei tempi le facoltà di psicologia erano solo a Padova e a Roma e non avendo la possibilità di andare a Padova per mille motivi familiari ho intrapreso questa strada. Laureata mi sono iscritta alla specializzazione e sono stati altri quattro anni. Ricordo tra i miei docenti anche il Dottor Musatti[1]. Nel frattempo, sia per la prima tesi, quella di facoltà, che per la tesi di specializzazione, avevo contattato il dottor Erba[2], che ai tempi lavorava al Paolo Pini (manicomio cittadino per eccellenza ai tempi) come psichiatra.
L: Ecco Dottoressa Bricchietti, può raccontarci per la sua esperienza la realtà manicomiale Italiana prima del 1978? Qual era il vero tessuto quotidiano dell’esperienza d’esser folli e del tentare di curare e lenire?
R: Certamente, come le dicevo ho conosciuto Erba nel ’74 e insieme abbiamo fatto la prima tesi (quella di facoltà) analizzando moltissimi casi di persone che arrivavano in manicomio. Persone con delle storie psichiatriche assolutamente incredibili, “gli alienati”. Persone che non potevano essere considerate soggetti, ma erano considerate semplicemente dei reietti che dovevano essere controllati, sedati, repressi perché creavano scompiglio all’interno della società. Ricordo in manicomio, ad esempio, quest’uomo di nome Luciano che era comunque una persona molto degna, non saprei come altro definirla, sempre vestito bene con camicia e giacca, mai sciatto o trasandato, di una famiglia modesta che dall’età di 15 anni l’aveva mandato in manicomio perché era un “masturbatore compulsivo”. Lui si masturbava sempre, continuamente, anche in manicomio poi lo faceva perché in realtà diciamocelo, cosa diavolo aveva da fare di meglio?! E così lui era lì da sempre.
Ai tempi i manicomi erano dei luoghi di contenimento perché queste persone venivano prese e lì stavano. Mi ricordo anche Angela, che è stata anche uno dei capitoli della mia tesi; quando l'abbiamo presa in considerazione era arrivata al centocinquantesimo ricovero. Lei entrava, stava dentro due giorni, si rifocillava un po' e poi se ne andava. Le porte le venivano riaperte sempre perché era una donna giovane di nessuna pericolosità né per sé né per gli altri... era molto bizzarra quello sì. Mi è capitato di rivederla poi dopo la chiusura del reparto psichiatrico e mi prese in giro dicendomi “ma guarda io ti ho vista che eri grande così!” Ecco, c'erano anche questi personaggi che andavano e venivano in questo reparto molto aperto. Faccia conto che in Italia ai tempi c’erano 98 manicomi con 100mila persone dentro. La cosa che colpì di più Basaglia quando entrò nell’ospedale di Gorizia fu “l’odore di morte e di piscio”, che è vero perché l’odore di morte e di piscio caratterizzava tutto.
Io da bambina mi ero fatta delle fantasie su come fosse un manicomio. Abitavo in un piccolo paese vicino a Brescia e c’erano alcune persone che lavoravano a Canton Mombello che era il manicomio di Brescia. Ai tempi la cosa che mi aveva incuriosito molto era che gli infermieri venivano assunti anche in base alla stazza perché più erano grandi, grossi e potenti più erano in grado di contenere le persone che avrebbero potuto avere delle manifestazioni violente. Questo anche per farvi capire il clima riguardo questi luoghi, le idee che circolavano. A me però questa voce mi aveva sempre incuriosita e quando decisi di fare la prima tesi di laurea sul tema fu perché avevo casualmente letto un articolo su un giornale in cui intervistavano Sergio Erba che aveva introdotto il concetto di “terapia della famiglia all’interno del manicomio”. Ecco questa cosa mi fece scattare ulteriormente la curiosità e gli chiesi di poter assistere e di poter fare la tesi. Mi avvicinai così alla settima divisione del Paolo Pini di Milano dove il Dottor Erba dirigeva un reparto. Quando entrai scoprì che il clima era completamente diverso da quello che avevo immaginato da bambina: ad esempio, il giovedì mattina c’era un’assemblea di reparto dove i pazienti non erano considerati dei numeri ma delle persone, ciò che poi è stato uno dei principi della Legge Basaglia, considerare la persona ricoverata una persona non da sedare o da contenere con fascette ma una persona con la quale parlare. Era faticoso e questa fatica non era tanto dovuta al comportamento dei pazienti, quanto dal personale infermieristico che non era abituato a mettersi in gioco nella relazione con il paziente. Era difficile per loro non intrattenere con i pazienti rapporti che non fossero di forza. Ad un certo punto infatti ci fu proprio una divisione degli infermieri tra chi voleva provare a lavorare in questa maniera e chi no. Così funzionava al piano dove c’era il Dottor Erba, al piano di sotto un altro psichiatra di cui non ricordo il nome procedeva con idee molto ma molto più tradizionaliste...
L: Nel 1978 grazie a Franco Basaglia inizia quindi il percorso verso la riorganizzazione dell’assistenza psichiatrica ospedaliera, ci racconti di questo periodo di transizione...
R: Faccia conto che io sono entrata in questo mondo nel ’74, la Legge 180 è del maggio ’78. Già prima comunque c’era una tendenza ad un approccio diverso alla malattia mentale solamente che era riservata al singolo psichiatra e al reparto dove lavorava, non era una cosa generalizzata e generalizzabile... Qualcosa a livello di chi operava nei contesti manicomiali si stava muovendo ma il livello di establishment diciamo “ufficiale” e politico era ancora orientato nel mantenere il manicomio come luogo di contenimento. È stato molto più difficile a livello istituzionale cambiare qualcosa. Le singole persone erano sicuramente più illuminate ma a livello di istituzioni è stato difficile. Con l’avvento della Legge Basaglia e la chiusura di questi manicomi uno dei temi di base della legge era proprio quella dell’umanizzazione del manicomio.
Basaglia aveva iniziato giovanissimo a Gorizia come direttore e lì aveva avuto grossi problemi. Era finito quindi a Colorno, in provincia di Parma, poi era andato a Trieste, insomma aveva girato vari manicomi sempre con questa idea che voglio esprimere leggendo proprio le sue parole:
“restituire l’individualità e la dignità ai pazienti che dovrebbero essere riconosciuti prima come esseri umani e poi come delle persone da riabilitare. La prima cosa da fare è sospendere ogni forma di giudizio e considerare l’individuo nella sua interezza partendo dalla sua storia, dal ruolo sociale svolto, dalle emozioni e dal malessere, per poi procedere con diagnosi e terapia ma evitando stigmatizzazioni inutili”. Questa legge è stata talmente rivoluzionaria che era arrivata ben prima alle orecchie di tanti psichiatri che non potevano ignorare queste cose. A Milano ad esempio c’era il “Gruppo di Psichiatria Democratica” che era molto attivo (ne facevano parte personaggi come Benedetto Saraceno[3], Leo Nahon[4] etc). I concetti quindi di cui parlava Basaglia li si maneggiava. Cercavamo di andare verso una nuova realtà, il desiderio di umanizzare il manicomio cercando di trasformarlo in quelle che potevano essere delle comunità terapeutiche dove per i pazienti, ad esempio, si iniziavano ad introdurre delle attività per evitare che questi passassero l’intera giornata a letto o in giro per i vialetti del Paolo Pini senza niente da fare se non fumare, fumare, fumare...
Un’altra innovazione di questo momento di transizione era l’idea di ricoverare anche i famigliari del paziente designato. Ricordo questi due ragazzi molto giovani che erano istituzionalizzati al Paolo Pini entrambi con diagnosi di schizofrenia e ad un certo punto venne invitata a rimanere tutta la famiglia, con questa madre molto dominante e un padre che si faceva più piccolino e la seguiva sempre da dietro. Questa donna arrivava sempre alle 9 del mattino con una borsa piena di cibo per i figli, che per altro erano magrissimi e lei riempiva loro la bocca di polpette, questi ragazzi me li ricordo come degli scoiattolini con le guanciotte piene di polpette che tenevano lì. La mattina avevamo un appuntamento fisso e si cercava di lavorare sulle dinamiche che venivano ad instaurarsi, ad un certo punto avevamo lavorato anche sul suo riempire le bocche dei figli. Insomma, esperienze ed esperimenti molto particolari.
La legge Basaglia comunque era molto bella nella teoria ma nella pratica è stata disattesa per molti anni. Addirittura se non ricordo male quelli che erano i precursori degli attuali Cps iniziarono ad aprire negli anni ’90. L’unica cosa rapida fu l’apertura dei reparti di psichiatria negli ospedali civili “normali” chiamiamoli così, come conseguenza immediata della chiusura manicomi.
L: Ma secondo lei quindi che cos’è cambiato veramente dopo che questi posti hanno chiuso?
R: Beh, hanno iniziato a creare i servizi di igiene mentale... A quei tempi Milano era divisa prima in 20 zone, poi 13, etc e una zona che faceva riferimento alla divisione del Paolo Pini era (adesso non si chiama più così) la zona 13 che era attorno all’aeroporto Forlanini (quindi via Mecenate, viale Ungheria etc) dove tutta la via Ungheria aveva un “buon gettito” di pazienti psichiatrici, invece la via Salomone erano tossici e lì cerano prima le case minime, poi le case bianche dove c’era, e forse c’è ancora oggi, una grossa presenza di tossicodipendenti. Quando hanno chiuso il Paolo Pini, hanno aperto in zona un ambulatorio con tre stanzette: una per l’infermeria, una per l’assistente sociale e una dove ruotavamo noi. Ecco lì siamo stati parecchi anni, nella stessa palazzina misero il consultorio e il fatto che ci fosse questa commistione tra matti e tossici (perché ai tempi ancora non avevano creato i servizi per la tossicodipendenza) non piaceva.
E nel concreto cosa succedeva, succedeva che c’erano appunto tutti questi tentativi di creazione di comunità terapeutiche, ambulatori zonali dove affluivano i pazienti psichiatrici mandati dai medici o che venivano ricoverati 10/15 giorni nei reparti di psichiatria e poi una volta dimessi passavano direttamente al territorio mandati con tanto di foglio di via in queste strutture per prendere contatti con il personale. Molti assumevano farmaci, per cui venivano a prenderli e a questo punto non ci si limitava a dare solamente il farmaco al paziente ma si cercava di parlare con lui, di vedere che cos’era successo nel frattempo, che cosa l’aveva portato in ospedale. Sempre in quell’ottica di umanizzazione e di rispetto della persona, di rendere la persona soggetto della propria potenziale -non tanto guarigione- quanto consapevolezza che il disagio che lui stava vivendo poteva essere affrontato diversamente e non solo con il farmaco. Ad esempio, se veniva una signora depressa si cercava di instaurare un approccio relazionale sia con lei, persona che arrivava portando una sofferenza, che con la famiglia.
L: Come prendevano i pazienti, a livello di cambiamento di approccio e non solo di cambiamento strutturale, l’esser trattati così diversamente, in questa maniera appunto relazionale?
R: Non era facile, non era facile. Però questo era ciò che ritenevamo l’approccio migliore cioè di “responsabilizzazione del paziente”. Il paziente non è oggetto di cura ma è soggetto. Il lavoro era quello di fare in modo che la persona si rendesse conto di essere portatore di una domanda e portatore di un possibile dimensionamento del suo star male. Solo lui poteva in qualche modo fare qualcosa per uscire da quella situazione. Noi, nella nostra posizione di curanti, potevamo “aiutarlo a”.
L: Lei prima diceva che però i manicomi erano dei luoghi per i pazienti di contenimento sì, ma in qualche modo luoghi in cui le persone che li abitavano ci avevano passato tutta la vita per poi ritrovarsi a dire “cosa faccio/dove vado”?
R: Assolutamente! Persone smarrite... Se vi ricordate Luciano di cui vi parlavo prima, quando hanno chiuso i manicomi lui si era trovato veramente perso perché dentro almeno era in una situazione molto protetta. Chiuso il manicomio lui è stato sbattuto fuori ma la famiglia non lo voleva, non sapevano dove cacciarlo e onestamente non mi pare siano riusciti a trovargli una sorta di comunità dove farlo stare... Mi pare di ricordare che non abbia vissuto a lungo fuori. Questo per dire che non è che ai tempi ci fossero i matti attaccati al cancello che urlavano “noi vogliamo uscire”, perché quello paradossalmente era un ambiente molto protetto dove le persone magari erano lì da sempre. Come dicevo anche per Angela; lei arrivava lì, mangiava un po’ perché magari passava qualche giorno in giro per Milano senza mangiare, e se ne andava. Era anche una Milano degli anni ’70 in cui la realtà fuori non è come quella di adesso. Io ai tempi ho visto solo un signore di colore nell’arco di tutta la mia esperienza, che era stato ricoverato perché aveva dato un po’ fuori di matto ma rimesso un attimo in sesto se ne era andato ed aveva continuato a fare quel che faceva, lavorare etc. Adesso credo che nelle odierne comunità terapeutiche ci siano molti più immigrati, piazzati ovunque senza esserci tante altre strutture per poterli ospitare...
L: Quindi lei crede che quello un tempo fosse un po’ un rifugio per gli emarginati sociali di allora...
R: Sicuramente... un’alternativa era il dormitorio di Viale Ortles. Perché una volta “liberati” dai manicomi questi soggetti non sapevano dove andare e andavano nei dormitori. Avevo avuto dei contatti con il direttore del dormitorio di viale Ortles anche per capire come cercare di fare questi passaggi perché non è che nei dormitori le persone poi potessero vivere: andavano là per dormire, stavano fino alla mattina alle 6, facevano la colazione ma poi dovevano andare fuori. Non c’era più quindi un luogo dove queste persone potevano stare 24 ore su 24. Il concetto di fondo però era quello del rispetto della persona, perché prima non era assolutamente così. Persona in quanto portatrice di un disagio, e quindi, nella sua storia come è nato, come si è evoluto questo disagio? Quindi, parlare e lavorare con queste persone.
L: Come prendeva l’opinione pubblica questo cambio di approccio in termini più relazionali di cui parlavamo poco prima?
R: L’opinione pubblica era arrabbiata! Comunque c’era ancora e credo ci sia tutt’ora una fetta più tradizionalista e in questo senso anche più assistenzialista, e le persone stesse arrivano da te con un’ottica di assistenzialismo. Riuscire a far cambiare alle persone questa ottica e renderli partecipi della terapeuticità della loro relazione non era facile. Persone che non ci stava anche ad assumersi la propria parte di responsabilità, volevano solo il farmaco e allora “va bene ti do il farmaco, però te lo do a modo mio”. Quando ad esempio venivano per fare le iniezioni depot[5] dei farmaci anti depressivi, questi nuovi infermieri erano capaci sì di fare l’iniezione ma anche di parlare con la persona, di cercare di sensibilizzarle in questo senso. Le famiglie spesso erano poco disposte a starci perché venivano messe in discussione, veniva messo in discussione il loro modo di relazionarsi con quello che doveva essere il paziente designato e magari le famiglie non avevano nessuna voglia di mettersi in gioco, era più comodo dire “lui è matto, è lui quello strambo, gli dia la medicina e a posto così”.
L: In Italia invece a livello di humus culturale, le persone erano spaventate da questo cambiamento?
R: Direi di no. Ma nemmeno gli importava così tanto anche perché le persone direttamente interessate non erano chissà quante e quindi si lavorava su quei numeri piccoli.
L: Siamo alla domanda finale, secondo lei, ad oggi c’è qualche aspetto che avrebbe bisogno di una nuova rivoluzione in ambito di salute mentale?
R: Sì. Ancora oggi fa molto più comodo somministrare quattro pillole piuttosto che tenere il paziente lì, una volta alla settimana, a parlare del suo male. Le cose sono cambiate ma fino ad un certo punto. Finché ho lavorato in consultorio sono sempre stata poco “ossequiosa” rispetto a quello che l’istituzione mi diceva di fare, ad esempio il pacchetto da dieci colloqui: io faccio i colloqui che mi servono, se il paziente ne vuole fare venti ne farà venti, se ne vuole fare cinque ne farà cinque ma lavoriamo insieme in quei venti o cinque che siano. Ho seguito ad esempio più pazienti per anni in consultorio, mandando su tutte le furie i responsabili. Adesso bisogna anche registrare tutte le prestazioni, c’è una sorta di controllo non tanto sui pazienti ma su noi operatori, ora. Per l’istituzione se tu fai più del tuo pacchetto standardizzato da dieci sedute con un paziente vuol dire che stai togliendo la possibilità ad un altro di utilizzarti e quindi tu devi fare dieci colloqui, punto. Finiti i dieci colloqui la persona che hai davanti speri si sia rimpannuncciata un po’ e se non si è rimpannuncciata pazienza e avanti il prossimo. Ora si cerca di lavorare sui comportamenti, così che la persona qualcosa modificherà, starà meno male in dieci appuntamenti e quindi vai, può arrivarne un altro che ha bisogno. Io questo non lo farò mai, faccio quello che ho imparato, lavorare con la relazione e quindi ho fatto così anche in consultorio.
L: Quindi se ci fosse una rivoluzione da fare ad oggi sarebbe quella di investire veramente sulla relazione?
R: Sì e anche di investire sugli operatori. Dare all’operatore la possibilità di lavorare un po’ più tranquillo rispetto alla registrazione della prestazione ad esempio. Io credo che questo approccio al disagio mentale ed emotivo non può passare attraverso una schematicità. Si sta tornando molto indietro ahimè...
***
Dovendo scrivere di Basaglia, dei suoi anni e di ciò che hanno rappresentato per la psichiatria italiana le sue intuizioni, ho pensato che potesse essere molto interessante parlarne con una persona che quegli anni li ha vissuti, permettendoci di rivivere la storia da un punto di vista privilegiato e originale in quanto legato al vissuto reale dei pazienti più ancora che alla teoria accademica.
Per chi scrive, giovane psicologa, alla luce di questa preziosa chiacchierata resta una sensazione di perdita. La sensazione è che oggi questo fermento di idee con al centro il benessere dei pazienti sia carente e si stia scivolando verso una standardizzazione di metodologie e un rigore operativo che lasciano poco spazio alla relazione.
Il sistema ha già riassorbito anche Basaglia e le idee di tutti i “rivoluzionari” di quegli anni?
NOTA BIOGRAFICA
Raffaella Bricchetti. Psicoterapeuta individuale e di coppia, laureata in Filosofia con indirizzo Psicologico e specializzata in Psicologia con indirizzo Sociale nel 1984, presso l’Università degli Studi di Milano. Dal 1974 collabora con la Scuola di Formazione Il Ruolo Terapeutico come docente clinica e teorica. Inoltre è redattrice della rivista “I Quaderni del Ruolo Terapeutico”.
NOTE
[1] Cesare Luigi Eugenio Musatti (Dolo, 21 settembre 1897 – Milano, 21 marzo 1989) è stato uno psicologo, psicoanalista, filosofo e politico italiano, tra i primi che posero le basi della psicoanalisi in Italia
[2] Sergio Erba psichiatria con formazione psicoanalitica. Dagli anni '60 sino all'85 ha lavorato per il servizio pubblico nella Clinica psichiatrica dell'Università di Milano, nell'Ospedale Psichiatrico P. Pini e al Centro psicosociale di zona 13. Fondatore della scuola "Il Ruolo Terapeutico" di Milano e dell’omonima rivista
[3] Benedetto Saraceno, Psichiatra ed esperto di sanità pubblica, ha lavorato a Trieste sotto la direzione di Franco Basaglia e a Milano come responsabile della Comunità per pazienti psicotici gravi prevista dalla legge Basaglia. Direttore del Laboratorio di epidemiologia e psichiatria sociale presso l’Istituto Mario Negri. È stato uno dei leader del movimento di Psichiatria antistituzionale e ha lavorato per molti anni in America latina, dove ha promosso modelli comunitari di assistenza psichiatrica ispirati alla difesa dei diritti umani dei pazienti. Dal 1999 al 2010 ha diretto il Dipartimento di salute mentale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra
[4] Leo Nahon, Psichiatra, è stato assistente di Franco Basaglia all’ospedale di Trieste. È stato poi Primario dei Servizi Psichiatrici di Vimercate e Carate e poi Direttore della Struttura Complessa di Psichiatria dell’Ospedale Niguarda a Milano.
[5] Letteralmente deriva dalla lingua francese e significa deposito. In medicina viene riferito a particolari formulazioni di farmaci che consentono l’accumulo nei tessuti ed il graduale rilascio nel tempo della sostanza terapeutica somministrata. Il farmaco quindi è disciolto in particolari veicoli oleosi che ne consentono lo stoccaggio nel tessuto muscolare (tramite iniezione intramuscolare profonda) o nelle mucose (mediante ovuli)