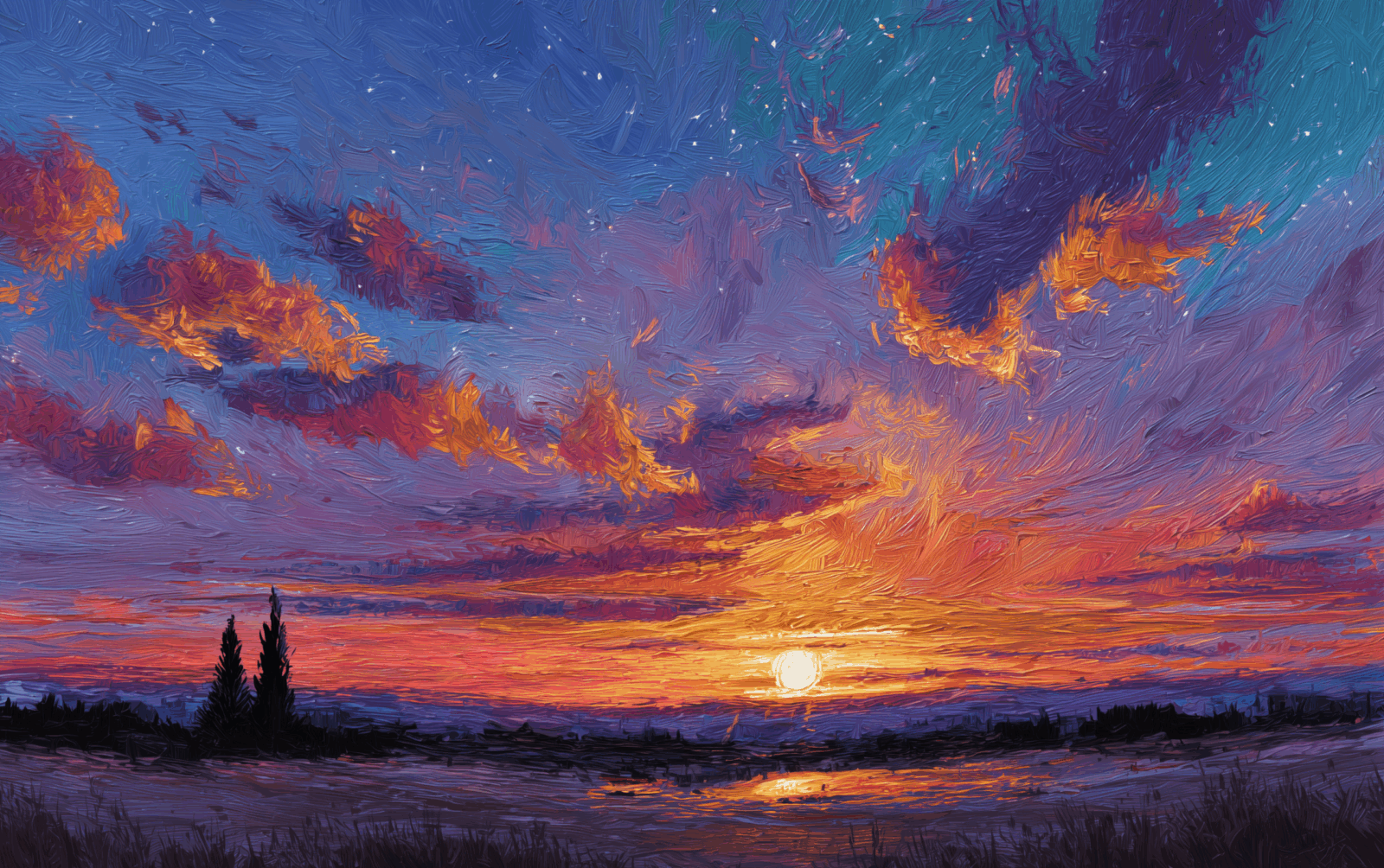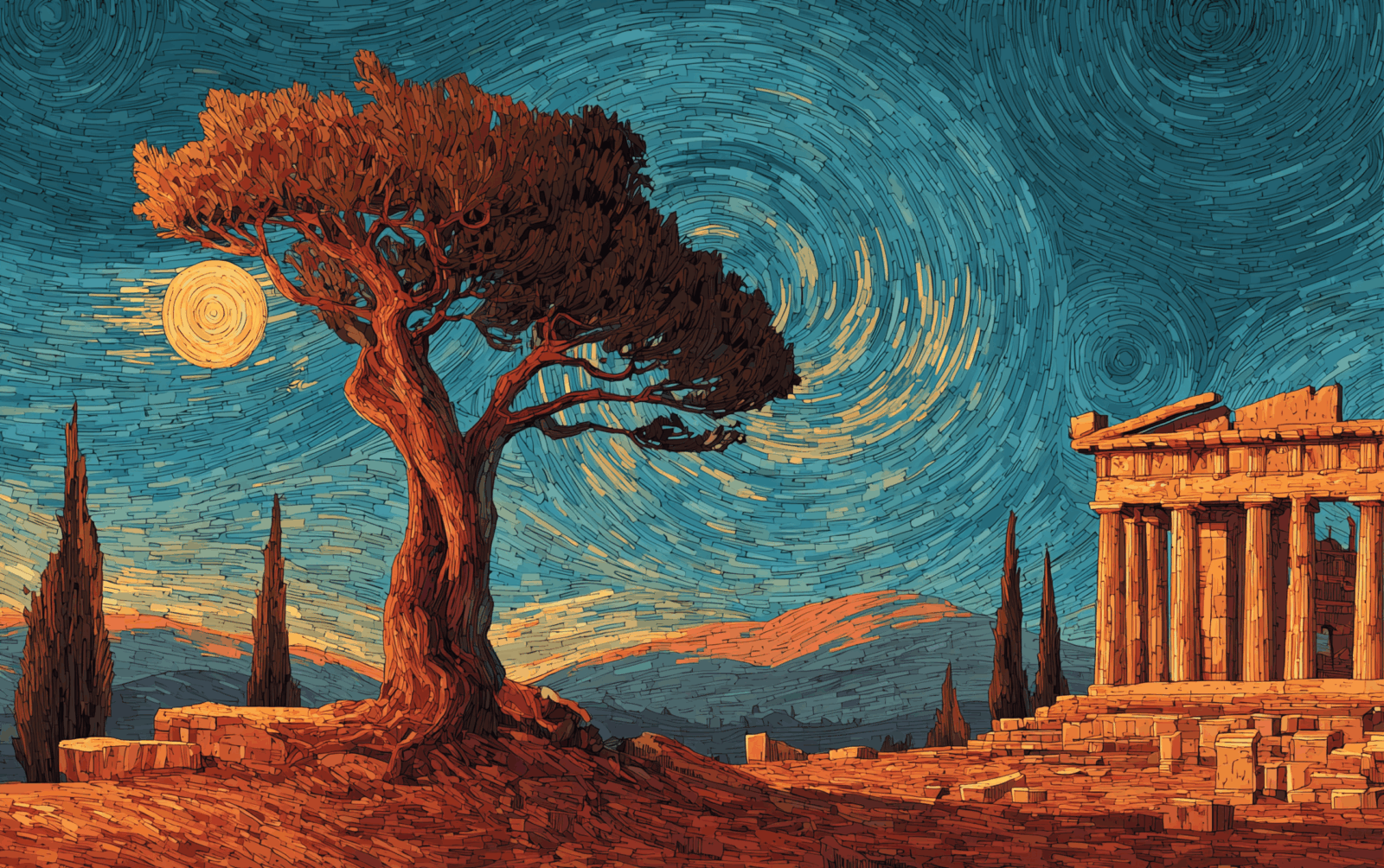La cultura occidentale non è mai esistita - L’alba di tutto di Graeber e Wengrow
1 - Il mito dell’Illuminismo
Esistono libri di intelligenza contagiosa, in cui l’audacia delle tesi e la felicità dell’argomentazione sembrano poter contaminare anche il lettore, e promettere un futuro meno assopito nell’inerzia dei pregiudizi e della noia accademica. L’alba di tutto di David Graeber e David Wengrow appartiene senz’altro a questo manipolo di capolavori, con l’invito a ripensare le categorie di modernità, di democrazia, di barbarie, di organizzazione, di potere – ma soprattutto a rigettare la fede nell’esistenza di una «cultura occidentale», la cui natura giustificherebbe ogni altra distinzione, classificazione, e l’intera epistemologia delle scienze sociali. In effetti il riesame coincide con una ricusazione delle differenze tra la civiltà che gli europei hanno sviluppato sul continente (ed esportato ovunque con la colonizzazione) – e le forme di vita frequentate dalle popolazioni cui assegnamo qualche tipo di minorità, che le rende adatte agli studi di etnologia.
L’Illuminismo è la frattura storica che assegnerebbe all’Occidente alla sua posizione straordinaria nel mondo e nella storia, perché avrebbe reso la nostra civiltà l’unica ad aver ucciso il suo Dio e ad essere sopravvissuta al delitto, con una volontà di potenza accresciuta, e persino con un’autocoscienza più intensa. La fine dell’egemonia religiosa avrebbe avviato la legittimazione della scienza, del potere politico, delle tecniche, solo sul fondamento della sola razionalità umana: avrebbe scisso la neutralità della logica e dell’osservazione empirica da un lato – e gli interessi, le finalità pragmatiche dell’individuo e della collettività dall’altro lato. La lucidità di questo sguardo, purificato dai pregiudizi e dalle pressioni dell’utilità sociale, permetterebbe alle nostre scienze sociali di osservare le altre culture (e naturalmente anche la nostra) con un’obiettività che nemmeno loro possiedono su se stesse.
Il primo obiettivo di Graeber e Wengrow è denunciare la narrazione sull’Illuminismo come una mitologia patologica, paragonabile a quelle che diagnostichiamo alle altre etnie. Il metodo consiste in una rilettura degli autori Settecenteschi, alla ricerca delle ragioni per cui dalla metà del secolo il dibattito sull’origine della diseguaglianza tra gli uomini, e quello sulla libertà individuale, diventano tanto pressanti. L’indagine è radiologica, individua l’ossatura delle argomentazioni originali, e la nervatura di trasmissione delle idee, al di sotto dei pregiudizi con cui i commentatori successivi hanno rivestito le dichiarazioni di Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu. L’esame critico delle istituzioni politiche europee attraverso gli occhi di stranieri, dagli amerindi ai persiani, è stato un genere letterario per tutto il Settecento: ma i suoi contenuti non devono essere intesi come prodotti di finzione. La pubblicistica dei frati missionari che hanno accompagnato gli eserciti spagnoli, francesi e britannici nella colonizzazione delle Americhe, quella dei gesuiti che hanno esplorato l’Oriente – la presenza in territorio europeo di ambasciatori delle tribù indigene d’oltreoceano – hanno contaminato il pensiero dei philosophes con idee non rispettose della teologia politica, delle istituzioni feudali e delle loro estensioni assolutistiche; il contagio si è propagato con il dibattito sulla separazione dei poteri dello stato, l’infiammazione dell’opinione pubblica contro i privilegi dell’aristocrazia, la decapitazione del re, l’elaborazione dei codici napoleonici, le convulsioni rivoluzionarie attraverso tutto il continente.
2 - Il mito delle origini
Ma il fine di Graeber e Wengrow è proprio quello di riportare alla luce il brulichio di esperienze culturali animate da una coscienza laica, da un’esperienza politica raffinata, da una complessità concettuale sull’organizzazione sociale, sui fondamenti di legittimazione del potere e della ricerca della verità, che si sono sviluppate al di fuori (e prima) dell’Europa illuministica. Le prodezze del politologo wendat Kondiaronk inaugurano un’anamnesi di fonti dimenticate e di nuove scoperte archeologiche, che sollecita una diagnosi differenziale rispetto alle tesi di Hobbes sulla condizione di guerra di tutti contro tutti nello «stato di natura», e alla storia evolutiva che Rousseau ha raccontato nel Discorso sull’origine della diseguaglianza (e che tutti hanno continuato a ripetere per oltre due secoli).
Il filosofo ginevrino riconosce senza reticenza che la sua ricostruzione non si fonda su alcuna prova empirica; ma l’impianto di fondo della sua favola non è mai stato contestato. L’uomo delle origini giacerebbe inerte presso le radici degli alberi che possono alimentarlo, privo di linguaggio, di pensiero e di società, dedito alla soddisfazione dei bisogni primari con il minor dispendio possibile di energia. La razionalità avrebbe fatto irruzione (insieme alla coscienza della mortalità, agli interessi sessuali e sociali, alla tecnica e alle funzioni verbali) nell’istante in cui imitazione e vocazione di perfezionamento hanno corrotto la natura umana e hanno avviato la sua decadenza. Libertà e uguaglianza sarebbero proprietà solo delle comunità più antiche, limitate a pochi individui e ad una struttura priva di articolazione funzionale e di necessità politiche. La complessità inoculata dall’agricoltura e dalle tecniche di canalizzazione delle acque, di gestione dei magazzini per le scorte, avrebbe provocato la remissione della democrazia comunitaria e la degenerazione verso le gerarchie degli imperi autoritari. L’evoluzione avrebbe condotto alla schiavitù e alla degradazione morale, a causa della corruzione dei costumi – effetto collaterale dell’articolazione sociale.
3 - Creatività politica
Al contrario, Graeber e Wengrow scoprono una creatività politica che scardina la complessità dei bisogni e delle azioni collettive dalla struttura del potere. Le comunità hanno sempre elaborato una comprensione esplicita della loro configurazione sociale, e della costituzione che legittima l’autorità di chi esercita il potere: probabilmente una delle meno consapevoli è stata proprio quella europea del Medioevo, che ha subito la tirannia di feudatari e imperatori, e che ha creduto nei principi della teologia politica. L’interpretazione dei reperti archeologici, con nuove domande e nuovi dati, permette di distillare una nuova comprensione delle società amerinde e orientali, dove la proliferazione delle forme di vita e la tassonomia delle identità politiche hanno tentato ibridazioni di ogni genere. Gli uomini non hanno rispettato i confini della differenza linguistica, della distanza geografica, della differenza di abitudini tecniche e alimentari, per sentirsi parte dello stesso popolo: le generalità dell’antenato totemico hanno permesso a uomini e donne di ottenere accoglienza fraterna presso gruppi dislocati anche dall’altra parte del continente Al contempo, la mancanza di infrastrutture di comunicazione di massa ha impedito ovunque, a qualunque forma di tiranno, di raggiungere con il suo potere assoluto individui distanti anche solo qualche chilometro dalla sua dimora.
Peraltro la configurazione stessa delle comunità, e del loro coordinamento politico, è stata modellata da esigenze di vario tipo: molte popolazioni hanno obbedito a due ordinamenti diversi ogni anno, secondo cadenze stagionali, disperdendosi in piccoli gruppi durante il periodo propizio per la caccia, e riunendosi in città o villaggi nel periodo dei raccolti. Hanno anche abbracciato, e poi abbandonato, tecniche che la narrazione di Rousseau dispiega in un ordine storico sequenziale e irreversibile – come è accaduto per l’agricolutura, che diverse civiltà del Medio Oriente e delle Americhe hanno prima esercitato, poi trascurato per recuperare strategie economiche fondate sulla caccia e sulla raccolta.
Persino l’autorità andrebbe ripensata in modo radicale, dal momento che all’investitura divina dovrebbero sostituirsi altre modalità di legittimazione, spesso riconducibili a qualche forma di talento, come l’abilità agonistica (che include anche, ma non solo, l’uso delle armi). L’aristocrazia degli Olmechi amava farsi ritrarre in tenuta da giocatore di palla, e ha consegnato questa cultura competitiva a bassorilievi che sono giunti fino a noi. In generale la dedizione alla combattività ha plasmato tutte le civiltà oligarchiche, e il peso della loro visione del mondo deve essere stata all’origine non della formazione – ma più spesso, della dissoluzione di città e di interi regni. La diaspora della popolazione di aree urbane e di percorsi commerciali può essere motivata dal bisogno di sottrarsi al controllo e alle pratiche di violenza con cui i gruppi nobiliari si sono sovrapposti alle organizzazioni precedenti; la gente ha preferito tornare a condizioni di autorganizzazione diverse (stagionali, totemiche, repubblicane), ignorando il precetto dello schema evolutivo di Rousseau, che le assegnerebbe ad una fase più antica, e disgregando regni e imperi. Le città sono un prodotto dell’immaginazione, non conglomerati di abitazioni, e la Teotihuacan priva di un governo secoli fa, come la Milano lottizzata di oggi, si estendono sul progetto e sulla visione del mondo in cui crediamo; la distribuzione in classi può essere l’effetto del gioco, dello sport, della conoscenza, della ritualità, senza essere per forza una mappatura della distribuzione del potere coercitivo.
La verità, di cui i reperti archeologici sono solo dei sintomi, rimarrà forse insondabile per sempre. Ma l’esercizio diagnostico di Graeber e Wengrow è prima di tutto una terapia contro l’inerzia della nostra immaginazione intellettuale. Combatte l’atrofia concettuale con cui ripetiamo la stessa storia sull’evoluzione della civiltà, delle tecniche, della politica e dell’economia; è un integratore di ipotesi e di informazioni che rianima un modello di umanità più intelligente e più affezionata alla libertà, alla ricerca della felicità, rispetto a quello che si è sclerotizzato nel mondo in cui noi ci siamo condannati a sopravvivere: quello dove «non ci sono alternative» al nichilismo del lavoro fine a se stesso, dell’arricchimento fine a se stesso, della fine della storia. Ma un universo dove non si attende più un futuro, che non sia la ripetizione vegetativa del presente, non ha nemmeno un passato da ricordare: è per questo che soffriamo la nevrosi della favola di Rousseau, senza cercare di uscirne. Il merito di Graeber e Wengrow è di aver tentato una cura, con uno scavo entusiasmante che attraversa ogni angolo del mondo, e che sollecita la nostra curiosità a far rifluire energie concettuali dove il pensiero era rimasto paralizzato, irrigidendosi nella fede della corrispondenza tra evoluzione tecnica e configurazione politica, dell’irreversibilità del percorso storico, della permanenza dell’umanità in un’infanzia della ragione, da cui solo l’Illuminismo europeo ci avrebbe educato a crescere. Gli uomini sono sempre stati adulti, e hanno sempre saputo scegliere l’alternativa migliore per loro: con buona pace della signora Thatcher, è ora che torniamo a esserlo anche noi.
A confronto con il pensiero di Platone: la memoria e la sua corruzione nell’era digitale.
A giugno di quest’anno Controversie ha organizzato un seminario in forma di tavola rotonda sul tema dell’ontologia dell'intelligenza Artificiale. Durante il dibattito è emersa la possibilità che i grandi modelli linguistici (LLM) si possano affermare – tra le diverse applicazioni che già si intravedono – come una sorta di bibliotecario con pretese di universalità. Questa ipotesi è ben delineata da A. Colamedici e S. Arcagni, nel loro libro L'algoritmo di Babele. Storie e miti dell'intelligenza artificiale (Solferino Libri, 2024) e suggerita tra le righe da Luca Sofri "Intelligenze artificiali" tra virgolette, nel suo blog Wittgenstein.
La biblioteca universale, la biblioteca fantastica che contiene tutto ciò che è stato scritto e che potrà essere scritto, è un tema che – in maniera ricorrente – prende forma nelle riflessioni di filosofi e letterati, da Leibniz allo scrittore Kurd Laßwitz, detto anche Velatus, fino ad ossessionare Jorge Borges (La Biblioteca di Babele) e a ispirare l’imprenditore Brunello Cucinelli, che nel 2022 annuncia la realizzazione di una “sua” biblioteca universale, a Solomeo, dedicata ai lavoratori delle sue aziende.
Il tema della biblioteca è strettamente connesso con quello della memoria; ritrovare un passo di un libro, di un autore richiede di averne memoria e di riuscire a situare questo scampolo di memoria nello spazio della propria biblioteca mentale e, solo successivamente, a ritrovare la collocazione di quell’autore o di quel libro all’interno della propria libreria o di una biblioteca istituzionale o pubblica.
Ecco, una potenziale funzione dei LLM è proprio di fare da contenitore molto ben indicizzato di grandi quantità di conoscenza, e di trovarle e metterle a disposizione degli utenti in modo ragionato e selettivo, su richiesta espressa in linguaggio naturale. E, proprio per la loro capacità di gestire volumi enormi di informazioni in tempi ragionevoli, può tendere a quel grado di infinito sotteso dall’espressione “universale”.
A contrasto con questa idea e prospettiva, vi proponiamo una riflessione di Fabio Talloru sulla memoria e su Platone, che per la memoria e la sua rilevanza nel pensiero umano aveva un debole.
-----
Se ancora oggi Platone viene inquadrato come filosofo sradicato dalla concretezza del mondo e proiettato nell’Iperuranio, ciò è dovuto perlopiù alla ormai superata (ma ancora presente) visione diffusa dalla formazione scolastica ordinaria. Invece, la filosofia di Platone è profondamente radicata nel mondo fisico e materiale.
Ѐ noto a tutti che per Platone vi sia una memoria di genere immortale, la quale provvede alla reminiscenza (anamnesis) degli oggetti intelligibili. Meno noto e poco esplicito nei dialoghi è invece l’altro genere, quello “mortale” (non è questo il termine platonico), inteso come proprio della condizione incarnata dell’Anima immortale in un vivente (zoòn).
La Memoria (mneme) è una delle facoltà dell’anima, quella di imprimere, tracciare o racchiudere nella forma di ricordo (hypomnema) le informazioni che otteniamo da oggetti incontrati attraverso l’esperienza empirica. Essa è l’insieme di ciò che si è sedimentato nell’anima a partire dalle sensazioni memorabili, prodotte dall’esperienza che facciamo di oggetti che esistono fisicamente nel mondo empirico (il processo completo è esposto nel discorso fisiologico contenuto nel Timeo1).
Il tema che ci interessa indagare in questo post è quello della “volatilità” del sapere in Platone, per produrre nuovi spunti di riflessione utili nel dibattito odierno.
La reminiscenza (anamnesis) è un’operazione prodotta dalla sola Anima immortale. Più propriamente essa è una forma del ri-memorare oggetti visti nella condizione disincarnata. L’operazione dell’apprendimento (mathesis) di nozioni avviene, invece, durante la vita e il contenuto di una memoria “mortale” (il ricordo) può dissolversi irrimediabilmente. La memoria nella sua totalità cessa definitivamente la propria esistenza con la morte del vivente che lo possiede, perciò con lo scioglimento dei vincoli tra l’anima e il corpo.
In primo luogo possiamo affermare l’esistenza di una memoria “mortale” nel pensiero di Platone poiché non ci è pervenuta nessuna testimonianza o accenno a proposito della possibilità di reminiscenza di ricordi appartenenti a vite passate - come invece è presente nelle dossografie pitagoriche2, che Egli conosceva e custodiva gelosamente nella propria biblioteca. In secondo luogo, nei dialoghi che affrontano problemi legati sia alla reminiscenza che alla metempsicosi, troviamo l’idea che a ogni nuova incarnazione debba esservi un “reset” della memoria in relazione alla vita empirica (si veda nello specifico il “Mito di Er”3)
Parrebbe anche che, sul piano mortale, le conoscenze pratiche e dell’esperienza empirica siano più durevoli rispetto a quelle epistemologicamente superiori (“scientifiche”) del filosofo o del matematico (che hanno come proprio oggetto ultimo gli intelligibili).
Questo lo si può dedurre in particolare da un passo del prologo drammaturgico del Timeo. Qui Crizia il Giovane riporta un racconto che apprese da bambino, in cui Solone incontrò in Egitto un sacerdote che così affermava:
«“Siete tutti giovani d’animo (voi greci)”, rispose il sacerdote, “perché non avete nelle vostre anime nessuna opinione antica trasmessa attraverso una tradizione che proviene dal passato né alcun sapere ingrigito dal passare del tempo».
Prosegue poi con la motivazione di questa brevità della memoria collettiva dei greci:
«ogni cosa viene registrata, fin dall’antichità, nei nostri templi e conservata alla memoria», mentre in Grecia «a intervalli regolari di tempo, come una malattia, torna il flusso del cielo che vi inonda e non lascia illesi fra voi che gli illetterati e i nemici delle Muse (gli incolti), sicché ricominciate nuovamente dal principio, come tornati giovani». Per di più, aggiunge il sacerdote: «nel corso di molte generazioni, i sopravvissuti sono morti senza aver fissato la loro voce nella scrittura». (Tim. 22 d – e)
In questo passo possiamo individuare almeno sei punti ri-attualizzabili al giorno d’oggi:
- la scrittura esprime qui il suo ruolo di strumento tecnico corruttibile ma preservabile dalla distruzione, perciò tramandabile;
- la scrittura è uno strumento tecnico ausiliario, che richiede una stabilità materiale continuativa della società per essere mantenuto e motivato nell’uso ordinario;
- il vivente mortale, se non ha né la possibilità né la premura di tramandare il prodotto della propria conoscenza, non conserverà un sapere collaudato da mettere a disposizione dei posteri;
- la condizione del dopo-catastrofe è analoga a un “momento zero” della memoria mortale, un “cominciare nuovamente da principio”;
- i saperi pratici “degli illetterati e degli incolti” sopravvivono più facilmente rispetto a quelli di filosofi e scienziati, propedeutici a porre le basi di quella stabilità materiale che rende possibile l’accumulo del sapere;
- l’accumulo di un sapere avanzato e complesso, come quello “scientifico” (episteme), non è necessario alla vita, ma è un “in più”.
Platone ci indica anche che, quando si sia memorizzata un’informazione, la sua durevolezza dipenderà non solo dalle condizioni in cui il suo proprietario la custodisce e preserva, ma anche da come egli l’ha ottenuta. Ad esempio, Crizia il Giovane racconta una storia di cui ha acquisito un ricordo “vivido”, in quanto giovane, attento e partecipativo nel momento del suo apprendimento4. Un caso diverso è invece quello di Fedro che, nel dialogo omonimo, deve confrontarsi con un’opera scritta che necessita di rileggere più volte per ricordarla “alla lettera” al fine di poter tenere il proprio discorso5 basato su di essa.
Nel primo caso, quello di Crizia, la qualità del ricordo è dovuta alle caratteristiche che contraddistinguono il momento in cui egli ha appreso un’informazione, ossia la pregnanza dell’esperienza di apprendimento. Nel secondo caso, quello di Fedro, la qualità della formazione del ricordo sarà dovuta all’ausilio di strategie mnemotecniche, quali la rilettura e la ripetizione a voce alta.
Per concludere, il problema della conservazione, del tramandare e della possibile perdita della memoria (nel senso più ampio che comprende storie, tradizioni, tecniche e conoscenze) è un fenomeno oggi ancora più complesso. In particolare se guardiamo al fenomeno di progressiva sostituzione dei mezzi di trasmissione “tradizionali” dell’oralità e della scrittura manuale in favore della digitalizzazione dell’informazione.
Quante tipologie e forme di “memoria” abbiamo a oggi sviluppato e quali si stanno depotenziando o stanno scomparendo?
Quante forme della scrittura possediamo e quali competenze sono necessarie per farne uso?
Quanti livelli di linguaggio e quante forme di linguaggio esistono per la sola codificazione informatica dell’informazione?
Quali i pericoli a cui si espone la loro conservazione?
Ai cataclismi menzionati dal sacerdote egizio che ha incontrato Solone, evidentemente presenti e comunque imprevedibili ancor oggi, quali si aggiungono?
Ovviamente, sono domande complesse che richiedono risposte altrettanto articolate. Ad esempio, per i supporti di archiviazione digitale, da cui oramai dipendiamo largamente, sono deleteri i fenomeni elettrici, magnetici ed elettromagnetici, i quali sono tutti in grado di cancellare, corrompere o rendere inaccessibili, se non addirittura irrecuperabili, le informazioni registrate.
La stessa obsolescenza delle tecnologie e delle tecniche di conservazione e riproduzione dell’informazione, giorno per giorno avvia verso la fine la riproducibilità delle precedenti forme di “memoria”, sia collettiva che individuale (foto, video, documenti, scansioni di immagini, etc.). Gli attuali dispositivi che possediamo saranno sempre meno reperibili con l’avanzare di nuove tecnologie e dei relativi sistemi che ne permettono il funzionamento?
I dispositivi attualmente in uso, per quanto collaudati, non saranno un giorno più compatibili con quelli più avanzati, per protocolli di scrittura e lettura?
Saranno reperibili le tecnologie di giunzione che permettono di interfacciare fisicamente vecchi e nuovi dispositivi di archiviazione di memoria?
Le tecnologie di traduzione e conversione reciproca tra vecchi e nuovi protocolli di archiviazione dell’informazione saranno ancora implementate sui nuovi dispositivi o saranno ancora reperibili e adoperabili?
Quali altre problematiche sono riscontrabili o sono di imminente larga diffusione?
La memoria è un affare complesso, sia individuale che collettivo.
NOTE:
1 Tim. 42 d - segg. e 69 c - segg.
2 Centrone, B. 1996, Introduzione a i pitagorici, Editori Laterza, Roma-Bari, pp. 52-61
3 Resp. 614 b - 621 d
4 Tim. 26 b
5 Phaedr. 228 a
La costruzione sociale e letteraria dell'animalità - Flush, una biografia di Virginia Woolf
In Flush, una biografia[1], Virginia Woolf fa parlare Flush, un cane, un animale non umano, in un modo che si manifesta ad una distanza davvero minima dall’umano, in cui si riscontrano una corporeità fortemente antropomorfa e delle forme di intelligenza che ricalcano, almeno in parte, lo schema delle intelligenze multiple[2]: l’intelligenza sociale, quella mappale, la pragmatica, la mimetica.
Questo racconto mette in scena la società patriarcale inglese e la concezione dell’animale e della donna che fanno capo a questo modello sociale; anticipa, in maniera non del tutto esplicita, una parte dei temi dell’impegno femminista, seppure sotto una patina snob ed elitaria, a favore del suffragio, della possibilità di studiare e di lavorare davvero, della autodeterminazione delle donne, poi sviluppati nelle Tre ghinee; è un racconto affettuoso e intellettualmente onesto, in cui si ritrovano molti dei temi che afferiscono al concetto di costruzione sociale dell’animale.
Woolf utilizza una prosopopea[3] indiretta, in grado di attribuire pensieri e scelte morali in forma condizionale al cane: “sono io che dico che pensa questo, senza esserne certa”, questo sembra essere il suo intertesto.
“Flush” è – di fatto - un inseguimento di biografie: Woolf racconta da narratrice fuori campo la vita di Flush e, nel farlo, mette in scena - secondo il punto di vista di Flush – uno spaccato biografico di Elisabeth Barret Browning, che dura quanto la vita di Flush con lei, i 12 anni dal 1842 al 1854.
Il libretto racconta di Elisabeth, invalidata da una malattia (riconducibile ai nervi, all’ansia o all’effetto dell’atmosfera paternalista e patriarcale della famiglia Barrett) che le non le permette di uscire dalla sua stanza, dell’arrivo e dell’amore di Robert Browning, del rapimento di Flush – che è un punto di snodo della storia e delle percezioni di tutti - del trasferimento della coppia a Firenze, del ritorno a Londra e del successivo e definitivo ritorno di Flush a Firenze.
Siamo di fronte ad un testo-pretesto per narrare la biografia di Elisabeth Barret Browning, il patriarcato inglese, la critica sociale alla nobiltà inglese e alle sue idiosincrasie, la critica all’illuminismo e alle – in un gergo femminista diffuso oggi - menxplenation nella cornice un po’ stereotipata della vita genuina, piena di eros e di luce, in Italia.
COSTRUZIONE SOCIALE E LETTERARIA DEL CANE
Il cane Flush, archetipo dei cani è definito e raccontato con diversi registri narrativi, ognuno dei quali rispecchia il soggetto con cui in quel momento ha a che fare Flush e – di conseguenza – diverse possibili forme di costruzione sociale dell’animale
Consideriamo solo i registri narrativi più aderenti al tema dell’animalità:
- il registro formale, quasi istituzionale e imperiale, dedicato al razzismo della linea di sangue del cane; è collegato alla medesima ossessione della linea di nobiltà nella società inglese umana – e insieme di costruzione tradizionale del cane
- un registro apertamente patriarcale, il cui esemplare rappresentativo è Mr. Barrett, patriarcale nei confronti della figlia, della sua malattia e anche del cane Flush, che non è neppure considerato poiché non fa parte del suo universo, a differenza dell’altro cane, il segugio Catilina, che ha un senso pratico: è un segugio!
- il registro illuminista, raziocinante, positivista e essenzialista di Robert Browning, che è il modo di essere colto e progressista del patriarcato
- due registri di Elisabeth Barrett Browning: uno arcadico, romantico, anche questo piuttosto tradizionale, e un registro più intimo che trascende la banalità stereotipata
- un ultimo, fondamentale registro: quello di un narratore che si immerge in una caninità profonda, inevitabile, materialista, centrata sulla corporeità
FORMA
Troviamo questo registro nel primo capitolo, nel racconto della razza Spaniel, in paragrafi permeati di specismo e di gradi gerarchici di nobiltà – con un raffronto con la nobiltà umana: “il cane come si deve” deve essere così e così, deve seguire delle linee di discendenza e avere dei tratti somatici ben precisi – una linea di demarcazione netta tra pedigree e niente del tutto (p.10)
Fa parte di questo schema di costruzione sociale anche la nozione di cane oggetto di contrattazione, cosa da comprare e da vendere, proprietà che può essere alienabile o non alienabile. Flush è inalienabile per Miss Mitford, “appartiene a quel raro ordine di oggetti che non può essere messo in relazione col denaro” (p.18) ma che si può regalare, suo malgrado. E viene quindi regalato alla signorina Barrett (p. 19).
TRADIZIONE
Ecco, in questo modello, la connotazione più tradizionale delle caratteristiche del cane: fedele, sensibile, innamorato del padrone in modo stereotipato e, nello stesso tempo, istintivo, legato al presunto ricordo ancestrale della caccia. È l’animale “tutto instinto”, senza mente, senza intelligenza, senza raziocinio – contrapposto alla tradizione metafisica di casa Barrett, e alla razionalità di Robert Browning.
PATRIARCATO
Centrato sul padre di Elisabeth, oppone al rapporto di amorosi sensi di Elisabeth con Flush la praticità funzionale di Catilina, segugio che ha la sua ragione d’essere nella caccia; alla sensibilità di Elisabeth la durezza del patriarca che decide per conto della figlia, che si prende cura di lei con piglio militaresco (“il pranzo è stato consumato? sono state eseguite le mie disposizioni?”), dando ordini e pretendendo risultati.
Il patriarcato[4] ha la sua espressione più esemplare nell’episodio del rapimento, quando Mr. Barrett decide inappellabilmente che non si pagherà il riscatto. Flush, nella concezione del patriarca è un non-umano, un animale distante, irrilevante, al massimo funzionale a dare un po’ di svago alla figlia convalescente ma sostituibile. Morto un Flush se ne fa un altro.
ILLUMINISMO
È Robert Browning. Distantissimo da Flush nel periodo del corteggiamento, al massimo condiscendente: anche per Browning Flush è un cane, un animale senza anima, senza mente, senza i caratteri che distinguono l’umano dall’animale. Non è degno di interesse se non come epifenomeno dell’amata Elisabeth[5]. Robert Browning “passa sopra” Flush in senso fisico: anche quando viene morso per gelosia non reagisce, passa sopra, oltre. Ci si può occupare di un piccolo cane quando la vita chiede la poesia? Eppure, ancora, per il principio del prolungamento e dell’ingraziamento dell’amata, Robert porta i pasticcini proprio per Flush.
Browning, però, è illuminista, razionalista e idealista, tutte caratteristiche che suggeriamo essere necessarie per essere patriarcale. Affronta gli eventi della vita con lo stesso atteggiamento da uomo di grandi dimensioni con cui si muove, si toglie i guanti gialli, si siede con ieraticità nella poltrona che gli verrà riservata.
Il razionalismo idealista e la concezione dell’animale che ne fa parte, emerge in modo palese dopo il rapimento: Browning spiega con autorevolezza che non si deve pagare il riscatto per non cedere al ricatto del male contro la legalità, per non permettere il dilagare della malvagità, per preservare il lato sano dell’umano. Il cane Flush, animale senza rilevanza etica, va in minoranza, è sacrificabile, deve – anzi - essere sacrificato sull’altare del principio. («di un eroe morto che se ne farà?», cantava De Andrè). (p. 85)
MATERIALISMO, VICINO ALL’ANIMALITÀ
È il registro più genuinamente vicino alla caninità, intesa come modo di essere animale condiviso con l’umano. Emerge nei momenti in cui Flush “esce” dagli stereotipi tradizionali e “entra” nella dimensione della corporeità, dominata dai sensi e dai bisogni, con due modalità di espressione.
La prima è quella della libertà di movimento: Flush stava bene a Three Miles Cross, dove poteva girare liberamente nella tenuta e viene, poi, chiuso dentro ad una stanza, in cui la libertà di movimento è ridotta drasticamente “sulle prime la costrizione era insopportabile”. L’assenza di libertà di movimento risulta essere molto più invalidante dell’assenza di altre libertà[6], come quella di parola, ad esempio, ed è evidente la sofferenza che genera.
La seconda è la prevalenza dei sensi, soprattutto dell’olfatto: quando “sente” l’odore della femmina in calore e fugge per l’impulso sessuale (che Virginia Woolf chiama amoroso), quando entra a Wimpole Street e sente gli odori di casa, quando descrive l’ambiente in cui è rinchiuso dai rapitori, tutto fatto di odori e rumori, intensamente psichedelico, la cui immagine è fondata tutta sulla corporeità e ricorda, per la sete, il digiuno del cane kafkiano; infine, in tutta la parte del racconto che si svolge a Firenze: Flush è cane fino in fondo, dedito agli odori, alla sensualità necessaria, al mangiare e sopravvivere. (p.122)
In questo registro narrativo, la Woolf compie due operazioni di avvicinamento tra animale umano e non umano, come fa Plutarco in Grillo, in un senso attribuendo a Elisabeth una sensibilità più animale che umanista, nell’altro senso ammettendo una razionalità del cane: Flush identifica dei nessi di contiguità (se non di causalità) tra fenomeni: i segni della città dicono che deve stare al guinzaglio, è assodato; l’altra facoltà - tradizionalmente negata all’animale – che Woolf concede a Flush è la coscienza o, meglio l’autocoscienza riflessiva, quando questi si guarda allo specchio ed sollevato: è di buon rango!
Tra l’altro, questo è uno dei pochi momenti di prosopopea in forma diretta – chiacchiere classiste e snob dei cani di Wimpole street - e definitivamente funzionale ad un discorso che non riguarda gli animali non umani ma il classismo: si parla di linee di demarcazione!
ELISABETH BARRET BROWNING: ARCADIA, SPECCHIO DEL SÈ E INTIMITÀ ANIMALE
Il discorso di Elisabeth è giocato su più registri: uno arcadico, del tutto immaginario e favolistico, in cui Flush è espressione della natura selvaggia, benevola, che fa parte del sublime naturale; banalità stereotipata e stucchevole, che Woolf usa come critica al naturalismo arcadico del ‘700. Un secondo, altrettanto tradizionale, della specularità del sé: Elisabeth proietta le proprie emozioni e pensieri su Flush, facendone un cane antropomorfo e artefatto; è pura costruzione sociale, parente stretta della nozione di fedeltà canina cieca ed assoluta. Nonostante la concessione della coscienza, troviamo questo registro nell’episodio dello specchio: quando Flush si guarda allo specchio, Elisabeth lo pensa filosofo ma, in realtà, Flush pensa ai suoi quarti di sangue.
L’ultimo registro è molto intimo e avvicina Elisabeth a Flush attribuendole delle facoltà e delle affezioni caratteristiche di tutta l’animalità: essa “è” mangiare e bere, poi diventa sensualità e possibilità di affrancamento con il matrimonio e infine “è” godimento di una libertà di movimento e di determinazione mai visti prima.
È in questo registro che – sempre in occasione dello snodo narrativo e comportamentale del rapimento – Elisabeth emerge con due nozioni in controtendenza, innovative: pur consegnandosi nelle mani di un altro patriarca paternalista travestito, quale è il suo futuro marito Robert Browning, si autodetermina, si sposa contro il volere del patriarcato (ma col patriarcato) e si veste della sua rilevanza morale, in contrappunto all’antropocentrismo etico di Browning e dei Barrett.
-----
Per tirare le somme, in questo denso racconto, Virginia Woolf tratteggia dei caratteri tipici di tutta l’animalità, sia umana che non umana, i tratti di tranquillità di cibo e di movimento, bisogni chiave del vivente animale, gli stessi che sottolineano Cervantes in Il dialogo dei cani (Marsilio Editore, 1993) e Kafka (cit. e altre opere [7]).
A questi caratteri, Woolf oppone tre antropocentrismi:
- ontologico: per Mr. Barrett, Flush è altro, è un animale funzionale, senza mente, senza caratteristiche umane. Per Mr. Browning, Flush è corpo, mentre lui è mente;
- epistemologico: per i personaggi patriarcali e per quelli più feroci il cane non capisce e non sente come “noi”;
- etico: Mr. Barrett e Robert Browning è sacrificabile, perché solo funzionale, perché eticamente irrilevante rispetto agli ideali di civiltà e di onestà.
La co-protagonista del racconto, Elisabeth, come abbiamo visto, smussa invece l’antropocentrismo ontologico, riavvicina le animalità – quella umana e quella non umana - anche epistemologicamente e nega del tutto quello etico. E va molto oltre: attribuisce a Flush la mente, l’autocoscienza riflessiva e, nella fase fiorentina, anche la progettualità, dando voce all’intenzione di riconoscere al non umano gradi diversi di intelligenza mappale, solutiva, relazionale, mimetica, autoimitativa – Flush impara dai suoi errori e dai suoi successi – e, infine, riflessiva.
NOTE
[1] Utilizziamo l’edizione Nottempo, 2012
[2] Cfr.: Biuso A., Animalia, Valverde, Villaggio Maori, 2020
[3] La prosopopea è una figura retorica che consiste nel far parlare o agire come persone esseri inanimati, concetti astratti o – appunto - animali
[4] È il patriacato che VW contrasta e denuncia esplicitamente a pag 13: “il dottor Mitford era un egoista: aveva dissipato il patrimonio suo e quello della moglie, per poi intaccare la rendita della figlia”
[5] È permesso esprimere dei dubbi sul sentimento di R. Browining per Elisabeth: è sentimento vero per lei o per la sua poesia? Vero è che Elisabeth e la sua poesia sono la stessa cosa. Lei è la sua poesia.
[6] Cfr.: F. Kafka, Una relazione per un'Accademia, in F. Kafka, Racconti, Feltrinelli, 1970
[7] Indagine di un cane e Il Digiunatore, in F. Kafka, Racconti, Feltrinelli, 1970