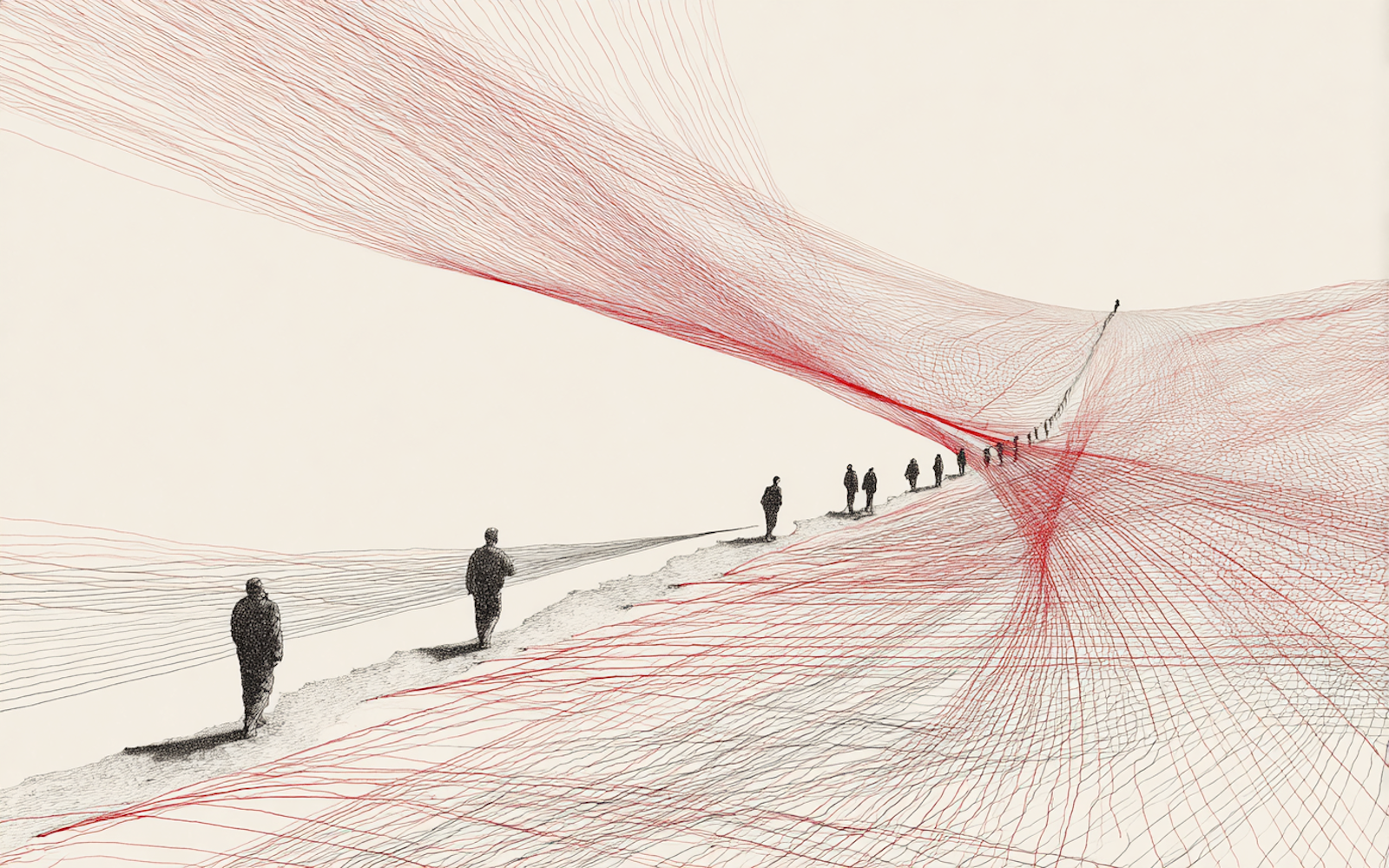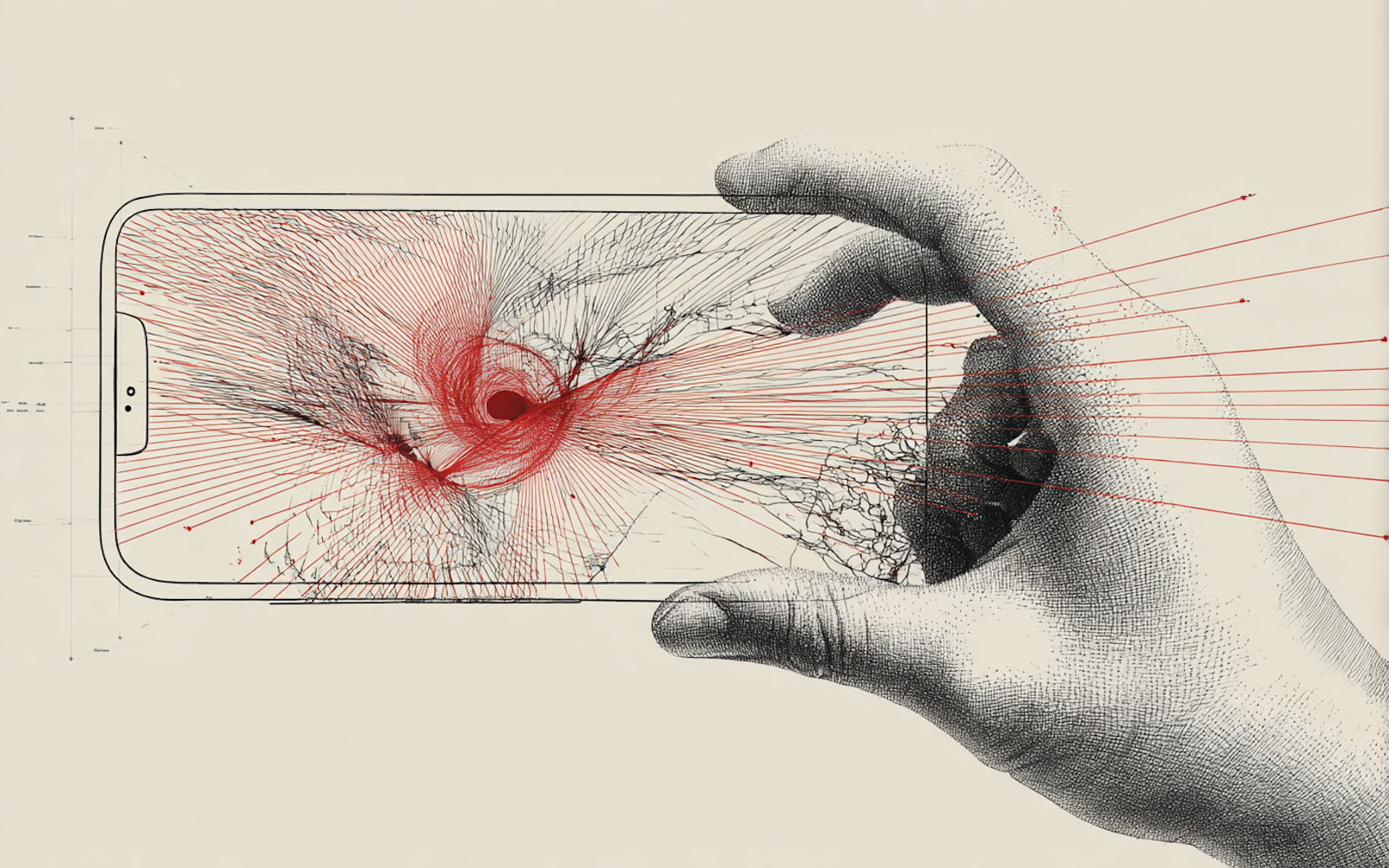La sensibilità di Gaia - Gli aspetti controversi dell’“ambientalismo scientifico”
Come molti sanno, l'ipotesi Gaia è stata formulata per la prima volta dallo scienziato inglese James Lovelock nel 1979, nel libro Gaia. A New Look at Life on Earth e co-sviluppata dalla microbiologa Lynn Margulis negli anni Settanta. Da quel libro sono nate moltissime riflessioni, anche nella sociologia della scienza.
GAIA: NON (SOLO) UN FATTO SCIENTIFICO, MA UN MODO DI IMPARARE A SENTIRE
Quando Lovelock propose l’ipotesi di Gaia, descrisse la Terra come un sistema vivente e autoregolativo: non un organismo unico, ma una rete di processi interdipendenti – oceani, atmosfera, suoli, specie viventi – che si influenzano a vicenda mantenendo condizioni favorevoli alla vita. Gaia, dunque, non è una divinità o un’entità mistica: è una maniera scientifica per dire che il pianeta risponde, reagisce, cambia insieme alle nostre azioni.
Bruno Latour (2014) riprende questo concetto, ma gli dà una torsione decisiva. Per lui il problema non è capire che cosa sia Gaia, ma come impariamo a percepirla. Non basta accumulare dati, grafici o modelli climatici per farci sentire la Terra come un attore con cui siamo in relazione. Gaia, dice Latour, non entra nel mondo attraverso la conoscenza meramente “scientifica”; entra quando diventiamo sensibili ai suoi segnali. E diventare sensibili non è un fatto automatico: è un apprendimento.
Latour parte da una domanda semplice: «Come diventiamo sensibili?» In altre parole: cosa ci fa accorgere che il mondo sta cambiando? Cosa ci fa sentire il ritorno delle nostre azioni sull’ambiente? La risposta è che i dati non bastano. Servono, ma non producono sensibilità da soli. Possiamo conoscere il riscaldamento globale senza percepirlo; sapere tutto delle emissioni senza sentire alcun coinvolgimento morale. Gaia allora non è – o non dovrebbe essere – un’idea astratta: è il nome che diamo a questo nuovo tipo di sensibilità verso il pianeta. È l’esperienza del “feedback” della Terra sulle nostre azioni.
SENZA ESTETICA NON C’È ECOLOGIA: PERCHÉ I DATI NON BASTANO
Qui entra in gioco l’estetica, nel senso originario del termine: aesthesis significa “percepire attraverso i sensi” e “rendere sensibile”. Per questo Latour (2014) rifiuta la separazione rigida tra scienza e arte. Gaia passa attraverso studi geologici e climatici, certo, ma anche attraverso romanzi, film, fotografie, metafore, immagini speculative. Tutto ciò che ci permette di percepire segnali minimi – un cambiamento nella qualità dell’aria, una siccità, una stagione fuori tempo, un paesaggio che non riconosciamo – e di collegarli tra loro, diventa una forma estetica che permette di percepire Gaia.
Anche Timothy Morton, uno dei teorici più radicali dell’ecologia contemporanea, insiste sullo stesso punto: la sensibilità ecologica non cambia semplicemente aggiungendo informazioni. In Hyperobjects (2013) e poi in Being Ecological (2018), Morton si lamenta apertamente del fatto che la crisi climatica continui a essere raccontata come un problema di più dati, più grafici, più evidenze, sottolineando che abbiamo già avuto mezzo secolo di informazioni sempre più precise senza che questo abbia modificato la nostra relazione con il pianeta. Conoscere non significa sentire.
Per Morton, il problema è esattamente quello che Latour vede in Gaia: l’assenza di un vero lavoro estetico, cioè di un cambiamento nella nostra capacità di percepire ciò che accade. I dati, da soli, possono descrivere la temperatura media globale, ma non aprono automaticamente uno spazio affettivo, immaginativo o etico capace di trasformare la nostra attenzione. Il rischio, dice Morton, è che il sovraccarico di informazioni produca l’effetto opposto: una sorta di torpore, una distanza anestetica che ci fa guardare la crisi climatica come un fenomeno astratto.
Questa critica rafforza l’idea che Gaia non sia solo un concetto scientifico, ma una questione di arte e di politica – o di “arte politica”. Per questo la sensibilizzazione a Gaia è un processo collettivo. Si costruisce nelle famiglie, nelle scuole, nelle discussioni quotidiane, ma soprattutto negli spazi della società civile: associazioni, movimenti, gruppi locali, comunità che sperimentano nuovi modi di stare a contatto con i problemi. Sono quelle che Kosnoski (2005) chiama “enclavi estetiche” (aesthetic enclaves): luoghi dove si impara a sentire insieme, a dialogare, a trasformare il nostro modo di preoccuparci per qualcosa.
QUANDO L’“AMBIENTALISMO SCIENTIFICO” ANESTETIZZA INVECE DI SENSIBILIZZARE
Negli anni Ottanta e Novanta molte organizzazioni ambientaliste costruivano il proprio messaggio sull’idea di “ambientalismo scientifico”: più dati, più misurazioni, più evidenze. Era una strategia comprensibile, nata nel tentativo di mostrare che i problemi ecologici non erano opinioni, ma fatti. L’intenzione era nobile: rendere oggettivo l’allarme climatico. Ma questa impostazione, centrata quasi esclusivamente sulle evidenze, ha prodotto un effetto collaterale imprevisto: una sorta di anestesia percettiva.
Con l’accumulo continuo di grafici, curve della CO₂, report sempre più tecnici, il rischio è stato quello di ridurre la crisi ecologica a un problema di calcolo, depurandola delle dimensioni affettive, morali, immaginative che permettono alle persone di sentirsi coinvolte. L’idea che “la scienza parlerà da sola” ha finito per lasciare “senza voce” i problemi ecologici. E infatti i dati, presi da soli, non convincono nessun climascettico: chi non vuole sentire, non sente nemmeno di fronte a migliaia di pagine dell’IPCC. Non perché i dati siano sbagliati, ma perché la sensibilità non si modifica per la mera accumulazione di informazioni.
L’ambientalismo scientifico, nel suo insistere sulla neutralità dei fatti, ha spesso trascurato il lavoro estetico necessario a trasformare la percezione. Questa stagione dell’ambientalismo “tecnico” mostra che la questione ecologica non è una questione di quantità di dati, ma di qualità dell’attenzione. Non basta mostrare: bisogna rendere sensibili. Senza questo passaggio, la scienza rimane un rumore di fondo, incapace di attivare responsabilità, immaginazione o cura. È proprio qui che Gaia, come figura estetica e sensoriale, offre un’alternativa: non un mondo da “dimostrare”, ma un mondo che si impara a sentire.
CONCLUSIONE: GAIA COME ARTE POLITICA
Se Gaia non è qualcosa da conoscere di più, ma qualcosa da percepire meglio, allora la sfida che abbiamo davanti non riguarda l’informazione, ma la risposta. La sensibilità a Gaia non nasce nei laboratori o nei report, ma nelle forme di vita che rendono possibile quell’attenzione condivisa che il solo sapere non produce. È in questo spazio intermedio – tra percezione, immaginazione e pratica – che la questione ecologica diventa veramente politica: perché ci chiede non soltanto di capire il mondo, ma di imparare a rispondergli.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
Kosnoski, J. (2005). John Dewey’s Social Aesthetics. Polity, 37(2), 193–215.
Latour, B. (2014). Sensitizing. In C. Jones (Ed.), Experience: Culture, Cognition, and the Common Sense (pp. 315–338). Cambridge, MA: MIT Press.
Lovelock, J. E. (1979). Gaia: A New Look at Life on Earth. Oxford: Oxford University Press.
Morton, T. (2013). Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Morton, T. (2018). Being Ecological. Cambridge, MA: MIT Press.
Sono diventato Morte, il distruttore di mondi
Quando J. Robert Oppenheimer, padre della bomba atomica, vide esplodere il primo ordigno nucleare nel deserto del New Mexico il 16 luglio 1945, non esultò. Non parlò di successo, né di trionfo. Pensò invece a un verso antico della Bhagavad Gita: “Sono diventato Morte, il distruttore di mondi.”
La frase cita parte del verso 32 capitolo 11 della Gita, uno dei testi fondamentali della spiritualità indiana : “Io sono il Tempo (Kāla), il grande distruttore dei mondi, e sono venuto per annientare queste genti. Anche senza di te, tutti i soldati schierati moriranno.”
Nella Gita, il principe guerriero Arjuna si trova sul campo di battaglia di Kurukshetra, tormentato all’idea di dover combattere contro parenti, amici e maestri. Il suo auriga è Krishna, che è in realtà una manifestazione divina che, per convincerlo a combattere, gli mostra la sua forma cosmica, una visione terrificante e sublime della divinità in tutta la sua potenza. Krishna dice ad Arjuna che il suo intervento è inevitabile, perché l'ordine cosmico va comunque avanti. Arjuna non è l’agente del destino: è solo uno strumento del dharma, dell’ordine cosmico.
Nel testo sacro la “Morte” o “Tempo” simboleggia il movimento inevitabile dell’universo, oltre il bene e il male umano; quindi, la frase non è una celebrazione della distruzione, ma una riflessione sul destino, sul ruolo dell’individuo, e sul fatto che la volontà divina (o il corso del tempo) trascende il volere umano.
Quando, dopo il test nucleare, Oppenheimer cita questa frase, la decontestualizza parzialmente, ma in modo molto significativo: lo scienziato si identifica non con Krishna, ma con l’atto distruttivo stesso, con la bomba.
Egli dice: “ho partecipato a un atto che cambia per sempre il corso del mondo e di cui ora sono consapevole. Abbiamo forse superato un limite che dovevamo tenere all'orizzonte?”. È una forma di shock esistenziale e morale: ha creato qualcosa che trascende il controllo umano, come il tempo o la morte.
Quella frase non è solo un riflesso personale di turbamento, ma il simbolo di un dilemma che attraversa tutta la storia moderna, la tensione tra il progresso e il darsi dei limiti. In essa si concentra la domanda che ogni società avanzata deve porsi: fino a che punto possiamo spingerci nella ricerca, senza compromettere ciò che ci rende umani?
La tecnoscienza è uno degli strumenti più potenti mai sviluppati dall’umanità. Gli strumenti che ne sono emanazione ci hanno permesso di sconfiggere malattie, esplorare l’universo, connettere continenti e prolungare la vita. Ma ogni nuova frontiera porta con sé un potenziale di meraviglia e di disastro. La meraviglia è irresistibile, ci chiama e ci muove; la consapevolezza di dove andremo, rispondendo alla chiamata, arriva solo dopo.
Nel caso della bomba atomica, la scoperta della fissione nucleare — una conquista intellettuale straordinaria — fu tradotta in una tecnologia di distruzione totale.
È qui che nasce la controversia: la scienza deve essere giudicata per la conoscenza che produce o per l’uso che se ne fa? O, più radicalmente, è possibile separare la ricerca pura dalle sue applicazioni concrete?
Sponsorizzare il progresso scientifico sembra essere giusto e necessario. A nostro avviso, fermarlo sarebbe come spegnere il fuoco per paura che bruci: sarebbe negare il potenziale del pensiero umano. Tuttavia, la fede cieca nella neutralità della scienza è pericolosa. La storia ha mostrato che non tutto ciò che può essere fatto, deve essere fatto. E lo ha mostrato con chiarezza molte volte. Ma la voce della meraviglia è irresistibile.
Oggi, le sfide si ripresentano in forme nuove: intelligenza artificiale, ingegneria genetica, manipolazione climatica, automazione militare. Anche qui la scienza offre strumenti di potere, ma chi decide come usarli? E chi ne sopporta le conseguenze?
Promuovere la ricerca senza interrogarsi sulle sue implicazioni etiche equivale a sponsorizzare la hybris umana che pretende di dominare la natura e il destino, dimenticando i propri limiti.
Il caso Oppenheimer è paradigmatico. Egli non era un folle né un cinico. Era un uomo colto, brillante, consapevole. Ma fu catturato dalla logica del tempo: la corsa contro i nazisti, la pressione politica, il desiderio di riuscire. Quando la bomba fu pronta, non c’era più spazio per fermarsi a riflettere. Da allora, si è discusso a lungo su cosa avrebbe potuto o dovuto fare; ma la domanda non riguarda solo lui, bensì tutti noi.
La scienza non avanza da sola. È parte di una rete fatta di governi, finanziamenti, opinione pubblica, interessi. Se vogliamo un progresso che non ci conduca alla rovina, dobbiamo creare una cultura della responsabilità condivisa. Dobbiamo stabilire come società estesa qual è la soglia del possibile e il confine dell'ammissibile.
“Sono diventato Morte, il distruttore di mondi.”
Non è una frase contro il progresso scientifico. È un avvertimento sulla necessità di non separare mai la conoscenza dalla saggezza, di non confondere la neutralità degli strumenti con l’innocenza dei fini.
I metodi sono neutrali, gli effetti non lo sono. Ogni nuova scoperta di impatto sociale ci avvicina a soglie irreversibili; confini oggi solo ipotizzati che improvvisamente vengono superati e socializzati. Per questo la riflessione critica deve precedere e non seguire l’applicazione tecnologica. Il futuro non si decide con le risposte giuste o sbagliate, ma ponendo le domande che richiedono quelle risposte prima di agire.
La neutralità degli strumenti non esiste.
Recensione di Oltre la tecnofobia, il digitale dalle neuroscienze all’educazione - Terza parte
Dopo una sintetica recensione del libro Oltre la Tecnofobia (qui), una critica al concetto di onlife e della rimozione dell'infanzia (qui), Simone Lanza continua a confrontarsi con le tesi degli autori e affronta i punti nodali del libro, le implicazioni cliniche e pedagogiche dei disagi sociali provocati dall’uso precoce e prolungato degli schermi.
---
LA DIPENDENZA DA INTERNET NON ESISTE?
Sappiamo che gli smartphone alterano il ciclo dopaminergico, creano abitudini e persino dipendenze: non è un mistero perché questo è descritto da chi disegna queste app per metterle gratuitamente sul mercato riuscendo a trarne profitti enormi. Al giorno d’oggi esiste un’ampia discussione sulla classificazione delle varie dipendenze da internet, trattandosi di un tema di salute pubblica delicatissimo. Incuranti della complessità della situazione gli autori di Oltre la Tecnofobia hanno deciso di abbracciare le posizioni di Matteo Lancini, che sostiene che il disagio dei giovani non sia da attribuire all’iperconnessione, bensì alle “mamme virtuali”. Avvalendosi di Lancini, il fenomeno degli hikikomori è così commentato dagli autori: “I media digitali lungi dall’essere la causa del ritiro, sono piuttosto ciò che consente a questi adolescenti di rimanere ‘attaccati’ al mondo evitando un esito psicotico della loro sindrome”. (p.95) Gli autori sostengono ogni abuso debba considerarsi nocivo, ma che ciò non deve condurci – ed questo il tema che sta loro molto a cuore - a “incolpare la tecnologia digitale” (p.67)! Come si fa pensare di poter dare la colpa alla tecnologia se non la si è già prima antropomorfizzata?
Per loro “l’utilizzo specifico è dettato e condizionato dal modello di società contemporaneo” (p.67), ma non spendono una parola a spiegare come le tecnologie digitali modellino la società. Credono di dovere emettere una sentenza sulla colpevolezza o innocenza della Tecnologia (al singolare, si vedrà poi perché), ma non si esprimono mai sugli umani che sono proprietari di queste tecnologie e le usano come mezzi di produzione. Come se le finalità non fossero di chi progetta le Tecnologie. L’antropomorfizzazione della Tecnologia consiste nel neutralizzare ogni carattere etico e politico della tecnica, rimuovendo il ruolo degli umani che vi investono soldi. Questo è proprio il carattere ideologico, su cui si tornerà, mai messo in discussione in questa edulcorante Weltanschauung.
Non esiste Una dipendenza da internet o da smartphone ma le organizzazioni mediche stanno mettendo a fuoco molti disturbi legati all’uso compulsivo di queste tecnologie. Si tratta di fasce sempre più vaste della popolazione che sono risucchiate in comportamenti patologici indotti per così dire dal design. La visione di chi sostiene che la psicosi non solo non venga amplificata dall’effetto schermo ma persino lenisca la malattia e mantenga attaccati al mondo (sic), è estrema, molto discutibile e pericolosa dal punto di vista terapeutico.
Sulla questione clinica, vorrei rassicurare le decine di migliaia di genitori che chiedono ai loro figli di uscire dalla stanza, che non tutti la vedono come Lancini e che ci sono terapisti che aiutano gli adolescenti a distaccarsi dall’oggetto che produce la loro dipendenza (lo schermo), senza far sentire in colpa i genitori.
In ogni caso è chiaro che questo libro vorrebbe mettere un bavaglio a chi solleva la questione del disagio sociale, bollandolo come tecnofobico. E allora possiamo dire tranquillamente che il re è nudo perché la prova più evidente che le categorie di uso e abuso siano inadeguate a interpretare la complessa questione di salute pubblica (di cui gli hikikomori sono solo una parte) è testimoniata dal fatto che le Big Tech come Meta, pur di non farsi dare regole, sono disposti a darsele da sole.
Ad oggi l’OMS ha già riconosciuto la dipendenza da videogioco e da gioco d’azzardo, mentre esiste una vasta discussione sulla classificazione di altre forme di dipendenza da internet (oltre al fenomeno degli hikikomori, c’è la dipendenza da relazioni virtuali e social network, la net compulsion o shopping online, dismorfismo, etc...), si tratta di molti comportamenti patologici che sono soggetti a studi perché in continuo (non rassicurante) aggiornamento, dove il confine tra dipendenza e abitudine è sfumato. In ogni caso gli autori non hanno dubbi sul dover sollevare da ogni responsabilità la Tecnologia digitale quasi fosse una umana presenza.
Non stupisce quindi che gli autori critichino Jonathan Haidt, reo di avere pubblicato La generazione ansiosa. Riprendendo quasi alla lettera una precedente recensione (V. Gallese, Haidt: quelli che... il digitale, in “Doppiozero”, 17/9/2024) bollano come tecnofobico un libro documentatissimo che contiene quasi un migliaio di fonti. La questione è che dal 2012 è aumentato in modo intensivo l’uso dei social network tra le adolescenti ma sono anche aumentati fenomeni di ansia, depressione, isolamento e suicidi. Per Haidt non c’è solo correlazione ma anche un nesso di causalità. Gli autori propongono altre cause più complesse: “accesso alle armi, la discriminazione, l’isolamento sociale e le difficoltà economiche” (p.66). Nel libro (a differenza di quello di Haidt) non c’è però nessun tentativo di convincere il lettore che queste siano le cause plausibili. Non vi sono spiegazioni per cui non mi è possibile comprendere questa loro diversa ipotesi. Trovo difficile capire come l’accesso alle armi, la discriminazione, l’isolamento sociale e le difficoltà economiche possano essere state la causa di comportamenti non certo patologici ma che hanno costretto il CT Spalletti a regolamentare rigidamente l’uso dei dispositivi durante la fase finale di Euro 2024 agli atleti della nazionale di calcio maschile.

Lasciamo a chi legge farsi un’idea del dibattito tra Jonathan Haidt e Candice Odgers, suggerendo il franco confronto pubblicato su MicroMega 3/2025 (“Disconnessi. L’impatto dei social sulle nostre vite”). Un altro confronto è stato pubblicato da Internazionale. Mi limito a due osservazioni. La prima è che se esiste una correlazione questo dovrebbe costituire un campanello d’allarme sufficiente per applicare il principio di precauzionalità fino a nuovi e approfonditi studi, proprio perché la correlazione non implica ma non esclude affatto la causalità. In secondo luogo vorrei ricordare Austin Bradford Hill, il noto epidemiologo britannico, celebre per i suoi studi che hanno dimostrato il rapporto tra fumo e cancro polmonare (quando ai suoi tempi in tanti sottovalutavano la correlazione, sic). Hill aveva elaborato una serie di nove criteri per dedurre la relazione causale tra un fattore di rischio e una malattia sulla base di correlazioni statistiche. Allora le lobbies del tabacco insistevano proprio con le stesse argomentazioni di oggi: “Correlation does not imply causation”. Gli autori sono più avanti: la correlazione è il contrario della causalità e pertanto qualunque divieto va escluso e ogni regolazione rifiutata. E veniamo così alla quarta critica, alla questione educativa.
VIETATO VIETARE!
Gli autori ci propongono l’idea pedagogica rivoluzionaria, del tutto simile a quella del 1968: vietato vietare. Non citano questo slogan di vecchia data, ma lo aggiornano e lo ampliano persino alla protezione: “ogni scelta di protezione o di divieto non è educativa” (p.). Per loro controllo, divieto e protezione sono la stessa cosa. Iniziamo quindi con il rassicurare chi legge che il pedagogista Paulo Freire, certamente caro ai sessantottini e da loro invocato come punto di riferimento teorico, non era certo incline a posizioni libertine che “vedono una manifestazione d’autoritarismo in ogni legittima espressione di autorità”. Freire era incline invece a una posizione più pacata, quella di una persona “democratica, coerente con il suo sogno solidale ed egualitario, per la quale non può esistere autorità senza libertà o questa senza l’altra.”
Oggi nel dibattito pedagogico contemporaneo, proprio seguendo Freire non è possibile concepire l’autorità senza la libertà, ma nemmeno la libertà senza l’autorità. L’appello a sviluppare pensiero critico suona retorico e Freire si lamentava proprio dell’assenza dei limiti normativi. Gli autori si spingono ad asserire persino che ogni protezione è autoritaria: ma come spiegare le leggi contro il lavoro minorile? E i divieti di balneazione? E il divieto di passare con il rosso al semaforo sarebbe diseducativo? Non sempre applicare un divieto produce un effetto contrario.
La realtà di oggi sembra al contrario esser dominata da un’assenza di limiti e regole, al punto che, per dirla con un noto slogan pubblicitario, “l’unica regola è che non ci siano più regole”. Secondo Daniel Marcelli, punto di riferimento nel dibattito francese sulla crisi dell’autorità genitoriale, domina oggi invece “il bambino sovrano” in un vuoto epocale di autorità. In un altro contributo Marcelli sostiene che in pedagogia sia persino auspicabile obbedire.
L'obbedienza lungi dall'essere virtù negativa è indispensabile nella relazione pedagogica che si basa sulla fiducia. L'obbedienza non è la sottomissione. Autorità e obbedienza hanno significati anche positivi a differenza della sottomissione a un potere. La sottomissione si ottiene attraverso l'obbligo o la seduzione, mentre l'obbedienza (educativa non politica!) si fonda su un rapporto di fiducia. Quando sarai grande ti spiegherò, ma adesso fidati e obbedisci, perché non tutto può essere spiegato e contrattato. Questo è vero soprattutto nell’infanzia. Proprio l’obbedienza conduce all'indispensabile libertà di disobbedire nella maturità. Persino Don Milani teorico di L’obbedienza non è più una virtù, aveva idee ben chiare sull’autorità del docente e sull’importanza dell’obbedire in classe! Anche qui la mancanza di distinzione tra adolescenza e infanzia non permette agli autori di inserirsi nel dibattito pedagogico attuale su autorità, autorevolezza, obbedienza, sottomissione, libertà su cui per altro le filosofie femministe italiane hanno dato importanti apporti. Assenza di regole, di limiti, di paletti sono invece i concetti base di una pedagogia corrente molto diffusa, basata sulla seducazione (termine coniato da Gilles Lipovetsky per descrivere uno stile educativo basato sul tentativo di sedurre il bambino anziché di educarlo in senso tradizionale) e sulla deresponsabilizzazione degli adulti, incapaci di gestire il sano conflitto educativo, pedagogia corrente che è però distante dal dibattito pedagogico sulla crisi dell’autorità genitoriale aperto da Arendt.
Del resto Gli autori sono davvero così inclini a lasciare che i loro figli o nipoti guardino film pornografici a otto anni perché vietarglielo significherebbe poi che i loro pari in un atto di giustizia retributiva faranno vedere loro film porno? Per loro tutto va contrattato, trasfigurando l’idea del pedagogista francese Meirieu, che non solo propone la contrattazione educativa ma anche l’autorità del docente e la necessità della sanzione, per non parlare degli interrogativi sulla “strumentalizzazione del digitale da parte del sistema di mercato” (Meirieu , La scuola e la sfida del digitale).
Se la critica all’autoritarismo poteva funzionare nel XX secolo, che iniziò quando Ellen Key scrisse Il secolo del fanciullo, oggi lo slogan vietato vietare non è altro che, come rileva sempre Marcelli, l’anticipazione del credo neoliberista in ambito pedagogico. Questa seducazione incapace di vietare inculca con l’esempio il credo neoliberista dominante. Teorizzare oggi un “antiproibizionismo digitale” significa abbracciare le posizioni dell’individualismo e del narcisismo più sfrenato che già il nostro sistema economico e culturale promuove abbondantemente, anche grazie alle piattaforme.
Per sostenere la tesi che “ogni scelta di protezione o di divieto, in senso proprio, non è educativa” (p.147), si è dovuto alterare il senso profondo della dialettica di Paulo Freiere e storpiare il concetto di contrattazione di Merieu, perché questo assunto, in campo pedagogico, è poco difendibile. Promuovere questa deregulation educativa costituisce al contrario la quintessenza del credo dominante, propugnato tanto dagli autori quanto da Trump e dalle Big Tech: eliminare ogni limitazione persino nell’infanzia.
Eppure i limiti sono proprio ciò che permette di educare: come qualsiasi pedagogista, allenatore, educatore o insegnante sa bene, la difficoltà consiste semmai in dove e come mettere i limiti, ma non se metterli
Nella quarta e ultima parte, si entrerà nel merito del concetto stesso di tecnologia, di fobia e si descriverà chiaramente la funzione ideologica di questo libro.