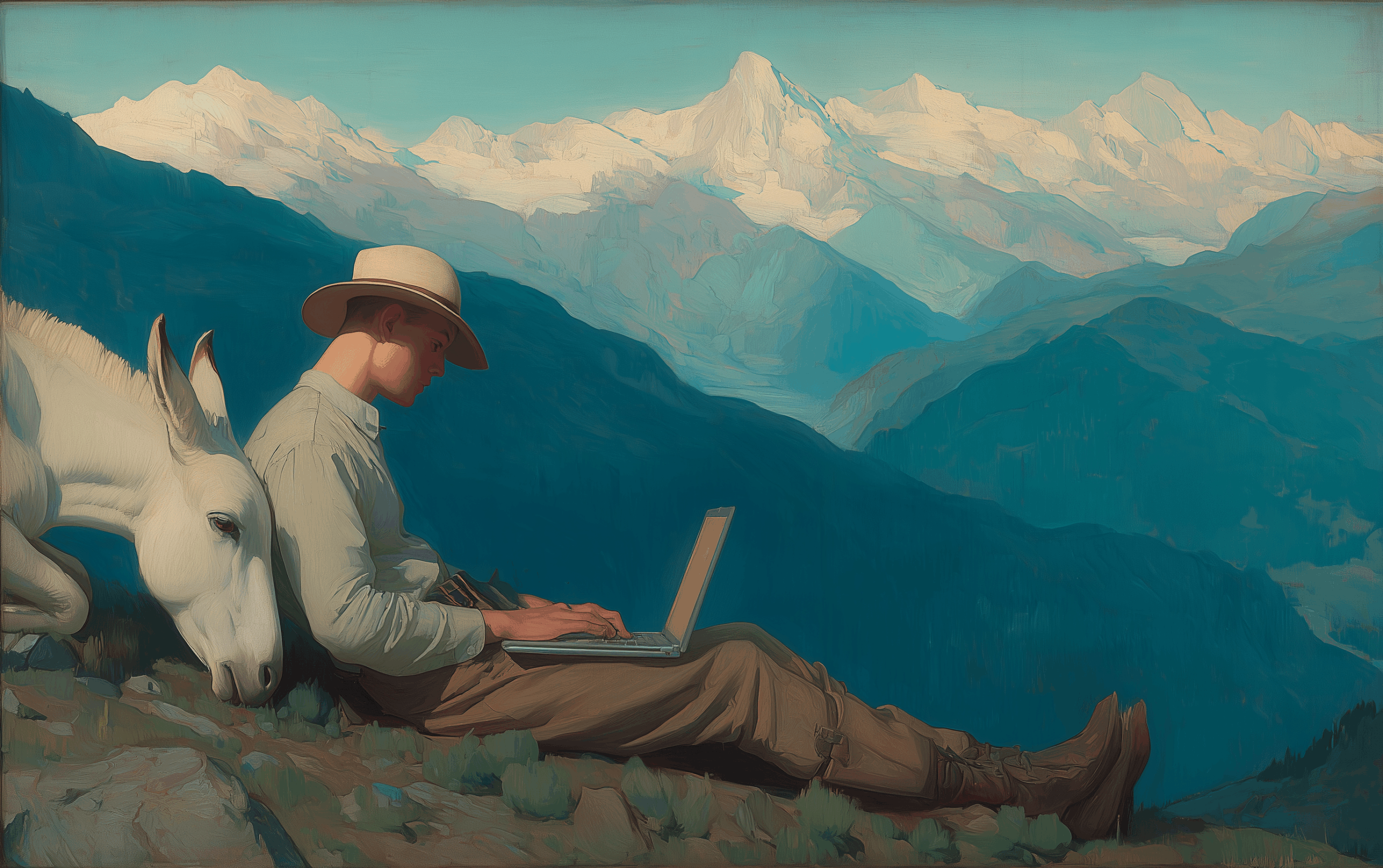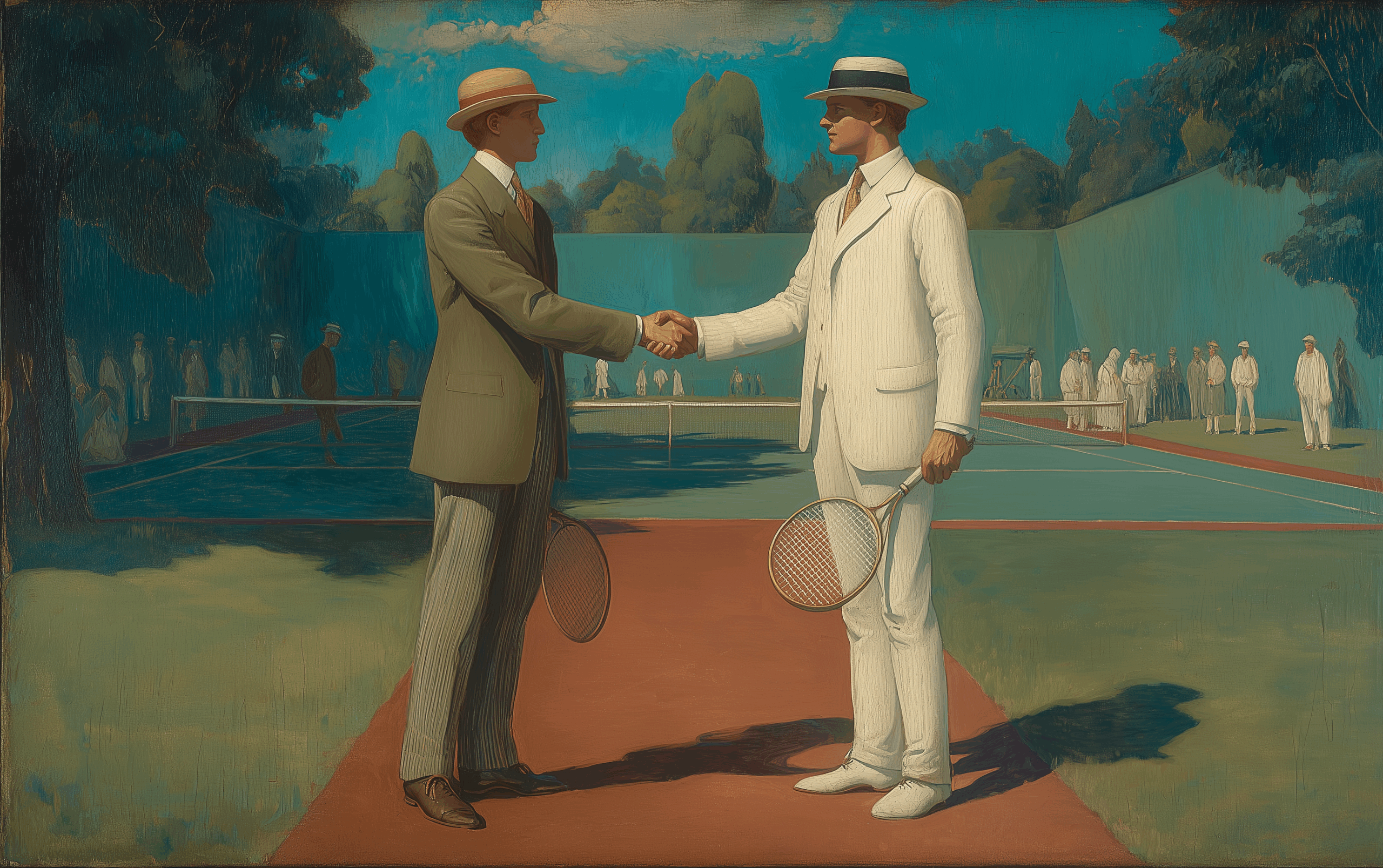La concezione tecnologica del vivente: dalla partenogenesi artificiale alla biologia sintetica - Seconda parte
Nella prima parte di questo articolo, Maurizio Esposito ha esaminato la prima delle tre coordinate che delineano lo spazio della concezione tecnologica del vivente, quella del fare. Nella sua analisi ha fatto riferimento alla controversia tra il fisiologo Jacques Loeb - per il quale la vita è totalmente riducibile a fenomeni fisico-chimici, e l’obiettivo della biologia deve essere la creazione e il controllo dei fenomeni viventi – e il biologo William Emerson Ritter propone una concezione “organicista”, in cui le entità biologiche non sono riducibili ai soli processi fisico-chimici, poiché possiedono proprietà emergenti che vanno considerate nella loro totalità. Controversia che anticipa l’affermazione della visione ingegneristica e della “science-based industry”.
Passiamo ora alla seconda coordinata: codificare. Non c’è dubbio che le scienze della vita contemporanee siano ormai inseparabili dall’informatica: oggi non si fa biologia senza calcolatori elettronici. Come osserva Hallam Stevens nel suo libro Life out of Sequence: A Data-Driven History of Bioinformatics (2013), durante e dopo Guerra Fredda, la biologia si trasforma in un settore tecnologico ed economico di primo piano anche grazie alle tecnologie digitali. I laboratori cambiano volto, e lo spazio dedicato all’uso delle tecnologie dell’informazione (i cosiddetti dry labs) si amplifica. L’incremento dell’impiego di strumenti digitali non ha avuto soltanto risvolti pratici ed economici, ma soprattutto implicazioni di natura epistemica. L’uso massiccio dei computer ridefinisce la concezione stessa del vivente: tutti i processi organici vengono tradotti in sequenze di zeri e uno, mentre algoritmi, database e software permettono di descrivere, simulare e manipolare processi biologici. L’aspetto forse più significativo della narrazione proposta da Stevens è l’osservazione secondo cui non è stata la tecnologia informatica ad adattarsi alle esigenze dei biologi, bensì i biologi stessi a rimodellare la propria disciplina in funzione delle tecnologie dell’informazione. Ne è scaturita una biologia data-driven, in cui la conoscenza non deriva più soltanto dalla formulazione di ipotesi e dalla loro verifica sperimentale, ma soprattutto dalla raccolta e dall’analisi di enormi quantità di dati. In genomica, per esempio, le sequenze di DNA, RNA e proteine vengono digitalizzate e trattate statisticamente. Malattie, tratti ereditari e caratteristiche fenotipiche si trasformano in insiemi di dati da mettere in correlazione. La conoscenza si manifesta nella capacità di decontestualizzare e poi ricontestualizzare dati discreti, riconoscendo pattern e regolarità che affiorano da basi di dati potenzialmente infinite.
Negli anni Sessanta, il biologo molecolare statunitense Joshua Lederberg fu tra i pionieri nell’uso delle tecnologie digitali in biologia, mentre il fisico nucleare Walter Goad applicò tecniche statistiche per modellare fenomeni biochimici complessi utilizzando calcolatori via via più complessi. Negli anni Settanta e Ottanta, la biologia cominciò a trattare DNA e proteine come “sequenze” di dati, aprendo la strada alla nascita della bioinformatica. Con il Progetto Genoma Umano, la disciplina si consolidò definitivamente, rendendo necessario l’uso di computer sempre più potenti per gestire e analizzare enormi quantità di dati in tempi brevi. Stevens osserva che i laboratori contemporanei richiedono così nuove figure professionali: matematici, informatici e ingegneri diventano componenti essenziali dei team di ricerca. In molte istituzioni, i biologi non rappresentano più la categoria predominante. La ricerca non consiste più soltanto nell’elaborazione di teorie, ma nella produzione, gestione e interpretazione dei dati, che assumono al tempo stesso valore scientifico ed economico.
Il Progetto Genoma Umano segnò senz’altro una svolta: sequenziare non era più un’attività ancillare, ma un obiettivo in sé, organizzato con criteri industriali. Per esempio, attraverso il suo studio etnografico condotto nei laboratori del Broad Institute di Boston, Stevens rileva l’adozione dei metodi della Lean production di Toyota: riduzione degli sprechi, ottimizzazione dei tempi e miglioramento della gestione dei dati. Si sviluppa così, secondo Stevens, una sorta di “Lean Biology”, in cui la produzione efficiente di dati diventa centrale. Il computer, in questo contesto, non è solo archivio: diventa strumento di modellizzazione, visualizzazione e sperimentazione virtuale. Le mappe genetiche e le rappresentazioni digitali permettono di manipolare fenomeni invisibili e di immaginare nuovi esperimenti. La bioinformatica non si limita a ordinare dati per fare biologia: essa stessa produce un nuovo tipo di scienza. Questa trasformazione ha reso la biologia una scienza predittiva e quantitativa, aprendo la strada alla medicina personalizzata e alla genetica individuale. Insomma, le tecniche digitali permettono di tradurre sequenze complesse in oggetti concreti e manipolabili, cambiando il modo stesso di concepire i fenomeni organici.
Veniamo infine alla terza coordinata: quella del promettere. Infatti, sostengo che questa concezione tecnologica del vivente si nutre di anticipazioni, proiezioni e utopie; cioè, non si limita a descrivere ciò che il vivente è, ma immagina e prefigura ciò che potrebbe diventare. Nel 2017, ho pubblicato un articolo intitolato “Expectation and Futurity: The Remarkable Success of Genetic Determinism”. Nell’articolo ho analizzato alcune delle visioni futuristiche che hanno accompagnato le scienze della vita nel corso del XX secolo. Nell’articolo osservavo che la costante ossessione per il futuro ha svolto una duplice funzione: da un lato, mantenere vivo l’interesse politico e sociale per determinati ambiti della ricerca scientifica; dall’altro, giustificare finanziamenti e sostegno pubblico, promettendo benefici straordinari, e al contempo concreti, nel breve e nel lungo periodo.
Già sul finire degli anni Venti del secolo scorso, lo scrittore di fantascienza Herbert G. Wells e il biologo inglese Julian Huxley, nel libro The Science of Life, immaginavano un mondo in cui la natura selvaggia si sarebbe trasformata in un giardino globale, privo di malattie e di specie pericolose. Nel 1934, in un articolo intitolato “The applied science of the next hundred years: Biological and social engineering”, Huxley scriveva che l’ingegneria biologica sarebbe diventata la scienza del futuro che avrebbe trasformato l'eredità biologica dell’umanità. Nel 1937, il genetista americano Hermann Muller tentò di persuadere Stalin che la genetica rappresentasse una risorsa fondamentale per il progresso della società sovietica. Come affermava enfaticamente in una lettera inviata a Stalin nel 1937, l’oggetto della missiva riguardava “…il controllo consapevole dell’evoluzione biologica dell’uomo, ossia la capacità dell’uomo di governare il patrimonio ereditario che sta alla base della vita umana” (Muller, 1937, mia traduzione). Nel discorso pronunciato durante la cerimonia del Premio Nobel ricevuto nel 1958, George Beadle ed Edward Tatum parlarono dell’avvento di un’epoca in cui il “codice” della vita sarebbe stato decifrato, aprendo la strada a un miglioramento radicale di tutti gli organismi viventi attraverso l’ingegneria biologica. Nel 1976, sulle pagine di BioScience, in un breve scritto intitolato “Recombinant DNA: On Our Own”, Robert Sinsheimer (il biologo molecolare che fu tra i principali ispiratori del Progetto Genoma Umano) immaginò che la biologia del futuro sarebbe stata in grado di rimodellare il mondo vivente secondo una proiezione della volontà umana.
Con il Progetto Genoma Umano, questa retorica della promessa si intensificò ulteriormente: nel 2005, Craig Venter dichiarò che conoscere il proprio genoma avrebbe permesso agli individui di prendere il controllo della propria vita e di prevedere il futuro delle proprie malattie. Imprenditori come Venter si sono adoperati per persuadere gli investitori del potenziale economico e sociale della genomica. Sebbene gli interlocutori cambino, l’idea di fondo rimane la stessa: il futuro della società dipende dalla capacità di controllare i geni, ossia le “lettere” che compongono l’”alfabeto” del vivente. In sintesi, la biologia deve diventare un’ingegneria del futuro, come Loeb aveva già prefigurato all’inizio del XX secolo.
La controversia tra Loeb e Ritter, tra riduzionismo ingegneristico e organicismo sistemico, rimane ancora oggi un nodo irrisolto. Sebbene l’approccio tecnologico al vivente abbia prodotto risultati di straordinaria rilevanza, esso rischia al contempo di appiattirne la complessità a meri dati, trascurando le dimensioni ecologiche e relazionali (una preoccupazione condivisa da tutti i discendenti di Ritter). In ogni caso, il potere della concezione tecnologica del vivente non risiede tanto nella sua pretesa di verità, quanto nella sua capacità di ridurre la complessità, semplificare e mostrare che la vita può essere manipolata e trasformata. Inoltre, proprio perché è una scienza orientata alla trasformazione, essa non teme di promettere più di quanto realizzi: vive infatti di proiezioni che vengono rapidamente dimenticate e sostituite da utopie ancora più ambiziose.
Oggi più che mai, mentre nuove biotecnologie come l’editing genetico e la biologia sintetica aprono possibilità inedite, la domanda rimane la stessa che animava la polemica tra Loeb e Ritter: la biologia deve limitarsi a comprendere la vita o deve rivendicare il potere di trasformarla radicalmente? Insomma, la biologia va intesa come una scienza naturale del presente o come un’ingegneria del futuro? Al di là delle opinioni che possiamo avere in proposito, la storia insegna che la forza della concezione tecnologica non deriva dalla sua abilità esplicativa, bensì dalla sua capacità di mobilitare risorse e orientare la ricerca in funzione di priorità e visioni future.
La lotta per la bellezza - Un testo di P.P. Pasolini commentato da T. Muzzioli
Non sappiamo se “la bellezza salverà il mondo”, come si sente ripetere ultimamente con una retorica abbastanza stucchevole (e ipocrita). Certo è che nel mondo attuale la produzione di bruttezza va in uno con l’inarrestabile e insensata “crescita” che caratterizza il declinante tardo-capitalismo espanso a scala globale. Basti pensare all’avanzare continuo della cementificazione e del «consumo di suolo», in particolare in Italia (dove, secondo l’ultimo rapporto ISPRA, ogni giorno in media 230.000 mq. di terreno vengono coperti da superfici artificiali). Così come fa continui progressi l’indifferenza anche verso i valori estetici e paesaggistici, salvo il loro recupero banalizzante in chiave di mercificazione turistica.
Erano temi, questi, cari a Pier Paolo Pasolini, come parte della sua più generale postura critica verso il mondo contemporaneo, che chiamava anche “l’universo orrendo”. Un mondo che, a suo parere, stava riuscendo a unificare perversamente le diverse classi sociali nel consenso a un presente neocapitalistico, fra le altre cose totalmente disinteressato alla tutela dei «segni del passato» e dell’integrità dei paesaggi (storici e naturali). E si occupa di questi temi, invocando una (improbabile) lotta politica di massa per la bellezza, l’articolo del 1969 che qui proponiamo, per ricordare la figura del grande poeta e intellettuale italiano, a cinquant’anni dalla sua morte.
(Toni Muzzioli)
NOTA AL TESTO:
l’articolo, che si riferiva alle battaglie per la difesa del patrimonio storico-artistico e naturale dell’associazione Italia Nostra (fondata nel 1955 da un gruppo di intellettuali, tra i quali Elena Croce e Giorgio Bassani), fu pubblicato con il titolo «Italia Nostra» non otterrà nulla sulla rivista “Tempo”, n. 12, 22 marzo 1969 ed è tratto da: Pier Paolo Pasolini, Il caos, a cura di Giancarlo Ferretti, Roma, Editori Riuniti, 1995 [1.ed. 1979], p. 117-119.
«Italia Nostra» non otterrà nulla
di Pier Paolo Pasolini
In Italia c’è una organizzazione per la difesa del patrimonio artistico e paesaggistico nazionale. Si chiama «Italia Nostra». Ma io mi chiedo: Italia nostra di chi? «Italia Nostra» ha combattuto delle buone lotte: anche nobilmente. Ma il mio amico Giorgio (Bassani) e gli altri amici che lavorano e lottano per «Italia Nostra» non si offendano se li pongo davanti a dei problemi.
1) «Italia Nostra» equivale a «Italia della borghesia», nella fattispecie di una piccola élite borghese intelligente, che ha saputo trasformare il privilegio in cultura. Ma tutta la sottocultura borghese italiana, non c’è alcun dubbio, non riconosce l’Italia in «Italia Nostra».
2) La classe operaia, ormai influenzata non solo dai vecchi poteri, ma dal nuovo potere industriale transnazionale – che sta accantonando i poteri politici nazionali – non «sente» in alcun modo il problema della sacralità del passato. Anche se comunisti, gli operai hanno, rispetto ai monumenti e al paesaggio, lo stesso atteggiamento di un tecnico neocapitalista, che, operosa formica, si dà da fare, innocente e stupido, a ricostruire daccapo il mondo.
«Italia Nostra» dunque non otterrà mai nulla, se non trasformerà la sua lotta in lotta politica. Per fare questo, deve prima di tutto distinguersi dalla restante borghesia (che ha monumenti e paesaggi nelle mani) e spossessarsi di ciò che ha (ossia monumenti e paesaggi): atto mistico impensabile, da parte dei componenti della associazione «Italia Nostra». In secondo luogo, essa dovrebbe rendere popolare il «problema del passato» presso chi non ha mai partecipato alla storia, se non passivamente, come classe dominata. Anche questa operazione è pressoché impensabile: infatti gli uomini politici (lo so da fonte diretta) non prendono in considerazione le esigenze di «Italia Nostra», appunto perché tali esigenze non sono popolari: e anzi, renderebbero impopolare l’uomo politico che se ne occupasse.
A questo punto, dunque, bisognerebbe prendere per il bavero gli uomini politici e costringerli a occuparsi del «problema della bellezza»: se non altro cominciando col renderlo popolare (se hanno tanta paura di perdere voti). Prendere per il bavero gli uomini politici significa, poi, adottare metodi nuovi di lotta politica. Quelli adottati spontaneamente, per esempio, dagli studenti. Ma è pensabile questo? È veramente così «politicamente» forte l’ideale di bellezza che anima i soci di «Italia Nostra», da convincerli a scendere in piazza, a occupare monumenti e paesaggi, a digiunare, o urlare con la necessaria violenza (quella che conduce a prendere le botte dai poliziotti)?
Ma, a questo punto, dovrebbero intervenire, in appoggio dello sparuto gruppo di persone che amano disperatamente i segni del passato in quanto bellezza, cioè integrazione del presente, altri gruppi di persone: una politica di alleanza, insomma. Scenderebbero in piazza, in tal caso, i giovani? Sarebbe stupendo che si accendesse una lotta – «estremistica» intendo dire – in difesa di un vecchio muretto borbonico, che uno sprezzante proprietario di aree sta per far abbattere per costruirvi una zona residenziale. Ma ciò non si verificherà mai. Perché puritanesimo rivoluzionario e puritanesimo industriale […] si identificano, e l’amore per la bellezza viene considerato peccato
Forse giustamente?
È questo, per concludere, il problema fondamentale: da Kaiseri [1] ad Arezzo il fronte della distruzione del vecchio mondo e della ricostruzione del nuovo (per ora orrendo) è potente, e passa di vittoria in vittoria, di trionfo in trionfo. La sua avanzata è inarrestabile. […]
NOTE:
[1] Pasolini era reduce da un recente soggiorno a Kaiseri (la Cesarea di Cappadocia), in Turchia, per le riprese di Medea. (NdR)
Il caso Sinner, l’eterna distanza tra intellettuali e sentire popolare
Poche settimane fa ho scoperto del tutto casualmente l’esistenza di un piccolo libro dal titolo “Effetto Sinner” e sottotitolo “Consumi responsabili e nuovo made in Italy oltre lo sport”. Libro scritto da due docenti di marketing presso la Luiss di Roma, Cesare Amatuelli e Matteo De Angelis.
Da grande e “antico” appassionato di tennis e professionista che nella vita lavorativa si è occupato a lungo di ricerche di mercato e sociali e posizionamento di brand, non potevo non acquistarlo.
Il lavoro di Amatuelli e De Angelis non si occupa minimamente degli aspetti tecnici e agonistici che riguardano l’ascesa di Sinner, ma si propone di identificare i valori che esprime il campione altoatesino, come atleta e come uomo, e quali siano i brand più in sintonia con questi valori.
Nel frattempo, solo pochi giorni fa (scrivo questo articolo negli ultimi giorni di ottobre), è scoppiata una polemica sorprendentemente virulenta che ha coinvolto quello che oggi è considerato lo sportivo italiano più popolare e influente [1], atleta conosciutissimo e amato a livello planetario.
Ma prima di addentrarci nei motivi della polemica, vediamo cosa hanno scoperto Amatuelli e De Angelis su Jannik Sinner.
I due docenti hanno usato tecniche di indagine qualitative e quantitative su campioni di popolazione italiana e estera. Per motivi di spazio non mi dilungherò sugli aspetti tecnici del lavoro di Amatuelli e De Angelis ma cerco di riassumere sinteticamente le conclusioni a cui sono giunti.
IL CARATTERE DELL'UMILTÀ?
Essi sostengono che il carattere precipuo con cui viene percepito Sinner sia quello dell’umiltà, in contrapposizione con molti sportivi di successo che non hanno questa caratteristica, vista come una dote positiva.
Su questo punto però mi permetto di esprimere un parere personale: ritengo che umiltà non sia la parola più appropriata per definire l’atteggiamento di Sinner (per quanto sia lo stesso Jannik a definirsi spesso un “ragazzo umile”); Sinner non è umile, egli è perfettamente consapevole di essere un grandissimo dello sport contemporaneo e ne è giustamente orgoglioso.
Probabilmente la parola che meglio esprime il suo modo di parlare di sé stesso è quello che fa capo al concetto di “modestia”. Nel senso che egli rifugge da qualsiasi atteggiamento di ostentazione del successo, è estremamente rispettoso degli avversari e mette costantemente al centro dell’attenzione dei media il lavoro di gruppo che fa col proprio team. Come se il suo talento fosse solo l’ultimo tassello di una piramide di competenze, qualità e allenamento; la logica conseguenza finale di un lavoro di gruppo (ed è così, ma solo in parte).
Per dovere di chiarezza, va ricordato che umiltà è la parola usata dai rispondenti all’indagine, non dagli autori del libro, che anzi ragionano molto sul significato di questa parola anche rifacendosi a una vasta letteratura.
Le altre caratteristiche principali che Sinner trasmette, secondo lo studio in questione, sono: la determinazione, l’onestà, la costanza, l’impegno, la semplicità, la lealtà, l’autenticità (nel senso che lui è come appare).
CAMPIONE DI COMPORTAMENTO?
In definitiva possiamo parlare di valori tutti connessi al concetto di etica; Sinner è un campione sul campo da tennis ma è altresì considerato un campione di comportamento.
E in effetti, i numerosi brand che lo hanno scelto come testimonial, lo hanno fatto per quel mix di risultati agonistici e quella che personalmente chiamerei “educazione naturale”, che ne fanno un campione speciale[2].
Che il fuoriclasse altoatesino sia percepito con queste caratteristiche non sorprende chi segue il tennis, lo vede in campo e ascolta le sue interviste. D’altra parte le indagini non devono per forza svelare situazioni sorprendenti e inattese, sono fatte anche per dare conferma scientifica di ciò che si avverte intuitivamente.
Emerge quindi il quadro di un giovane uomo che trasmette valori fortemente positivi e un’italianità diversa, più responsabile e seria (ma non seriosa, Jannik è anche un giovane uomo dotato di humor e che non rinuncia allo svago).
Aggiungerei io, un’italianità fortemente innestata da valori di “solidità montanara” (non dimentichiamo che Sinner è nato e cresciuto fino a 14 anni in un paesino di montagna).
Fin qua, in estrema sintesi, la ricerca di Amatuelli e De Angelis, ora veniamo alla polemica.
Al ritorno dal ricchissimo torneo esibizione giocato e vinto da Sinner a Dubai a metà ottobre, il giocatore ha annunciato che quest’anno avrebbe rinunciato alla convocazione in Coppa Davis.
Ovvero, Sinner chiude il suo 2025 agonistico con le Finals di Torino e nella settimana successiva non gioca quello che è considerato una specie di campionato del mondo a squadre del tennis.
Il giocatore ha giustificato la decisione con la necessità di avere una settimana in più per il riposo e per la preparazione tecnico - atletica in vista della stagione 2026.
Decisione discutibile dal punto di vista dell’attaccamento ai colori nazionali? Certamente, ma subito la polemica si è spostata dal merito della scelta di non giocare, alla critica all’uomo Sinner.
Ha iniziato il notissimo giornalista del Corriere della Sera e della rete televisiva La7 Aldo Cazzullo e, a ruota, sono arrivati i giudizi di altri volti o voci molto noti del giornalismo italiano. Corrado Augias, Massimo Gramellini, Francesco Merlo, Giovanna Botteri, Mattia Feltri e altri ancora, compreso Bruno Vespa, volto notissimo anche lui, ma che poco ha in comune con i nomi che lo precedono. A questi si è poi aggiunto anche il Codacons, suscitando non poche ironie per l’evidente “invasione di campo”.
Le critiche di tutto questo mondo giornalistico sono state molto forti - anche se certamente con toni diversi che ben rispecchiano il carattere di ognuno dei critici - concentrate su due aspetti: lo scarso attaccamento ai colori nazionali (c’entra l’essere nato in Alto Adige?) e la residenza a Montecarlo (tema vecchio, mai sopito, destinato a riproporsi periodicamente), critiche che hanno messo in discussione non le scelte del tennista Sinner, ma il suo valore umano.
Anche Ubaldo Scanagatta, autorevole decano dei giornalisti italiani specialisti di tennis, ha criticato la scelta di Sinner sul proprio sito (Ubitennis), ma si è trattato di una critica alla decisione di non giocare la Davis, motivata e argomentata, di tutt’altro tenore rispetto all’attacco personale.
Si può dire che la summa dei commenti negativi da parte delle persone succitate fa capo a una italianità debole o ipocrita, soprattutto per la residenza a Montecarlo che lo sottrae al fisco italiano.
RISENTIMENTO
Complessivamente, nei toni, emerge una sorprendente esplosione di risentimento.
Evidentemente queste persone, che si occupano prevalentemente di politica e divulgazione, non percepiscono in Sinner i valori che gli sono attribuiti dalle persone intervistate nel lavoro di Amatuelli e De Angelis.
Anzi, fermo restando la stima per l’atleta, per questo gruppo di critici i valori espressi da Sinner non sono di segno positivo.
Al contempo la polemica si è rapidamente spostata sui social con tutte le polarizzazioni tipiche di quei media.
Tuttavia si può dire senza tema di smentita che la grande maggioranza delle persone sono intervenute a sostegno del giocatore [3], in contrapposizione alle argomentazioni dei critici.
In moltissimi, per esempio, hanno segnalato che la Coppa Davis è ormai una manifestazione di secondo livello rispetto ai tornei dello Slam e che la Davis è stata più volte snobbata dai tre top players dell’ultimo ventennio, ovvero: Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal [4] senza che questo portasse a polemiche o accuse di scarso attaccamento ai colori nazionali nei loro rispettivi paesi.
Tra i moltissimi commenti che ho letto, quello che mi sembra meglio riassumere il punto di vista “popolare” dei difensori di Sinner, lo ha espresso il notissimo showman Fiorello, che ha fortemente criticato il sarcasmo sulla presunta scarsa italianità di Jannik e ha concluso un’appassionata difesa con queste parole: “Io mi sento orgoglioso di essere rappresentato da uno come Sinner. È un ragazzo perbene, educato, forte, e ci fa fare bella figura nel mondo.”
ECCESSIVO RIGORE MORALE O CECITÀ DEL TIFO
A questo punto è legittimo chiedersi se questi famosi giornalisti, molto critici, stiano prendendo una posizione di eccessivo rigore (nel caso, perché?) o se, viceversa, i difensori di Sinner, “accecati dal tifo”, non colgano le contraddizioni comportamentali dell’atleta.
La discussione è aperta. Quel che è certo, a mio modo di vedere, è che certo sarcasmo sprezzante appare ingiustificato rispetto ai sentimenti di stima e anche di amore che Sinner suscita in moltissime persone.
***
C’è poi un altro tema: oggi Sinner non è più solo un tennista di grande successo, ormai è un brand globale, di cui il giocatore è al contempo Ceo e “operaio” in campo.
Nel 2018, il Sinner diciasettenne che cominciava a farsi largo nei tornei del circuito minore, ha guadagnato in tutta la stagione circa 20.000 € lordi; oggi Jannik, tra prize money nei tornei e sponsorizzazioni ha superato i 50 milioni di dollari di incassi annui.
Praticamente un’azienda. Che reinveste i propri utili in varie attività economiche e anche in una fondazione che si propone di devolvere parte dei profitti generati “dall’azienda” in attività sociali.
Infine, lo studio di Amatuelli e De Angelis dimostra che il brand Sinner porta un enorme valore reputazionale al made in Italy, che a sua volta si traduce in valore economico. L’effetto Sinner è un booster economico e culturale per il nostro Paese.
Quanto sopra però porta ad una ulteriore riflessione: per persone come Sinner, che muovono interessi economici e di investimento emotivo assolutamente globali, è ancora tempo di valutare i comportamenti sociali con gli stessi parametri di mezzo secolo fa?
In fondo sono moltissime le aziende italiane con sede fiscale all’estero…
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
Il libro di riferimento di questo articolo è: Effetto Sinner
Autori: Cesare Amatuelli e Matteo De Angelis; Edizione Luiss University Press
NOTE
[1](*) Da un sondaggio Ipsos dell’agosto 2025, pubblicato su “La Gazzetta dello Sport”, risulta che Sinner è lo sportivo italiano in attività più conosciuto (più di qualsiasi calciatore), con un livello di riconoscibilità superiore all’82%, tecnicamente da considerare “totale”.
[2] Ad esempio, Banca Intesa ha scelto di sponsorizzare Sinner con la seguente motivazione: “crediamo nella potenza del suo impegno e nei valori che esprime ogni volta che scende in campo. Il talento del giovane azzurro, già oggi uno dei tennisti più conosciuti al mondo, non ha confini e ci aiuta a raccontare una storia italiana di successo”
[3] Non sono ancora disponibili dati quantitativi di monitoraggio del web a riguardo, ma basta scorrere i commenti ai post sui social di persone con largo seguito che parlano di tennis per rendersi conto che il sentiment popolare è a larghissima maggioranza a favore di Sinner.
[4] Il giocatore spagnolo Carlos Alcaraz, che da due anni si gioca la leadership del tennis mondiale con Sinner, è stato portato ad esempio dai critici perché quest’anno parteciperà alla fase finale della Coppa Davis per il suo Paese. Va notato che ad oggi Sinner ha giocato 23 volte con la maglia azzurra; Alcaraz 8 volte per la Spagna.