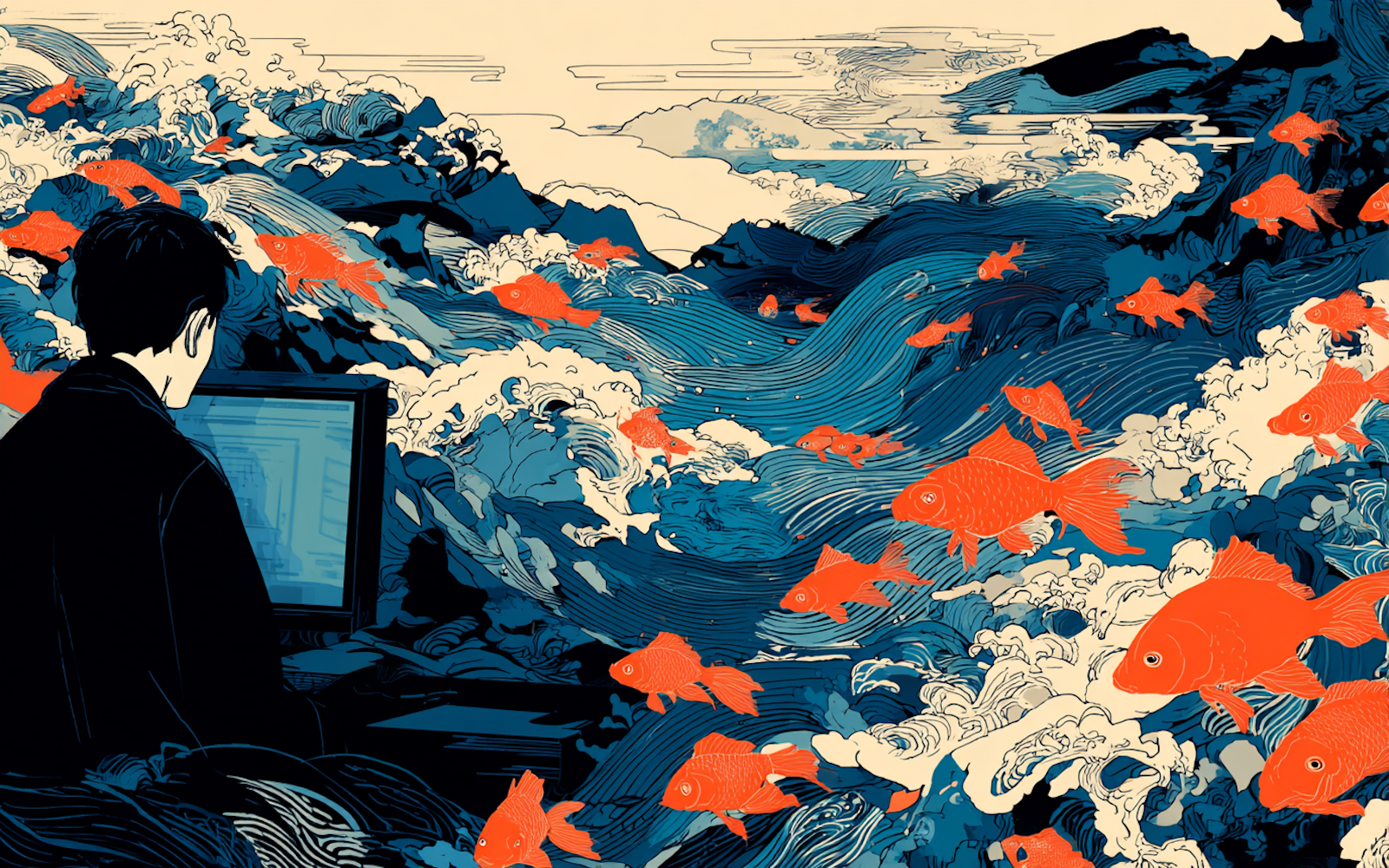Intelligenza Artificiale - Simulacri di Arte senza arte
La maggior parte degli articoli scritti sull’argomento “Intelligenza Artificiale e Arte”, compresi quelli di questa rivista, suonano ottimisti. Il loro pathos si riduce all’idea che l’intelligenza artificiale sostituisca il creatore umano solo nei livelli inferiori e tecnici del processo creativo, ma che l’uomo mantenga la funzione di operatore: è lui a impostare gli algoritmi secondo i quali l’IA opera, e quindi conserva lo status di soggetto del processo creativo.
Tuttavia, questa conclusione è ingannevole: i praticanti e i teorici dell’arte che vi aderiscono sono, consapevolmente o meno, vittime di un’autoillusione, e vi sono alcuni argomenti che lo confermano.
Già nel 1992, Neil Postman scriveva che le tecnologie non sono neutrali, esse cambiano chi le utilizza, e nella fase attuale, che Postman definisce “tecnocrazia”, le tecnologie si sono trasformate in un sistema che ha sottomesso tutte le altre aree della cultura. Yanis Varoufakis richiama l’attenzione su questo schema in relazione all’uso dell’IA nell’economia: l’IA “cloud” non produce nulla, controlla solo il comportamento umano, spingendo le persone ad acquistare ciò che l’algoritmo suggerisce. Nelle impostazioni di base dell’IA, indipendentemente dall’ambito in cui viene usata, l’obiettivo principale incorporato è vendere (beni, idee, storie, pensieri), manipolando la coscienza adulando gli utenti. Usando l’IA anche nelle operazioni più semplici, la persona cede gradualmente le proprie posizioni, cominciando ad agire secondo l’algoritmo dato e perdendo progressivamente la propria soggettività. Da gestore si trasforma in controllato, da soggetto diventa oggetto di un processo che non è più regolato da lui. Negli ultimi anni, Hollywood è stata scossa da proteste da parte degli sceneggiatori, il cui lavoro è stato massicciamente sostituito dai prodotti dell’IA. Le ragioni della protesta non sono solo la perdita del lavoro e, di conseguenza, del reddito, ma anche l’eccessiva qualità delle sceneggiature scritte dall’IA. Il regista Todd Haynes afferma che le storie create dalla rete neurale sono troppo levigate, prive di errori, imprevedibilità, incoerenze, cioè prive della vita stessa. E la cosa peggiore, secondo lui, è che gli stessi sceneggiatori hanno iniziato a scrivere storie altrettanto “senza vita”, come se fossero create da un’IA.
L’intelligenza artificiale, in qualsiasi forma e volume di utilizzo, è controindicata per l’arte, perché con la sua illimitata capacità di imitazione si oppone all’essenza stessa dell’arte, sia dal punto di vista del processo creativo che dal punto di vista della percezione. Prima di tutto, la rete neurale rompe l’unità di corpo, anima e mente (l’entelechia di Aristotele), che è la base di qualsiasi arte: i primi due componenti di questa triade non sono rilevanti per l’IA. Pertanto, l’IA non ha e non può avere emozioni: può solo imitarle. L’interazione di mente, sentimento e corpo crea una polisemia intrinseca, che è uno dei criteri più importanti del valore artistico di un’opera d’arte. Più un testo – nel senso ampio del termine – è polisemico, più è aperto a interpretazioni, più è significativo, più è importante per l’umanità. Qualunque cosa crei l’IA, per quanto tecnicamente complessa possa essere, è semplice nel contenuto, o meglio, primitiva, unilineare e non implica alcuna interpretazione. Queste sono solo alcune delle differenze fondamentali tra la vera arte e l’arte creata dall’IA. La questione di come far sì che le persone apprezzino un’arte che non è arte è l’argomento di questo articolo.
La storia della cultura ha stabilito il seguente schema costante: per l’introduzione ampia e universale di nuove tecnologie che cambiano significativamente il mondo, non è necessaria innanzitutto la corrispondente evoluzione tecnica, ma piuttosto la disponibilità della coscienza collettiva ad accettarle. In altre parole, i cambiamenti nella coscienza precedono la diffusione capillare delle tecnologie. I cambiamenti di coscienza che si muovono verso l’IA sono iniziati con la nascita della cultura di massa e di tutti i suoi attributi. Il primo di questi è la semplificazione delle idee e delle forme, che porta a un vuoto concettuale. Generi semplici, come la canzone, la danza o il disegno a matita, non sono necessariamente legati a contenuti primitivi (e viceversa). Ma nella cultura di massa diventano un percorso verso pensieri e sentimenti superficiali, che non richiedono alcun lavoro interiore per essere compresi e vissuti. Il successo facile e rapido in ogni cosa è uno degli slogan principali della cultura di massa, e questo vale anche per l’arte. Al posto del lavoro mentale su significati e interpretazioni – rilassamento nel consumo di soluzioni già pronte; al posto della catarsi che sconvolge l’anima – piacere facile e intrattenimento. I sentimenti e i pensieri evocati dall’arte di massa sono standardizzati e superficiali, come scriveva J. Ortega y Gasset: “l’uomo-massa rivendica il diritto alla mediocrità.” Un altro attributo è la replicabilità, con lo scopo di rendere fisicamente disponibile l’arte a tutti, il che in realtà porta a sfumare la distinzione tra originale e copia. Oggi, l’IA può generare qualsiasi immagine esteriormente indistinguibile dall’originale realizzato dal più brillante degli artisti, e per rendere il prodotto di una rete neurale legittimo quanto l’opera originale, è necessario delegittimare e poi distruggere fisicamente le differenze tra i due: se non possiamo distinguere un dipinto di Leonardo da uno disegnato da una rete neurale, allora perché dovremmo aver bisogno di Leonardo? Distruggere il criterio con cui il reale si distingue dal falso è la strategia principale per abituare le persone all’IA.
Ma se ciò è facile da fare nella cultura pop, l’arte classica sembra rappresentare un serio ostacolo su questa strada, e sono state sviluppate strategie speciali contro di essa. Spiegherò il mio punto con un esempio. Negli ultimi decenni, la musica accademica europea è stata investita dalla moda della cosiddetta “regia d’opera” – allestimenti liberi di opere classiche che impongono trame che non hanno nulla a che vedere con la fonte originale. Ci sono moltissimi esempi: i registi di tutti i teatri d’opera del mondo competono nel mostrare la loro immaginazione. Ne cito uno: la produzione del Parsifal di R. Wagner da parte del regista alla moda C. Serebrennikov all’Opera di Vienna, dove sul palco viene mostrato il GULAG accompagnato dalla musica del grande compositore tedesco. Ricordo che la trama di quest’opera, come di molte altre di Wagner, si basa sull’epica medievale tedesca e che la partitura dell’opera è un complesso lavoro sinfonico con un vasto sistema di leitmotiv e una drammaturgia musicale intricata, attraverso cui si rivelano le idee di Wagner. Mettere in scena un’opera – qualsiasi opera, e in particolare un’opera wagneriana – significa decifrare la partitura musicale, ma il regista Serebrennikov (come la stragrande maggioranza dei registi moderni) non ha una formazione musicale. In questo spettacolo egli adula il pubblico: invece di cercare di comprendere i leitmotiv, di seguire il movimento dei simboli musicali, di approfondire la filosofia di Wagner, il pubblico viene intrattenuto da scene di GULAG – è così di moda, “spiega” direttamente ciò di cui Wagner parlava! È evidente l’introduzione di attributi della cultura di massa nell’arte classica, la vendita del primitivo sotto la veste del complesso.
Così, al posto dell’arte, compaiono simulacri di arte, simili nell’aspetto ma opposti nell’essenza. Vediamo la stessa situazione non solo nell’arte, ma anche in altri ambiti della nostra vita. Viviamo già in un mondo di simulacri totali, senza la possibilità di correlazione con l’autentico, perché la rete neurale può generare qualsiasi “prova” per i falsi diffusi dai media. Perciò non sappiamo chi sia l’aggressore e chi la vittima nella politica internazionale, non sappiamo chi sia il vincitore e chi lo sconfitto nella storia passata, talvolta non sappiamo neppure chi sia un uomo e chi una donna, e infine non sappiamo chi siamo. Per manipolare la coscienza collettiva, imponendole qualsiasi fantasma sotto le sembianze della verità, è necessario distruggere l’idea stessa di verità nella coscienza e sostituirla con un simulacro, e l’unico modo per farlo è cancellare i criteri di distinzione tra il simulacro e l’originale. Non è forse questo ciò di cui scriveva J.W. Goethe nel Faust?
Ma dove tutti sono orgogliosi della depravazione,
Mescolando i concetti,
L’onesto sarà colpevole,
E il colpevole avrà ragione.
Nulla era più sacro.
Ognuno è disperso e si divide.
Le fondamenta vengono scosse,
Quelle che crearono ogni cosa.
Sicuramente molti diranno che, sullo sfondo dei problemi globali moderni, la distinzione tra arte reale e arte finta non è così importante. Non posso essere d’accordo, perché l’arte riflette in forma concentrata tutti i problemi del nostro mondo: l’arte è la principale fonte per mantenere l’identità e l’integrità dell’essere umano. Nel 1986, il grande regista sovietico Georgij Danelija realizzò la profetica distopia Kin-dza-dza. Essa mostra una società incredibilmente avanzata dal punto di vista tecnico, su un pianeta lontano, dove le persone volano liberamente tra le galassie, hanno armi sofisticate, leggono i pensieri altrui e comprendono qualsiasi lingua senza interprete. Ma le loro vite sono terribili, il loro mondo interiore è orribilmente primitivo, il pianeta è diventato un deserto senza acqua e aria, e la regola principale della società è che l’uomo è nemico dell’altro uomo. Tutto perché sul pianeta non esiste arte né alcunché legato all’estetica: le persone hanno perso la capacità di apprezzare e produrre una vera bellezza umana, e ciò ha trasformato le loro vite in un simulacro di vita, e loro stessi in simulacri di persone. Più introduciamo l’IA nell’arte, più ci avviciniamo alla civiltà di Kin-dza-dza.
NOTE BIBLIOGRAFICHE
- Postman, Neil. Technopoly: The Surrender of Culture to Technology. New York: Vintage Books, 1993
- Rottenberg, Josh. Hollywood’s being reshaped by generative AI. What does it mean for screenwriters? // Los Angeles Times, July, 17, 2025.
- Varoufakis Yanis. Technofeudalism: What Killed Capitalism, Bodley Head UK, 2023
Decomputing come atto di resistenza – Seconda parte
Nella prima parte di questo articolo ho esaminato come l'I.A. «sia di per sé un problema tecnico, un balbettante passo falso dell'ordine neoliberista che ne suggerisce l’intrinseco disordine», tracciando un percorso che ne tocca la dannosità, la dimensione violenta – sia dal punto di vista geopolitico che ambientale – l’effetto perverso della scalabilità, per arrivare al concetto di tecnofascismo.
Quello che proporrò, ora, come contromisura è il decomputing; un approccio che prende di mira direttamente l'intelligenza artificiale, ma riguarda e intende scollegare qualcosa di più del solo digitale, fino a riconfigurare le nostre relazioni sociali ed economiche più ampie.
DECRESCITA
Il decomputing è un tentativo di rispondere ai danni sociali e ambientali, via via crescenti, che l’attuale evoluzione tecnopolitica sta producendo; e, il rifiuto della scalabilità è un modo per mitigare gli effetti peggiori e un’euristica mirata a trovare modi alternativi di procedere.
Al contrario della scalabilità dell'IA – il cui fascino e potere è basato sul principio unificante della crescita senza restrizioni - il decomputing è una svolta verso la decrescita, una sfida esplicita all'estrattivismo dell'IA e alle sue logiche sistemiche.
Soprattutto, la decrescita non è semplicemente un rifiuto di dipendere dall'espansionismo, un tentativo di interrompere – qui e ora - l'estrattivismo dell'IA, ma uno spostamento dell'attenzione verso un metabolismo alternativo basato sulla sostenibilità e la giustizia sociale.
DEAUTOMATIZZAZIONE
Il principio del decomputing si oppone alla scalabilità anche perché questa induce uno stato di automatizzazione, in cui l'autonomia e la capacità di pensiero critico sono minate dall'immersione in un sistema di relazioni macchiniche.
In questo senso, l'IA è un'intensificazione delle strutture istituzionali, burocratiche e di mercato che già spogliano i lavoratori e delle comunità della loro agentività, e la collocano in meccanismi opachi e astratti. Il decomputing, al contrario, è la districazione del pensiero e delle relazioni dalle influenze riduttive delle logiche – appunto – burocratiche e di mercato che l’IA replica e rafforza.
Come esempio pratico, possiamo prendere in considerazione il caso del processo di tagli algoritmici al welfare, che viene legittimato proprio dalla presenza di un umano (human-in-the-loop) – come elemento di controllo: l’azione umana, il cui obiettivo dovrebbe essere di garantire un processo giusto, viene neutralizzata dal bias dell'automazione e dall’architettura delle scelte che tende ad allinearsi alla proposta – presunta neutrale – della macchina.
Il decomputing si propone, invece, come modello di sviluppo di forme alternative di organizzazione e di processo decisionale, sostenute dal giudizio riflessivo e dalla responsabilità situata.
Il decomputing riguarda, sia la deprogrammazione della società dalle sue certezze tecnogeniche quanto la decarbonizzazione delle sue infrastrutture computazionali.
La dataficazione e l'ideologia dell'efficienza giocano un ruolo chiave nelle ottimizzazioni negligenti e disumanizzanti dell'IA.
Il decomputing tenta, invece, di strappare la prassi sociale alla crudeltà utilitaristica apertamente celebrata dai seguaci della tecnopolitica reazionaria.
Si tratta di un deliberato allontanamento dai quadri alienanti dell'efficienza e dell'ottimizzazione e di un ritorno al contesto e alle "questioni di cura" in cui le nostre reciproche vulnerabilità e dipendenze sono centrali per la riproduzione sociale.
STRUMENTI CONVIVIALI
Il decomputing afferma che lo sviluppo e l'implementazione di qualsiasi tecnologia avanzata con impatti diffuso sulla società dovrebbero essere soggetti a un scrutinio critico e all'approvazione collettiva.
Possiamo attingere direttamente dal lavoro di Illich sugli strumenti per la convivialità: Illich definisce, infatti, strumenti le tecnologie e le istituzioni, e strumenti conviviali quelli che consentono l'esercizio dell'autonomia e della creatività, in opposizione alla risposte condizionate dai sistemi manipolativi.
La Matrice delle Tecnologie Conviviali estende le idee di Illich, specificando domande che permettono di valutare il grado di convivialità delle tecnologie, domande sull'accessibilità (chi può costruirla o usarla?), sulla relazione (in che modo influisce sulle relazioni tra le persone?) e sulla bio-interazione (in che modo la tecnologia interagisce con gli organismi viventi e le ecologie?).
CONSIGLI POPOLARI
Tuttavia, è improbabile che andremo molto lontano semplicemente ponendo domande ragionevoli sul senso di tutta questa mobilitazione. Il potere delle big tech si è esteso ben oltre la cattura delle norme, fino alla cattura dello stato, o almeno, fino a una situazione in cui c'è una crescente fusione tra gestori delle tecnologie e strutture politiche.
Il decomputing adotta invece un approccio preconizzatore degli effetti della tecnopolitica, enfatizzando il ruolo delle forme assembleari e collegiali che ho descritto altrove come consigli dei lavoratori e del popolo.
Questo tipo di collettività, auto-costituente, radicata nel contesto locale e nell'esperienza vissuta, può essere applicata a qualsiasi livello e in qualsiasi contesto, dalle associazioni genitori-insegnanti che si oppongono alla dipendenza delle giovani menti dai chatbot alle comunità minacciate dalla costruzione di un datacenter hyperscale.
Ovunque l'intelligenza artificiale venga considerata come "la risposta", c'è già una cucitura da scucire, un problema strutturale in cui coloro che sono direttamente coinvolti dovrebbero essere in prima linea nel determinare cosa debba essere cambiato.
RESISTENZA TECNOPOLITICA
La resistenza ai data centre, che è già in atto dai Paesi Bassi al Cile, mostra il potenziale delle giunzioni che si intersecano, di quella che possiamo chiamare intersezionalità infrastrutturale. Queste intersezioni si verificano perché è probabile che le stesse comunità che subiscono interruzioni di corrente a causa del sovraccarico della rete locale o respirano aria inquinata dalle turbine a gas, come – ad esempio - le comunità nere che vivono intorno al data centre XAI di Musk a Memphis, lavorino in condizioni di sfruttamento governate da un algoritmo.
Non è difficile immaginare che la resistenza a un nuovo data center sia solidale - attraverso un'assemblea congiunta di lavoratori e comunità - con gli scioperi selvaggi dei lavoratori nel centro logistico locale di Amazon.
Allo stesso modo, il principio del decomputing può assumere un ruolo importante a supporto dei movimenti per la disabilità, che stanno resistendo ai tagli selvaggi al welfare giustificati da algoritmi che stigmatizzano i disabili come membri improduttivi della società.
Per esempio, si può diffondere la comprensione del modo in cui la disabilità stessa è socialmente costruita dalle tecnologie che la società sceglie di utilizzare o non utilizzare; il concetto di crip technoscience[1] è una critica al ruolo discriminante della tecnologia, e si combina con approcci all'hacking e all'adattamento per rendere la vita delle persone più vivibile; creando così tecnologie conviviali che siano sostenibili e abilitanti.
DECOMPUTING
Il decomputing è, quindi, lo sviluppo di un contropotere rivolto contro l'apparato tecnopolitico dell'IA e contro le sue trasformazioni totalizzanti.
Ciò che il decomputing propone è un percorso verso società costruite su relazioni di cura, i cui attributi non sono l'astrazione e la manipolazione, ma l'aiuto reciproco e la solidarietà. I decomputing afferma che l'autonomia, l'azione e l'autodeterminazione collettiva sono inversamente proporzionali al grado in cui le relazioni umane sono distorte dall'ordinamento algoritmico.
Il decomputing è il progetto di separare la tecnologia avanzata dalle decisioni sugli obiettivi della società. È la riaffermazione della necessità di strumenti conviviali e della costruzione di forme di potere sociale collettivo che possano realizzarli.
Ci sono esempi di lotte contemporanee che non partono direttamente dalla resistenza all'IA, ma combinano comunque la pratica della resistenza auto-organizzata con l'obiettivo di costruire futuri alternativi. Uno di questi è il collettivo di fabbrica GKN, collegato aduna fabbrica in Italia che produceva assali per veicoli, acquistata da un hedge fund che ha cercato di chiuderla e incassare. I lavoratori si sono opposti, hanno occupato il loro posto di lavoro e hanno formato un collettivo con la comunità locale per riutilizzare i loro strumenti per una transizione giusta; cioè, per la giustizia dei lavoratori e la sostenibilità ambientale. Ora producono cargo bike e riciclano pannelli solari e continuano la loro lotta sotto lo slogan partigiano "Insorgiamo!" o "Ci alziamo!".
UN MONDO DA VINCERE
Esigere la determinazione sociale della tecnologia è un modo per scucire la perdita di azione collettiva, risultato di decenni di neoliberismo.
È di questa azione collettiva che avremo bisogno per resistere all'ondata crescente di movimenti politici che vogliono far arretrare ogni tipo di uguaglianza sociale e proiettare la loro visione nichilista attraverso tecnologie che sono già codificate come anti-operaie e anti-democratiche.
E questo è il mio ultimo punto sul decalcolo, che non è una visione per un ritorno a uno status quo pre-IA, ma una rivendicazione deliberata di un mondo migliore per tutti. Una resistenza efficace non è mai stata fondata sulla difesa di uno stato di cose già ingiusto. Ha senso solo come precursore di qualcosa di meglio, avendo l'obiettivo di una società più giusta e più solidale.
Il decomputing è la combinazione di decrescita e tecnopolitica critica che dice che altri mondi sono ancora possibili, e che intendiamo portarli in essere.
NOTE:
[1] La crip technoscience è una prospettiva teorica e un movimento politico che descrive come le persone con disabilità utilizzino, modifichino e reinventino tecnologie e processi scientifici per creare accesso e pratiche di solidarietà nel mondo, piuttosto che essere semplicemente gli utenti di tecnologie prodotte per loro. Il concetto si colloca all'intersezione tra studi critici della disabilità, studi femministi sulla technoscience e pratiche di design, che si contrappone a una visione più tradizionale di design e tecnologia incentrata su un'idea di "normale" o "abilista".
«Tutto bene, madama la marchesa!» - Soluzionismo, accelerazionismo, tecno-ottimismo
Mais, à part ça, madame la Marquise,
tous va très bien, tous va très bien.
(Paul Misraki, 1935)[1]
Dalla celebre Tout va très bien,
madame la marquise, di Paul Misraki,
canzone umoristica francese del 1935.
Di fronte ai pericoli e ai rischi che lo sviluppo tecnologico presenta, sempre più spesso da parte dell’ideologia dominante si risponde o negandoli senz’altro (e riducendo le connesse preoccupazioni a semplici reazioni tecnofobiche), oppure dichiarando che tali controindicazioni in effetti esistono ma vanno per così dire ridimensionate, perché in prospettiva passibili a loro volta di soluzione tecnica. Questa seconda strategia argomentativa è negli ultimi tempi, a fronte della sempre maggior evidenza dei problemi ecologici e non solo, largamente dominante. Il risultato che si ottiene, sul piano ideologico, non è poi tanto diverso da chi nega semplicemente i problemi: si afferma, infatti, che i rischi connessi all’adozione di una certa tecnologia non devono in alcun modo frenarne o rimetterne in discussione l’applicazione. Dal momento che appunto, se problemi e rischi esistono, questi verranno immancabilmente, in futuro, risolti dallo stesso sviluppo tecnico. Così è stato, del resto in passato – si aggiunge – e così sarà in futuro, nei secoli dei secoli, amen. Quest’ultima parola, naturalmente, non viene detta; la metto io solo per richiamare (provocatoriamente) il carattere quasi religioso,[1] o meglio magico-religioso, di tale convinzione.
SOLUZIONISMO
Un esempio notevole di questa visione, che alcuni chiamano “soluzionismo tecnologico” (o semplicemente soluzionismo)[2] si trova nelle recenti dichiarazioni di uno dei big della Silicon Valley, Eric Schmidt, già CEO di Google (dal 2002 al 2011) e più di recente, tra le altre cose, presidente della National Security Commission on Artificial Intelligence statunitense. Parlando a proposito dell’impatto ecologico dell’universo digitale,[3] in particolare con riferimento alla prospettiva di diffusione dell’intelligenza artificiale (molto dispendiosa sul piano energetico), Schmidt ha sostenuto tra l’altro:
«Non raggiungeremo gli obiettivi di sostenibilità perché non siamo organizzati per farlo. Investiamo quindi senza limiti in intelligenza artificiale e data center, anche se consumano tantissima energia, e sarà proprio l’AI a risolvere il problema».
A una prima lettura di queste due frasi, riportate dal “Sole 24 Ore”, appare evidente il non sequitur del ragionamento; ma la cosa non deve stupire, perché alla base sta appunto il dogma soluzionista. Continua infatti Schmidt:
«È in arrivo un’intelligenza aliena. Tutto sarà sommerso dalle enormi esigenze di questa tecnologia […]. Potremo commettere degli errori nell’utilizzarla ma non arriveremo mai alla soluzione attraverso la conservazione. Investiamo senza barriere e sarà lei a fornirci la risposta».[4]
A voler essere benevoli, si potrebbe dire che questo “soluzionismo”, questo ottimismo radicale riguardo alla capacità del genere umano di trovare, appunto, soluzioni ai problemi che di volta in volta si trova di fronte, compresi quelli che esso stesso produce, sia in fondo lo sviluppo di un’idea profonda e ben radicata nella cultura dell’Occidente, e che troviamo per esempio in alcuni celebri versi dell’Antigone di Sofocle, allorché l’uomo viene definito «sempre capace di trovare soluzioni» (così si potrebbe tradurre l’aggettivo usato dal tragediografo greco, pantòporos).[5]
Ora, ammesso e non concesso che si debba necessariamente dar ragione a Sofocle, credo che si possa certo convenire che l’uomo è sempre stato capace di cavarsela in situazioni complesse; e tuttavia questo non è un buon motivo per credere che riuscirà a farcela sempre e comunque, e dunque per figurarsi una sorta di onnipotenza dell’uomo. E del resto, com’è noto, apparteneva alla saggezza dell’antica Grecia (e dello stesso Sofocle nel verso appresso), insieme a questa precoce capacità di cogliere l’ingegnosità umana e le sue capacità di sovrastare le asperità della natura, anche la precisa consapevolezza che – parole questa volta di Eschilo nel Prometeo incatenato – «la tecnica è di gran lunga più debole della necessità».[6] Da notare che lo stesso quotidiano economico, evidentemente perplesso, chiede il parere dello scienziato Francesco Stellacci (IPFL, Politecnico federale di Losanna), che definisce una simile posizione molto pericolosa,
«perché è basata sull’ipotesi che una soluzione esista; e cosa succederebbe allora se una soluzione non esistesse? Per altri aspetti importanti della sostenibilità come il consumo del cibo e di materie prime, ad esempio, la soluzione non esiste affatto».
E perché non pensare, allora, che tra i modi per fare fronte alle difficoltà e ai rischi, dunque per rendere onore a tale nostra pantoporìa, non ci sia, per esempio, il principio di precauzione, la scelta cioè di astenersi da certe scelte, il rifiuto di applicare certe tecniche ecc.? Non è anche questo un modo intelligente per andare verso un futuro così ricco di incertezze e pericoli?
ACCELERAZIONISMO E TECNO-OTTIMISMO
Qui – abbandonando ora gli antichi e tornando purtroppo ai contemporanei – si aggiunge un altro elemento a determinare il cocktail dell’ideologia tecno-nichilistica contemporanea: quello del culto dell’accelerazione, o accelerazionismo, anch’esso evidente nelle dichiarazioni che stiamo esaminando.
Già fortemente implicata nell’idea di progresso, e secondo alcune letture (come quella di Koselleck)[7] interpretabile almeno in parte come concetto religioso secolarizzato, l’idea di accelerazione appare un tratto caratterizzante del mondo moderno, in particolare dalla rivoluzione industriale in avanti. L’accelerazione appare non solo un carattere dell’industria moderna, ma allo stesso tempo un imperativo tecnico, etico e politico per la società nel suo complesso: se infatti – questa la tesi – la via intrapresa dall’umanità è senza dubbi orientata alla piena felicità, allora appare sensato invocare l’accelerazione di tutti i processi in essere.
A rigore, l’accelerazionismo sarebbe una corrente minoritaria (e piuttosto bizzarra) di marxisti angloamericani che, in linea con un certo Marx, perorano la causa di uno sviluppo estremo di ogni innovazione tecnologica, certi che questo infine porterà al comunismo, ambiente nel quale peraltro lo sviluppo troverà davvero modo di espandersi, dal momento che il modo di produrre capitalistico, secondo loro – e sempre secondo un certo Marx – è dello sviluppo tecnico in verità anche un freno (poiché i rapporti sociali di produzione costituirebbero, per ragioni su cui non è possibile qui soffermarsi, una “costrizione” allo sviluppo delle forze produttive).[8]
Non intendo però qui occuparmi di questa scuola di pensiero, ma di quell’accelerazionismo che è invece normalmente presente nella logica di funzionamento dell’attuale capitalismo e che soprattutto sta nella ideologia di molti dei suoi agenti, in particolare dalle parti dell’industria digitale, dove non s’accompagna certo a fantasie socialiste ma molto più prosaicamente alle proprie prospettive di arricchimento.[9] Ecco, nelle parole che abbiamo letto prima, infatti, risuona anche questo imperativo: lo sviluppo tecnologico, la macchina tecno-economica non si deve fermare, né rallentare, per alcuna ragione, ma anzi deve costantemente accelerare. Tanto più rapida sarà, in tal modo anche la soluzione ai problemi e ai “guasti” eventualmente prodottisi. Se si vuole un’esemplificazione molto chiara di tale concezione, si può leggere utilmente il Technooptimist Manifesto di Marc Andreessen (2023):
«Crediamo che non esista problema materiale, creato dalla natura o dalla tecnologia, che non possa essere risolto con maggiore tecnologia. […] Dateci un problema reale e noi inventeremo la tecnologia che lo risolverà. […] Crediamo nell’accelerazionismo – la propulsione consapevole e deliberata dello sviluppo tecnologico».[10]
Siamo qui in presenza di una variazione sul tema di quel «futurismo nichilista» di cui mi sono occupato in un saggio su “Controversie” qualche tempo fa.[11]
-----
È chiaro che quello che ho qui sommariamente descritto è un ottimo dispositivo culturale di supporto all’attuale sistema economico-sociale sotto forma di celebrazione dell’incessante progresso tecnologico (che è poi – non dimentichiamolo – progresso nell’affermazione del potere del capitale sull’umanità e sulla natura). Un dispositivo che, tra le altre cose, tende a liquidare l’idea che, in un qualunque senso, sia necessario porre qualche freno o controllo sullo sviluppo tecnologico in favore di più importanti valori umani o societari.
Proprio la capacità delle società di governare (lo dice oggi perfino un apologeta della transizione digitale come Luciano Floridi),[12] e dunque anche di frenare in determinate circostanze, gli sviluppi tecnologici sarebbe, invece, essenziale oggi di fronte all’evidenza dei danni ambientali prodotti dal crescere esponenziale dell’infrastruttura digitale. Lo osserva per esempio una studiosa americana di questi temi, Arielle Samuelson, che include tra le strategie per rendere Internet meno inquinante una «maggiore cautela nel considerare se l’applicazione dell’IA sia davvero necessaria in ogni industria».[13]
Parole sacrosante, che dovrebbero essere incise all’ingresso delle aziende, delle scuole e delle università, e più in generale fatte circolare nel dibattito pubblico delle nostre società, in un momento in cui la prospettiva della colonizzazione digitale di ogni ambito della vita ci viene presentata come ineluttabile Destino.
NOTE
[1] Che l’ideologia del digitale sia una «quasi-religione» è ben argomentato, da ultimo, nel notevole saggio di Gabriele Balbi, L’ultima ideologia. Breve storia della rivoluzione digitale, Bari-Roma, Laterza, 2022, p. 75-115).
[2] Il termine è stato coniato da E. Morozov in Internet non salverà il mondo, Milano, Mondadori, 2014, avendo poi una certa fortuna. Va detto, tuttavia, che non si tratta di una novità connessa specificamente alle tecnologie digitali, ma più in generale a un mito collegato alla cultura tecnica delle società industriali avanzate (capitalistiche certamente, ma non è mancata una tecnofilia socialista in Urss), secondo il quale in fondo la tecnica è, in termini quasi religiosi, una entità salvatrice.
[3] Su questi temi, oggi al centro di un crescente interesse delle scienze sociali, mi permetto di rimandare ad alcuni miei articoli apparsi su questa rivista: Internet non è una “nuvola”, https://www.controversie.blog/internet-non-e-una-nuvola-prima-parte/ e https://www.controversie.blog/internet-non-e-una-nuvola-seconda-parte/, e I costi ambienali del digitale. Una bibliografia ragionata, “Controversie”, anno I, n. 5 (2025), https://www.controversie.blog/costi-ambientali-del-digitale-bibliografia/
[4] Barbara Carfagna, Intelligenza artificiale: consumi di energia enormi, non sappiamo chi la produrrà, “Il Sole 24 Ore”, 13 ottobre 2024, p. 12. Sottolineatura mia.
[5] Sofocle, Antigone, ai vv. 360-61, dove si dice che l’uomo, pantpòros appunto, àporos ep’oudèn èrchetai to mèllon, ovvero «non va mai verso il futuro privo di risorse» (traduzione mia, ma la tr.it. di Ezio Savino, per esempio, recita «infinito artista, inerte non affronta / nessun domani». Sofocle, Edipo re. Edipo a Colono. Antigone , introduzione di Umberto Albini, traduzione, nota storica e note di Ezio Savino, Milano, Garzanti, 1988, p. 249).
[6] Traduce invece «O arte, quanto più debole sei del destino» Carlo Carena (Eschilo, Prometeo incatenato, a cura di Carlo Carena, Torino, Einaudi, 1995, p. 24). È proprio questa consapevolezza della cultura greca antica che costituì sempre un freno alla formazione del concetto di progresso illimitato nello sviluppo storico (per il quale si dovrà attendere l’età moderna), come aveva notato Dilthey, secondo il quale la concezione greca del mondo «faceva susseguire l’uno all’altro periodi di nascimento, di svolgimento e di regresso dell’universo, in una monotona mancanza di speranza; e questo corso circolare diventava per i Greci il più sublime simbolo della transitorietà della razza umana» (Wilhelm Dilthey, Il secolo XVIII e il mondo storico, Milano, Edizioni di Comunità, 1977, p. 28).
[7] Cfr. Reinhart Koselleck, Accelerazione e secolarizzazione, Napoli, Istituto Suor Orsola Benincasa, 1989.
[8] Per questa ideologia si veda Alex Williams – Nick Srniceck, Manifesto accelerazionista, postfazione di Valerio Mattioli, Roma-Bari, Laterza, 2018. Al termine di questa sfrenata fantasia utopistica sta poi l’utopia tecno-comunista che uno di questi teoreti, Aaron Bastiani, ha chiamato Fully Automated Luxury Communism, «comunismo del lusso integralmente automatizzato», da lui illustrato in un omonimo volume pubblicato (con sprezzo del ridicolo!) dalla casa editrice londinese Verso.
[9] Anche qui, comunque, le fantasie tecno(fanta)scientifiche non mancano, tra ibridazione uomo-macchina, “superamento della biologia”, prolungamento della vita, colonizzazione dei pianeti extraterrestri ecc. Per una rassegna di queste affabulazioni utopiche, si vedano, oltre a Gabriele Balbi, L’ultima ideologia, cit.; Mark O’Connell, Essere una macchina. Un viaggio attraverso cyborg, utopisti, hacker e futurologi per risolvere il modesto problema della morte, Milano, Adelphi, 2018; e, con particolare attenzione alla lunatica Weltanschaaung di Elon Musk e della sua combriccola, Paolo Bottazzini, The Musk. Teoria e pratica di un genio egoista, Milano, Bietti, 2025, sul quale tornerò prossimamente con un articolo dedicato.
[10] Marc Andreessen, The Techno-Optimist Manifesto, “Andreessen Horowitz”, October 16, 2023, https://a16z.com/the-techno-optimist-manifesto/
[11] Cfr. Toni Muzzioli, Avanti verso il nulla. Sul futurismo nichilista contemporaneo, “Controversie”, 24/06/2024, https://www.controversie.blog/futurismo-nichilista-1/
[12] Cfr. Luciano Floridi, L’era digitale richiede responsabilità, “La lettura” / “Corriere della sera”, 20 luglio 2025, p. 7-9. «La società digitale – leggiamo – necessita di nuove regole per gestire e indirizzare le trasformazioni in corso. (…) L’evoluzione tecnologica non dovrebbe procedere per inerzia di mercato o secondo logiche puramente ingegneristiche e di massimizzazione del profitto. Queste sono il motore necessario, ma le mani sul volante, e la decisione su dove andare, restano alla società e alla politica». Naturalmente una simile capacità di governo deve implicare anche la possibilità di fermare talune scelte tecniche, altrimenti ogni dichiarazione in favore delle regole resta “acqua fresca”. Come temo sia il caso anche di queste parole.
[13] Arielle Samuelson, Are your internet habits killing the planet?, “Heated”, May 28, 2024, https://heated.world/p/are-your-internet-habits-killing