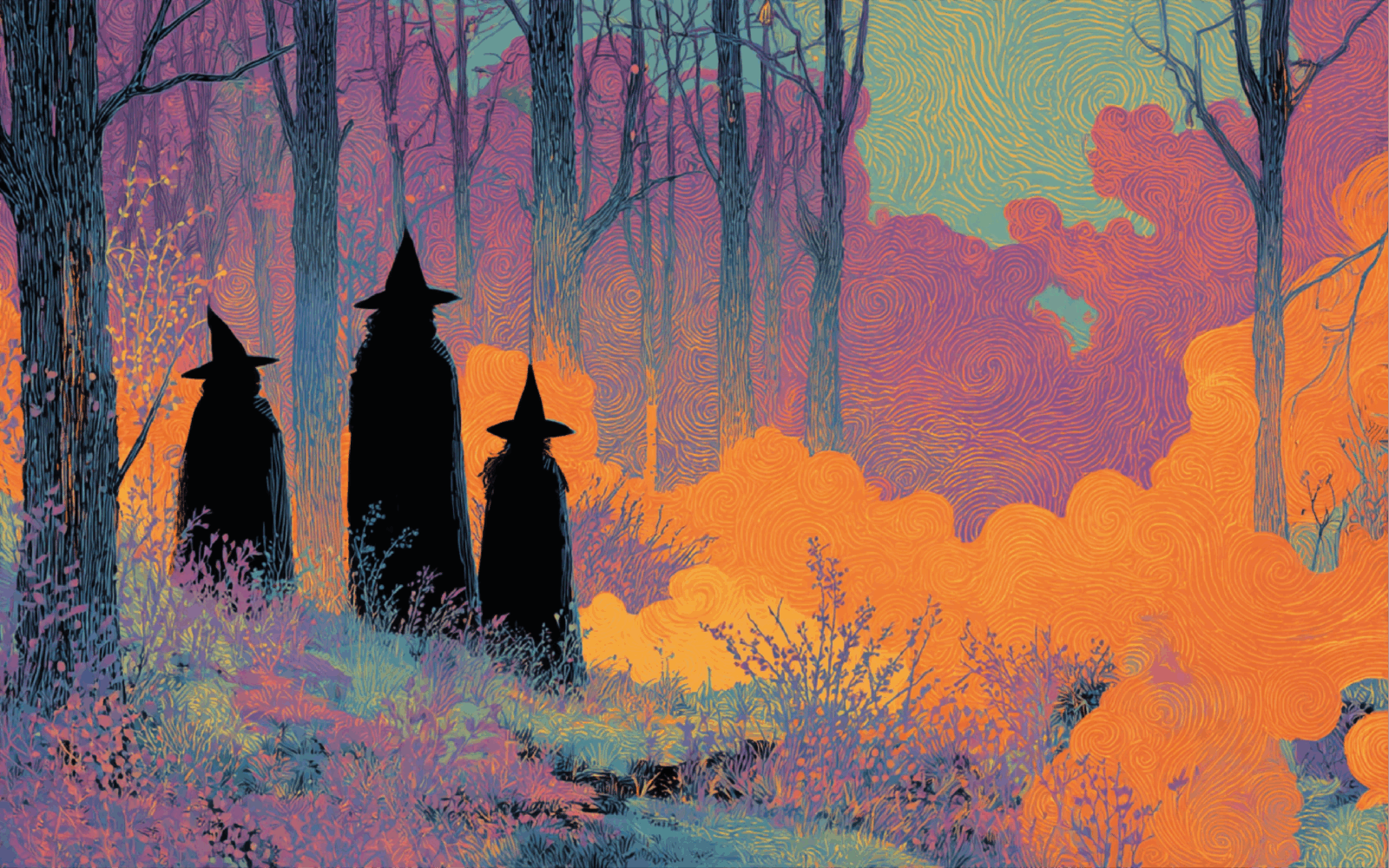Robotica sociale assistiva: l’espansione della cura nell’era tecnologica
Negli ultimi ͏anni, il rapido pr͏ogresso ͏della tecnologia ha aperto nuove possibilità nel settor͏e clin͏ico e di assistenza, soprattut͏to per gli anziani. Tra le innovazioni più interess͏anti c’è la robotica sociale assisti͏va (SAR), una parte della͏ robotica c͏he si occupa͏ di fornire aiuto͏ em͏otivo, fisico e mentale alle persone più fragili. Alcuni studi hanno evidenziato il fatto che “la pandemia da Covid-19 ha spinto ad usare solu͏zioni͏ automatizzate”[1] , mostrando sia gli effetti positivi dei robot sociali sia le difficoltà nell’inser͏irli nella vita normale de͏gli utent͏i. ͏Le ricerche recenti mostrano risultati positivi sullo stato d’animo͏, su͏lla͏ diminuzione della so͏litud͏i͏ne e sulla qualità d͏ella vita delle persone anzia͏ne ma͏ inducono anche a interrogarsi sulla questione etica e psico͏logica. In relazione a questi aspetti si riflette sull'autoingann͏o e sul rischio di infantilizzazione dell’utente. In quest͏a situazione complessa e in continuo cambiamento, il nostro contributo intende esplorare come gli ͏italiani percepiscono l’introduzione dei SAR nel servizio d’assistenz͏a͏. Partendo dalle argomentazioni proposte dal͏la ricercatrice Nicoletta Massa e dalla sua pubblicazione riguardo la psicologia della salute[2], è interessante domandarsi quanto͏ siano note alla collettività le potenzialità dei SAR e in quale ottica verrebbero accolte, facendo riferimento in͏ modo particolare ag͏li aspetti m͏entali, c͏ulturali e so͏ciali che influenzano l'accettazione della robotic͏a assistiva. Per fare ciò abbiamo sottoposto un questionario online al fine di approfondire tali tematiche.
L’indagine nasce da alcuni interrogativi iniziali: come verrebbero accolti i SAR dalla popolazione generale del nostro paese? Potrebbe quest’ultima, nel prossimo futuro, trovarsi a beneficiarne? La nostra ricerca è stata orientata ad esaminare il livello di conoscenza, percezione e accettazione sociale verso la robotica sociale assistiva (SAR) nel contesto italiano. Nel mese di gennaio 2025, abbiamo proposto una serie di domande, sotto forma di questionario online da somministare ad un “campione di convenienza”, attraverso piattaforme social. L’indagine si è basata su precedenti ricerche nel campo delle tecnologie assistive e consiste in due tipologie di domande: quesiti a risposta multipla e scale Likert. Il questionario è stato diviso in quattro parti: dati demografici, familiarità con le tecnologie assistive, opinioni sull’uso dei SAR negli ambienti domestici e riflessioni etico-culturali. Il campione raggiunto è di 203 persone, la maggioranza dei rispondenti è nella fascia di età 18-24 anni (37%) con una prevalenza di rispondenti donne (66%). Benché il campione non sia rappresentativo della popolazione italiana nella sua interezza, l’indagine consente una prima esplorazione sulle impressioni riguardo i SAR, ponendo le basi per successivi approfondimenti.
Da un lato si riscontra una maggiore apertura dal punto di vista emotivo nel rapporto con la tecnologia, tanto che l’idea di avere un rapporto affettivo con un robot potrebbe non essere percepita come inverosimile. A livello personale, tuttavia, persiste un meccanismo psicologico: l’utente attribuisce un valore emotivo al comportamento del robot, nonostante quest’ultimo sia totalmente privo di tali caratteristiche umane[3].
Va in aggiunta contestualizzato il tema delle carenze diffuse, le quali stanno segnando il sistema lavorativo contemporaneo. Tale termine viene utilizzato nel contesto occupazionale, per fare riferimento a una carenza estesa e sistemica di competenze, risorse o personale adeguato, che non può che influenzare negativamente la produttività e l'efficienza. Le fonti hanno registrato mancanze significative per quanto riguarda le categorie di operatori sanitari a livello sub-nazionale. In questo insieme si includono i posti vacanti difficili da ricoprire e anche i bisogni sanitari insoddisfatti, segnalati dalla popolazione stessa.
Il caso italiano presenta un numero di infermieri per abitante inferiore alla media UE[4]. Questa situazione suggerisce un maggiore affidamento sui medici nell'erogazione dei servizi. La situazione si aggrava con la riduzione del personale medico e paramedico impiegato nel sistema sanitario nazionale[5], specialmente a fronte del trend di invecchiamento della popolazione e della richiesta crescente di cure e domande di assistenza medica[6]. In questo contesto questi strumenti potrebbero offrire un supporto concreto, se integrati correttamente.
Risulta opportuno, in primo luogo, affrontare alcune questioni aperte che vengono trattate nell’articolo[7] , come la self-deception (autoinganno),fenomeno che può essere analizzato come conseguenza di due ordini di fattori: uno di natura storico-contestuale e l’altro di natura individuale.
Gli intervistati hanno dimostrato la non conoscenza del nuovo strumento di robotica sociale assistiva, visto che il 75,9% dei rispondenti non aveva mai sentito parlare dei SAR. Nonostante la distanza iniziale dall’argomento, ciò non ne ha precluso il successivo interesse: le opinioni espresse non si traducono in un rifiuto netto, bensì in una posizione di scetticismo esplorativo. Il campione analizzato non si è dimostrato del tutto ostile alla novità. Ne è un esempio il fatto che quasi il 41% si dichiari incuriosito, pur restando perplesso, nel concepire un robot che sia in grado di interagire con persone anche nella sfera emotiva, mentre solo il 14% considera esplicitamente utile tale interazione. Inoltre, pur prevalendo una visione tradizionalista dell’assistenza, con il 66,5% che preferisce ancora le cure umane a quelle automatizzate, emerge una quota consistente (34%) che accetterebbe l’inserimento di un SAR in casa se accompagnato da una figura umana, specialmente se designata a mansioni più tecniche. Ciò indica in ogni caso che la tecnologia venga percepita più come supporto che come minaccia. Sebbene il 69% non ritenga possibile il successo di queste tecnologie nel nostro paese, una percentuale analoga (66,5%) riconosce che i SAR potrebbero essere efficacemente impiegati per monitorare la salute e avvisare i medici in caso di necessità. Dunque, a fronte della diffidenza culturale e affettiva, si afferma una concezione relativamente positiva, specialmente in ambiti in cui la presenza umana non sia sempre garantita. Questa ambivalenza rappresenta probabilmente l’aspetto più interessante dell’indagine: le persone si mostrano scettiche, ma non particolarmente ostili, quello che emerge infatti, è una forte curiosità.
Il timore non appare di tipo apocalittico ma è piuttosto legato a preoccupazioni etico-relazionali e affettive. È interessante considerare come, anziché preoccuparsi di una possibile diminuzione dell’impiego (aspetto ricorrente se si tratta di intelligenza artificiale e robotica nell’ambito lavorativo), il campione si sia concentrato piuttosto sulla mancanza di empatia da parte delle macchine, ritenuta un elemento imprescindibile del settore dell’assistenza sanitaria. In tale contesto lo scetticismo di molti potrebbe essere mitigato attraverso una maggiore informazione e consapevolezza, considerando che, la maggior parte delle mansioni svolte dai SAR non si limiterebbero soltanto ad aiutare i soggetti fragili, quanto il personale sanitario in primo luogo.
In base͏ ai͏ dati r͏a͏ccol͏ti e alle idee condivise, sembra emergere ch͏e l'arrivo dei robot sociali di assistenza sia un͏a sfida complessa ma forse rivoluzionaria per il ͏sis͏tema sanitario di ogg͏i. Il fatt͏o che mo͏lti sarebbero pro͏nti ad accettar͏e un SAR a casa sug͏gerisce una disponibil͏i͏tà all'in͏tegrazione; purché si mantenga un buon equilibrio tra tec͏nologia e umanità.
In sintesi, ciò che è emerso non è un rifiuto del progresso, bensì la richiesta che quest’ultimo venga integrato con attenzione, trasparenza e sensibilità. Se i SAR verranno inseriti non come sostituti, ma come alleati del lavoro umano, rispettando la dignità delle persone, potranno contribuire a riformare un sistema che ad oggi si ritrova spesso in difficoltà. Non si tratta di una sfida prettamente tecnica, ma anche culturale e politica.
In conclusione, l’accettazione sociale della robotica assistiva dipenderà dalla capacità di affrontare con consapevolezza quelle che sono le implicazioni psicologiche ed etiche di queste tecnologie.
Maggiore consapevolezza, una progettazione che punta ai bisogni del paziente ed una chiara regolamentazione d’uso vanno considerati come elementi decisivi al fine di garantire che i SAR possano realmente contribuire all’ideazione di un sistema di cura diverso, progressivamente più efficace ed equo.
NOTE:
[1] Massa N. (2022) Innovazioni in psicologia della salute: il contributo della Social Assistive Robotics. Tra opportunità terapeutiche e questioni aperte della robotica sociale. Psicologia della salute: quadrimestrale di psicologia e scienza della salute, 37(5), 267-286
[2] Ibidem
[3] OECD (2025), Prospettive economiche dell'OCSE, Rapporto intermedio, marzo 2025: Navigare in acque incerte, OECD Publishing, Paris
[4] Massa N. (2022) Innovazioni in psicologia della salute: il contributo della Social Assistive Robotics. Tra opportunità terapeutiche e questioni aperte della robotica sociale. Psicologia della salute: quadrimestrale di psicologia e scienza della salute, 37(5), 267-286
[5] Ibidem
[6] OECD (2025), Prospettive economiche dell'OCSE, Rapporto intermedio, marzo 2025: Navigare in acque incerte, OECD Publishing, Paris
[7] Ibidem
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
Massa N. (2022), Innovazioni in psicologia della salute: il contributo della Social Assistive Robotics : tra opportunità terapeutiche e questioni aperte della robotica sociale, in "Psicologia della salute: quadrimestrale di psicologia e scienze della salute: 3, 2022, Milano: Franco Angeli, 2022 , 1972-5167 - Casalini id: 5378331" - P. 14-27
OECD (2025), Prospettive economiche dell'OCSE, Rapporto intermedio, marzo 2025: Navigare in acque incerte, OECD Publishing, Paris
OECD/European Commission (2024), Health at a Glance: Europe 2024: State of Health in the EU Cycle, OECD Publishing, Paris
Terrorismo: uso politico del termine?
È molto probabile che uno dei termini più menzionati nel gergo giornalistico quando si parla di politica internazionale sia “terrorismo”, una parola utilizzata per definire, identificare o categorizzare diversi individui, gruppi o addirittura organizzazione politiche o paesi.
L’Organizzazione delle Nazione Unite non ha una definizione ufficiale di “terrorismo” ma, di norma, il termine viene usato per riferirsi ad azioni violente e premeditate con lo scopo di suscitare terrore nella popolazione.
Pertanto, in ogni paese i codici penali nazionali fanno riferimento a una definizione diversa di “terrorismo” e di “azione terroristica”.
Al di là delle diverse definizioni, di frequente e nella pratica, sono state identificate come “terroristiche” quelle entità politiche con le quali non si era disposti a trattare. Si pensi, ad esempio, alla lista di paesi presunti sponsor del terrorismo, stilata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che viene – in realtà - aggiornata in base alle linee politiche e geopolitiche dell’amministrazione di turno.[1]
A complicare il ulteriormente il quadro, si noti che, di recente, in paesi come il Regno Unito o la Repubblica Ceca, alcune manifestazioni in favore della Palestina sono state segnalate come “difesa delle attività terroristiche”.
In questo senso, possiamo riprendere le parole Alex Schmidt, uno degli accademici che ha più studiato il termine:
«Terrorismo” è forse oggi il termine più politicizzato del vocabolario politico. Usato come etichetta per alcune forme di violenza politica, quando “attecchisce” incide negativamente su un avversario politico, demonizzandolo e delegittimandolo. Nella sua dimensione peggiorativa, il destino del termine “terrorista” è paragonabile all’uso e all’abuso di altri termini del vocabolario politico, come “razzista”, “fascista” o “imperialista».[2]
È evidente che il senso del termine molto spesso dipende dall'intenzione politica di chi lo utilizza. Ad esempio, gli Stati Uniti considerano Al-Qaeda un'organizzazione terroristica, ma non era così quando la stessa Al-Qaeda ricevette il sostegno degli Stati Uniti contro i sovietici durante gli anni Ottanta. Un esempio simile si riguarda Hezbollah: questa organizzazione politica e la sua ala paramilitare vengono considerati come organizzazione terroristica da 26 paesi, ma non dal resto del mondo, dove di solito è identificato come un movimento di resistenza libanese.
Allo stesso modo, c’è chi utilizza il termine di “terrorismo di stato” per riferirsi, ad esempio, al genocidio perpetrato dallo Stato di Israele contro i palestinesi, nella striscia di Gaza o in altre regioni della Palestina, e, invece, il termine viene evitato dalla maggior parte dei media nei paesi occidentali in cui è fortemente osteggiata una linea contraria alle politiche di Israele.
In altri casi, gli Stati Uniti (che, come ricordato prima, hanno una loro lista di paesi ritenuti sponsor del terrorismo), sono stati accusati a loro volta di terrorismo di stato per il sostegno, ufficiale o ufficioso, ad alcune attività della CIA. Ad esempio, l’attentato contro il volo di Cubana de Aviacion il 6 di ottobre 1976, che produsse 73 morti e nel quale furono coinvolti numerosi elementi legati alla Central Intelligence Agency.[3]
È possibile trovare altri esempi simili ad altre latitudini del pianeta. In Ucraina, quando i ribelli armati hanno rifiutato di riconoscere il governo di Kiev nel 2014 e hanno cominciato i primi scontri contro l’esercito ucraino, la presidenza di Poroshenko ha subito organizzato una operazione armata chiamata “Operazione Anti-Terroristica” (ATO). Pertanto, quando le autorità ucraine hanno definito come terroristi i ribelli nell'Est, intendevano già dire che non vi era alcuna reale intenzione di negoziare un cessate il fuoco pacifico o trovare un accordo politico per l'Ucraina orientale.[4]
Nei film di Hollywood si sente spesso la frase “Non negoziamo con i terroristi”, proprio per far capire che non c’è alcuna intenzione di trovare un accordo e per segnalare quindi che è possibile soltanto una soluzione di forza. Quella stessa frase viene ripetuta, con lo stesso significato, dagli organi di sicurezza di diversi paesi.
Questa volontà di mostrare risolutezza contro una posizione politica considerata inaccettabile, ed etichettata come “terrorista”, assume spesso tratti contraddittori. Infatti, per fare un esempio recente, questa logica è stata messa in questione dalla presidenza del Messico: nonostante il governo degli Stati Uniti avesse considerato il Cartel di Sinaloa come una organizzazione terroristica, poco dopo (come ha sottolineato Claudia Sheinbaum) trovarono un accordo con Ovidio Guzman, uno dei figli di Joaquin “El Chapo” Guzman, uno dei fondatori del cartello.[5]
Quindi, a quali condizioni non si negozia con terroristi? Oppure, attribuire questa etichetta è solo un mezzo per far pressione nei confronti dell’organizzazione definita “terroristica”?
Allo stesso modo, è possibile trovare altri esempi che mostrano in maniera evidente la natura politica del termine “terrorista”. In generale, sarebbe consigliato evitare l’uso del termine nei paesi con una forte polarizzazione del tessuto politico, a meno che non si proponga un'altra definizione.
Infatti, molti dei reati che tipicamente vengono considerati “terrorismo” sarebbero facilmente descritti anche senza utilizzare questo termine, il cui uso può essere strumentale, per esempio di fronte ad una strage per elevare o diminuire il livello di attenzione o di preoccupazione nell’opinione pubblica.
Si pensi al recente incidente del 26 maggio a Liverpool, in cui un’autista britannico ha diretto la sua auto contro folla e che ha causato più di 100 feriti.[6] Una volta che le autorità hanno determinato che l’incidente causato da un’autista (bianco) non era un atto terroristico, e che non vi erano state vittime fatali, l’evento è sparito dall’interesse dell’opinione pubblica.
Di conseguenza, sarebbe molto importante fare attenzione all’uso che si fa della parola “terrorismo”. Ovviamente, questo non significa avallare forme estreme di violenza, ma al contrario, significa fare attenzione alla sua vera origine e di trovare quindi spiegazioni che invitano all’analisi e alla riflessione piuttosto che usare un’etichetta che vieta, o quantomeno scoraggia, la ricerca di soluzioni e accordi politici.
Perché se, come diceva il generale prussiano e teorico militare Carl von Clausewitz, la guerra è un’estensione della politica, e se consideriamo la violenza estrema chiamata terroristica come un’estensione della guerra, allora non sarebbe forse più auspicabile trovare degli spazi per l’accordo politico prima di arrivare al momento di massima polarizzazione? O non sarà piuttosto che la ragione della diffusione dell’uso della parola terrorismo vada ricercato semplicemente nel fatto che ci troviamo in un periodo dove predominano posizioni politiche più estreme?
NOTE:
[1] Attualmente in questa lista si trovano Cuba, Siria, Corea del Nord e Iran. Cuba era stata tolta dalla lista durante l’amministrazione Obama ma è stata rimessa durante la prima presidenza Trump. Sudan, Iraq e Libia erano nella lista ma furono poi rimossi. I paesi appartenenti a questa lista sono soggetti a sanzioni unilaterali, non possono ottenere alcun aiuto economico, né acquistare armi, e sono sottoposti a un controllo rafforzato per diversi prodotti a doppio uso. United States Department of State, State Sponsors of Terrorism - United States Department of State
[2] Schmid, Alex P., ‘The definition of terrorism,’ in The Routledge Handbook of Terrorism Research, Edited by Schmid, Alex P., New York, Routledge, 2011, page 40. Traduzione Enrico Campo
[3] Luis Posada Carriles, The Declassified Record, The National Security Archive, Maggio 10, 2005. Luis Posada Carriles: The Declassified Record
[4] Rolando Dromundo, State-building in the middle of a geopolitical struggle: The cases of Ukraine, Moldova and Pridnestrovia, Ibidem, Stuttgart, 2018.
[5] Sheinbaum critica acuerdo EEUU con hijo de El Chapo | Las últimas Noticias de España y del Mundo - upday News
Negare l’evidenza. Un clima di disinformazione
Quando la realtà ci sfugge di mano, il nostro cervello si rifugia in un’antica strategia di sopravvivenza: trovare un colpevole. È più rassicurante immaginare un “volto tra le nuvole”, che accettare l’idea che il mondo sia, talvolta, caotico, privo di intenzione e difficile da controllare. È il cosiddetto modulo di rilevazione dell’agente: un dispositivo cognitivo descritto dalle scienze cognitive evoluzionistiche che ci spinge, per prudenza, a vedere intenzionalità dove non ce n’è. Meglio sospettare un predatore inesistente, che ignorarne uno reale.
Lo storico delle religioni Stewart Guthrie, nel suo Faces in the Clouds (Oxford University Press, 1993), chiama questo meccanismo “antropomorfismo cognitivo”: attribuire caratteristiche umane a entità o eventi naturali, come tuoni, terremoti o carestie. Un’ipotesi evoluzionista che spiega la nascita di molte religioni come estensione dell’animismo primitivo: ci dev’essere qualcuno dietro, anche se non si vede.
Non è un caso se lo stesso schema mentale viene riattivato oggi di fronte al cambiamento climatico, alla pandemia, all’instabilità globale. Come spiega la psicologa sociale Karen Douglas in “The Psychology of Conspiracy Theories” (Current Directions in Psychological Science, 2017), le teorie del complotto proliferano in situazioni di incertezza, ansia, senso di esclusione. Non servono a spiegare il mondo, ma a renderlo psicologicamente tollerabile. Dietro un virus? Un laboratorio. Dietro il riscaldamento globale? Un piano delle élite per controllare le masse.
Nel Medioevo, per spiegare carestie e pestilenze si cercavano streghe. Oggi, si cercano burattinai: Bill Gates, Klaus Schwab, George Soros e ovviamente Greta Thunberg. Cambiano i nomi, non lo schema. I roghi si sono trasformati in commenti sotto i post, meme, video virali. Ma la logica è la stessa: trovare un capro espiatorio e scaricare su di lui l’angoscia collettiva.
Il pensiero complottista offre un doppio vantaggio narcisistico: ci fa sentire sia speciali (“io so la verità”) sia perseguitati (“gli altri non capiscono”). È un rifugio identitario: se il cambiamento climatico fosse reale e causato da noi, dovremmo cambiare. Ma se è tutto un inganno, possiamo restare come siamo. E magari sentirci anche eroi per averlo smascherato.
Ogni smentita, poi, diventa una conferma. Se i dati scientifici contraddicono la teoria, è solo perché “loro” ci stanno mentendo. Una trappola mentale chiusa dall’interno, a doppia mandata.
Ma non c’è solo psicologia. Il negazionismo climatico è una strategia deliberata e ben orchestrata. A documentarlo in modo puntuale sono Naomi Oreskes e Erik Conway in Merchants of Doubt (Bloomsbury Press, 2012). Una vera radiografia del sistema: think tank finanziati dall’industria dei combustibili fossili, “esperti” compiacenti, studi isolati, messaggi ambigui. Non per negare apertamente il cambiamento climatico – oggi sarebbe insostenibile – ma per seminare dubbi. Perché se non puoi smentire la scienza, puoi almeno confondere il pubblico.
È la stessa tecnica usata, decenni fa, dall’industria del tabacco. Quando ormai era evidente il legame tra fumo e cancro, non restava che un’arma: chiedere “ulteriori studi”. Creare l’illusione di un dibattito aperto. Come dichiarò con cinismo S. J. Green, direttore della ricerca della British American Tobacco: «La richiesta di nuove prove scientifiche è sempre stata un espediente per giustificare l’inazione o il rinvio. Di solito è la prima reazione di chi è colpevole.»
Lo stesso copione, aggiornato, è stato messo in campo da ExxonMobil. Già negli anni ’70 e ’80 i loro scienziati interni producevano modelli previsionali molto accurati sugli effetti della CO₂. Ma la direzione aziendale scelse un’altra strada: finanziare il dubbio. Tra il 1998 e il 2004, la compagnia ha speso oltre 16 milioni di dollari per sostenere think tank negazionisti, come il Competitive Enterprise Institute. Celebre la loro campagna del 2006: «CO₂: They call it pollution. We call it life». Nessun dato. Solo retorica.
La disinformazione funziona anche perché sfrutta un altro meccanismo psicologico: la truthiness, termine coniato dal comico Stephen Colbert per indicare ciò che “suona vero”, anche se non lo è. Un effetto verità che prende scorciatoie emotive, bypassa il pensiero analitico e colpisce direttamente l’istinto.
Uno studio pubblicato su Science da Soroush Vosoughi, Deb Roy e Sinan Aral (“The Spread of True and False News Online”, 2018) ha mostrato che le fake news si diffondono più rapidamente, più lontano e più in profondità rispetto a quelle vere. Non sono i bot i principali responsabili, ma noi: indignati, frettolosi, disattenti. Le bufale provocano emozioni forti – rabbia, paura, disgusto – che attivano il cervello più rapidamente della riflessione razionale.
È il cosiddetto bullshit asymmetry principle (Brandolini’s law): per smontare una sciocchezza servono almeno dieci volte le risorse necessarie per produrla. La scienza richiede tempo, verifiche, cautele. Il complotto no. Viaggia leggero, virale, immune alla smentita. E mentre la politica si divide, la transizione ecologica si arena. Perché, intanto, il tempo corre.
Le teorie del complotto e la disinformazione scientifica sono la conseguenza, prevedibile, di come funziona il nostro cervello e di come funzionano – in modo non meno prevedibile – gli interessi economici organizzati. Comprenderlo è il primo passo per difenderci. Perché mentre la scienza avanza a passi lenti e incerti tra ipotesi, verifiche, margini d’errore e formule prudenti (“altamente probabile”, “coerente con i modelli”, “correlazione significativa”), la disinformazione finanziata dalle lobby del carbone, del petrolio e del gas corre – rapida ed emozionale – sul tapis roulant della truthiness. Non deve dimostrare nulla. Solo dirci quello che desideriamo sentire.
NOTA
Su questo tema Matteo Motterlini ha appena pubblicato, per Solferino Libri, Scongeliamo i cervelli, non i ghiacciai