L’Effetto Proteo: Quando l’Avatar cambia chi siamo
Nell’era digitale, l’identità personale non è più confinata al corpo fisico: sempre più spesso si estende ai nostri avatar, quei corpi virtuali che abitiamo nei social network, nei videogiochi, negli ambienti digitali in generale. Ma cosa succede quando l’aspetto di questi avatar inizia a influenzare profondamente il nostro comportamento reale? Questo è il cuore dell’“Effetto Proteo”, un fenomeno psicologico che mette in luce il potere trasformativo dell’identità digitale.
DALLA MASCHERA ALL’AVATAR: LE ORIGINI DELL’EFFETTO PROTEO
Coniato nel 2007 da Nick Yee 1 e Jeremy Bailenson 2, il termine “Effetto Proteo” richiama la figura mitologica greca di Proteo, capace di cambiare forma a piacimento. L’idea alla base è semplice ma potentissima: quando adottiamo un avatar in un ambiente digitale, tendiamo inconsciamente a comportarci in modo coerente con il suo aspetto. Se l’avatar è alto e attraente, potremmo mostrarci più sicuri di noi; se appare debole, potremmo essere più remissivi.
Già Oscar Wilde, ben prima del digitale, scriveva: “Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth”. La maschera, oggi, è l’avatar, e funziona da catalizzatore per l’esplorazione dell’identità.
Nell’affrontare l’identificazione tra avatar ed essere umano si analizzeranno, in prima battuta, i meccanismi psicologici e cognitivi che sono alla base dell’esistenza dell’Effetto Proteo; successivamente, verranno valutati gli effetti di stereotipi e bias su comportamento e identità; infine, si tenterà una sintesi di quanto analizzato, vagliando come e quanto l’identificazione nel proprio avatar conduca a delle modifiche nella percezione di sé, tanto nei mondi virtuali quanto in quello reale.
INQUADRAMENTO PSICOLOGICO
Numerosi studi hanno indagato i fondamenti teorici dell’Effetto Proteo. Uno dei principali è la “self-perception theory” di Daryl Bem 3. Secondo questa teoria non sempre conosciamo i nostri stati interiori in modo immediato: spesso ci osserviamo dall’esterno, proprio come farebbe un osservatore qualsiasi, e traiamo conclusioni su cosa proviamo in base al nostro comportamento visibile. Questo meccanismo diventa particolarmente evidente quando mancano segnali interni chiari o quando ci troviamo in contesti ambigui. Negli ambienti virtuali ciò significa che, quando “indossiamo” un avatar, tendiamo a comportarci secondo le caratteristiche estetiche e simboliche che gli abbiamo attribuito, e da tali comportamenti inferiamo i nostri stati d’animo. L’avatar, quindi, non è solo una maschera, ma anche uno specchio che riflette (e crea) il nostro Sé.
Un’altra teoria rilevante è la “deindividuation theory” di Philip Zimbardo 4, sviluppata a partire dagli anni Sessanta. Secondo Zimbardo, in situazioni di anonimato o di forte immersione in un gruppo, l’individuo tende a perdere il senso della propria individualità, diminuendo l’autocontrollo e mostrando comportamenti che normalmente inibirebbe. L’anonimato riduce la paura del giudizio altrui e attenua il senso di responsabilità personale: in un ambiente digitale queste condizioni si verificano con facilità. Secondo Zimbardo, l’effetto della de-individuazione è tendenzialmente negativo, e conduce a comportamenti antisociali; tuttavia, altri autori hanno evidenziato che individui in condizione di de-individuazione, temendo meno il giudizio sociale, possono esibire anche espressioni di empatia, solidarietà o affetto.
Questa visione è stata successivamente affinata da Tom Postmes 5, Russell Spears 6 e Martin Lea 7 attraverso il modello SIDE (Social Identity Model of Deindividuation Effects). Gli autori sostengono che l’anonimato non elimina l’identità personale, ma favorisce il passaggio a un’identità sociale condivisa. Quando un individuo si sente parte di un gruppo tende a interiorizzarne norme e valori, comportandosi in maniera coerente con le aspettative collettive. Ciò significa che, in un contesto digitale, l’utente può sviluppare un forte senso di appartenenza a una comunità online assumendo atteggiamenti e comportamenti che riflettono la cultura del gruppo stesso. Come osservano gli autori, il bisogno di sentirsi accettati nella cerchia sociale di riferimento supera qualsiasi considerazione etica riguardo il comportamento adottato. In questo senso, l’avatar non è solo uno strumento di espressione individuale, ma anche di conformità sociale. L’interazione tra anonimato, immersione e identità condivisa crea una cornice psicologica che amplifica le norme del gruppo. In positivo, questo può rafforzare la cooperazione, il supporto reciproco e l’inclusività; in negativo, può alimentare polarizzazioni, intolleranze e comportamenti aggressivi.
STEREOTIPI E IDENTITÀ DIGITALI
Gli stereotipi giocano un ruolo centrale nell’Effetto Proteo. Già nel 1977, Mark Snyder 8 dimostrava che le aspettative proiettate sull’interlocutore influenzano profondamente l’interazione. Tre fenomeni descrivono l’impatto degli stereotipi:
- Stereotype threat: la paura di confermare uno stereotipo negativo conduce a prestazioni peggiori.
- Stereotype lift: l’identificazione con un gruppo visto positivamente migliora fiducia e risultati.
- Stereotype boost: l’appartenenza a gruppi stereotipicamente forti conduce a benefici in prestazioni e autostima 9.
Nei videogiochi è stato osservato che avatar maschili e femminili esibiscono comportamenti diversi quando utilizzati da persone del sesso opposto: tale fenomeno è noto come “gender swapping”. Gli uomini tendono a usare avatar femminili per ottenere vantaggi sociali, mentre le donne lo fanno per evitare attenzioni indesiderate. Uno studio condotto su World of Warcraft (Yee, Bailenson, & Ducheneaut, 2009) ha rilevato che avatar più attraenti o più alti generano atteggiamenti più estroversi, mentre avatar meno imponenti portano a comportamenti più schivi. In uno studio parallelo, condotto su giocatrici e giocatori di EverQuest II (Huh & Williams, 2010), è stato evidenziato che personaggi maschili controllati da donne sono più attivi in combattimento, mentre personaggi femminili controllati da uomini si dedicano maggiormente alla socializzazione: in entrambi i casi si assiste alla messa in atto di comportamenti stereotipici, aderenti a ciò che un determinato individuo si aspetta da persone identificate in un genere altro.
IDENTITÀ DESIDERATA E OVERCOMPENSATION
Il fenomeno dell’identificazione desiderata, o “wishful identification”, si manifesta quando l’individuo si immedesima in personaggi con qualità che vorrebbe possedere. Nel 1975 Cecilia von Feilitzen 10 e Olga Linné 11 teorizzavano che gli spettatori più giovani dei programmi televisivi tendessero a proiettarsi nei protagonisti delle storie che consumavano per sentirsi più intelligenti, forti o valorosi. Questo desiderio di immedesimazione non richiede necessariamente una somiglianza fisica tra soggetto e personaggio: l’importante è che il personaggio incarni qualità desiderabili, e assenti nella vita reale dell’osservatore. Nei mondi virtuali, tale meccanismo assume una dimensione interattiva: non ci si limita più a osservare un eroe sullo schermo, ma lo si diventa, scegliendo avatar che riflettono i nostri desideri più profondi e agendo attraverso di essi.
Una manifestazione concreta di questo processo si osserva nel fenomeno dell’overcompensation. In uno studio condotto da Roselyn Lee-Won 12 e colleghi, a un gruppo di giovani uomini è stato chiesto di sottoporsi a una serie di test stereotipicamente associati alla mascolinità (forza fisica, cultura generale “virile”, autovalutazioni). Coloro che ottenevano risultati deludenti tendevano poi a creare avatar in The Sims 3 con tratti fisici accentuatamente maschili: muscoli pronunciati, lineamenti decisi, capelli corti. Questa costruzione ipermaschile del proprio alter ego virtuale rappresenta una forma di riaffermazione identitaria, un tentativo inconscio di compensare una percezione negativa del proprio Sé fisico o sociale. Non solo: quando questi stessi individui ripetevano i test dopo aver interagito con l’avatar, i loro risultati miglioravano. Questo suggerisce che l’identificazione con un corpo virtuale desiderato possa rafforzare l’autoefficacia anche nel mondo reale. Il Sé digitale, in questo senso, non è solo uno strumento di espressione, ma anche un vero e proprio alleato nella costruzione di fiducia e autostima.
Questa dinamica di retroazione è una delle più affascinanti implicazioni dell’Effetto Proteo: non è solo l’avatar a essere influenzato dall’utente, ma anche l’utente a essere modificato dal suo avatar. L’identità digitale, quindi, diventa non solo espressione, ma anche motore di trasformazione del Sé.
ETICA E DESIGN DELL’IDENTITÀ DIGITALE
L’Effetto Proteo non è un semplice artificio sperimentale: è una dinamica concreta con ripercussioni reali su comportamento, percezione di sé e relazioni sociali.
Come vogliamo che ci vedano gli altri? E quanto siamo pronti ad accettare che il nostro comportamento possa cambiare, anche profondamente, in base al corpo digitale che abitiamo? La progettazione di avatar non può essere considerata solo una questione estetica: è un atto di modellazione identitaria. Costruire un corpo digitale significa anche dare forma a una possibile versione di sé, con tutto il potere trasformativo che questo comporta.
NOTE:
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Bem, D. (1972). Self-Perception Theory. In L. Berkovitz (ed.), Advances in Experimental Social Psychology, vol. 6. New York: Academic Press.
Gergen, K. J., Gergen, M. M., & Barton, W. H. (1976). Deviance in the Dark. In Psychology Today, vol. 7, no. 5. New York: Sussex Publishers.
Huh, S., & Williams, D. (2010). “Dude Looks like a Lady: Gender Swapping in an Online Game”. In W. S. Bainbridge (ed.), Online Worlds: Convergence of the Real and the Virtual. Londra: Springer.
Hussain, Z., & Griffiths, M. D. (2008). Gender Swapping and Socializing in Cyberspace: An Exploratory Study. In CyberPsychology & Behavior, vol. 11, no. 1. Larchmont: Mary Ann Liebert, Inc.
Lee-Won, R. J., Tang, W. Y., & Kibbe, M. R. (2017). When Virtual Muscularity Enhances Physical Endurance: Masculinity Threat and Compensatory Avatar Customization Among Young Male Adults. In Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, vol. 20, no. 1. Larchmont: Mary Ann Liebert, Inc.
Postmes, T., Spears, R., & Lea, M. (1998). Breaching or Building Social Boundaries?: SIDE-Effects of Computer-Mediated Communication. In Communication Research, vol. 25, no. 6. Thousand Oaks: SAGE Publishing.
Shih, M., Pittinsky, T. L., & Ambady, N. (1999). Stereotype Susceptibility: Identity Salience and Shifts in Quantitative Performance. In Psychological Science, vol. 10, no. 1. New York: SAGE Publishing.
Snyder, M., Tanke, E. D., & Berscheid, E. (1977). Social Perception and Interpersonal Behavior: On the Self-Fulfilling Nature of Social Stereotypes. In Journal of Personality and Social Psychology, vol. 35, no. 9. Washington, D.C.: American Psychological Association.
Steele, C. M., & Aronson, J. (1995). Stereotype Threat and the Intellectual Test Performance of African Americans. In Journal of Personality and Social Psychology, vol. 69, no. 5. Washington, D.C.: American Psychological Association.
Walton, G. M., & Cohen, G. L. (2003). Stereotype Lift. In Journal of Experimental Social Psychology, vol. 39, no. 5. Amsterdam: Elsevier.
Yee, N., & Bailenson, J. (2007). The Proteus Effect: The Effect of Transformed Self-Representation on Behavior. In Human Communication Research, vol. 33, no. 3. Oxford: Oxford University Press.
Yee, N., Bailenson, J., & Ducheneaut, N. (2009). The Proteus Effect. Implications of Transformed Digital Self-Representation on Online and Offline Behavior. In Communication Research, vol. 36, no. 2. New York: SAGE Publishing.
Zimbardo, P. G. (1969). The Human Choice: Individuation, Reason, and Order versus Deindividuation, Impulse, and Chaos. In W. J. Arnold, & D. Levine (eds.), Nebraska Symposium on Motivation, vol. 17. Lincoln: University of Nebraska Press.
“Ostipitalità” - Controversia di un concetto (anche) politico
Dopo la cosiddetta “crisi dei rifugiati” che ha segnato profondamente l’Europa e l’Italia negli ultimi anni, il concetto di ospitalità ha assunto una rilevanza centrale nel dibattito pubblico e politico. Lontano dall’essere un semplice gesto privato di gentilezza, l’ospitalità è diventata una posta in gioco etica e politica, un banco di prova per le democrazie contemporanee. Accogliere chi fugge da guerre, persecuzioni o condizioni di vita insostenibili significa oggi confrontarsi con domande fondamentali: chi ha diritto di entrare? Chi decide le condizioni dell’accoglienza? Quali obblighi morali e sociali comporta il prendersi cura dell’altro?
In questo contesto, l’ospitalità rivela tutta la sua ambivalenza. Da un lato, rappresenta un’apertura verso l’altro, un riconoscimento della sua vulnerabilità e un tentativo di costruire legami di solidarietà e coesistenza. Dall’altro, proprio nel momento in cui viene istituzionalizzata – attraverso leggi, regolamenti, dispositivi di controllo – l’ospitalità può diventare uno strumento di esclusione, di selezione, di subordinazione. Le pratiche di accoglienza si situano dunque in una zona grigia, dove generosità e potere, cura e controllo, si intrecciano in modi spesso contraddittori.
È in questo intreccio che diventa urgente interrogarsi sul significato profondo dell’ospitalità e sulle sue implicazioni nei confronti della cittadinanza, dell’identità e della giustizia sociale.
NON SAPPIAMO COSA SIA L’OSPITALITÀ
«Non sappiamo cosa sia l’ospitalità». Con questa frase, Jacques Derrida (2000: 7, Hostipitality) riassume tutta l’ambivalenza del gesto di accogliere. L’ospitalità non si può definire in astratto, perché prende forma solo dentro contesti concreti, attraversati da emozioni contrastanti, relazioni asimmetriche, limiti materiali. È proprio nello scarto tra l’ideale dell’accoglienza incondizionata e la pratica quotidiana che l’ospitalità rivela il suo carattere conflittuale. A prima vista appare come un gesto di apertura, generosità, cura verso l’altro. Ma basta osservarla da vicino per coglierne il lato meno rassicurante. L’ospitalità non è mai neutra: implica sempre una posizione di potere, una gerarchia, una condizione. E può facilmente trasformarsi in una forma sottile di controllo.
È a partire da questa tensione che Derrida elabora alla fine degli anni Novanta il concetto – oggi più attuale che mai – di ostipitalità, un neologismo che unisce “ospitalità” e “ostilità”. Con questa idea, il filosofo mette in luce il potere tacito di chi ospita nel fissare regole, limiti e condizioni dell’accoglienza. L’ospitalità, quindi, non è solo un gesto di solidarietà: è anche un dispositivo di normalizzazione. Il suo paradosso, per Derrida, sta proprio qui: promette apertura, ma la limita per mantenere l’autorità dell’ospitante.
In questo senso, ospitalità e cittadinanza sono concetti “gemelli”. Entrambi tracciano confini: tra chi ha diritto a restare e chi può solo transitare, tra chi appartiene e chi viene tollerato, tra chi stabilisce le regole e chi deve adeguarvisi.
IL DEBITO INVISIBILE
C’è poi un altro elemento meno evidente, ma altrettanto incisivo: l’aspettativa del “contro-dono”. Chi viene accolto dovrebbe, in qualche modo, ricambiare. Mostrare gratitudine, adattarsi, non disturbare. Come spiegava l’antropologo Marcel Mauss (1925), ogni dono porta con sé l’obbligo di rispondere. E l’ospitalità non fa eccezione. Anche quando è presentata come “incondizionata”, si accompagna spesso a richieste implicite: di rispetto, di conformità, di invisibilità. È così che la persona accolta entra in una posizione fragile: deve dimostrare di meritare l’ospitalità; deve evitare di apparire “troppo esigente” o “fuori posto”. L’asimmetria è evidente, anche se si presenta con il volto della solidarietà. Chi accoglie ha il potere di definire cosa è giusto, normale, accettabile. Chi è accolto deve adeguarsi.
ACCOGLIERE SELEZIONANDO
Uno degli aspetti più evidenti dell’ostipitalità italiana è la sua natura selettiva. Si accolgono alcuni, i “veri rifugiati”, i “profughi ucraini”, i “minori stranieri non accompagnati”, mentre altri vengono respinti, criminalizzati o semplicemente ignorati. Si costruiscono gerarchie di merito, in cui il diritto all’accoglienza dipende da criteri morali, politici o culturali. Le leggi sull’immigrazione, dalla Bossi-Fini ai decreti sicurezza, fino al recente “Piano Mattei”, consolidano questa distinzione, trasformando l’ospitalità in un privilegio riservato a chi si adatta, rispetta, non disturba.
Questo approccio prende forma nei dispositivi di governo: i CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) si aprono e si chiudono in base all’emergenza del momento; le commissioni territoriali decidono chi ha diritto a restare e chi deve andarsene; le frontiere (da Lampedusa al confine italo-sloveno) si trasformano in luoghi di ostilità permanente, dove ogni gesto di accoglienza appare come una minaccia da contenere. Anche il linguaggio è attraversato da questa logica ostile: termini come “clandestino”, “emergenza”, “degrado” servono a delegittimare l’idea stessa di accoglienza, trasformandola in problema, in anomalia da gestire o nascondere.
Nelle città, questa ostilità si riflette nello spazio: l’accoglienza è tollerata solo se invisibile, silenziosa, discreta. Laddove non è possibile renderla invisibile, si tenta di spostarla ai margini. Sempre più spesso, il compito dell’accoglienza viene lasciato al volontariato, mentre il welfare pubblico si ritira, ridotto a una presenza intermittente e inefficace. Così, l’ospitalità smette di essere un diritto e diventa un gesto condizionato, fragile, continuamente messo alla prova.
VIVERE L’OSPITALITÀ
Eppure, tra ospitalità e ostilità esiste una zona grigia, fatta di pratiche quotidiane: è in questa zona che si muovono i volontari, i mediatori, gli operatori sociali. Il caso delle “famiglie accoglienti” – famiglie che accolgono nella loro abitazione un rifugiato per un tempo che va da poche settimane fino, in rari casi, a molti anni – è un esempio concreto dell’esperienza paradossale e dilemmatica dell’ospitalità. Come messo in evidenza da alcune ricerche (Sperandio e Lampredi, 2024), è in queste pratiche concrete che nascono dilemmi che possono diventare profondamente politici: come rispettare l’altro senza annullare le proprie abitudini? Come evitare di imporre? Come convivere con differenze radicali? Sono momenti scomodi, ma preziosi, perché mettono in discussione l’idea stessa di appartenenza, sicurezza, normalità. L’ospitalità, allora, non è più solo un gesto di apertura, ma un processo di apprendimento. Non è una concessione, ma una relazione da coltivare, sbagliare, ripensare. Queste pratiche mostrano che l’ospitalità è un processo fragile e trasformativo, non una condizione data. È qualcosa che si costruisce, e si mette in discussione, ogni giorno, nei rapporti concreti con l’altro. È proprio nel confronto con le contraddizioni che può emergere un senso più profondo di responsabilità e giustizia.
CONCLUSIONE: NON INVISIBILIZZARE LE CONTROVERSIE DELL’OSPITALITÀ, MA AFFRONTARLE
La vera sfida, allora, non è eliminare (o invisibilizzare) l’ambiguità dell’ospitalità, ma imparare a riconoscerla e ad attraversarla. Significa costruire forme di convivenza che non cancellino la differenza, che non trasformino la solidarietà in paternalismo, che non implichino silenziosamente un dovere di riconoscenza. Significa anche accettare che l’ospitalità, per essere davvero etica e politica, deve saper trasformare le sue imperfezioni in occasioni per rivalutare costantemente le radici etico-politiche del vivere comune. Deve esporsi al rischio del fraintendimento, del conflitto, dell’errore. Solo così può diventare, davvero, un’apertura all’altro – non come proiezione dei nostri ideali, ma come incontro imprevedibile e trasformativo. In un’epoca in cui l’ospitalità è invocata tanto per includere quanto per escludere, riflettere sul suo carattere paradossale non è un lusso teorico. È un’urgenza politica.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Derrida, J. (2000). Hostipitality. Angelaki: Journal of Theoretical Humanities, 5(3), 3-18.
Mauss, M. (1925). Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques. L’Année sociologique, 1(2), 30–186.
Sperandio, E., & Lampredi, G. (2024). From hospitality to dwelling: a lens for migrant homesharing in Italy. Journal of Ethnic and Migration Studies, 1-19. https://doi.org/10.1080/1369183X.2024.2346618
Un'ombra sulla democratizzazione della tecnoscienza - Il fallimento della consultazione nazionale CNAPI
Nell’articolo precedente abbiamo provato a dare un’idea di cosa sia il progetto del Deposito Nazionale delle scorie radioattive e della situazione di stallo in cui versa – in questo momento – tra una legge approvata nel 2011 e l’apparente cambiamento di piani enunciato dal Ministro dell’Ambiente meno di un mese fa.
Abbiamo anche accennato che il processo di identificazione della località dove costruire il Deposito1 doveva passare attraverso la Consultazione Pubblica, un iter che prevede la discussione pubblica, con «tutti i soggetti interessati alla realizzazione e all’esercizio del deposito, inclusi i comuni in cui potrebbero essere localizzati, le regioni coinvolte, le associazioni ambientaliste e i cittadini residenti nelle aree interessate».
OBIETTIVI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA
Nel disegno delineato da Sogin, la Consultazione Pubblica aveva tre obiettivi:
- il primo, di ampio respiro, era spiegare a tutti gli stakeholder coinvolti cos’è il Deposito, perché è necessario farlo, come viene fatto e perché non comporta rischi significativi per l’ambiente e la popolazione;
- il secondo obiettivo era arrivare alla Carta Nazionale delle Aree Idonee per la costruzione del deposito escludendo quelle 2 che – sulla base delle considerazioni fatte dagli interessati – presentano delle criticità ancora non considerate;
- il terzo, il più importante di tutti, era stimolare la candidatura di alcune delle Aree giudicate Idonee a luogo in cui costruire il Deposito.
COME SI FA LA CONSULTAZIONE POPOLARE
La Consultazione Popolare è costituita da un ciclo – chiamato Seminario Nazionale - di 10 sessioni: 2 plenarie di apertura e di chiusura dei lavori, una nazionale e una sessione per ciascuna delle 7 Regioni 3 in cui si trovano il 67 siti potenzialmente idonei.
Le sessioni e le relative discussioni sono tenute in video conferenza 4 e trasmesse in streaming in tempo reale, può partecipare chiunque, istituzioni, associazioni, privati cittadini.
La struttura delle sessioni, ripetuta quasi identicamente per ogni regione, è in forma di dialogo contradditorio, con:
- la componente promotrice del Progetto, costituita da Sogin, ISIN 5, Nucleco 6, le Università direttamente coinvolte nel progetto o nei Seminari;
- le parti portatici di interessi potenzialmente contrari o di richieste di chiarimento, come le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Arpa 7, i rappresentanti degli agricoltori, le associazioni ambientaliste.
Il colloquio procede secondo uno schema di narrazione, obiezioni, risposte alle obiezioni, conclusione istituzionale; all’interno del confronto è prevista una sessione di domande fatte dai partecipanti – inclusi i cittadini – e di relative risposte da parte del responsabile del progetto: l’Ing. Chiaravalli di Sogin.
Ogni sessione è seguita da una sintesi e da una formalizzazione dei risultati.
A titolo di esempio, ecco il programma della Sessione dedicata a Basilicata e Puglia:
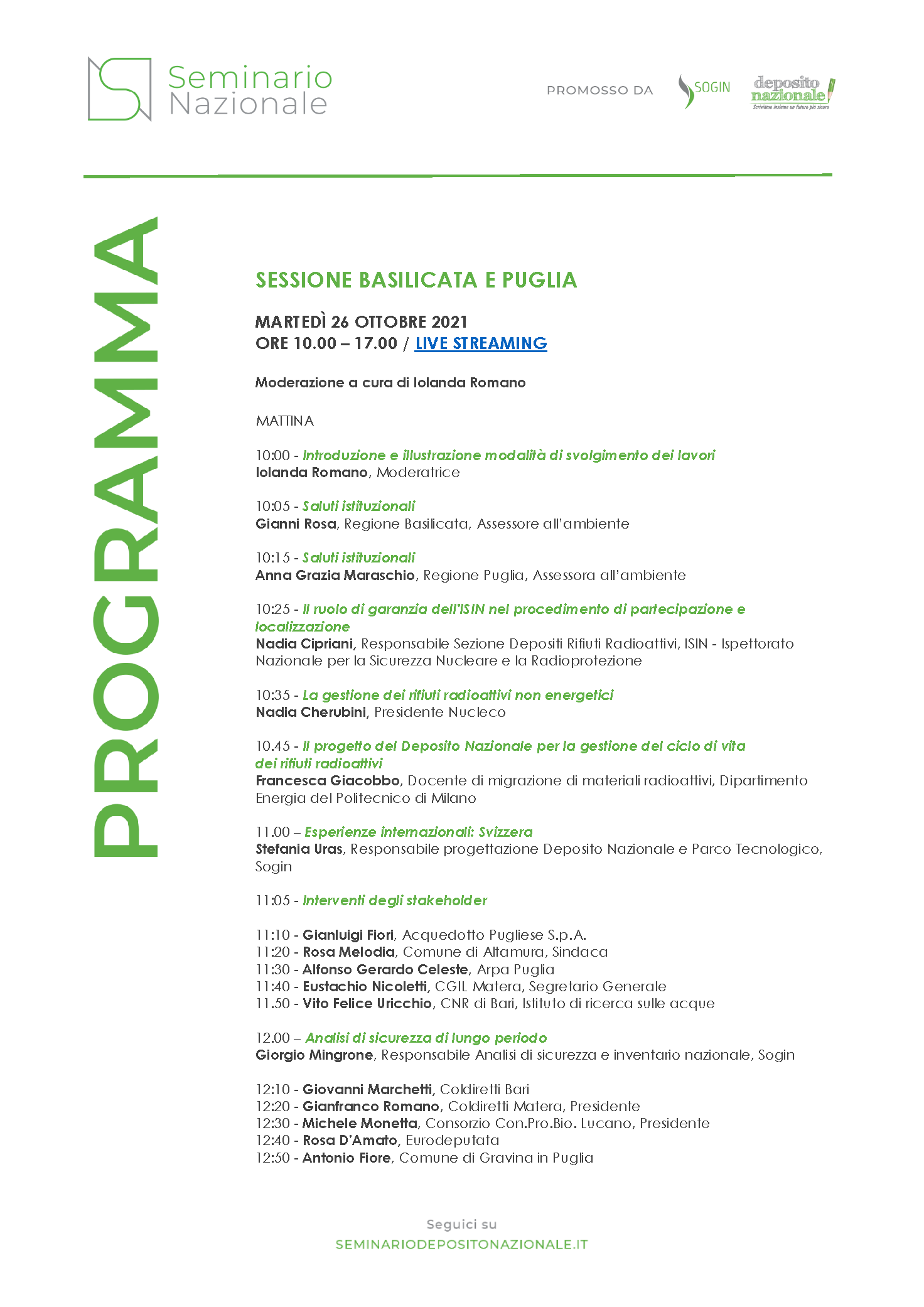
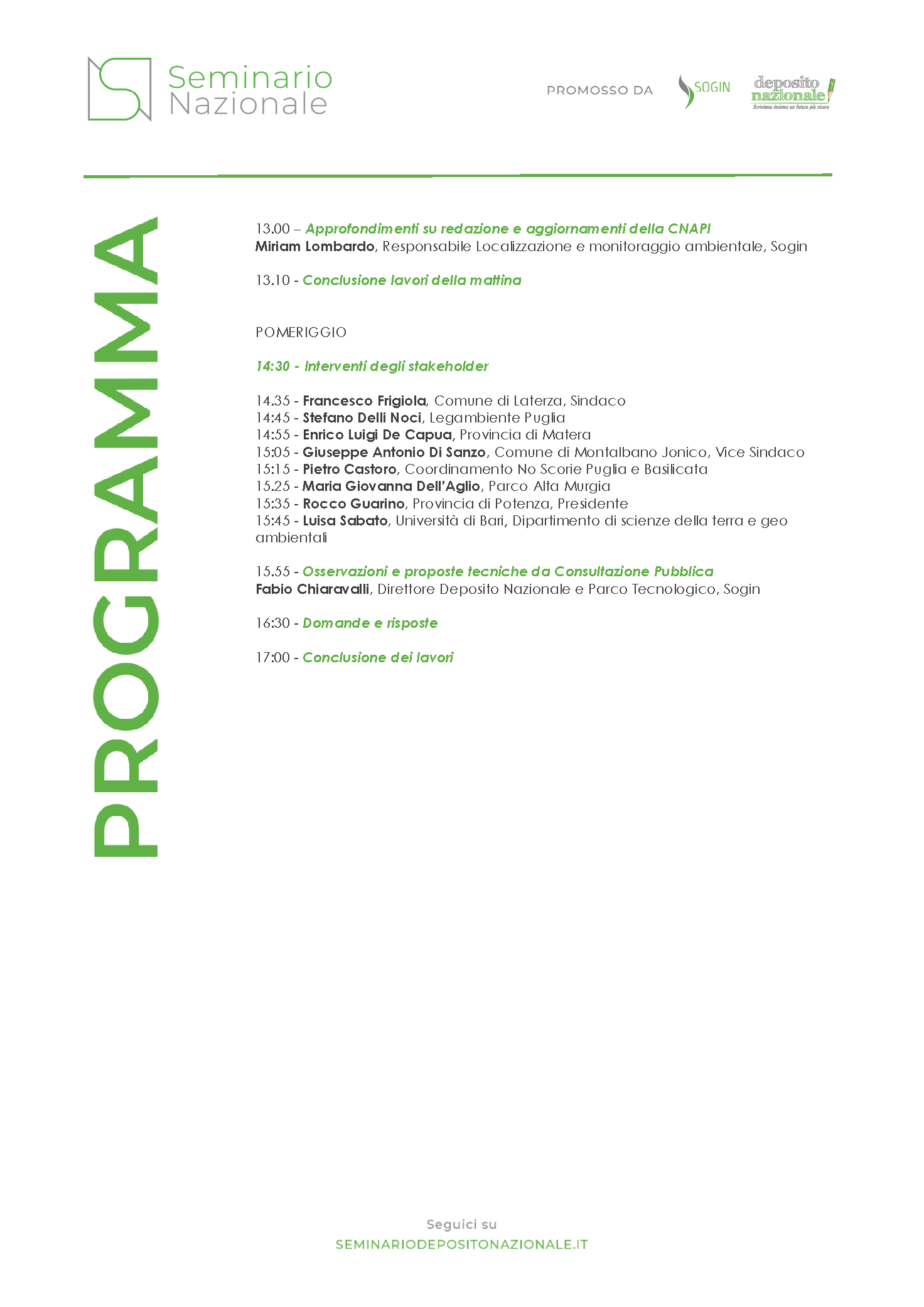
In filigrana, nello svolgimento dei Seminari si intuisce che:
- Sogin domina il contraddittorio da una posizione cattedratica: è il referente delle domande, fornisce chiarimenti e neutralizza le obiezioni;
- il confronto mira a neutralizzare le obiezioni sull’impianto generale del progetto, a convincere gli ascoltatori della necessità e non pericolosità del Deposito. Solo occasionalmente censisce fattori di esclusione di alcuni siti.
QUALI DUBBI E OBIEZIONI SONO EMERSI?
Nelle sintesi degli incontri sono riportate le principali classi di obiezioni emerse durante i seminari. Sogin identifica due classi di argomenti ricorrenti:
- quelli di carattere generale (non direttamente collegati ai territori interessati dalla CNAPI);
- quelli legati direttamente alla CNAPI e all’applicazione dei Criteri di localizzazione della Guida Tecnica n. 29 (Sintesi Sessione Piemonte) 8.
Nel secondo gruppo figurano problemi come:
- aspetti geologici locali (ad esempio: sismicità locale o particolarità idrogeologiche) non considerati che potrebbero sconsigliare la localizzazione in una determinata area;
- la presenza di aree naturali protette, di habitat faunistici, di direttive protezionistiche, quale, ad esempio, il Geoparco degli etruschi, in Lazio (Sintesi Sessione Lazio);
- la «presenza di coltivazioni di prodotti di pregio e la presenza di zone sottoposte a vincolo di tutela ambientale e dei beni culturali» o una concentrazione abitativa superiore a quanto rilevato (Restituzione dei lavori – Sessione Sicilia);
- possibili difficoltà logistiche, quali le condizioni dei trasporti e delle strade 9.
Questo genere di obiezioni è stato preso in considerazione dal Progetto 10 e ha portato all’esclusione di 16 siti potenzialmente idonei dalla Carta definitiva delle Aree Idonee, che ne contiene solo 51.
Scrive Sogin nella Sintesi della Sessione Lazio: «i temi affrontati e le indicazioni pervenute costituiscono un arricchimento della sua base conoscitiva, integrando le descrizioni preliminari fornite nelle Relazioni d’Area pubblicate a corredo della CNAPI […] Le tematiche evidenziate […] saranno debitamente tenute in conto nel corso delle eventuali successive fasi del processo di caratterizzazione. Le segnalazioni di potenziali criticità ed elementi di attenzione […] completeranno l’insieme delle conoscenze attualmente disponibili per ognuna delle API e integreranno la base conoscitiva a partire dalla quale verrà eventualmente elaborato il Piano di Indagine per la caratterizzazione tecnica di dettaglio delle aree idonee».
In questo senso, si può sostenere che la Consultazione Pubblica abbia raggiunto uno degli obiettivi: disegnare la mappa dei siti in cui è effettivamente possibile – visto il parere degli stakeholder nazionali e locali - costruire il Deposito Nazionale delle scorie radioattive.
Nella prima classe di obiezioni espresse dagli stakeholder, invece, ricadono temi quali:
- il mancato coinvolgimento nella decisione sui criteri per le Aree Potenzialmente Idonee;
- la mancata considerazione di principi rilevanti quali, ad esempio, la presenza di coltivazioni di prodotti di pregio (Coldiretti), di aree protette (WWF, LegaAmbiente), di vincoli dei beni culturali, che avrebbero potuto delineare con maggiore precisione la mappa di idoneità;
- la visione datata del territorio, in termini di densità abitativa, di antropizzazione, di tutele e di evoluzione dei vicoli, a causa del fatto che il Progetto è nato nel 2011, che le osservazioni spesso sono precedenti a quella data e che il Seminario si tiene nel 2021;
- la componente reputazionale dei territori, molti dei quali hanno una forte identità turistica – accentuata dal turismo di wilderness – che può essere messa in crisi dalla presenza del Deposito;
- la modalità eccessivamente strutturata e rigida della Consultazione Pubblica;
- infine, una serie di domande e obiezioni generali sulla pericolosità del Deposito, sull’opportunità di realizzarlo, sulla forma e sui contenuti del progetto 11.
Queste domande e obiezioni sono state neutralizzate dalle risposte di Sogin, che ha difeso, giustificato e sostenuto – di fatto senza possibilità di replica – l’adeguatezza del progetto e della consultazione, senza però – sembrerebbe dal tenore delle domande della Sessione conclusiva 12 – placare più di tanto i timori degli stakeholder.
IL FALLIMENTO DELLA DEMOCRATIZZAZIONE DELLA DECISIONE
Il terzo obiettivo della Consultazione Pubblica, quello di stimolare le candidature degli enti locali come aree obiettivo per la localizzazione del Deposito, è stato, invece, platealmente mancato.
Come abbiamo già visto, nessun Ente locale, fatto salvo per il Comune di Trino Vercellese che però non fa parte delle Aree Idonee, ha manifestato interesse ad ospitare il Deposito, vanificando di fatto lo sforzo organizzativo ed economico della Consultazione.
Tuttavia, è evidente che:
- la forma di road-show 13 con esposizione frontale e risposta alle obiezioni, adottata da Sogin per la consultazione pubblica, ha certamente favorito la contrapposizione tra il Progetto e le obiezioni, tra Sogin e le comunità locali;
- la segmentazione temporale e spaziale, regione per regione, dei lavori ha lasciato campo libero alla fuga dalla responsabilità, aggiungendo alla posizione NIMBY quella dello “scaricabarile” verso il successivo attore consultato;
- lo scarso coinvolgimento iniziale dei diversi attori e la mancanza sia di una fase co-creazione dei presupposti e dei valori dell’iniziativa, che di una adeguata “traduzione” del progetto e di un progressivo “arruolamento”, nei confronti delle comunità locali 14, hanno minato alla base il processo.
DARE SPAZIO AL DECISIONISMO OPPURE RIPROVARCI?
Si possono, ora delineare due possibili percorsi per uscire dall’impasse: il primo è – banalmente – che Sogin abdichi al ruolo (mal recitato, finora) di primus inter pares, che cerca di mettere d’accordo le istanze di tutti gli attori coinvolti, e la decisione passi nelle mani del Governo.
Tuttavia, dato che la mappa delle aree idonee, gli stakeholder e le obiezioni sono note a tutti e che – soprattutto – il fattore tempo non è ancora così stringente, si può pensare di fare un passo indietro e salvare l’idea della democratizzazione del processo di localizzazione.
Si può, forse, adottare un approccio co-creativo di maggiore coinvolgimento, sollecitare un dialogo paritetico tra tutti gli stakeholder, dedicare tempo e energie a esplicitare le scale valoriali locali, e condividere il valore irrinunciabile della realizzazione del deposito, l’analisi del rischio, le ragioni del timore, le opportunità, le regole per la localizzazione; si possono stimare le condizioni per l’alternativa di più siti, la componente economica, i vantaggi e le rinunce che comportano le diverse soluzioni – per sceglierne una che conti sull’adesione convinta di tutti.
Tuttavia, il fallimento di questo genuino 15 tentativo di coinvolgimento degli stakeholder getta un’ombra 16 inquietante sull’applicabilità del principio di democratizzazione delle decisioni tecnoscientifiche; perlomeno nei casi – come questo – di rilievo sociale e politico di grande respiro, con numerosi e variegati interessi coinvolti, che richiedano una forte assunzione di responsabilità da parte di alcuni segmenti di popolazione, il cui senso – soprattutto – sia legato a questioni ideologiche.
È possibile che alcune di queste decisioni, il cui oggetto ha carattere tecnoscientifico ma che sono così strettamente legate al sociale e al politico, implicano in ogni caso lo scontento di qualcuno: devono quindi essere affrontate con un articolato processo di ascolto degli interessi e dei potenziali vincoli, ma devono poi per forza convergere in una presa di responsabilità, informata e trasparente, ad opera di chi governa super partes.
NOTE:



