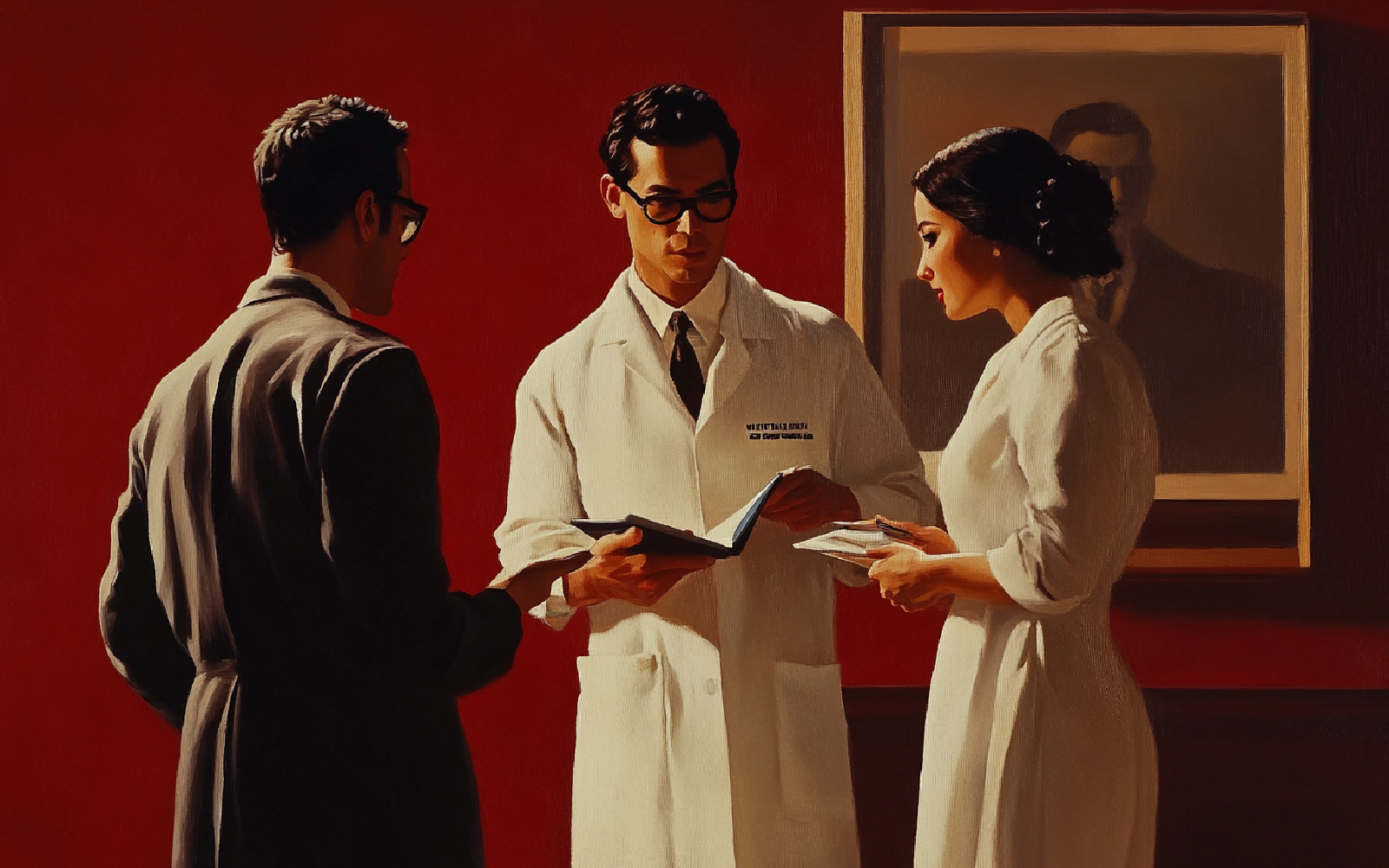La controversia sulla Commissione Vaccini in Italia e il suo contraltare in USA
Il 6 agosto scorso, il Ministro della Salute italiano - Orazio Schillaci – nomina i membri del Nitag (National Immunization Technical Advisory Group, in coerenza con quanto definito dalla Organizzazione Mondiale della Salute). Di fatto un organismo che sostituisce la commissione vaccini del Governo.
I membri del NITAG sono 22 (qui l’elenco dei nomi e la funzione dell’organismo); 17 sono laureati in medicina, 2 in scienze infermieristiche e ostetriche, 2 in biologia e 1 in sociologia; 11 insegnano o hanno insegnato in università, 12 ricoprono cariche pubbliche – dalle dirigenze di unità medico sanitarie locali e nazionali a incarichi all’Istituto Superiore della Sanità.
Tra questi, ci sono 2 medici – un pediatra e un patologo, entrambi che insegnano o hanno insegnato in università – che hanno espresso posizioni critiche nei confronti delle politiche vaccinali. Uno di loro è un pediatra ospedaliero, specializzato in pediatria preventiva e membro di una commissione vaccinale provinciale; l’altro è specializzato in ematologia, ha insegnato patologia generale all’Università di Verona, è autore di più di 100 pubblicazioni su PubMed, con 9767 citazioni e un indice h pari a 55.
Alla nomina nel NITAG di questi due membri con posizioni critiche sulla attuale politica vaccinale esplodono reazioni indignate e polemiche nella comunità medico-scientifica e tra i rappresentanti politici, sia di governo che di opposizione, reazioni riportate e amplificate dalla maggior parte dei media, che hanno definito i due medici No-vax e demonizzato la loro presenza nell’organismo deputato ad aiutare il governo nella definizione delle politiche vaccinali dei prossimi 4-5 anni.
In pochi giorni, un gruppo di scienziati raccoglie 34.000 firme di colleghi e – insieme ad alcune società medico-scientifiche e alla Federazione degli Ordini dei Medici (FNOMCeO) - chiedono le dimissioni dei due medici dalla commissione, perché inadeguati – sulla base dei loro curricula e delle loro pubblicazioni, dicono - a ricoprire il ruolo loro assegnato. Alcuni titolati e noti medici dichiarano che il loro indice di pubblicazioni è inferiore a quelle dei loro dottorandi.
Pochi giorni dopo, il Ministro Schillaci cancella le nomine e azzera la commissione NITAG.1
------
Di converso, negli Stati Uniti d’America, il 27 agosto, la responsabile dei Centri di Controllo della diffusione delle malattie (CDC), viene rimossa dal suo incarico perché critica nei confronti delle posizioni sui vaccini del Segretario alla Salute Robert Kennedy Jr. e perché si rifiuta di licenziare tre alti funzionari suoi collaboratori, “rei” di non condividere le opinioni di Kennedy sulle politiche vaccinali.
------
Ora, siamo certi di non poter giudicare il valore medico e scientifico dei due membri del NITAG di cui sono chieste le dimissioni2, ma possiamo sospettare che l’attacco rivolto alla loro adeguatezza scientifica sia strumentale e di copertura della tacitazione delle voci dissenzienti rispetto alle politiche dominanti.
Riteniamo, inoltre, che l’azzeramento delle nomine, fatto per evitare lo scandalo della presenza di due cosiddetti No-vax in commissione, sia un’occasione persa per disegnare una politica vaccinale che tenga conto anche di posizioni diverse da quelle dominanti.
Non per solo amore di pluralismo e di democrazia ma perché il confronto con posizioni che sono di rottura, di vero skandalon - inteso come inciampo, scomodità, ostacolo al percorso lineare - può stimolare riflessioni più profonde su come affrontare la salute pubblica, anche per garantire l’indipendenza dal sospetto di influenze commerciali sulle politiche di diffusione dei vaccini.
Lo stesso vale per il licenziamento – in America – della responsabile dei CDC: un’altra occasione persa, questa volta per la linea di Kennedy, di riflettere insieme agli oppositori.
È più facile asfaltarli, gli oppositori.
NOTE:
1 Ad oggi, la commissione NITAG italiana non è ancora stata nominata.
Robotica sociale assistiva: l’espansione della cura nell’era tecnologica
Negli ultimi ͏anni, il rapido pr͏ogresso ͏della tecnologia ha aperto nuove possibilità nel settor͏e clin͏ico e di assistenza, soprattut͏to per gli anziani. Tra le innovazioni più interess͏anti c’è la robotica sociale assisti͏va (SAR), una parte della͏ robotica c͏he si occupa͏ di fornire aiuto͏ em͏otivo, fisico e mentale alle persone più fragili. Alcuni studi hanno evidenziato il fatto che “la pandemia da Covid-19 ha spinto ad usare solu͏zioni͏ automatizzate”[1] , mostrando sia gli effetti positivi dei robot sociali sia le difficoltà nell’inser͏irli nella vita normale de͏gli utent͏i. ͏Le ricerche recenti mostrano risultati positivi sullo stato d’animo͏, su͏lla͏ diminuzione della so͏litud͏i͏ne e sulla qualità d͏ella vita delle persone anzia͏ne ma͏ inducono anche a interrogarsi sulla questione etica e psico͏logica. In relazione a questi aspetti si riflette sull'autoingann͏o e sul rischio di infantilizzazione dell’utente. In quest͏a situazione complessa e in continuo cambiamento, il nostro contributo intende esplorare come gli ͏italiani percepiscono l’introduzione dei SAR nel servizio d’assistenz͏a͏. Partendo dalle argomentazioni proposte dal͏la ricercatrice Nicoletta Massa e dalla sua pubblicazione riguardo la psicologia della salute[2], è interessante domandarsi quanto͏ siano note alla collettività le potenzialità dei SAR e in quale ottica verrebbero accolte, facendo riferimento in͏ modo particolare ag͏li aspetti m͏entali, c͏ulturali e so͏ciali che influenzano l'accettazione della robotic͏a assistiva. Per fare ciò abbiamo sottoposto un questionario online al fine di approfondire tali tematiche.
L’indagine nasce da alcuni interrogativi iniziali: come verrebbero accolti i SAR dalla popolazione generale del nostro paese? Potrebbe quest’ultima, nel prossimo futuro, trovarsi a beneficiarne? La nostra ricerca è stata orientata ad esaminare il livello di conoscenza, percezione e accettazione sociale verso la robotica sociale assistiva (SAR) nel contesto italiano. Nel mese di gennaio 2025, abbiamo proposto una serie di domande, sotto forma di questionario online da somministare ad un “campione di convenienza”, attraverso piattaforme social. L’indagine si è basata su precedenti ricerche nel campo delle tecnologie assistive e consiste in due tipologie di domande: quesiti a risposta multipla e scale Likert. Il questionario è stato diviso in quattro parti: dati demografici, familiarità con le tecnologie assistive, opinioni sull’uso dei SAR negli ambienti domestici e riflessioni etico-culturali. Il campione raggiunto è di 203 persone, la maggioranza dei rispondenti è nella fascia di età 18-24 anni (37%) con una prevalenza di rispondenti donne (66%). Benché il campione non sia rappresentativo della popolazione italiana nella sua interezza, l’indagine consente una prima esplorazione sulle impressioni riguardo i SAR, ponendo le basi per successivi approfondimenti.
Da un lato si riscontra una maggiore apertura dal punto di vista emotivo nel rapporto con la tecnologia, tanto che l’idea di avere un rapporto affettivo con un robot potrebbe non essere percepita come inverosimile. A livello personale, tuttavia, persiste un meccanismo psicologico: l’utente attribuisce un valore emotivo al comportamento del robot, nonostante quest’ultimo sia totalmente privo di tali caratteristiche umane[3].
Va in aggiunta contestualizzato il tema delle carenze diffuse, le quali stanno segnando il sistema lavorativo contemporaneo. Tale termine viene utilizzato nel contesto occupazionale, per fare riferimento a una carenza estesa e sistemica di competenze, risorse o personale adeguato, che non può che influenzare negativamente la produttività e l'efficienza. Le fonti hanno registrato mancanze significative per quanto riguarda le categorie di operatori sanitari a livello sub-nazionale. In questo insieme si includono i posti vacanti difficili da ricoprire e anche i bisogni sanitari insoddisfatti, segnalati dalla popolazione stessa.
Il caso italiano presenta un numero di infermieri per abitante inferiore alla media UE[4]. Questa situazione suggerisce un maggiore affidamento sui medici nell'erogazione dei servizi. La situazione si aggrava con la riduzione del personale medico e paramedico impiegato nel sistema sanitario nazionale[5], specialmente a fronte del trend di invecchiamento della popolazione e della richiesta crescente di cure e domande di assistenza medica[6]. In questo contesto questi strumenti potrebbero offrire un supporto concreto, se integrati correttamente.
Risulta opportuno, in primo luogo, affrontare alcune questioni aperte che vengono trattate nell’articolo[7] , come la self-deception (autoinganno),fenomeno che può essere analizzato come conseguenza di due ordini di fattori: uno di natura storico-contestuale e l’altro di natura individuale.
Gli intervistati hanno dimostrato la non conoscenza del nuovo strumento di robotica sociale assistiva, visto che il 75,9% dei rispondenti non aveva mai sentito parlare dei SAR. Nonostante la distanza iniziale dall’argomento, ciò non ne ha precluso il successivo interesse: le opinioni espresse non si traducono in un rifiuto netto, bensì in una posizione di scetticismo esplorativo. Il campione analizzato non si è dimostrato del tutto ostile alla novità. Ne è un esempio il fatto che quasi il 41% si dichiari incuriosito, pur restando perplesso, nel concepire un robot che sia in grado di interagire con persone anche nella sfera emotiva, mentre solo il 14% considera esplicitamente utile tale interazione. Inoltre, pur prevalendo una visione tradizionalista dell’assistenza, con il 66,5% che preferisce ancora le cure umane a quelle automatizzate, emerge una quota consistente (34%) che accetterebbe l’inserimento di un SAR in casa se accompagnato da una figura umana, specialmente se designata a mansioni più tecniche. Ciò indica in ogni caso che la tecnologia venga percepita più come supporto che come minaccia. Sebbene il 69% non ritenga possibile il successo di queste tecnologie nel nostro paese, una percentuale analoga (66,5%) riconosce che i SAR potrebbero essere efficacemente impiegati per monitorare la salute e avvisare i medici in caso di necessità. Dunque, a fronte della diffidenza culturale e affettiva, si afferma una concezione relativamente positiva, specialmente in ambiti in cui la presenza umana non sia sempre garantita. Questa ambivalenza rappresenta probabilmente l’aspetto più interessante dell’indagine: le persone si mostrano scettiche, ma non particolarmente ostili, quello che emerge infatti, è una forte curiosità.
Il timore non appare di tipo apocalittico ma è piuttosto legato a preoccupazioni etico-relazionali e affettive. È interessante considerare come, anziché preoccuparsi di una possibile diminuzione dell’impiego (aspetto ricorrente se si tratta di intelligenza artificiale e robotica nell’ambito lavorativo), il campione si sia concentrato piuttosto sulla mancanza di empatia da parte delle macchine, ritenuta un elemento imprescindibile del settore dell’assistenza sanitaria. In tale contesto lo scetticismo di molti potrebbe essere mitigato attraverso una maggiore informazione e consapevolezza, considerando che, la maggior parte delle mansioni svolte dai SAR non si limiterebbero soltanto ad aiutare i soggetti fragili, quanto il personale sanitario in primo luogo.
In base͏ ai͏ dati r͏a͏ccol͏ti e alle idee condivise, sembra emergere ch͏e l'arrivo dei robot sociali di assistenza sia un͏a sfida complessa ma forse rivoluzionaria per il ͏sis͏tema sanitario di ogg͏i. Il fatt͏o che mo͏lti sarebbero pro͏nti ad accettar͏e un SAR a casa sug͏gerisce una disponibil͏i͏tà all'in͏tegrazione; purché si mantenga un buon equilibrio tra tec͏nologia e umanità.
In sintesi, ciò che è emerso non è un rifiuto del progresso, bensì la richiesta che quest’ultimo venga integrato con attenzione, trasparenza e sensibilità. Se i SAR verranno inseriti non come sostituti, ma come alleati del lavoro umano, rispettando la dignità delle persone, potranno contribuire a riformare un sistema che ad oggi si ritrova spesso in difficoltà. Non si tratta di una sfida prettamente tecnica, ma anche culturale e politica.
In conclusione, l’accettazione sociale della robotica assistiva dipenderà dalla capacità di affrontare con consapevolezza quelle che sono le implicazioni psicologiche ed etiche di queste tecnologie.
Maggiore consapevolezza, una progettazione che punta ai bisogni del paziente ed una chiara regolamentazione d’uso vanno considerati come elementi decisivi al fine di garantire che i SAR possano realmente contribuire all’ideazione di un sistema di cura diverso, progressivamente più efficace ed equo.
NOTE:
[1] Massa N. (2022) Innovazioni in psicologia della salute: il contributo della Social Assistive Robotics. Tra opportunità terapeutiche e questioni aperte della robotica sociale. Psicologia della salute: quadrimestrale di psicologia e scienza della salute, 37(5), 267-286
[2] Ibidem
[3] OECD (2025), Prospettive economiche dell'OCSE, Rapporto intermedio, marzo 2025: Navigare in acque incerte, OECD Publishing, Paris
[4] Massa N. (2022) Innovazioni in psicologia della salute: il contributo della Social Assistive Robotics. Tra opportunità terapeutiche e questioni aperte della robotica sociale. Psicologia della salute: quadrimestrale di psicologia e scienza della salute, 37(5), 267-286
[5] Ibidem
[6] OECD (2025), Prospettive economiche dell'OCSE, Rapporto intermedio, marzo 2025: Navigare in acque incerte, OECD Publishing, Paris
[7] Ibidem
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
Massa N. (2022), Innovazioni in psicologia della salute: il contributo della Social Assistive Robotics : tra opportunità terapeutiche e questioni aperte della robotica sociale, in "Psicologia della salute: quadrimestrale di psicologia e scienze della salute: 3, 2022, Milano: Franco Angeli, 2022 , 1972-5167 - Casalini id: 5378331" - P. 14-27
OECD (2025), Prospettive economiche dell'OCSE, Rapporto intermedio, marzo 2025: Navigare in acque incerte, OECD Publishing, Paris
OECD/European Commission (2024), Health at a Glance: Europe 2024: State of Health in the EU Cycle, OECD Publishing, Paris
I disturbi neurologici funzionali: oltre il dualismo mente-corpo
I disturbi neurologici funzionali (o FND, dall'inglese Functional Neurological Disorders) rappresentano una delle condizioni mediche più affascinanti e complesse del panorama neurologico contemporaneo; caratterizzati da sintomi reali e invalidanti, non spiegati da alterazioni strutturali del sistema nervoso, costituiscono un caso di studio emblematico per comprendere l'intricata relazione tra mente e corpo.
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE CLINICHE
I disturbi neurologici funzionali sono definiti come condizioni causate da alterazioni nel funzionamento delle reti cerebrali piuttosto che da cambiamenti nella struttura del cervello stesso. Questa distinzione fondamentale è spesso illustrata attraverso l'analogia del computer: mentre in altre patologie neurologiche si osserva un danno all'"hardware" cerebrale (come la degenerazione dei neuroni nella substantia nigra nei Parkinsonismi), nei disturbi neurologici funzionali il problema risiede nel "software", ovvero nei “programmi” che regolano il funzionamento del sistema nervoso.
La sintomatologia dei disturbi neurologici funzionali è estremamente variegata e può comprendere debolezza o paralisi degli arti, disturbi del movimento come tremori e distonie, crisi epilettiche non epilettiche, problemi sensoriali, difficoltà del linguaggio, problemi visivi e uditivi, dolore cronico e alterazioni cognitive, interferendo notevolmente con la qualità di vita dei pazienti, dei loro caregiver e comportando una spesa notevole per il SSN; l’esordio può avvenire a qualsiasi età, sebbene sia più comune tra l'adolescenza e l'età adulta precoce, con una maggiore incidenza nel sesso femminile (in rapporto 3:1).
NEUROBIOLOGIA TRA FUNZIONE E STRUTTURA
Le neuroscienze hanno fornito evidenze crescenti che i disturbi neurologici funzionali non sono disturbi "immaginari" ma rappresentano condizioni neurobiologiche genuine con correlati neurali identificabili. In questo senso, appare straordinariamente attuale l’intuizione di Jean-Martin Charcot, che già alla fine del XIX secolo ipotizzava nei pazienti con isteria l’esistenza di una “lesione funzionale”, ovvero una disfunzione reale del sistema nervoso priva di una base strutturale visibile. Sebbene privo degli strumenti della neurologia moderna, Charcot riconobbe che l’assenza di una lesione anatomica non implicava l’inesistenza di un disturbo neurologico autentico - un’intuizione che trova oggi conferma nei dati neurobiologici contemporanei. Particolarmente significative sono le alterazioni osservate a carico del salience network, del default mode network e nelle connessioni tra aree cortico-limbiche e regioni motorie. Il salience network, composto principalmente dall'insula anteriore e dalla corteccia cingolata anteriore dorsale, è responsabile del rilevamento e del filtraggio degli stimoli rilevanti e della regolazione emotiva. Nei pazienti con disturbo neurologico funzionale, questo sistema mostra iperattivazione e connettività alterata con le aree motorie, suggerendo un'influenza eccessiva dei processi emotivi sul controllo motorio. Il default mode network, attivo durante il riposo cosciente e coinvolto nei processi di auto-riferimento e nella costruzione del senso di sé, presenta anch'esso alterazioni in questi pazienti. Queste modificazioni potrebbero riflettere disturbi nei processi di integrazione dell'esperienza soggettiva e nella percezione di agency, ovvero nella sensazione di controllo sulle proprie azioni.
I DISTURBI NEUROLOGICI FUNZIONALI COME PARADIGMA DEL RAPPORTO MENTE-CORPO
Storicamente, l’approccio cartesiano alla medicina ha portato a una netta distinzione tra cause organiche e psicogene, relegando i disturbi neurologici funzionali nell’ambito delle patologie “senza base organica”. Tuttavia, le evidenze attuali dimostrano che questa dicotomia è riduttiva: gli stati mentali, come lo stress, il trauma o i conflitti emotivi, possono indurre alterazioni misurabili nei circuiti cerebrali, nei pattern di attivazione neuronale e nei processi di integrazione sensomotoria, senza che vi sia necessariamente un danno strutturale rilevabile con le tecniche diagnostiche convenzionali.
La definizione storica di “disturbo di conversione” o “di somatizzazione” per quelli che oggi chiamiamo disturbi neurologici funzionali, radicata nella teoria freudiana della conversione di conflitti psichici in sintomi somatici, rifletteva una comprensione limitata e spesso stigmatizzante della condizione. Oggi, la ricerca riconosce che questi disturbi non sono semplicemente manifestazioni di conflitti inconsci, ma il risultato di una complessa interazione tra vulnerabilità biologiche (come predisposizioni genetiche o alterazioni neurochimiche), fattori psicologici (traumi, stili di coping, attenzione selettiva ai sintomi) e contesti sociali (stress ambientali, dinamiche familiari, influenze culturali).
L’approccio attuale è quindi multidisciplinare e integrato: la diagnosi si basa su criteri clinici positivi e segni neurologici specifici, mentre il trattamento prevede interventi personalizzati che possono includere la riabilitazione neurologica, la psicoterapia e, quando necessario, il supporto farmacologico. Questa visione supera la dicotomia cartesiana, promuovendo una comprensione più ampia e meno stigmatizzante della malattia, e sottolinea l’importanza di un approccio empatico e collaborativo nella gestione dei pazienti con disturbo neurologico funzionale.
CONCLUSIONI
I disturbi neurologici funzionali costituiscono un caso emblematico della complessità del rapporto mente-corpo, rivelando quanto siano ormai inadeguate le dicotomie tradizionali della medicina occidentale per spiegare la natura (che è invece profondamente integrata) dell’essere umano. Lungi dall’essere semplici anomalie “psicogene”, si impongono oggi come una sfida cruciale per la medicina contemporanea: non solo per la loro eterogeneità clinica e l’impatto sulla qualità di vita, ma soprattutto per l’opportunità epistemologica che rappresentano.
La moderna comprensione di questa condizione così fraintesa in passato, alimentata dai progressi delle neuroscienze, offre una finestra privilegiata per indagare i meccanismi attraverso cui l’esperienza soggettiva si incarna nel corpo e nel cervello, mostrando come stati mentali complessi possano influenzare direttamente il funzionamento dei network cerebrali. In tal senso, i disturbi neurologici funzionali mettono in discussione le rigide separazioni tra neurologia e psichiatria, tra cause organiche e fattori psicologici. L’evoluzione della ricerca scientifica, insieme a una crescente sensibilità clinica, sta gradualmente restituendo legittimità e riconoscimento a una condizione per troppo tempo relegata ai margini del sapere medico. Questa condizione ci obbliga a ricordare che mente e cervello non sono domini separati, ma aspetti interdipendenti di una stessa realtà incarnata, e ci sollecitano a ripensare profondamente non solo le categorie diagnostiche, ma anche il modo in cui intendiamo la cura.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Aybek, S., & Perez, D. L. (2022). Diagnosis and management of functional neurological disorder. BMJ, o64. https://doi.org/10.1136/bmj.o64
Baek, K., Doñamayor, N., Morris, L. S., Strelchuk, D., Mitchell, S., Mikheenko, Y., Yeoh, S. Y., Phillips, W., Zandi, M., Jenaway, A., Walsh, C., & Voon, V. (2017). Impaired awareness of motor intention in functional neurological disorder: Implications for voluntary and functional movement. Psychological Medicine, 47(9), 1624–1636. https://doi.org/10.1017/S0033291717000071
Edwards, M. J., Yogarajah, M., & Stone, J. (2023). Why functional neurological disorder is not feigning or malingering. Nature Reviews Neurology, 19(4), 246–256. https://doi.org/10.1038/s41582-022-00765-z
Hallett, M., Aybek, S., Dworetzky, B. A., McWhirter, L., Staab, J. P., & Stone, J. (2022). Functional neurological disorder: New subtypes and shared mechanisms. The Lancet Neurology, 21(6), 537–550. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(21)00422-1
Voon, V., Brezing, C., Gallea, C., & Hallett, M. (2011). Aberrant supplementary motor complex and limbic activity during motor preparation in motor conversion disorder. Movement Disorders, 26(13), 2396–2403. https://doi.org/10.1002/mds.23890
Dopo tre anni di trattative, l’Oms ha approvato il primo Piano pandemico globale
Quasi un anno fa, su questa rivista avevamo parlato del Piano pandemico globale, sollevando non poche critiche. In questi giorni, dopo tre anni di negoziazioni, il piano è stato approvato. I voti a favore sono stati 124, mentre 11 i Paesi si sono astenuti: Italia, Russia, Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacchia, Giamaica, Guatemala, Paraguay, Israele e Iran. Nessuno contrario.
Due le considerazioni. In primo luogo, il testo ha perso l’impostazione iniziale che appariva fortemente “dirigista”. Le sovranità nazionali non sembrano più surclassate perché è specificato che l’Oms non sarà autorizzato né a prescrivere leggi nazionali né a incaricare gli Stati di intraprendere azioni specifiche come vietare i viaggi, imporre blocchi o vaccinazioni e misure terapeutiche. Per il segretario generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, il piano «è una garanzia che si possa proteggere meglio il mondo da future pandemie. Ed è anche un riconoscimento da parte della comunità internazionale che i nostri cittadini, le nostre società e le nostre economie non devono subire nuovamente perdite come quelle subite durante il Covid 19».
Seconda considerazione: la porta Oms non è del tutto chiusa per nessuno. Il Piano pandemico verrà inviato a tutti i 60 Stati membri per essere ratificato dai Parlamenti, e sarà allora che il “sì” o il “no” dei singoli Stati diventerà definitivo.
Il fatto che l’Italia non abbia votato il Piano è stato visto come un segnale forte; per chi, in Italia, ritiene che il governo italiano abbia fatto bene, dovrà vigilare affinché questa posizione venga mantenuta quando il Parlamento sarà chiamato a esprimersi. Va detto che il trattato entrerà in vigore, a livello internazionale, solo per i Paesi che lo ratificano.
Quali sono le perplessità? I tempi sembrano allungarsi ancora – si ipotizza fino a marzo 2026 - perché il Piano potrà essere votato soltanto quando sarà ultimato in ogni suo allegato e al momento manca quello dedicato alla trasmissione dei patogeni (che riguarda cioè le misure di sicurezza per i laboratori che isolano batteri o virus).
A preoccupare chi dovrebbe sentirsi rassicurato dal linguaggio ammorbidito di Ghebreyesus, c’è però il Regolamento sanitario approvato dall’Oms il 1° giugno scorso: un testo che ha la volontà di censurare qualsiasi informazione considerata come non-informazione e che surclasserebbe le leggi nazionali. I Paesi hanno tempo fino al 19 luglio per respingerlo, inviando una lettera (in questo caso varrebbe il Regolamento sanitario precedente del 2015) altrimenti entrerà in vigore di default.
Coltivare la vita in laboratorio - Come siamo arrivati a intendere la materia vivente come tecnologia
Pensando al lavoro di scienziati o biologi in laboratorio non ci risulta strana la possibilità che questi possano essere impegnati nella coltivazione di cellule o linee cellulari provenienti da vari organismi viventi. Ad esempio, attualmente le cellule che provengono da esseri umani sono ampiamente utilizzate nei laboratori e in programmi di ricerca biomedica, così come rivestono un ruolo centrale nella ricerca farmaceutica. In breve, la possibilità di mantenere in vita cellule e tessuti umani al di fuori del corpo e di usarle come una materia tecnologica è qualcosa che accade di routine, è ritenuto normale e non desta alcun particolare senso di straniamento. Tuttavia, com’è possibile questo? Quando siamo arrivati a pensare la vita al di fuori del corpo come qualcosa di normale e non problematico? E in quale momento la vita e le cellule hanno assunto questa particolare forma tecnologica? Questi sono alcuni degli interrogativi da cui parte anche Hannah Landecker (2007), sociologa e storica della scienza, nel ricostruire la storia della coltura dei tessuti. Tali questioni ci possono aiutare a focalizzare l’attenzione su alcune delle condizioni che hanno permesso la costruzione di infrastruttura in cui è stato possibile standardizzare metodi, tecniche e oggetti sperimentali impiegati nella coltura cellulare.
Un evento da cui iniziare può essere rintracciato nel 1907, quando Ross Harrison, a partire dal tessuto embrionale di una rana, riuscì ad osservare la crescita di una fibra nervosa al di fuori del corpo. In quegli anni era in corso un vivace dibattito scientifico sulla natura e sviluppo delle fibre nervose a cui risultava difficile trovare una soluzione con le tecniche e i metodi sperimentali impiegati. Infatti, gli scienziati si affidavano principalmente a tecniche istologiche, le quali consistevano nell’acquisizione di sezioni del corpo di un animale in diverse fasi nel tempo, per cui era necessario sacrificare vari animali in diversi momenti per osservare degli sviluppi tissutali. I tessuti ottenuti in questo modo erano resi adeguati alla conservazione e all’analisi attraverso sostanze fissative e coloranti, e in questo modo fornivano dei modelli statici di momenti precisi dello sviluppo. Nonostante ciò, con queste tecniche istologiche non era possibile trovare una risposta sostanziale allo sviluppo delle fibre nervose: gli scienziati potevano dare delle interpretazioni opposte dello stesso frammento di tessuto reso in forma statica. Harrison risolse questa controversia cercando di rendere visibile, al di fuori del corpo, il processo di sviluppo di una fibra nervosa mentre avveniva. Partendo da nozioni di coltura dei microrganismi, egli riuscì a realizzare una preparazione a “goccia sospesa” (hanging-drop) che forniva un supporto attraverso della linfa coagulata per far crescere le fibre nervose di rana al di fuori del corpo. In questo modo, Harrison utilizzando delle cellule vive risolse il problema di come gli organismi biologici viventi cambiano nel tempo e rese visibili i processi che erano interni al corpo degli animali. È in questo senso che all’inizio del XX secolo inizia ad emergere la possibilità e l’idea di sperimentazione in vitro e non più solo in vivo.
Qualche anno più tardi Alexis Carrel e il suo assistente Montrose Burrows tentarono di sviluppare le tecniche adottate da Harrison nel tentativo di mantenere in vita le cellule al di fuori del corpo. Carrel e Burrows trasformarono “il metodo di Harrison per la crescita a breve termine di un tessuto embrionale in un metodo generalizzato per la coltivazione di tutti i tipi di tessuto” (Landecker 2007, p.53) e nel 1910 coniarono il termine “coltura tissutale” per riferirsi a questa serie di operazioni. In particolare, Carrel e Burrows cercarono di mantenere in vita le cellule attraverso la creazione di colture secondarie a partire da un frammento di tessuto: spostando una parte delle cellule in un nuovo medium plasmatico si generava una sorta di riattivazione cellulare e queste continuavano a vivere. Tuttavia, con questa tecnica le cellule cessavano di aumentare di massa e diventavano più piccole ad ogni trasferimento, per cui la soluzione tecnica che adottò Carrel fu quella di aggiungere del tessuto embrionale macinato – chiamato “succo embrionale” – per nutrire le cellule. Fu in questo contesto che Carrel affermò la possibilità di poter coltivare delle “cellule immortali”, che potevano vivere in maniera indefinita al di fuori del corpo. Infatti, per Carrel la morte cellulare era un “fenomeno contingente” che poteva essere rimandato attraverso la manipolazione del medium plasmatico e le sostanze in cui era immersa la cellula. Per questa ragione, Carrel brevettò una fiaschetta, nota come “Carrel flask”, che gli permise di coltivare le cellule in modo asettico evitando infezioni e manipolando le sostanze in cui erano immerse le cellule in modo controllato. Tuttavia, va precisato che negli anni ’60 si dimostrò che le uniche cellule che potevano essere tecnicamente immortali erano quelle di origine cancerosa.
È attraverso le pratiche sperimentali di Harrison e Carrel che inizia ad emergere una nuova enfasi sul corpo e sulla possibilità di coltivare delle cellule in vitro. All’inizio del XX secolo non era nuova la possibilità di tenere i tessuti al di fuori del corpo per un po’ di tempo, ma in quel contesto il corpo era concepito come l’elemento essenziale che garantiva la vita delle cellule, le quali non avrebbero potuto sopravvivere al di fuori di esso. Le pratiche sperimentali di Harrison e Carrel segnano un passaggio all’idea che le cellule e i tessuti non solo possono sopravvivere al di fuori del corpo, ma continuano a dividersi, differenziarsi e vivere. In questo senso, inizia ad emergere un senso di possibilità legato al fatto che le cellule possono vivere con una certa autonomia anche se staccate dal corpo.
È tra gli anni ’40 e ’50 con la campagna contro il virus della poliomielite che, attraverso una serie di sforzi infrastrutturali, fu reso possibile l’impiego per la prima volta di tessuti umani su larga scala: in precedenza ciò non era possibile e le cellule venivano coltivate in singoli laboratori senza la possibilità di scambi e trasferimenti. Nella prima metà del XX secolo i virus erano molto difficili da osservare e coltivare: venivano conservati in laboratorio facendoli passare attraverso uova ed animali infetti; ciò era un metodo molto complesso e costoso. Per questa ragione nel 1940 John Enders pensò di utilizzare i metodi di coltura tissutale per osservare lo sviluppo delle infezioni virali. In questo modo, Enders e il suo collega Weller svilupparono un modello cellulare per osservare il lento sviluppo nel tempo del virus della parotite, questo si rivelò poi anche utile per studiare la poliomielite. Pertanto, attraverso la coltura dei tessuti è diventato possibile osservare lo sviluppo delle infezioni virali osservando i cambiamenti cellulari invece che guardare i sintomi che si manifestavano negli animali infetti. In seguito, nel 1954 John Salk attraverso l’impiego di queste tecniche di coltura cellulare riuscì a realizzare un vaccino contro la poliomielite.
Va sottolineato che ciò che Enders e Salk riuscirono a fare va inserito in uno sforzo più ampio della comunità scientifica a partire dagli anni ’40 che ha permesso il miglioramento delle tecniche di coltura tissutale e la loro standardizzazione. In particolare, in quegli anni organizzazioni come la Tissue Culture Association (TCA) e la National Foundation for Infantile Paralysis (NFIP) si impegnarono nel tentativo di standardizzare e rendere disponibile alla comunità scientifica materiali e tecniche per la coltura cellulare: vennero organizzati convegni e in breve tempo diventò possibile acquistare terreni ed estratti con cui far crescere le cellule. Fu anche grazie a questo lavoro coordinato che fu possibile utilizzare la linea cellulare immortale HeLa come materiale standard per il test del vaccino contro la poliomielite in diversi laboratori. HeLa era stata stabilita da George Gey nel 1951 grazie alla biopsia di una massa tumorale prelevata da Henrietta Lacks, la quale si era recata in ospedale per ricevere assistenza e non sapeva come sarebbe stato impiegato il tessuto prelevato (Skloot 2010). Al termine della campagna contro la poliomielite HeLa era ampiamente diffusa nei laboratori e gli scienziati iniziarono ad utilizzarla per gli scopi di ricerca più disparati, generando così un’ampia mole di studi e pubblicazioni. Dunque, se in precedenza era possibile lavorare su oggetti dello stesso tipo – lo stesso tipo di topo o lo stesso tipo di tumore – attraverso HeLa diventò possibile lavorare sulla “stessa cosa” in tempi e luoghi diversi. Pertanto, è in questa cornice che i tessuti umani sono diventati così una base standard e un modello per la ricerca biomedica.
Secondo Landecker questa storia ci racconta di come la biotecnologia dal 1900 ad oggi si associ ai “crescenti tentativi di esplorare e realizzare la plasticità della materia vivente” (Landecker 2007, p. 232). Nello specifico, la plasticità riguarda la capacità della materia vivente di essere modificata dagli esseri umani, la quale continuando a vivere può reagire all’intervento anche in modi inaspettati. Inevitabilmente, in questo racconto la plasticità si associa al tentativo di rendere operativo il tempo biologico attraverso una manipolazione della cellula, del medium e delle sostanze in cui questa è immersa. In breve, questa storia ci può aiutare a comprendere il modo attraverso cui siamo arrivati alla concezione odierna di “vita come tecnologia”; ovvero, la possibilità di utilizzare le cellule come una forma tecnologica per interventi terapeutici, sviluppi farmaceutici e per l’industria alimentare. In secondo luogo, questo resoconto permette di evidenziare alcune delle condizioni attraverso cui è stato possibile costruire un’infrastruttura con cui poter mantenere stabilmente le cellule in laboratorio. Infatti, uno scienziato tende a dare per scontata l’idea che sia possibile coltivare delle cellule in laboratorio proprio perché nel tempo è stata sviluppata un’infrastruttura funzionale, e che per questo motivo tende a risultare “invisibile” (Star 1999). In tal senso, ripercorrere gli sviluppi della coltura tissutale permette di portare alla luce gli aspetti infrastrutturali e tecnici che invece rimarrebbero opachi nello sfondo.
BIBLIOGRAFIA
Landecker H. (2007). Culturing Life: how cells become technologies. Harvard University Press, Cambridge.
Skloot R. (2010). La vita immortale di Herietta Lacks. Adelphi, Milano.
Star S.L. (1999). The ethnography of infrastructure. American behavioral scientist, 43(3), 377-391.
Sanare una controversia - Il dissidio tra Basaglia e Tobino
Tra le pubblicazioni dello speciale Basaglia pubblicate su questa rivista, risalta l’articolo di Gianluca Fuser che ha saputo fare controversia nella controversia parlando di Mario Tobino, grazie a un’approfondita lettura degli archivi della Fondazione Tobino. Vorrei con questo articolo porre in risalto una questione che sposta il focus della controversia, cercando di suggerire un modo per ricomporla prendendo in considerazioni elementi diversi storici e sociali.
Centrale nell’articolo di Fuser è l’impossibilità di conciliare la controversia nei seguenti punti:
«Tobino, seppure non escluda del tutto l’origine sociale, ha una visione organica, fisiologica della follia, e accusa Basaglia di credere che la chiusura dei manicomi cancelli ogni traccia della follia. Basaglia, infatti, la nega e nello stesso tempo, ne attribuisce la creazione alla società malata, al potere, per rinchiudere i disallineati, i disturbatori dell’ordine e dello sfruttamento.»[1]
«Altro punto di dissidio insanabile è il tema della presenza e della forma delle strutture di cura, che coinvolge anche la visione politica delle due posizioni: Tobino non prescinde dalla necessità di un luogo dove i matti possano trovare – per periodi lunghi o brevi, più o meno volontariamente, in modo comunque aperto – riparo, protezione, cura e tranquillità; e sottolinea l’assenza di preparazione dei territori, della popolazione e delle famiglie per la trasformazione dalle strutture accentrate a quelle diffuse; Basaglia, al contrario, non transige, insiste sulla necessità di distruggere l’istituzione manicomiale e ribadisce la necessità della riforma, da farsi subito, in nome della «crescita politica, e quindi civile e culturale del paese».»[2]
Ora, mi chiedo se davvero questi punti siano insanabili. Non è mia intenzione conciliare due persone che chiaramente non andavano d’accordo in quel momento e su quell’argomento. La controversia c’è stata. Se la differenza evidenziata da Fuser può essere sanata, significa soltanto che l’oggetto del contendere è da cercare altrove.
Riguardo alla forma e alla presenza delle struttura di cura, Tobino parla di un luogo dove la persona possa avere riparo, protezione, cura e tranquillità, e non vedo come questo luogo possa essere associato al manicomio basagliano, luogo di repressione, controllo e emarginazione. Se penso a Gorizia, ma anche alle diverse applicazioni della legge 180 – alcune raccontate nello stesso speciale su Controversie[3] – è innegabile la presenza di un punto di raccolta del malato, punto in cui la società lo raccoglie e egli stesso si raccoglie. Un luogo in cui ripararsi dopo una crisi sopravvenuta e cercare una normalità.
Tobino ribadisce,[4] giustamente, che Lucca era già un posto così ma non può dire lo stesso del resto d’Italia. Così, anche Basaglia ha realizzato l’esperimento di Gorizia prima e senza la legge 180 e continua nondimeno a ritenere necessaria l’abolizione del manicomio. Siamo di fronte ad una ambiguità del manicomio? Da un lato, c’è la pretesa oggettività della struttura manicomio come un certo luogo costruito in un certo definito modo con l’obiettivo di una determinata funzione. Dall’altro, invece, troviamo il significato sociale che ognuna di queste strutture porta con sé, in termini di violenza o di carità delle istituzioni. Significati e strutture che formano i luoghi, a partire dalla scelta di come disporre stanze, corridoi, finestre, fino alla formazione degli stessi operatori sanitari.
Sembra che sia Tobino che Basaglia siano ben consapevoli di questo ed entrambi hanno lavorato per contrastare strutture e pratiche che conservano il segno della storia di violenza dell’istituzione manicomiale. La frattura avviene sulla legge e, fino a qui, nulla di nuovo. Ci torno a breve, vorrei, prima, coinvolgere nel discorso anche il primo dei punti inconciliabili indicati da Fuser.
Che cosa si intende con il fatto che Tobino abbia una visione organica, fisiologica e Basaglia no? Che Tobino non consideri il ruolo dei determinanti sociali nella malattia – per quanto non li escluda – e invece Basaglia riconduca la malattia solo a quelli?
Tobino sembrerebbe distinguersi per una visione realista della malattia. “Dolorosa follia, ho udito la tua voce” è il racconto di una follia che esiste per sé stessa. Non è questione di quanto sia organica, perché proprio i racconti di Tobino sono descrizioni di comportamenti che risultano patologici proprio per la sofferenza a stare in un contesto sociale che diremmo normale. L’uomo che graffia i volti degli altri pazienti, nel racconto di Tobino, non dice esplicitamente “sto soffrendo”, ma noi comprendiamo la sua impossibilità di vivere, appunto, nel mondo normale. Tobino con coraggio risponde alla prima questione pratica della cura: il fatto è che le cose sono andate così, adesso sono malato e in qualche modo è da qui che si deve partire.
Basaglia allora è diverso? Non molto a mio parere. Egli non nega la realtà della malattia, ma si concentra sulla diversità, sul fatto che ogni variazione dalla norma è una diversa norma possibile. Non credo che si possa vedere - nel tentativo di modificare l’ambiente del malato (distruggere i muri) - un’omissione della realtà della malattia. Basaglia aveva visto una possibilità. Quella che alcune condizioni di sofferenza trovassero un nuovo senso.
Non sbaglia, Basaglia, quando afferma questa possibilità. Lo abbiamo visto nei tanti tentativi che hanno avuto successo. Sbaglia, invece, quando nega il significato pratico della «carità continua», pratica della quale Tobino spiega per bene il significato: «se il malato pulito, vestito, lì seduto, di nuovo si risporca, perde le urine, scendono le feci, noi si ricomincia da capo, per riportarlo al suo precedente aspetto». Penso sia innegabile che la speranza data da Basaglia, di una vita diversa nella società con gli altri, sia anche di nuovo possibilità di fallimento e in alcuni casi si trasformi nella falsa speranza che noi o quel nostro parente non sia quello che è.
Sono, quindi, due facce dello stesso discorso su salute e malattia. Se le guardiamo dal lato della persona che viene curata, Basaglia è la speranza di guarire ancora,Tobino la forza di salvarsi ancora un giorno. Abolito il manicomio, la persona malata trova un nuovo senso e prospera. Nel manicomio, la persona malata vive al riparo da un mondo che lo ferisce. Abolito il manicomio il malato che non trova una strada muore. Nel manicomio che lo cura, il malato vive costretto in un’unica vita possibile.
A produrre la nostra salute sono i rapporti tra organismo e ambiente, dove il primo comprende la sua personale storia non solo come determinanti, ma anche come biografia e autobiografia, mentre il secondo comprende l’inscindibile nesso tra la disposizione “materiale” dell’ambiente e i valori che lo costruiscono e strutturano. Il primo e il secondo punto di questa controversia rispondono a quella divisione tra interno e esterno, tra soggetto e mondo. Quell’ambiguità della salute che da un lato si descrive oggettivamente e dall’altro non può fare a meno di riferirsi a un soggetto che dice di se stesso di essere in salute, o in malattia.[5]
Eppure, la controversia c’è stata! Vedo due possibilità (e sicuro ce ne sono altre) per ricomporre la controversia come tale. La prima è che la morale che sottende le antropologie di Basaglia e Tobino sia in realtà molto diversa e che si rifletta nella realtà pratica delle scelte. La seconda (ed è quella che personalmente più mi interessa) è che questi Basaglia e Tobino simbolici fossero strumenti del discorso politico e culturale che faceva leva (allora come oggi) sull’autorità dei due scienziati. Consapevoli nella misura in cui era dato loro modo di ribadire la possibilità di una vita diversa, fosse essa segnata dalla quotidiana carità continua o dall’aiuto per tornare nel mondo degli altri. Inconsapevoli però del fatto che a parlare per il loro tramite sia stata ancora la voce della normalizzazione, la violenza dell’istituzione che schiaccia nella malattia (Tobino) o che distrugge nell’afflato positivista di ricondurre ogni diversità a alla norma (Basaglia). La stessa verità dei discorsi dei due scienziati è poco importante se non comprendiamo come queste verità siano state tradotte dalle forze sociali del tempo e quali elementi effettivamente abbiano concorso a comporre questa controversia.
NOTE
[1]Fuser, G., 2024, Controcanto, https://www.controversie.blog/controcanto-tobino/
[2]Fuser, G., 2024, Controcanto, https://www.controversie.blog/controcanto-tobino/\
[3]Si veda l’intervista di L. Pentimalli alla dott.sa Bricchetti [https://www.controversie.blog/raffaella-bricchetti/] così come la mia intervista al dott. Iraci [https://www.controversie.blog/rete-psichiatrica-sul-territorio-intervista-a-uno-psichiatra-che-attuava-la-legge-180/]
[4]M. Tobino, Dolorosa follia, ho udito la tua voce, La Nazione 7 maggio 1978.
[5]Su questo si veda G. Canguilhem, “La salute: concetto volgare” in G. Canguilhem, Sulla medicina. Scritti 1955-1989, tr. it. di D. Tarizzo, Einaudi, Torino 2007.
Stabilizzare il farmaco, stabilizzare la biomedicina - Reciproche catture tra medici e vaccini
“Se l’instabilità del pharmakon non è un nostro problema, quel che sembra distinguerci al contrario […] è l’intolleranza della nostra tradizione di fronte a questo tipo di situazione ambigua e l’angoscia che suscita. È necessario un punto fermo, un fondamento, una garanzia. È necessaria una differenza stabile tra il medicamento benefico e la droga malefica, tra la pedagogia razionale e il condizionamento suggestivo, tra la ragione e l’opinione” (Stengers, 2005: 40-41)
Se volessimo analizzare la farmacovigilanza tenendo in considerazione le parole di Stengers qui in epigrafe, potremmo ritenerla uno strumento volto a stabilizzare farmaci: distinguere vantaggi e pericoli sembra essere obiettivo precipuo di questa pratica. Ciò è ancor più evidente se ci riferiamo alla vaccinovigilanza. Scindere ciò che è benefico da ciò che risulta dannoso appare particolarmente opportuno nel caso dei vaccini: anche i documenti ufficiali rilevano che, in questo caso, “poiché la popolazione target è rappresentata prevalentemente da soggetti sani, per la maggior parte di età pediatrica, il livello accettabile di rischio è inferiore a quello degli altri prodotti medicinali. […] Queste peculiarità dei vaccini rendono necessarie attività di farmacovigilanza post-marketing che vadano oltre quelle routinarie, al fine di monitorare e valutare adeguatamente gli eventuali rischi” (AIFA, 2017:4). Tuttavia, nonostante i vaccini siano considerati tra i prodotti più controllati nel panorama farmacologico, abbiamo già avuto modo di esplorare come le pratiche di vaccinovigilanza siano dispositivi socio-culturali complessi (Lesmo, 2025).
Di fatto, i dubbi in merito a possibili correlazioni causali tra alcuni vaccini e determinati eventi avversi sembrano affiorare tra i professionisti. Nel corso della ricerca etnografica da me condotta sul tema tra il 2017 e il 2021, è emerso come diversi medici abbiano preso in considerazione in più occasioni questa ipotesi. Ciò è stato rilevato in vario modo. Non solo alcuni di essi hanno suggerito ai genitori di bambini con possibile danno da vaccino l’ipotesi di una correlazione, per poi spesso negarla dopo poco (secondo quanto i genitori mi hanno riferito). La presenza di simili “dubbi” è stata poi esplicitata direttamente da alcuni medici da me intervistati, che ne hanno approfondito criticità e problematiche durante i colloqui. Oltre a queste testimonianze di prima mano, alcuni libri, pubblicazioni e lettere scritte da medici specialisti hanno proposto pubblicamente di re-interrogare la sicurezza e/o l’efficacia delle pratiche vaccinali in corso. Alcuni tra questi professionisti sono stati in seguito interpellati, richiamati, sospesi o finanche radiati dai rispettivi ordini, evidenziando una zona di tensione particolarmente evidente che intercorre tra il sapere vaccinale e la pratica medico-clinica. È dunque estremamente rilevante interrogare la relazione complessa che lega vaccinazioni, pratica biomedica e professionisti della cura. Come si costruiscono vicendevolmente questi rapporti? Quali obiettivi, più o meno consapevoli, essi si prefiggono?
“UNKNOWN KNOWNS”: CONOSCENZE SCONOSCIUTE
Bisogna però dire che attualmente le indicazioni della medicina occidentale accademica hanno una tendenza a non mettere in correlazione patologie avverse con la vaccinazione, proprio perché la tendenza è quella di dare un valore solo positivo alla vaccinazione escludendo tutti gli elementi negativi.
Questo è quanto afferma un medico da me intervistato quando riflettiamo insieme sul rapporto rischio/benefici associati ai vaccini. L’esclusione di alcuni elementi dalle pratiche di costruzione del sapere è un elemento intrinseco ad ogni epistemologia. Se già Foucault (2004) aveva illustrato come molteplici procedure di esclusione agissero nel dare consistenza a un discorso, conferendogli uno statuto di verità attraverso interdetti, evitamenti ed elisioni, questi temi sono stati ri-articolati successivamente da molti altri studiosi. Tra questi, l’antropologo Michael Taussig si è riferito al “lavoro del negativo” per evidenziare come “sapere che cosa non sapere” sia un passaggio fondamentale in molti processi socio-culturali oltre che epistemologici. Secondo quanto osserva Taussig, il “lavoro del negativo” nei singoli contesti di riferimento è così profondo che “pur riconoscendolo, pur nello sforzo di liberarci dal suo abbraccio vischioso cadiamo in trappole ancora più insidiose che ci siamo autocostruiti” (Taussig, 1999:6). Difficile è dunque acquisire consapevolezza in merito a talune esperienze note eppur sottese, che a volte fondano vere e proprie imprese epistemiche e sociali. Geissler, antropologo sociale, ha ripreso nei suoi studi il concetto ossimorico di “conoscenze sconosciute” [“unkwnown knowns”] (Geissler, 2013: 13) per evidenziare quanto queste possano talvolta aprire la strada a determinate pratiche di ricerca e/o di cura: il confine tra sapere e non-sapere risulta così estremamente labile.
Anche in ambito vaccinale sembra che alcune esperienze vengano talvolta “espulse” dall’orizzonte conoscitivo - quasi sulla soglia della consapevolezza - per rendere le pratiche di immunizzazione possibili. Una pediatra intervistata, con cui riflettiamo sulle posizioni discordanti sul tema in ambito biomedico, mi spiega:
Allora, ci sono secondo me alcuni vaccini su cui… effettivamente ci può essere una discussione, perché effettivamente non mettono a rischio la società, no? Ci sono dei vaccini invece per cui questa cosa qua si mette a maggior rischio e allora… […] Ci sono dei caposaldi che… che secondo me sono intoccabili.
In questo frammento di discussione, parte di uno scambio molto lungo e articolato, la pediatra evidenzia come certi dubbi non possano essere sollevati – a meno che non siano già sostanziati da studi scientifici solidi ed epidemiologicamente fondati. I dubbi così sommersi - questi sospetti silenziati - sembrano in qualche misura concretarsi anche nell’eliminazione simbolica, operata attraverso sanzioni disciplinari di vario genere, dei medici che tentano di palesarli. Quando interpellata in merito a tali sanzioni, un’altra pediatra intervistata ha ribadito come ciò fosse indispensabile, e finanche rassicurante, poiché la vaccinazione “è la base della medicina moderna” e “se un medico non crede ai vaccini, soprattutto un pediatra – e soprattutto alle vaccinazioni pediatriche… forse ha sbagliato campo”.
STABILIZZARE IL SAPERE BIOMEDICO
Per molti professionisti della cura, dunque, la fiducia nella vaccinazione sembra essere precondizione della stessa professione medica. Ciò è stato spesso attribuito al particolare statuto che le vaccinazioni risultano avere in biomedicina: per riprendere le espressioni qui proposte, esse sarebbero un “caposaldo”, se non “la base della medicina stessa”. Sembra così adeguato riprendere quanto asserito da Isabelle Stengers (2005) in relazione alla stabilizzazione di un sapere, che si intreccia saldamente con ciò che la studiosa definisce “reciproca cattura”, o “inter-presa”. La “reciproca cattura” è quel legame che vincola due entità attraverso la creazione di un valore reciproco. Secondo Stengers, tale cattura si attiva nel momento in cui due identità si costruiscono e si legittimano vicendevolmente. In questo caso il ruolo del medico sembra consolidarsi anche in base alle considerazioni che egli associa ai vaccini: sostenere sicurezza ed efficacia delle vaccinazioni in uso – “credere” nei vaccini come asserito più sopra – dimostra la competenza e la credibilità dei professionisti. Nel contempo, tuttavia, le pratiche vaccinali sono rinsaldate proprio dalla fiducia accordata loro dai medici, le cui competenze ne garantiscono l’affidabilità. Ciò produce un’ulteriore antinomia: i medici – ossia gli specialisti competenti che potrebbero eventualmente porre dubbi sui vaccini - non riescono a farlo, pena la perdita della propria credibilità sul campo. Questa circolarità non è però priva di uno scopo: come si può desumere dalle considerazioni sopra proposte, essa assolve un compito ben preciso, ossia la stabilizzazione del ruolo dei vaccini, attraverso la rimozione dell’ambivalenza ad essi intrinseca: scindendo, cioè, il potere di proteggere da quello di ferire. Se poi il vaccino diviene espressione del successo biomedico, allora è la biomedicina tutta che viene in questo modo rinsaldandosi. Come osserva Stengers, tuttavia, proprio l’“ossessione di differenziazione che ci contraddistingue” (ivi:43) può divenire pericolosa: essa rischia di conferire a certi oggetti epistemici “un potere che non hanno” (ibidem). Rilevare ed esplorare il “lavoro del negativo” in opera diviene dunque cruciale per cogliere le forme di “instabilità” esistenti e trovare modi alternativi di relazionarvisi.
BIBLIOGRAFIA
AIFA, 2017, “La vaccinovigilanza in Italia: ruolo e obiettivi”, https://www.aifa.gov.it/sites/default/files/La_Vaccinovigilanza_in_Italia_18.04.2017.pdf
Foucault M., 2004, L'ordine del discorso e altri interventi, Torino: Einaudi.
Geissler P. W., 2013, Public Secrets in Public Health: Knowing not to Know while Making Scientific Knowledge, “American Ethnologist”, Vol. 40 (1):13-34.
Lesmo I, 2025, “Ecologie delle evidenze in vaccinovigilanza: quali esperienze (non) si trasformano in conoscenza?”, Controversie-Ripensare le scienze e le tecnologie, 2025,4, https://www.controversie.blog/vaccinovigilanza/
Stengers, I., 2005, Cosmopolitiche, Roma: Luca Sossella Editore.
Taussig M., 1999, Defacement: Public Secrecy and the Labor of the Negative, Stanford University Press, Stanford.
Ecologie delle evidenze in vaccinovigilanza: quali esperienze (non) si trasformano in conoscenza?
Le pratiche vaccinali sono generalmente rappresentate nei discorsi pubblici, nelle discussioni mediatiche, ma anche nei documenti ufficiali nazionali e sovranazionali, come una delle forme di tutela della salute pubblica più sicure ed efficaci. Vero e proprio emblema del successo biomedico – sino a diventarne spesso una metonimia - le vaccinazioni operano “salvando innumerevoli vite” (Ministero della Salute della Repubblica Italiana, 2023:4) e assicurando un rapporto “rischi/benefici particolarmente positivo” (ivi: 10). La sicurezza, in particolare, sarebbe garantita da un sistema di vaccinovigilanza, anche post-marketing, particolarmente efficiente: esso si articola attorno a complessi apparati burocratico-amministrativi che coinvolgono molteplici infrastrutture e soggetti diversificati.
Secondo le indicazioni dell’OMS, infatti, ogni AEFI (Adverse Event Following Immunization) – ossia qualsiasi episodio sfavorevole verificatosi dopo la somministrazione di un vaccino, non necessariamente causato dal vaccino stesso – andrebbe riportato al sistema di sorveglianza preposto.
SEGNALAZIONI DI AEFI IN ITALIA: TRA SICUREZZE E CRITICITA’
In Italia, l’organo deputato a questa sorveglianza è la Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF), connessa, da una parte, al SSN (Sistema Sanitario Nazionale) e, dall’altra, alle reti di farmacovigilanza sovranazionali. Solo in seguito alla segnalazione, l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) è tenuta a valutare la possibile correlazione causale tra l’AEFI e la vaccinazione somministrata. Tuttavia, in Italia, la RNF è un sistema di segnalazione passivo, nel senso che la segnalazione è volontaria. Per cui i medici, così come i cittadini, possono inserire spontaneamente un AEFI sul sito dell’AIFA. La vaccinovigilanza strutturata in questo modo permetterebbe di “raccogliere, monitorare e investigare continuamente l’eventualità di eventi avversi (anche imprevedibili) ed è in grado di rilevare anche potenziali segnali di allarme, utili a rivalutare il rapporto beneficio/rischio del vaccino e a gestire gli eventuali rischi per la salute” (ivi: 14).
In quanto processi socio-culturali complessi, tuttavia, queste pratiche meritano di essere esplorate in profondità, tenendo in considerazione anche i discorsi che ne evidenziano limiti e lacune e che, spesso, sono frettolosamente derubricati come “no-vax” o “anti-vax”. Prendere in considerazione tali discorsi è un passo fondamentale non solo per comprendere come sfiducia e diffidenza possano generarsi proprio all’interno di quelle azioni di “vigilanza” che vorrebbero invece produrre affidabilità e sicurezza, ma anche perché gli sguardi critici si rivelano spesso essere strumenti utili per cogliere alcune antinomie intrinseche al sistema di produzione del sapere stesso.
VISSUTI IMMOBILIZZATI IN UN’ECOLOGIA DELLE EVIDENZE
Nel corso della ricerca etnografica che ho condotto sulle pratiche vaccinali e, in particolare, sul danno da vaccino (soprattutto in relazione all’età pediatrica, Lesmo 2024), alcune narrazioni tornavano, ostinate, a tormentare i racconti di molti genitori. “Allora dopo la seconda vaccinazione, proprio… è la catastrofe” mi ha raccontato una mamma. “Dopo che ha fatto il richiamo è cambiato tutto”, ha ricordato un’altra madre. Di narrazioni simili, rievocate con emozione da madri e padri, ne ho raccolte numerose. Nonostante ciò, un’unica famiglia aveva, faticosamente, segnalato “l’episodio sfavorevole” all’AIFA. La maggior parte degli altri genitori da me incontrati non era stata informata della possibilità di farlo in autonomia; in due casi i miei interlocutori ne acquisirono piena consapevolezza solo durante i nostri incontri. D’altra parte, i genitori si erano spesso rivolti ai pediatri evidenziando l’accadimento e, in almeno due situazioni, i medici avevano immaginato una possibile correlazione tra l’evento e le vaccinazioni. In nessuna di queste situazioni, tuttavia, l’evento era stato segnalato all’AIFA.
Perché?
Il senso di questi vuoti – questi passaggi mancati - non può restare sotto traccia. Renderli visibili diviene fondamentale perché permette di intercettare quei momenti in cui l’esperienza del singolo e il sistema volto a tradurre quest’ultima in un sapere condiviso non riescono a incontrarsi. Espulse e deviate verso traiettorie divergenti, le esperienze di alcuni soggetti non possono così contribuire alla produzione di una conoscenza di cui pure riconoscerebbero il valore (Lello, 2020). L’antropologo Charles Briggs (2016) ha definito “ecologie delle evidenze” quei processi per cui alcune esperienze individuali sono chiamate ad esistere all’interno del sapere scientifico, mentre altre ne sono rigettate, declassate “allo stato di ignoranza, superstizione, o patologia”, o finanche rese “impensabili” (ivi: 151). Quali ecologie delle evidenze vengono dunque attivate entro i processi di vaccinovigilanza, e specificamente nelle pratiche di segnalazione degli eventi avversi? Quali antinomie del sistema esse rendono manifeste?
CIRCOLARITA’ EPISTEMICHE
La maggior parte dei medici incontrati sul campo ha rilevato come, effettivamente, la segnalazione di eventi avversi non avvenga di frequente. Se alcuni tra loro attribuivano questa difficoltà all’onerosità di un tempo-lavoro da situarsi tra una crescente burocratizzazione della pratica medica e la conseguente compressione degli spazi clinici – con il rischio di una riduzione nella qualità dell’assistenza ai pazienti – altri processi sono emersi più spesso, sino a delineare un’ecologia delle evidenze specifica. Essa opera in due diverse – e paradossali – direzioni.
Da una parte, i medici incontrati hanno sottolineato come disturbi “benigni” o “quadri non gravi” (l’innalzamento della temperatura, l’irritabilità, le reazioni cutanee locali o le convulsioni febbrili…) fossero “già noti” o finanche “attesi”. In quanto tali, si riteneva superfluo segnalarli. “Ci sono eventi avversi previsti e non sono neanche considerabili tali” spiegava una dottoressa. Queste esperienze, pertanto, venivano immobilizzate all’esterno del sistema di rilevazione.
D’altra parte, un’eguale immobilità interessava alcuni disagi importanti occorsi nel periodo di somministrazione vaccinale - quali ad esempio disturbi neuro-muscolari o psicomotori severi. In questo caso, la motivazione alla base dell’esclusione era, paradossalmente, opposta a quella delineata in precedenza: dal momento che la letteratura medico-scientifica in questi casi aveva già escluso ogni possibile correlazione con le vaccinazioni, sarebbe stato superfluo segnalare l’evento.
In questo modo, tuttavia, ciò che avrebbe dovuto garantire una rivalutazione costante del rischio associato a possibili eventi avversi, veniva pre-determinato a priori dalle interpretazioni già esistenti in relazione al rischio stesso. Questa circolarità epistemica, a tratti paradossale, non affiorava in un vuoto epistemologico, ma si radicava entro una gerarchia delle evidenze ben consolidata nell’Evidence Based Medicine. I livelli di evidenza qui definiti, infatti, collocano tra le prove più attendibili le revisioni sistematiche di studi clinici randomizzati; all’opposto, le opinioni e le esperienze cliniche degli esperti si collocano alla base di simile costruzione piramidale (Oxford Centre for Evidence-Based Medicine). Tale gerarchia, profondamente interiorizzata dai medici da me incontrati, non consentiva ad osservazioni basate su singole esperienze cliniche di contravvenire quanto già sostenuto in letteratura e, dunque, neanche di ritenerlo manifesto al punto da doverlo/poterlo segnalare.
In questo modo, tuttavia, il sistema di sapere tendeva a riprodurre sé stesso riconfermando quanto già definito e dirottando – o immobilizzando - al suo esterno esperienze che avrebbero potuto contribuire a sollecitarne un riesame. Tali esperienze venivano così ricondotte - e ridotte – allo stato di banalità, ovvietà, ignoranza.
Già Foucault, in fondo, aveva rilevato come “l’esterno di una scienza è più e meno popolato di quanto non si creda” (Foucault, 2004:17), costellato da tutto ciò che ogni disciplina “respinge oltre i suoi margini” (ibidem). Tuttavia, per molti genitori da me incontrati, vedersi convergere a forza verso una simile esteriorità escludeva contemporaneamente ogni possibile credibilità di un sistema orientato, invece, a produrre fiducia: esso si trasformava piuttosto in fonte di sospetto e biasimo nelle istituzioni tutte e nei loro discorsi.
BIBLIOGRAFIA
Briggs, Charles, L. 2016. “Ecologies of evidence in a mysterious epidemic.” Medicine Anthropology Theory 3(2):149-162.
Foucault M., 2004, L'ordine del discorso e altri interventi, Torino: Einaudi.
Lello, E., 2020, “Populismo anti-scientifico o nodi irrisolti della biomedicina? Prospettive a confronto intorno al movimento free vax”, Rassegna Italiana di Sociologia, 3:479-507.
Lesmo, I., 2024, “Ecologie delle pratiche nella vaccinovigilanza italiana. Antinomie nel sapere vaccinale”, AM_Rivista della Società italiana di antropologia medica, 25(58):181-211,
Ministero della Salute della Repubblica Italiana, 2023, Piano nazionale Prevenzione Vaccinale PNPV 2023-2025.
Oxford Centre for Evidence-Based Medicine, https://www.cebm.ox.ac.uk/resources/levels-of-evidence/oxford-centre-for-evidence-based-medicine-levels-of-evidence-march-2009
Robert F. Kennedy Jr ministro della Sanità USA. Perché non è necessariamente una brutta notizia
Il 13 febbraio 2025, Robert F. Kennedy Jr è stato nominato ministro della sanità. Avrà anche la supervisione della Food and Drug Administration, la potente agenzia federale che vigila su cibo e farmaci, e il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC), che si occupa espressamente anche di vaccinazioni. Il suo intento sarebbe quello di rendere l’America più sana (MAHA – Make America Healthy Again https://www.maha.vote/), combattendo il cibo-spazzatura e lo strapotere delle Big Pharmas.
Sì è molto parlato di lui, nei media mainstream. Generalmente male.
71 anni compiuti, avvocato di molte cause ambientaliste (ne ha vinte alcune contro importanti industrie accusate di inquinamento) e dei diritti delle tribù native, è figlio di Robert Francis Kennedy (candidato alla Casa Bianca mentre fu ucciso a 43 anni) e nipote di John Fitzgerald Kennedy (che invece Presidente era riuscito a diventarlo, ma anche lui fu ucciso, a 46 anni).
Contro la sua nomina si sono scagliate più di 80 organizzazioni, numerose scienziate (sempre usando il femminile sovraesteso), 25.000 professioniste dell’American Public Health Association, 15.000 mediche.
Il (risicatissimo – 14 a favore e 13 contrarie) parere favorevole alla sua nomina da parte della commissione Finanze del Senato, è coinciso con un vistoso calo del titolo Pfizer (-2,3%) e Moderna (6,2%) sulla borsa di Wall-Street. E anche in Senato la sua conferma è passata per soli 4 voti: 52 senatori/trici repubblicani/e a suo favore (di cui 2 incerti fino all’ultimo), e 48 contrari (di cui 45 democratici/che, 2 indipendenti e Mitch McConnell, senatore repubblicano, per decenni alla guida dei repubblicani del Senato, in forte contrasto con Trump e che si definisce “un sopravvissuto alla poliomielite”.
Le accuse, tutte vere, nei confronti di Kennedy sono di:
- essere un traditore del Partito Democratico (il quale però ostacolò fortemente la sua corsa alle primarie nel partito);
- essere stato un consumatore di droghe per molti anni (sembra però che ora abbia smesso, mentre molte altre politiche continuano…)
- aver avuto una relazione extraconiugale con una nota reporter di sinistra (ma noi di queste cose non ci scandalizziamo, avendo avuto un Presidente del Consiglio sicuramente molto più esperto in materia)
- aver confessato di aver ucciso un orso per poi abbandonarne il cadavere a Central Park (almeno in Trentino queste cose le fanno dopo una delibera)
- essere un nemico dell’industria agroalimentare e farmaceutica (cosa però stranamente apprezzata sia a destra che a sinistra, e in particolare da giovani, ambientaliste radicali, salutiste, new age, ultras dell’anti-capitalismo tipo Occupy Wall Street)
- voler contrastare la diffusione di prodotti chimici inquinanti e pesticidi (che idea balzana)
- voler abolire le pubblicità dei farmaci, danneggiando così le TV (non lo sa che sono soltanto dei “consigli per gli acquisti”, come li chiamava Maurizio Costanzo?)
- voler imporre normative per la messa al bando di vari additivi alimentari tossici o di organismi geneticamente modificati (direttive peraltro già adottate nell’Unione Europea e nella California, governata dai democratici).
- abbracciare teorie complottiste senza fondamento (tra cui gli assassinii del padre e dello zio, da lui attribuiti alla Cia, agenzia che mai ha commissionato omicidi o organizzato colpi di stato da quanto è stata costituita nel lontano 1947).
- essere un anti-vaccinista e di credere che alcuni vaccini possano causare (indirettamente) l’autismo nelle bambine. Con queste convinzioni, numerose scienziate prevedono il ritorno negli Usa di malattie scomparse o fortemente ridimensionate proprio per merito delle vaccinazioni. Non tutte le scienziate però la pensano così e il tema è molto più complesso delle semplificazioni proposte da molte scienziate e giornaliste (vedi Gobo e Sena 2019).
Complessivamente, però, se Kennedy riuscisse a mettere in pratica solo metà del suo programma (almeno quella metà che trova d’accordo tutte le persone di buon senso), ne vedremo delle belle.
Ma le vere domande sono: lui è in grado di farlo? Ha le competenze necessarie?
Alla prima è difficile rispondere. Per quanto motivata e decisa, una persona sola non è in grado di imprimere tutti questi cambiamenti. C’è bisogno della collaborazione di molte altre persone e istituzioni. Occorrono quindi capacità manageriali oltre che vision.
Veniamo quindi alla seconda domanda. Che competenze dovrebbe avere una ministra della sanità? Essere un’esperta di sanità? E chi è un’esperta di sanità: una medica? Una paziente? Una manager della sanità? Forse nessuna di queste.
La prima laurea di Sergio Marchionne era in filosofia. Poi si laureò in giurisprudenza. Successivamente in Discipline Commerciali e poi ottenne un Master in business administration. È stato, nell’ordine: direttore finanziario al Lawson Group, società di consulenza su salute e sicurezza (1992); amministratore delegato si Lonza Group Ltd, azienda operante nel settore della chimica farmaceutica e biofarmaceutica (2000); amministratore delegato della SGS, azienda attiva nei servizi di ispezione, verifica e certificazione (2002); nel CdA del gruppo biotecnologico Serono; nel 2008 vicepresidente non esecutivo e direttore indipendente senior di UBS (banche) e amministratore delegato FIAT.
Marchionne era forse un esperto dei settori dove operavano le “sue” aziende? No.
Eppure non pare abbia fatto peggio (anzi…) di Carlos Tavares, che è un ingegnere e ha fatto tutta la sua carriera nel settore automobilistico.
In Italia, come ministre delle sanità abbiamo avuto di tutto e di più. Nell’ordine: Nicola Perrotti (psicoanalista), Mario Cotellessa (medico), Tiziano Tessitori (avvocato), Angelo Giacomo Mott (medico), Vincenzo Monaldi (medico), Camillo Giardina (giurista), Angelo Raffaele Jervolino (avvocato e giurista), Giacomo Mancini (avvocato penalista), Luigi Mariotti (commercialista), Ennio Zelioli-Lanzini (avvocato), Camillo Ripamonti (Ingegnere), Athos Valsecchi (insegnante di scuola media), Remo Gaspari (avvocato), Luigi Gui (insegnante di filosofia), Vittorino Colombo (dirigente d’azienda), Antonino Pietro Gullotti (avvocato), Luciano Dal Falco (giornalista), Tina Anselmi (insegnante elementare e sindcalista), Renato Altissimo (dirigente d’azienda), Aldo Aniasi (pubblicista), Costante Degan (ingegnere), Carlo Donat-Cattin (giornalista e sindacalista), Francesco De Lorenzo (medico e accademico), Raffaele Costa (avvocato e giornalista); Mariapia Garavaglia (insegnante di lettere e giornalista), Elio Guzzanti (medico), Rosy Bindi (giurista), Umberto Veronesi (oncologo), Girolamo Sirchia (medico accademico), Francesco Storace (giornalista), Livia Turco (insegnante elementare), Maurizio Sacconi (funzionario), Ferruccio Fazio (medico e accademico), Renato Balduzzi (giurista), Beatrice Lorenzin (giornalista), Giulia Grillo (medico legale), Roberto Speranza (laureato in scienze politiche) e Orazio Schillaci (medico e accademico).
Eppure, almeno fino a poco tempo fa, il sistema sanitario italiano era considerato un’eccellenza mondiale.
Ma allora, che competenze servono per fare la ministra della sanità (o di un altro dicastero)? Non competenze specifiche, bensì trasversali come la capacità di: scegliersi le collaboratrici (queste sì) competenti nel settore, leadership, gestire i gruppi, mediare tra le diverse istituzioni, gestire i conflitti, motivare le collaboratrici e farle lavorare ecc. Insomma capacità gestionali, relazionali e comunicative.
Kennedy le ha? Molte persone lo dubitano…
Vedremo se riuscirà davvero a rendere l’America più sana.
Sempre che non lo uccidano prima…
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Gobo, G. e Sena B. (2019), Oltre la polarizzazione "pro-vax" versus "no-vax". Atteggiamenti e motivazioni nel dibattito italiano sulle vaccinazioni, in SALUTE E SOCIETÀ, XVIII, 2, pp. 176-190.
Covid, tecnocrazia e "vera" politica - Due progetti paralleli
Dalle prime due parti (qui, la prima parte e qui, la seconda parte) dell’analisi degli algoritmi di valutazione dell'andamento della pandemia, ad aprile 2020, è emerso che questi algoritmi sono un caso solo apparente di tecnocrazia.
In realtà, abbiamo visto che:
- il tentativo di rendere gli algoritmi completi ha generato un eccesso di complessità che ha reso questi strumenti praticamente inservibili ai fini della decisione sulla Fase 2
- la decisione di passare alla Fase 2 è stata principalmente politica, seppur basata su un set minimale di dati scientifici, limitato ai trend di contagi, decessi e di saturazione delle terapie intensive.
Ora, questo non toglie che la relazione tra scienziati e governo abbia effettivamente avuto un carattere tecnocratico già nel primo periodo della pandemia[1], tra febbraio e maggio 2020.
Per comprendere la reale portata ed estensione di questo carattere tecnocratico faremo alcune brevi considerazioni su:
- il CTS e la rilevanza del valore della salute nella gestione della crisi
- il ruolo che ha giocato il CTS nei processi di decisione del governo
Vedremo che il governo ha preso le sue decisioni in modo principalmente politico ma, invece, ha lasciato ampio spazio a scienziati e tecnici sul come metterle in atto.
COS’ERA E COME FUNZIONAVA IL COMITATO MEDICO SCIENTIFICO
La presenza del CTS nel processo di decisione del Governo ha, certamente, amplificato il ruolo dei valori di salute e di sopravvivenza come condizioni di possibilità del bene comune e, quindi, ha condizionato le azioni del governo nella direzione di “prima la salute”.
Infatti:
- il ruolo del CTS era di dare consulenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile – e più tardi direttamente al Governo – su come fronteggiare la diffusione del contagio;
- i componenti del CTS erano “esperti e qualificati rappresentati degli Enti e Amministrazioni dello Stato”, di fatto 8 componenti su 12 erano medici: i tre presidenti del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell’AIFA, un professore di patologia clinica e di comunità, un esperto di medicina delle catastrofi, un infettivologo e un epidemiologico.
- Il CTS era sempre – ogni giorno, al mattino molto presto – l’iniziatore del processo di decisione. Era il CTS a effettuare la sintesi e il vaglio delle informazioni raccolte dal fronte del contagio e a prepararsi, sulla base dei dati, a dare consiglio al Capo della Protezione civile e ai rappresentanti del Governo, in primis al Ministro della Salute;
- spesso, il CTS agiva in coda al processo, assumendo la funzione di supporto e di legittimazione delle decisioni prese: i membri del CTS partecipavano e parlavano alle conferenze stampa e ai talk show fornendo elementi di spiegazione e di sostegno alle misure restrittive o meno del Governo.
Ora, per disciplina, per etica procedurale, la salute è il faro guida del medico, soprattutto in termini di assenza di malattia, di normale funzionamento del corpo, «Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza» (Codice di Deontologia Medica, all’Art. 3 – Doveri del Medico).
Ne risulta abbastanza ovvio che il CTS - un consesso di medici - si sia concentrato sui pilastri deontologici, guarire chi si è ammalato, garantire il funzionamento delle strutture di cura e, in caso di infettività, prevenire e controllare la diffusione della malattia.
Altrettanto ovvio appare il fatto che il Governo, consigliato e sostenuto dal CTS abbia posto i valori della salute e della sopravvivenza biologica al primo posto della propria scala assiologica nell’affrontare la crisi.
È interessante, peraltro, vedere che paesi iper-liberisti come Inghilterra e Brasile, in cui non c’era nulla di simile al nostro CTS, si siano, invece, orientati più nettamente sui valori della sussistenza economica delle imprese, del paese in generale e di conseguenza dei cittadini, mettendo in conto «un numero evitabile di persone contagiate e di morti» (Habermas J., Proteggere la vita, tr. It. D’Aniello F., Società editrice Il Mulino, 2022, p. 51); è famosa l’infelice frase di Boris Johnson: «many more families are going to lose loved ones before their time».
TECNOCRAZIA O NO?
Si ripropone quindi la domanda: Il Governo ha davvero preso delle decisioni, ha fatto delle scelte morali[2], oppure chi le ha fatte è stato il CTS?
Prima di provare a dare una risposta va ricordato che la più grande partita di decisioni si è giocata sul campo dell’economia, quello degli aiuti e dei sostegni economici.
Su questo campo il governo ha preso delle posizioni, ha compiuto delle vere e proprie scelte morali, basate su dei criteri e su una assiologia chiari; una assiologia che ha determinato la destinazione e i tempi dei sostegni economici, a chi prima e a chi dopo, a chi di più e a chi di meno. La scala di priorità è stata inizialmente concentrata sui lavoratori dipendenti delle imprese medio-grandi, quelle in grado di accedere alla cassa integrazione guadagni, per intenderci ed è poi cambiata, per rispettare le istanze di giustizia sociale portate avanti dalle opposizioni: occhio ai dimenticati dei primi momenti – tra cui liberi professionisti, lavoratori autonomi e microimprese.
Fatta questa premessa, proviamo a focalizzare quale sia stato il rapporto tra CTS e Governo nei primi mesi; l’analisi[3] di documenti video, di verbali e di decreti mostra che:
- è fuori di dubbio che il Governo abbia fatto delle scelte morali sul tema della salvaguardia della salute e della sopravvivenza. Il Governo ha delineato una scala di valori e questi valori li ha contestualizzati nel particolare della situazione che andava affrontando.
- È altrettanto fuori di dubbio che, nel costruire questa priorità di valori che vede salute e sopravvivenza in alto, il governo sia stato influenzato dal CTS – soprattutto dalla componente medica. Però, è emerso anche che la storia personale dei leader di governo, la tradizione di partito, le esperienze fatte, abbiano avuto un ruolo determinante
- Dove, invece, il Governo è stato molto più influenzato dal CTS sembra essere stato nel COME realizzare la tutela della salute e della vita. In questo, la vera scelta del governo è stata di affidarsi a tecnici, ai medici, agli epidemiologi. Lo dice Conte in passaggio chiarissimo il 25 di febbraio.[4]
- È evidente che la scelta di affidarsi a scienziati e tecnici è stata fatta sulla base del criterio delle competenze mediche e tecniche del CTS.
Quindi, sul come gestire la crisi, come salvaguardare la salute, il governo ha scelto di affidarsi, consapevolmente, a quelli che riteneva competenti e questo delinea palesemente una forma di tecnocrazia indiretta. Il processo analisi – sintesi – decisione – legittimazione in cui il CTS è dominante in tre passaggi su quattro ne è conferma.
Ma, ricordiamolo, all’inizio nessuno sapeva cosa stesse accadendo, né capiva cosa potesse accadere e, in quel momento di emergenza, il fattore tempo sembrava essere determinante[5].
Così come – in un momento successivo - ha fatto affidando a un militare la logistica della distribuzione dei vaccini. In Italia solo i militari hanno competenze logistico-operative e piani già pronti di quel tipo. Nessun altro. Non avrebbe potuto farlo un tecnico degli acquisti come Arcuri (bravo a reperire materiali con contratti emergenziali a prova di bomba).
Che poi il CTS abbia seguito delle linee super consolidate e tradizionali come l’ospedalizzazione sempre e comunque, la rinuncia alle cure domiciliari, linee che trovano una impressionante analogia nel Diario della Peste di Defoe – parliamo del 1665 – è altra cosa, su cui non credo di poter dare giudizi. Mi tengo dei sospetti.
Quindi, in conclusione, siamo stati di fronte ad una forma di solo parziale tecnocrazia, in cui il governo ha mantenuto per sé la prerogativa delle decisioni politiche sul cosa fare per gestire la crisi sanitaria ed economica, in termini di priorità, quantità, destinazioni, inclusioni ed esclusioni, ma ha ceduto sovranità alla scienza e alla tecnica sul come perseguire a questi obiettivi.
NOTE
[1] Non considero quello che è successo nei mesi successivi, con le due seconde ondate, quella di riaperture e quella di contagi dell’autunno 2020, del secondo lockdown, dei vaccini, del green pass e delle varie misure interdittive.
[2] Scelta morale: decisione su come orientare la propria condotta pratica basata su una scala di priorità tra principi o valori, appunto, morali.
[3] Le fonti sono i discorsi pubblici del Presidente de Consiglio e dei diversi Ministri – reperibili facilmente su YouTube o sul sito della Presidenza del Consiglio, i testi dei Decreti del presidente del Consiglio, i Decreti Ministeriali, le circolari della Protezione Civile, ecc.. Chi volesse avere un’ampia bibliografia e sitografia può chiederla alla Redazione di Controversie.
[4] Le parole di G. Conte: «io non ho competenza scientifica in questo campo, non ho alcuna competenza, e sarebbe presuntuoso […] sopravanzare e sovrapporsi a […] quelle che sono le valutazioni tecnico-scientifiche […] loro hanno articolato quelli che sono tutti i comportamenti e sono raccomandazioni indicazioni rivolte al personale sanitario e ovviamente a tutti i cittadini» (Conferenza stampa del Presidente Conte dalla Protezione civile, YouTube - Palazzo Chigi, Canale ufficiale del Governo italiano, 25 febbraio 2020 (https://www.youtube.com/watch?v=gWJoo8O6mZ8))
[5] Il problema del confronto con una situazione in cui «i fatti sono incerti, la posta in gioco alta, i valori in conflitto, e le decisioni urgenti» è affrontato dalle raccomandazioni della Scienza Post Normale; rimandiamo a Saltelli, A., 2024, SCIENZA POST-NORMALE, XI Appendice dell’Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma - https://www.researchgate.net/publication/387296164