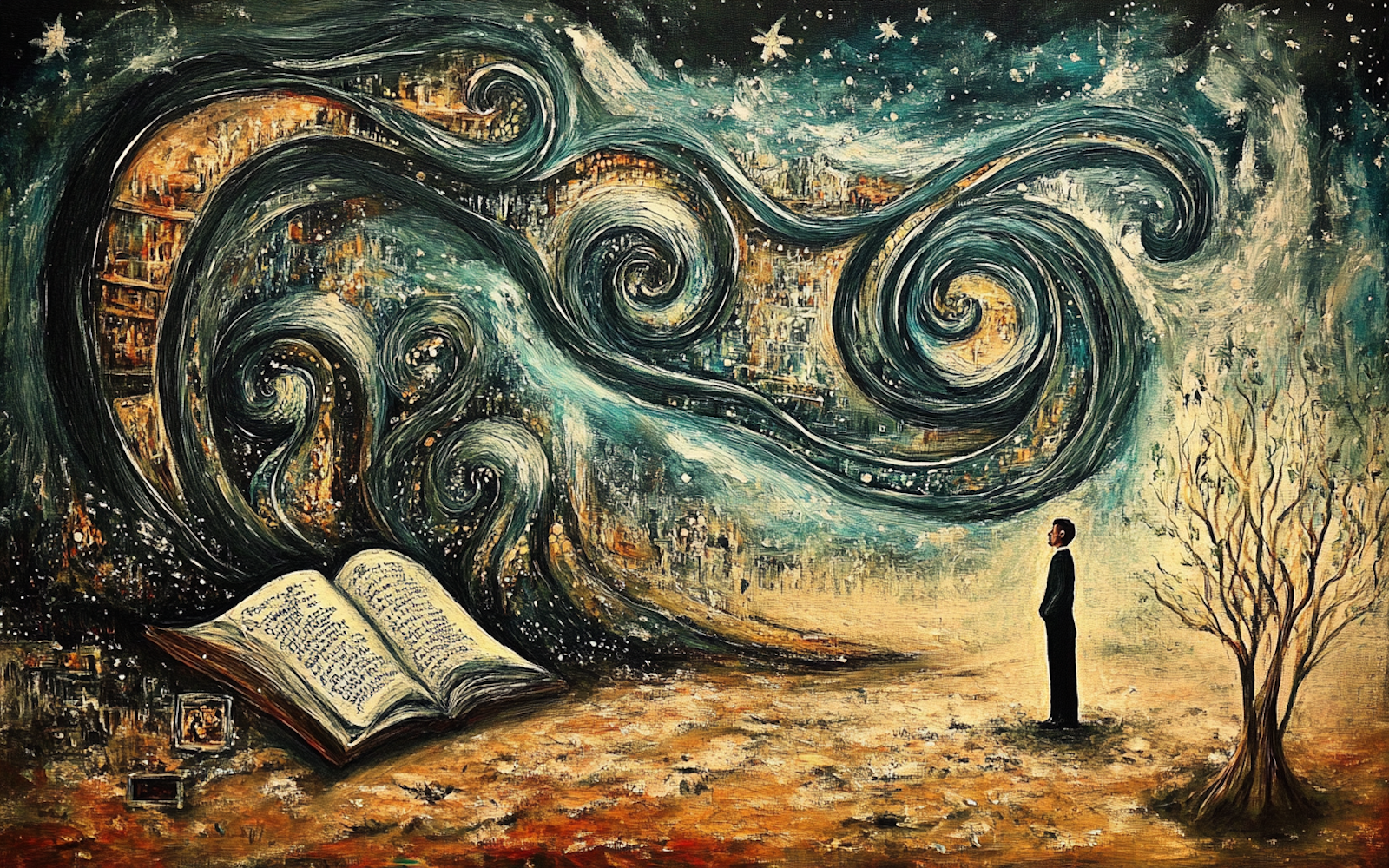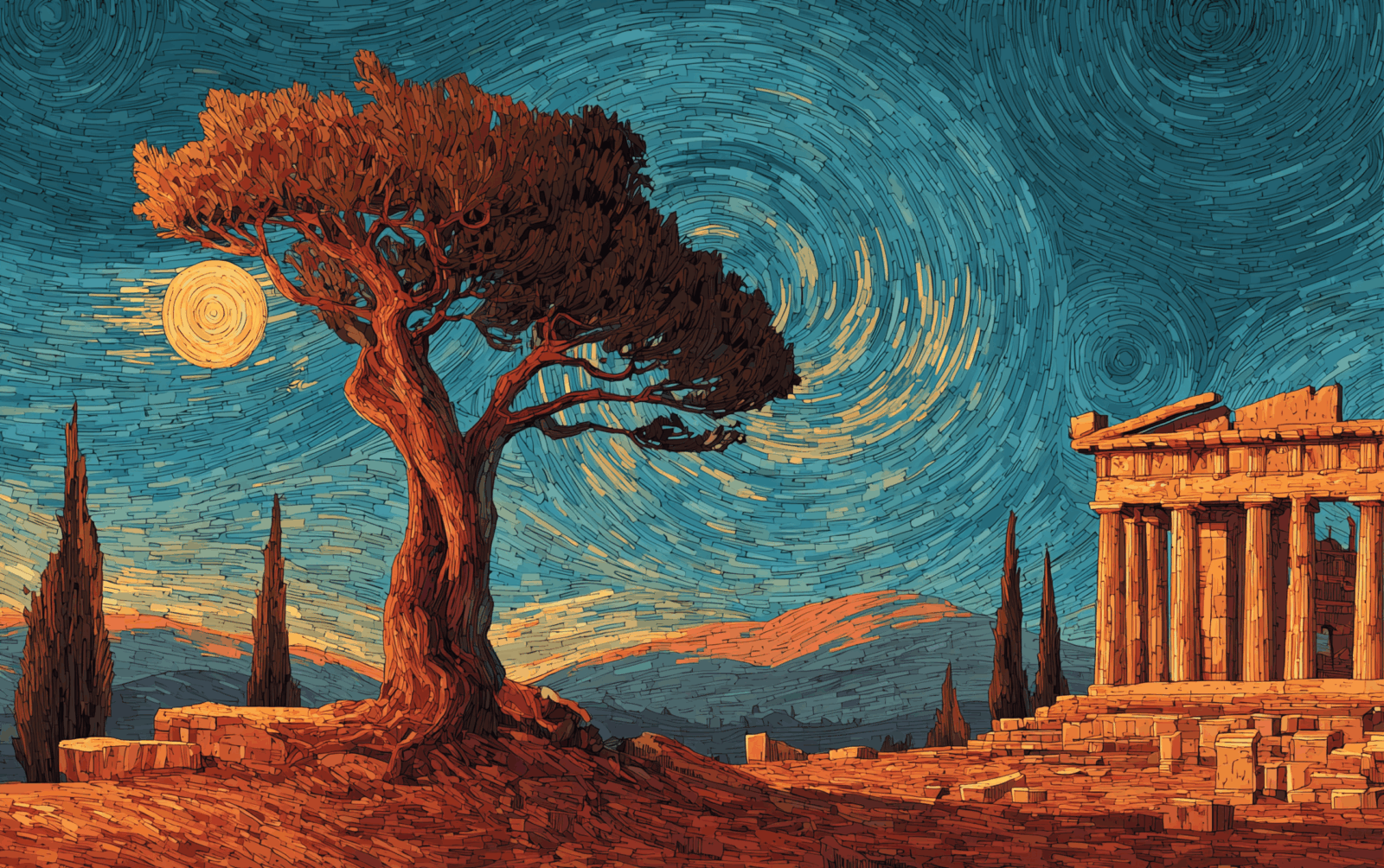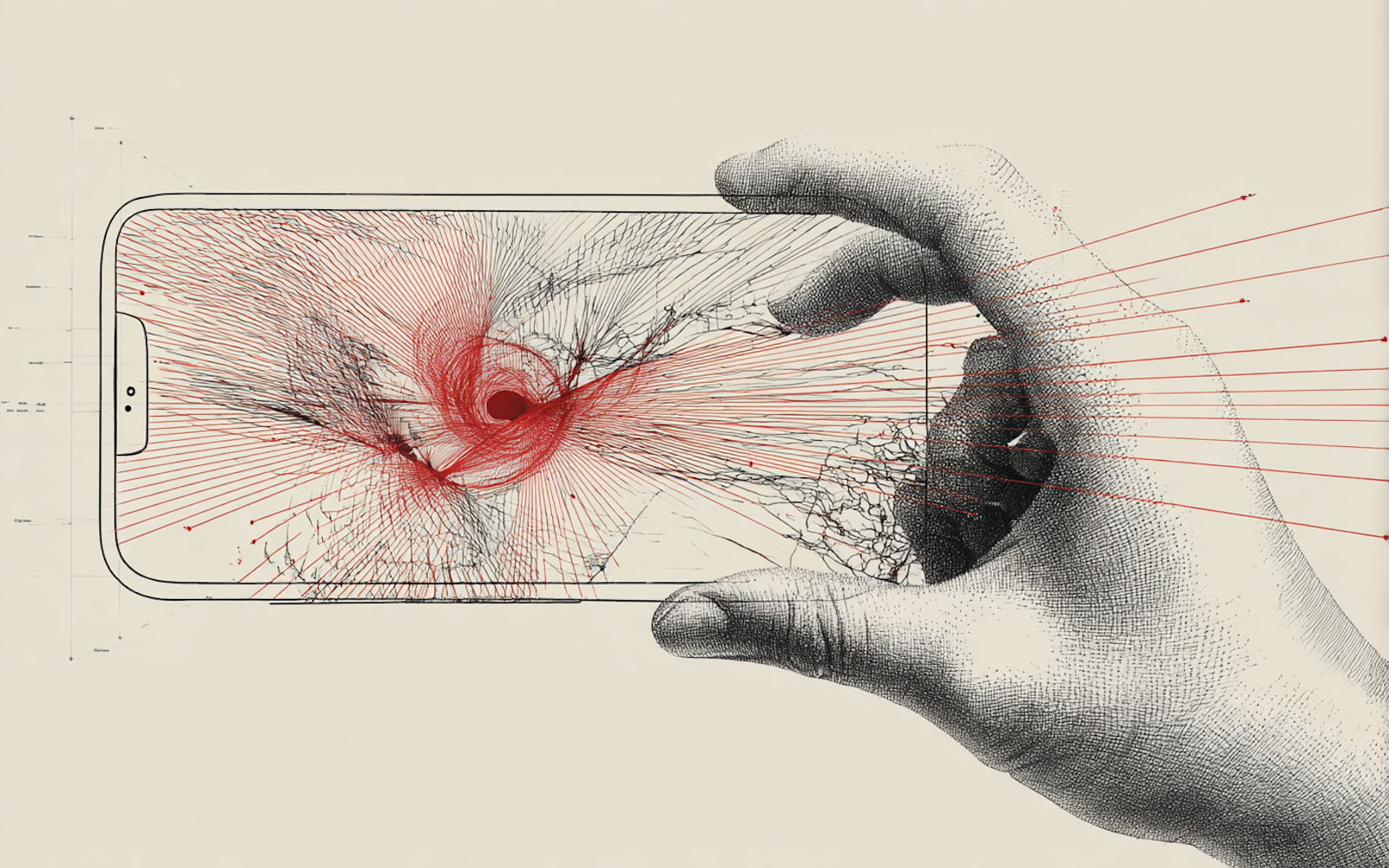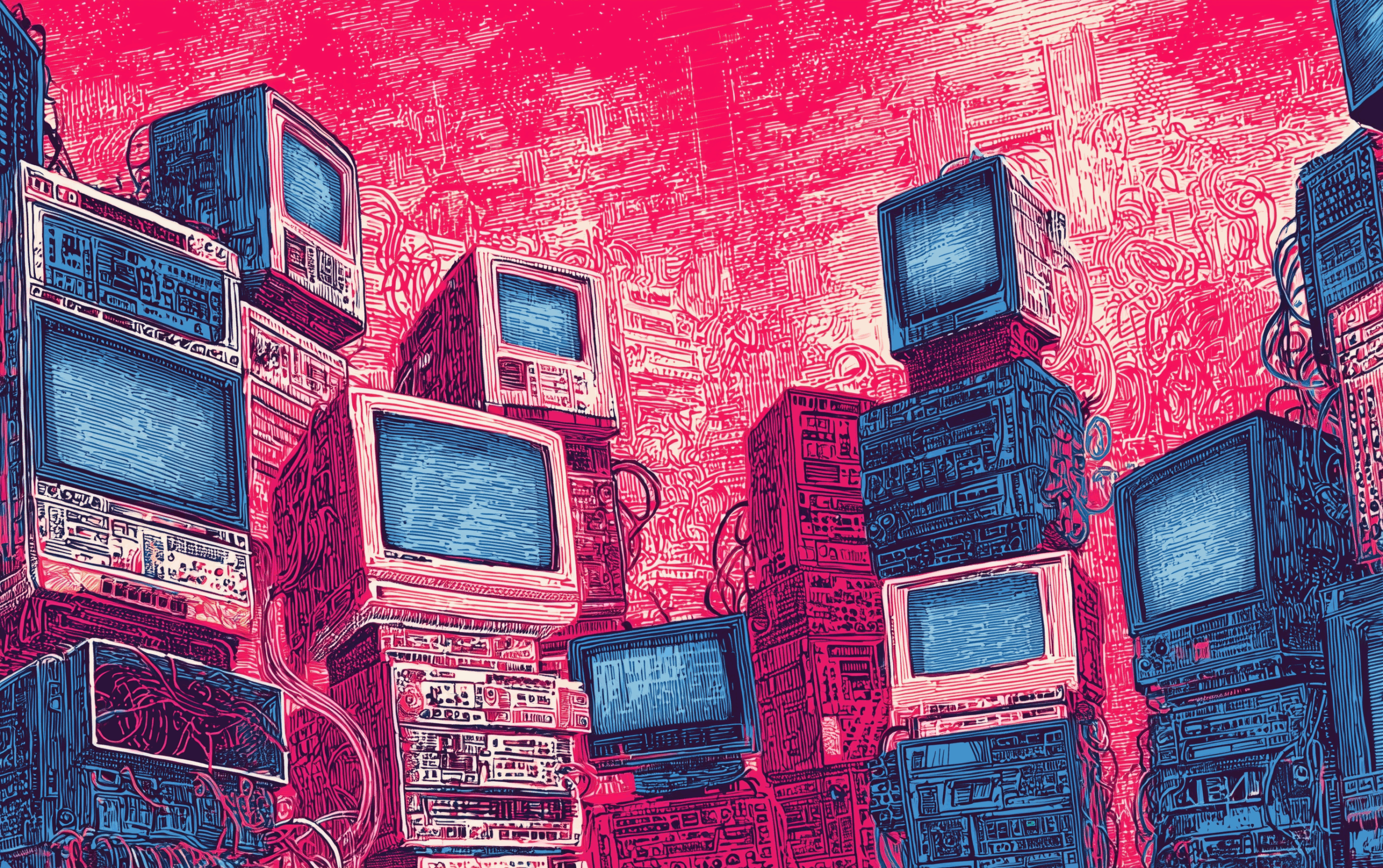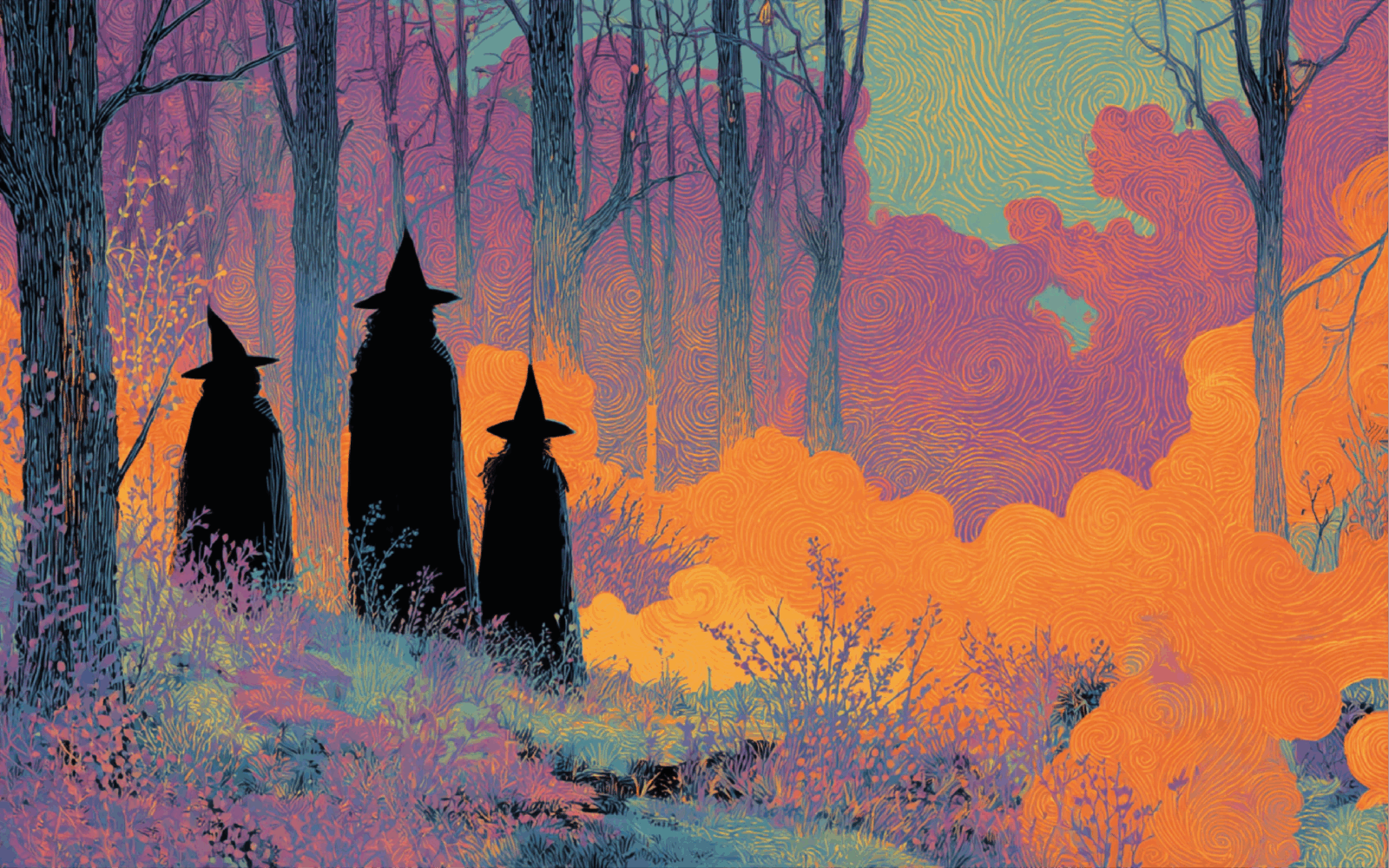Recensione di "Oltre la tecnofobia, il digitale dalle neuroscienze all’educazione" - Quarta parte
Dopo un a sintetica recensione del libro Oltre la Tecnofobia (qui), una critica al concetto di onlife e della rimozione dell’infanzia (qui), la disamina del concetto di dipendenza da internet e l’idea pedagogica che sia vietato vietare (qui), Simone Lanza con questa quarta e ultima parte, conclude il confronto con le tesi del libro, affrontando gli ultimi luoghi comuni: l’idea di progresso tecnologico lineare, le paure per le tecnologie, il carattere fortemente ideologico del libro.
a sintetica recensione del libro Oltre la Tecnofobia (qui), una critica al concetto di onlife e della rimozione dell’infanzia (qui), la disamina del concetto di dipendenza da internet e l’idea pedagogica che sia vietato vietare (qui), Simone Lanza con questa quarta e ultima parte, conclude il confronto con le tesi del libro, affrontando gli ultimi luoghi comuni: l’idea di progresso tecnologico lineare, le paure per le tecnologie, il carattere fortemente ideologico del libro.
Qui puoi scaricare il contributo completo.
TECNOLOGIA O TECNOLOGIE?
Con la quinta critica vorrei iniziare a porre qualche domanda sulle parole usate nel titolo stesso di Oltre la tecnofobia. Il termine “tecnofobia” è incluso in alcuni dizionari con il significato di “avversione per la tecnologia”. Ma esiste la Tecnologia? O forse ne esistono molte? Gli autori ne parlano troppo spesso al singolare.
Il XVIII secolo ha rappresentato il grande momento di espansione di attrezzi e utensili, presentati ancora nell’Enciclopedia, non senza ripetizioni, in base ai loro usi umani (i mestieri), e non alle caratteristiche intrinseche degli oggetti. Con la rivoluzione industriale si diffusero nuove tecnologie produttive che destarono non poche preoccupazioni, perché, a differenza dell’utensile che aiutava l’artigiano (prolungandone per così dire la mano), le nuove tecnologie raramente erano alleate dell’operaio, anzi spesso si sostituivano a lui.[1] Pertanto le paure per alcune tecnologie potrebbe spesso essere molto più recenti di quello che si creda e le smisurate reazioni a favore o contro sarebbero più il riflesso della nostra società industriale. In ogni caso la storia ci insegna che non esiste una sola Tecnologia, ma tante tecnologie, spesso alternative, negli ultimi secoli selezionate forse più per interessi di mercato che in base a qualità intrinseche.[2]
Ma quindi alcune paure per alcune tecnologie non possano essere fondate? Quando si parla della Tecnologia, si tratta di prendere o lasciare, o si ha fiducia o si ha paura: l’atteggiamento verso la tecnologia sembrerebbe qualcosa di molto religioso, una sorta fede nella Storia dell’Umanità verso il Progresso. Nella visione di Oltre la tecnofobia il mondo si evolverebbe in modo unilineare, benché con qualche balzo: “la storia dell’homo sapiens è una progressiva esternalizzazione delle nostre abilità” (p.102), anzi è persino una evoluzione delle tecnologie cognitive “dall’invenzione del fuoco agli smartphone” (p.22): una sola linea retta, che separa gli umani tra favorevoli (ottimisti) e contrari (nostalgici). Platone (nostalgico) sarebbe stato contrario alla scrittura, anzi Platone avrebbe anticipato la critica al cellulare poiché rifiutò la scrittura: “Platone era stato profetico” (p.128-30). Siccome gli autori sanno bene che Platone non rifiutava la scrittura ma affidava l’insegnamento e i pensieri più importanti al dialogo, mi limito piuttosto a contestare la logica argomentativa: se qualcuno è contrario alla scrittura ipso facto è contrario al cellulare (e viceversa) perché la Tecnologia o si prende o si rifiuta, non si può mai accogliere qualche tecnologia rifiutandone altre. La Tecnologia è sempre singolare e la tecnofobia ne indica l’avversione.
Forse sarebbe più utile chiedersi se oggi le tecnologie siano tutte da prendere o se come società (democratica) possiamo anche sceglierle. Ma soprattutto forse la domanda giusta (visto che il libro avrebbe velleità pedagogiche) non è tanto se prenderle o rifiutarle quanto “da che età introdurle ai più piccoli”? Scegliere le tecnologie in base ai valori sociali condivisi non è proprio ciò che ha fatto per decine di migliaia di anni l’homo sapiens?[3] Proporne un uso con delle regole sociali per ciascuna età non è ciò che ha sempre fatto ogni società con i coltelli? È lecito scegliere tra le varie tecnologie oppure la tecnologia è un destino? E per fare queste scelte la paura non ci può proprio essere d’aiuto? A tutte queste domande il libro risponde in modo semplificatorio che la tecnologia è Una e Indivisibile e che sia necessario andare oltre questa atavica paura per essa.
ESISTONO PAURE LEGITTIME PER LE TECNOLOGIE?
Arriviamo così a un altro luogo comune che questo libro rinforza: come tutte le paure anche quella per la tecnologia è una emozione negativa. Ma se esistono tante tecnologie perché non è lecito che alcune destino paure e altre speranze? Inoltre, per andare dritti alla radice del titolo: avere paura è davvero una emozione così negativa? La paura non è, al contrario, anche un aiuto per anticipare i pericoli? É così errato avere paura che le nuove generazioni vengano svezzate davanti a uno schermo? É così risibile avere paura che la propria figlia frequenti siti web che promuovono l’anoressia (comunità proAna)? É così sbagliato avere paura che Amazon faccia le sue ricerche di mercato per costruire i magazzini proprio laddove la popolazione giovanile è meno alfabetizzata e meno sindacalizzata? É così misero avere paura che le nuove IA possano provocare dipendenze ancora maggiori dei social network? Non è proprio lecito avere paura che sempre più milioni di euro vengano ceduti da risorse pubbliche a industrie digitali?
Se si volesse andare oltre le paure forse bisognerebbe prima ascoltarle, comprenderle, descriverle. Infine, non sempre il rifiuto delle tecnologie è dovuto solo a paure. Uno studio molto interessante ha ripercorso i motivi per cui nelle scuole statunitensi non si siano mai diffuse in tutto il XX secolo tecnologie come cinema, TV e radio nonostante le forti pressioni dall’alto. La risposta è che non erano considerate dagli insegnanti validi strumenti di apprendimento.[4] Quindi non tutte le paure per le tecnologie sono risibili e non tutti i rifiuti per alcune tecnologie sono dovuti a paure.
Il presupposto più forte di Oltre la tecnofobia è quello più nascosto, ovvero che ogni paura verso ogni tecnologia sia infondata. Tuttavia, non una pagina è dedicata a spiegare cosa sia la paura, e nemmeno si nomina la nomofobia, una delle più diffuse, quella di rimanere senza cellulare. La paura però non è un’emozione umana negativa, poiché aiuta la concentrazione della mente. La paura dà consapevolezza ed è ciò che permette di darci il giusto coraggio per affrontare i pericoli. Nella mia esperienza a stretto contatto con le paure di genitori e insegnanti per le tecnologie digitali, credo di poter dire che oggi una delle paure più grandi sia quella di parlare pubblicamente degli effetti negativi sulla vita familiare (benché siano osservati quotidianamente). Ogni discorso pubblico deve iniziare con questa frase: “io non sono contrario alle tecnologie” oppure “non voglio certo demonizzare le tecnologie”. Si tratta di una devozione fobica verso la tecnologia che il filosofo tedesco Anders ha descritto come “vergogna prometeica”: “non c’è nulla di più scabroso oggi, nulla che renda una persona prontamente inaccettabile quanto il sospetto che sollevi delle critiche nei confronti delle macchine”.[5] Il libro sostiene al contrario che si possono “liquidare le preoccupazioni legate alle tecnologie digitali come ansie convenzionali derivanti da atteggiamenti conservatori verso il progresso” (p.63). Mentre Anders è al centro del dibattito filosofico contemporaneo, il libro ripropone ancora l’antitesi Progresso e Conservazione del lontano XIX secolo. Ma si può davvero scrivere oggi un pamphlet oltre la tecnologia senza ascoltare le paure che le famiglie vivono oggi per alcune precise tecnologie senza essere ideologici?
UNA VISIONE IDEOLOGICA
Gli autori hanno definito la “tecnofobia umanista” una “delle influenti ideologie del giorno d’oggi” (pp. 88-89). Il termine ideologia è di derivazione marxista ma nel gergo accademico contemporaneo ideologico è il contrario di scientifico. Ideologico è tutto ciò che introduce posizionamenti etici in un discorso sociale anziché restare rigorosamente neutro: “La scienza non dovrebbe essere prescrittiva, poiché il suo ruolo principale è quello di far luce sui fenomeni piuttosto che giudicarli” (p.67 ). Per Gramsci, al contrario, l’ideologia è il posizionamento all’interno della società rispetto ai rapporti di sfruttamento capitalistico, rapporti a cui non ci si può sottrarre. Inoltre Gramsci odiava l'indifferenza che “opera potentemente nella storia”. Siamo sicuri che questo pamphlet faccia luce sui fenomeni piuttosto che giudicarli? Alla fine questo libro prende una posizione, proprio per l’ostentato oggettivismo scientifico, poiché il posizionamento etico non si deduce dall’epistemologia ma la precede. Questo libro infatti non si schiera contro chi cerca di operare in modo diverso dall’industria digitale di oggi? Perché tutto questo accanirsi contro le famiglie che fanno dei patti per difendersi dall’invasione dell’industria digitale sulla pelle delle nostre bambine? Perché questo accanirsi insieme a Lancini ad accusare i genitori che sono invece le prime vittime di questa industria digitale senza scrupoli? Perché evitare di “incolpare la tecnologia digitale” (p.67) come fosse un essere umano da difendere?
É abbastanza ovvio che gli oggetti tecnologici non siano né colpevoli né innocenti e che le responsabilità siano solo umane: ma perché in tutto il libro non viene spesa una parola su chi queste tecnologie le possiede, le progetta e le usa come mezzi per arricchirsi con videogiochi, social network, pornografia, etc...? Il vizio più grande del libro è l’apparenza di oggettività scientifica da cui deborda un attacco continuo alle vittime: chi cerca di dar regole allo strapotere delle Big Tech. Così come nel XIX secolo in nome del Progresso c’era chi difendeva lo sfruttamento del lavoro minorile, oggi abbiamo trovato chi per la stessa incondizionata fede nella Tecnologia, difende il potere di sfruttamento delle Big Tech.
Spesso, spiegava sempre Gramsci, ciò che accade nella storia avviene non tanto perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Così l'ostentato ottimismo spesso non è altro che un modo di difendere la propria pigrizia, le proprie irresponsabilità, la propria volontà di non fare nulla di fronte a quanto accade. Ed era precisamente in questa forma di fatalismo che Husserl vedeva nel 1936 l’origine della crisi delle scienze europee: nell’oggettivismo della matematizzazione, nell’assenza di prescrizioni e nella distanza dal mondo della vita. È proprio heideggeriano l’orizzonte teorico del pensiero di Oltre la tecnofobia: poiché non si danno speranze ad altre tecnologie, si finisce per far credere che la Tecnologia sia un Destino anziché una scelta umana. Tra gli autori portati come testimoni mi sembra proprio però che né Benjamin, né Stiegler, né Freire, né Debord, fossero dell’idea che bisognasse abitare farmacologicamente la catastrofe causata dalle Big Tech. Direi piuttosto che hanno passato l’intera vita a lottare contro chi, con le tecnologie, ha sfruttato gran parte dell’umanità a partire dai suoi figli più piccoli.
NOTE
[1]Il XVIII secolo vedeva con favore la sostituzione della forza animale, quando la macchina a vapore sostituisce il cavallo. Le cose cambiano con la Rivoluzione Industriale a proposito della quale Simondon notava come l’alienazione non fosse un dato solo economico e giuridico di estraneità ai mezzi di produzione, ma un dato psicologico e fisiologico di percezione della mancanza di prolungamento dello schema corporeo. Infatti, per tutti gli illuministi e per Marx stesso “la frustrazione dell’uomo inizia con la macchina che sostituisce l’uomo” (Simondon, Del modo di esistenza degli oggetti tecnici), essa infatti più che far risparmiare lavoro al lavoratore per lo più fa risparmiare soldi al capitalista. È quindi con l'arrivo della macchina utensile nella Rivoluzione Industriale che si pone la questione della tecnologia (Technologie) da distinguere dalla tecnica (Technik). La tecnologia è tutta moderna e implica l’analisi delle forme elementari in cui si scompone il movimento del corpo umano, un logos incorporato nell’utensile e mosso da una macchina. Comporta un’oggettiva conoscenza dei processi produttivi, integrata dalla precisa oggettività delle scienze naturali: nella tecnologia non deve rimanere spazio per la scelta autonoma della mano umana.
[2]Da parte mia sono un entusiasta fautore di automobili con guida automatizzata che non superino mai i limiti (ops che parolaccia tecnofobica!) di velocità, obbligatoriamente disponibili solo (ops un altro divieto!) in carsharing e solo fuori dalle città.
[3]La storia tecnologica dell’Homo sapiens è sempre meno descritta in termini lineari, bensì sempre più spesso è ricostruita privilegiando l’evoluzione a spirale, ramificata, pluriversa, se non persino ciclica: cf. Graeber, Wengrow, L'alba di tutto. Una nuova storia dell'umanità (2021) o Diamond, Collasso, Come le società scelgono di morire o vivere (2005). L’evoluzione tecnologica della nostra civiltà sarebbe in questo quadro una eccezione.
[4]Cuban, Teachers and Machines, The Classroom Use of Technology Since 1920 (1982).
[5]Anders L'uomo è antiquato (1956). Anders parlava propriamente di antiquatezza dell'essere umano (Die Antiquiertheit des Menschen). Sulle rivalutazioni di Anders nel dibattito filosofico contemporaneo cf. la rivista “aut aut”, n. 397/2023 “L’uomo è antiquato? Günther Anders e la scena attuale”.
A confronto con il pensiero di Platone: la memoria e la sua corruzione nell’era digitale.
A giugno di quest’anno Controversie ha organizzato un seminario in forma di tavola rotonda sul tema dell’ontologia dell'intelligenza Artificiale. Durante il dibattito è emersa la possibilità che i grandi modelli linguistici (LLM) si possano affermare – tra le diverse applicazioni che già si intravedono – come una sorta di bibliotecario con pretese di universalità. Questa ipotesi è ben delineata da A. Colamedici e S. Arcagni, nel loro libro L'algoritmo di Babele. Storie e miti dell'intelligenza artificiale (Solferino Libri, 2024) e suggerita tra le righe da Luca Sofri "Intelligenze artificiali" tra virgolette, nel suo blog Wittgenstein.
La biblioteca universale, la biblioteca fantastica che contiene tutto ciò che è stato scritto e che potrà essere scritto, è un tema che – in maniera ricorrente – prende forma nelle riflessioni di filosofi e letterati, da Leibniz allo scrittore Kurd Laßwitz, detto anche Velatus, fino ad ossessionare Jorge Borges (La Biblioteca di Babele) e a ispirare l’imprenditore Brunello Cucinelli, che nel 2022 annuncia la realizzazione di una “sua” biblioteca universale, a Solomeo, dedicata ai lavoratori delle sue aziende.
Il tema della biblioteca è strettamente connesso con quello della memoria; ritrovare un passo di un libro, di un autore richiede di averne memoria e di riuscire a situare questo scampolo di memoria nello spazio della propria biblioteca mentale e, solo successivamente, a ritrovare la collocazione di quell’autore o di quel libro all’interno della propria libreria o di una biblioteca istituzionale o pubblica.
Ecco, una potenziale funzione dei LLM è proprio di fare da contenitore molto ben indicizzato di grandi quantità di conoscenza, e di trovarle e metterle a disposizione degli utenti in modo ragionato e selettivo, su richiesta espressa in linguaggio naturale. E, proprio per la loro capacità di gestire volumi enormi di informazioni in tempi ragionevoli, può tendere a quel grado di infinito sotteso dall’espressione “universale”.
A contrasto con questa idea e prospettiva, vi proponiamo una riflessione di Fabio Talloru sulla memoria e su Platone, che per la memoria e la sua rilevanza nel pensiero umano aveva un debole.
-----
Se ancora oggi Platone viene inquadrato come filosofo sradicato dalla concretezza del mondo e proiettato nell’Iperuranio, ciò è dovuto perlopiù alla ormai superata (ma ancora presente) visione diffusa dalla formazione scolastica ordinaria. Invece, la filosofia di Platone è profondamente radicata nel mondo fisico e materiale.
Ѐ noto a tutti che per Platone vi sia una memoria di genere immortale, la quale provvede alla reminiscenza (anamnesis) degli oggetti intelligibili. Meno noto e poco esplicito nei dialoghi è invece l’altro genere, quello “mortale” (non è questo il termine platonico), inteso come proprio della condizione incarnata dell’Anima immortale in un vivente (zoòn).
La Memoria (mneme) è una delle facoltà dell’anima, quella di imprimere, tracciare o racchiudere nella forma di ricordo (hypomnema) le informazioni che otteniamo da oggetti incontrati attraverso l’esperienza empirica. Essa è l’insieme di ciò che si è sedimentato nell’anima a partire dalle sensazioni memorabili, prodotte dall’esperienza che facciamo di oggetti che esistono fisicamente nel mondo empirico (il processo completo è esposto nel discorso fisiologico contenuto nel Timeo1).
Il tema che ci interessa indagare in questo articolo è quello della “volatilità” del sapere in Platone, per produrre nuovi spunti di riflessione che siano utili nel dibattito odierno.
Ri-memorazione e memoria mortale.
La reminiscenza (anamnesis) è un’operazione prodotta dalla sola Anima immortale. Più propriamente essa è una forma del ri-memorare oggetti visti nella condizione disincarnata. L’operazione dell’apprendimento (mathesis) di nozioni avviene, invece, durante la vita e il contenuto di una memoria “mortale” (il ricordo) può dissolversi irrimediabilmente. La memoria nella sua totalità cessa definitivamente la propria esistenza con la morte del vivente che lo possiede, perciò con lo scioglimento dei vincoli tra l’anima e il corpo.
In primo luogo possiamo affermare l’esistenza di una memoria “mortale” nel pensiero di Platone per almeno due ragioni:
- non ci è pervenuta nessuna traccia diretta, testimonianza indiretta o qualsiasi forma di accenno a proposito della possibilità di reminiscenza di ricordi appartenenti a vite passate - come invece è presente nelle dossografie pitagoriche2, che Egli conosceva e custodiva gelosamente nella propria biblioteca;
- nei dialoghi che affrontano problemi legati sia alla reminiscenza che alla metempsicosi, troviamo l’idea che a ogni nuova incarnazione debba esservi un “reset” della memoria in relazione alla vita empirica (si veda nello specifico il “Mito di Er”3)
Durevolezza delle forme della conoscenza.
Parrebbe anche che, sul piano mortale, le conoscenze pratiche e dell’esperienza empirica siano più durevoli rispetto a quelle epistemologicamente superiori (“scientifiche”) del filosofo o del matematico - i quali hanno come proprio oggetto ultimo gli intelligibili.
Questo lo si può dedurre in particolare da un passo del prologo drammaturgico del Timeo. Qui Crizia il Giovane riporta un racconto che apprese da bambino, nel quale Solone incontrò in Egitto un sacerdote che così affermava:
«“Siete tutti giovani d’animo (voi greci) [...] perché non avete nelle vostre anime nessuna opinione antica trasmessa attraverso una tradizione che proviene dal passato né alcun sapere ingrigito dal passare del tempo».
Prosegue poi con la motivazione di questa brevità della memoria collettiva che imputa ai greci:
«ogni cosa viene registrata, fin dall’antichità, nei nostri templi e conservata alla memoria», mentre in Grecia «a intervalli regolari di tempo, come una malattia, torna il flusso del cielo che vi inonda e non lascia illesi fra voi che gli illetterati e i nemici delle Muse (gli incolti), sicché ricominciate nuovamente dal principio, come tornati giovani». Per di più, aggiunge il sacerdote: «nel corso di molte generazioni, i sopravvissuti sono morti senza aver fissato la loro voce nella scrittura». (Tim. 22 d – e)
In questo passo possiamo individuare almeno sei punti di riflessione ancora validi nel contesto d’oggi:
- la scrittura esprime qui il suo ruolo di strumento tecnico corruttibile ma preservabile dalla distruzione, perciò tramandabile;
- la scrittura è uno strumento tecnico ausiliario, che richiede una stabilità materiale continuativa della società per essere mantenuto e motivato nell’uso ordinario;
- il vivente mortale, se non ha né la possibilità né la premura di tramandare il prodotto della propria conoscenza, non conserverà un sapere collaudato da mettere a disposizione dei posteri;
- la condizione del dopo-catastrofe è analoga a un “momento zero” della memoria mortale, un “cominciare nuovamente da principio” simile a quello di un'anima incarnata;
- i saperi pratici “degli illetterati e degli incolti” sopravvivono più facilmente rispetto a quelli di filosofi e scienziati; sono inoltre propedeutici a porre le basi di quella stabilità materiale e tecnica che rende possibile l’accumulo del sapere;
- l’accumulo di un sapere avanzato e complesso, come quello “scientifico” (episteme), non è necessario alla vita, ma è un “in più”.
Platone nei suoi dialoghi ci indica anche che, quando si sia memorizzata un’informazione, la sua durevolezza dipenderà non solo dalle condizioni in cui il suo proprietario la custodisce e preserva, ma anche da come egli l’ha ottenuta. Ad esempio, Crizia il Giovane racconta una storia di cui ha acquisito un ricordo “vivido”, in quanto giovane, attento e partecipativo nel momento del suo apprendimento4. Un caso diverso è invece quello di Fedro che, nel dialogo omonimo, deve confrontarsi con un’opera scritta che necessita di rileggere più volte per ricordarla “alla lettera” al fine di poter tenere il proprio discorso5 basato su di essa.
Nel primo caso, quello di Crizia, la qualità del ricordo è dovuta alle caratteristiche che contraddistinguono il momento in cui egli ha appreso un’informazione, ossia la pregnanza dell’esperienza di apprendimento dei fanciulli. Nel secondo caso, quello di Fedro, la qualità della formazione del ricordo sarà dovuta all’ausilio di strategie mnemotecniche, quali la rilettura e la ripetizione a voce alta.
Conclusioni e domande aperte.
Per concludere, il problema della conservazione, del tramandare e della possibile perdita della memoria (nel senso più ampio che comprende storie, tradizioni, tecniche e conoscenze) è un fenomeno oggi ancora più complesso. In particolare se guardiamo al fenomeno di progressiva sostituzione dei mezzi “tradizionali” di trasmissione dell’oralità e della scrittura manuale in favore della digitalizzazione dell’informazione.
Quante tipologie e forme di “memoria” abbiamo a oggi sviluppato e quali si stanno depotenziando o stanno scomparendo?
Quante forme della scrittura possediamo e quali competenze sono necessarie per farne uso?
Quanti livelli di linguaggio e quante forme di linguaggio esistono per la sola codificazione informatica dell’informazione?
Quali i pericoli a cui si espone la loro conservazione?
Ai cataclismi menzionati dal sacerdote egizio incontrato da Solone, evidentemente ancora presenti e comunque imprevedibili quali si aggiungono oggigiorno?
Ovviamente, sono queste tutte domande complesse che richiedono risposte altrettanto articolate. Ad esempio, per i supporti di archiviazione digitale, da cui oramai dipendiamo largamente, sono deleteri i fenomeni elettrici, magnetici ed elettromagnetici, i quali sono tutti in grado di cancellare, corrompere o rendere inaccessibili, se non addirittura irrecuperabili, le informazioni registrate.
L'informazione digitale e la sua memorizzazione quanto sono volatili? Quanto durevoli? Quanto sono "delicate"?
La stessa obsolescenza delle tecnologie e delle tecniche di conservazione e riproduzione dell’informazione, giorno per giorno avvia verso la fine la riproducibilità delle precedenti forme di “memoria”, sia collettiva che individuale (foto, video, documenti, scansioni di immagini, etc.). Gli attuali dispositivi che possediamo saranno sempre meno reperibili con l’avanzare di nuove tecnologie e dei relativi sistemi che ne permettono il funzionamento?
I dispositivi attualmente in uso, per quanto collaudati, non saranno un giorno più compatibili con quelli più avanzati, per protocolli di scrittura e lettura?
Saranno reperibili le tecnologie di giunzione che permettono di interfacciare fisicamente vecchi e nuovi dispositivi di archiviazione di memoria?
Le tecnologie di traduzione e conversione reciproca tra vecchi e nuovi protocolli di archiviazione dell’informazione saranno ancora implementate sui nuovi dispositivi o saranno ancora reperibili e adoperabili?
Quali altre problematiche sono riscontrabili o sono di imminente larga diffusione?
La memoria è un affare complesso, sia individuale che collettivo.
NOTE:
1 Tim. 42 d - segg. e 69 c - segg.
2 Centrone, B. 1996, Introduzione a i pitagorici, Editori Laterza, Roma-Bari, pp. 52-61
3 Resp. 614 b - 621 d
4 Tim. 26 b
5 Phaedr. 228 a
Recensione di Oltre la tecnofobia, il digitale dalle neuroscienze all’educazione - Terza parte
Dopo una sintetica recensione del libro Oltre la Tecnofobia (qui), una critica al concetto di onlife e della rimozione dell'infanzia (qui), Simone Lanza continua a confrontarsi con le tesi degli autori e affronta i punti nodali del libro, le implicazioni cliniche e pedagogiche dei disagi sociali provocati dall’uso precoce e prolungato degli schermi.
---
LA DIPENDENZA DA INTERNET NON ESISTE?
Sappiamo che gli smartphone alterano il ciclo dopaminergico, creano abitudini e persino dipendenze: non è un mistero perché questo è descritto da chi disegna queste app per metterle gratuitamente sul mercato riuscendo a trarne profitti enormi. Al giorno d’oggi esiste un’ampia discussione sulla classificazione delle varie dipendenze da internet, trattandosi di un tema di salute pubblica delicatissimo. Incuranti della complessità della situazione gli autori di Oltre la Tecnofobia hanno deciso di abbracciare le posizioni di Matteo Lancini, che sostiene che il disagio dei giovani non sia da attribuire all’iperconnessione, bensì alle “mamme virtuali”. Avvalendosi di Lancini, il fenomeno degli hikikomori è così commentato dagli autori: “I media digitali lungi dall’essere la causa del ritiro, sono piuttosto ciò che consente a questi adolescenti di rimanere ‘attaccati’ al mondo evitando un esito psicotico della loro sindrome”. (p.95) Gli autori sostengono ogni abuso debba considerarsi nocivo, ma che ciò non deve condurci – ed questo il tema che sta loro molto a cuore - a “incolpare la tecnologia digitale” (p.67)! Come si fa pensare di poter dare la colpa alla tecnologia se non la si è già prima antropomorfizzata?
Per loro “l’utilizzo specifico è dettato e condizionato dal modello di società contemporaneo” (p.67), ma non spendono una parola a spiegare come le tecnologie digitali modellino la società. Credono di dovere emettere una sentenza sulla colpevolezza o innocenza della Tecnologia (al singolare, si vedrà poi perché), ma non si esprimono mai sugli umani che sono proprietari di queste tecnologie e le usano come mezzi di produzione. Come se le finalità non fossero di chi progetta le Tecnologie. L’antropomorfizzazione della Tecnologia consiste nel neutralizzare ogni carattere etico e politico della tecnica, rimuovendo il ruolo degli umani che vi investono soldi. Questo è proprio il carattere ideologico, su cui si tornerà, mai messo in discussione in questa edulcorante Weltanschauung.
Non esiste Una dipendenza da internet o da smartphone ma le organizzazioni mediche stanno mettendo a fuoco molti disturbi legati all’uso compulsivo di queste tecnologie. Si tratta di fasce sempre più vaste della popolazione che sono risucchiate in comportamenti patologici indotti per così dire dal design. La visione di chi sostiene che la psicosi non solo non venga amplificata dall’effetto schermo ma persino lenisca la malattia e mantenga attaccati al mondo (sic), è estrema, molto discutibile e pericolosa dal punto di vista terapeutico.
Sulla questione clinica, vorrei rassicurare le decine di migliaia di genitori che chiedono ai loro figli di uscire dalla stanza, che non tutti la vedono come Lancini e che ci sono terapisti che aiutano gli adolescenti a distaccarsi dall’oggetto che produce la loro dipendenza (lo schermo), senza far sentire in colpa i genitori.
In ogni caso è chiaro che questo libro vorrebbe mettere un bavaglio a chi solleva la questione del disagio sociale, bollandolo come tecnofobico. E allora possiamo dire tranquillamente che il re è nudo perché la prova più evidente che le categorie di uso e abuso siano inadeguate a interpretare la complessa questione di salute pubblica (di cui gli hikikomori sono solo una parte) è testimoniata dal fatto che le Big Tech come Meta, pur di non farsi dare regole, sono disposti a darsele da sole.
Ad oggi l’OMS ha già riconosciuto la dipendenza da videogioco e da gioco d’azzardo, mentre esiste una vasta discussione sulla classificazione di altre forme di dipendenza da internet (oltre al fenomeno degli hikikomori, c’è la dipendenza da relazioni virtuali e social network, la net compulsion o shopping online, dismorfismo, etc...), si tratta di molti comportamenti patologici che sono soggetti a studi perché in continuo (non rassicurante) aggiornamento, dove il confine tra dipendenza e abitudine è sfumato. In ogni caso gli autori non hanno dubbi sul dover sollevare da ogni responsabilità la Tecnologia digitale quasi fosse una umana presenza.
Non stupisce quindi che gli autori critichino Jonathan Haidt, reo di avere pubblicato La generazione ansiosa. Riprendendo quasi alla lettera una precedente recensione (V. Gallese, Haidt: quelli che... il digitale, in “Doppiozero”, 17/9/2024) bollano come tecnofobico un libro documentatissimo che contiene quasi un migliaio di fonti. La questione è che dal 2012 è aumentato in modo intensivo l’uso dei social network tra le adolescenti ma sono anche aumentati fenomeni di ansia, depressione, isolamento e suicidi. Per Haidt non c’è solo correlazione ma anche un nesso di causalità. Gli autori propongono altre cause più complesse: “accesso alle armi, la discriminazione, l’isolamento sociale e le difficoltà economiche” (p.66). Nel libro (a differenza di quello di Haidt) non c’è però nessun tentativo di convincere il lettore che queste siano le cause plausibili. Non vi sono spiegazioni per cui non mi è possibile comprendere questa loro diversa ipotesi. Trovo difficile capire come l’accesso alle armi, la discriminazione, l’isolamento sociale e le difficoltà economiche possano essere state la causa di comportamenti non certo patologici ma che hanno costretto il CT Spalletti a regolamentare rigidamente l’uso dei dispositivi durante la fase finale di Euro 2024 agli atleti della nazionale di calcio maschile.

Lasciamo a chi legge farsi un’idea del dibattito tra Jonathan Haidt e Candice Odgers, suggerendo il franco confronto pubblicato su MicroMega 3/2025 (“Disconnessi. L’impatto dei social sulle nostre vite”). Un altro confronto è stato pubblicato da Internazionale. Mi limito a due osservazioni. La prima è che se esiste una correlazione questo dovrebbe costituire un campanello d’allarme sufficiente per applicare il principio di precauzionalità fino a nuovi e approfonditi studi, proprio perché la correlazione non implica ma non esclude affatto la causalità. In secondo luogo vorrei ricordare Austin Bradford Hill, il noto epidemiologo britannico, celebre per i suoi studi che hanno dimostrato il rapporto tra fumo e cancro polmonare (quando ai suoi tempi in tanti sottovalutavano la correlazione, sic). Hill aveva elaborato una serie di nove criteri per dedurre la relazione causale tra un fattore di rischio e una malattia sulla base di correlazioni statistiche. Allora le lobbies del tabacco insistevano proprio con le stesse argomentazioni di oggi: “Correlation does not imply causation”. Gli autori sono più avanti: la correlazione è il contrario della causalità e pertanto qualunque divieto va escluso e ogni regolazione rifiutata. E veniamo così alla quarta critica, alla questione educativa.
VIETATO VIETARE!
Gli autori ci propongono l’idea pedagogica rivoluzionaria, del tutto simile a quella del 1968: vietato vietare. Non citano questo slogan di vecchia data, ma lo aggiornano e lo ampliano persino alla protezione: “ogni scelta di protezione o di divieto non è educativa” (p.). Per loro controllo, divieto e protezione sono la stessa cosa. Iniziamo quindi con il rassicurare chi legge che il pedagogista Paulo Freire, certamente caro ai sessantottini e da loro invocato come punto di riferimento teorico, non era certo incline a posizioni libertine che “vedono una manifestazione d’autoritarismo in ogni legittima espressione di autorità”. Freire era incline invece a una posizione più pacata, quella di una persona “democratica, coerente con il suo sogno solidale ed egualitario, per la quale non può esistere autorità senza libertà o questa senza l’altra.”
Oggi nel dibattito pedagogico contemporaneo, proprio seguendo Freire non è possibile concepire l’autorità senza la libertà, ma nemmeno la libertà senza l’autorità. L’appello a sviluppare pensiero critico suona retorico e Freire si lamentava proprio dell’assenza dei limiti normativi. Gli autori si spingono ad asserire persino che ogni protezione è autoritaria: ma come spiegare le leggi contro il lavoro minorile? E i divieti di balneazione? E il divieto di passare con il rosso al semaforo sarebbe diseducativo? Non sempre applicare un divieto produce un effetto contrario.
La realtà di oggi sembra al contrario esser dominata da un’assenza di limiti e regole, al punto che, per dirla con un noto slogan pubblicitario, “l’unica regola è che non ci siano più regole”. Secondo Daniel Marcelli, punto di riferimento nel dibattito francese sulla crisi dell’autorità genitoriale, domina oggi invece “il bambino sovrano” in un vuoto epocale di autorità. In un altro contributo Marcelli sostiene che in pedagogia sia persino auspicabile obbedire.
L'obbedienza lungi dall'essere virtù negativa è indispensabile nella relazione pedagogica che si basa sulla fiducia. L'obbedienza non è la sottomissione. Autorità e obbedienza hanno significati anche positivi a differenza della sottomissione a un potere. La sottomissione si ottiene attraverso l'obbligo o la seduzione, mentre l'obbedienza (educativa non politica!) si fonda su un rapporto di fiducia. Quando sarai grande ti spiegherò, ma adesso fidati e obbedisci, perché non tutto può essere spiegato e contrattato. Questo è vero soprattutto nell’infanzia. Proprio l’obbedienza conduce all'indispensabile libertà di disobbedire nella maturità. Persino Don Milani teorico di L’obbedienza non è più una virtù, aveva idee ben chiare sull’autorità del docente e sull’importanza dell’obbedire in classe! Anche qui la mancanza di distinzione tra adolescenza e infanzia non permette agli autori di inserirsi nel dibattito pedagogico attuale su autorità, autorevolezza, obbedienza, sottomissione, libertà su cui per altro le filosofie femministe italiane hanno dato importanti apporti. Assenza di regole, di limiti, di paletti sono invece i concetti base di una pedagogia corrente molto diffusa, basata sulla seducazione (termine coniato da Gilles Lipovetsky per descrivere uno stile educativo basato sul tentativo di sedurre il bambino anziché di educarlo in senso tradizionale) e sulla deresponsabilizzazione degli adulti, incapaci di gestire il sano conflitto educativo, pedagogia corrente che è però distante dal dibattito pedagogico sulla crisi dell’autorità genitoriale aperto da Arendt.
Del resto Gli autori sono davvero così inclini a lasciare che i loro figli o nipoti guardino film pornografici a otto anni perché vietarglielo significherebbe poi che i loro pari in un atto di giustizia retributiva faranno vedere loro film porno? Per loro tutto va contrattato, trasfigurando l’idea del pedagogista francese Meirieu, che non solo propone la contrattazione educativa ma anche l’autorità del docente e la necessità della sanzione, per non parlare degli interrogativi sulla “strumentalizzazione del digitale da parte del sistema di mercato” (Meirieu , La scuola e la sfida del digitale).
Se la critica all’autoritarismo poteva funzionare nel XX secolo, che iniziò quando Ellen Key scrisse Il secolo del fanciullo, oggi lo slogan vietato vietare non è altro che, come rileva sempre Marcelli, l’anticipazione del credo neoliberista in ambito pedagogico. Questa seducazione incapace di vietare inculca con l’esempio il credo neoliberista dominante. Teorizzare oggi un “antiproibizionismo digitale” significa abbracciare le posizioni dell’individualismo e del narcisismo più sfrenato che già il nostro sistema economico e culturale promuove abbondantemente, anche grazie alle piattaforme.
Per sostenere la tesi che “ogni scelta di protezione o di divieto, in senso proprio, non è educativa” (p.147), si è dovuto alterare il senso profondo della dialettica di Paulo Freiere e storpiare il concetto di contrattazione di Merieu, perché questo assunto, in campo pedagogico, è poco difendibile. Promuovere questa deregulation educativa costituisce al contrario la quintessenza del credo dominante, propugnato tanto dagli autori quanto da Trump e dalle Big Tech: eliminare ogni limitazione persino nell’infanzia.
Eppure i limiti sono proprio ciò che permette di educare: come qualsiasi pedagogista, allenatore, educatore o insegnante sa bene, la difficoltà consiste semmai in dove e come mettere i limiti, ma non se metterli
Nella quarta e ultima parte, si entrerà nel merito del concetto stesso di tecnologia, di fobia e si descriverà chiaramente la funzione ideologica di questo libro.
Recensione di Oltre la tecnofobia, il digitale dalle neuroscienze all’educazione - Seconda parte
Dopo una sintetica recensione del libro Oltre la Tecnofobia (qui), Simone Lanza continua a confrontarsi con le tesi degli autori, e inizia – con questo secondo passo - il suo ragionamento analitico di messa in discussione dell'onlife e della adultizzazione dell’infanzia come effetto mediatico anziché come dato naturale.
---
Oltre la Tecnofobia intende criticare i tecnofobici, ma chi sono i tecno-fobici oggi? Doveroso esplicitare, che nessuno si definisce tecno-fobico (né tecno-ottimista). Sotto questa etichetta gli autori criticano apertamente almeno lo studioso Haidt, il Ministro Valditara per le circolari, Alberto Pellai e Daniele Novara per le posizioni pubbliche di proposta di legge. Tuttavia, in generale anche se non in modo esplicito tutti quelli che vogliono regolamentare il digitale.
Gli autori, poi, in particolare, hanno a cuore che le famiglie facciano liberamente usare le tecnologie digitali senza dare indicazioni che seguano il principio di gradualità, anzi continuando a porre l’equazione: limiti e regole denotano tecnofobia. Le mie critiche, quindi, spazieranno su tutti gli aspetti di questa enorme costruzione ideologica: partirò dal mostrare le aporie relativa all’adolescenza, per finire sulle incoerenze nel respingere ogni paura per le tecnologie, come se oggi l’umanità non disponesse di tecnologie spaventose.
Gli esseri umani non mangiano il cibo nei primi mesi, non maneggiano coltelli nei primi anni, non guidano macchine nei successivi e per quanto riguarda l’uso di alcol e tabacchi le leggi, nonostante molte resistenze, hanno finito per dare limiti di età. Ma perché per l’uso di smartphone (e di schermi in generale) i nostri autori ritengono che non sia importante porsi la domanda: quali regole e a partire da quale età?
LA RIMOZIONE DELL’INFANZIA
La risposta a questa domanda è che l’intero libro si regge su una concezione dell’adolescenza che ignora platealmente ciò che la precede: l’infanzia. Gli autori liquidano con sufficienza l’idea che i minori possano essere "soggetti fragili per ragioni anagrafiche, qualcuno che è più esposto al rischio" (p. 145), rifiutando qualsiasi protezione basata sull’età. Se avessero preso in considerazione maggiormente l’infanzia forse avrebbero potuto comprendere anche loro qualche paura legittima dei genitori di oggi, ma in tutto il libro veramente poche righe sono dedicate all’infanzia, e come per Lancini, il riferimento implicito è sempre un ragazzo prossimo alla maturità (il povero diciassettenne), per il quale quella definizione di minore potrebbe essere riduttiva, ma che riduttiva non è se fosse riferita all’infanzia. Malgrado gli sforzi adultizzanti degli autori l’adolescenza resta però la terra di mezzo tra adultità e infanzia.
Del resto Bernard Stiegler (che costituisce uno dei riferimenti teorici degli autori del libro), si era dedicato a denunciare con estrema forza l’impatto devastante delle tecnologie sui bambini proprio nell’opera dove ha tematizzato il concetto di pharmakon. Ed è stato proprio Stiegler che dalle sue premesse teoriche traeva conclusioni opposte a quelle dei nostri autori, prendendo una posizione netta in quella che definì senza mezzi termini “la strage degli innocenti”, cioè l’impatto devastante delle Big Tech sull’infanzia.
Questa mancanza di considerazione degli impatti sull’infanzia da parte non tanto della Tecnologia quanto dell’industria culturale (termine che i nostri autori non usano mai a differenza di Stiegler) è proprio ciò che aveva condotto Postman (La scomparsa dell’infanzia, 1982) a parlare di adultizzazione dell’infanzia e infantilizzazione dell’adultità quale effetto dell’uso esasperato dei mass media. Senza questo doppio movimento ogni considerazione attuale sugli impatti in età adolescenziale (e infantile) risulta superficiale e fuorviante, nonché disarticolata dal vero dibattito di oggi: mettere a fuoco in cosa consista l’esposizione precoce e prolungata agli schermi e capire quando una certa quantità di tempo schermo non si trasformi in vero e proprio veleno per il tempo di sonno, per il tempo all’aria aperta, per il tempo di lettura, che restano tempi di apprendimento essenziali (come ben sanno del resto tutti i Ceo e ingegneri della Silicon Valley, nonché le famiglie statunitensi con redditi sopra i 100.000 dollari, che per lo più evitano gli schermi ai loro figli in giovane età e applicano il principio di gradualità). Il riferimento principale dei nostri autori non è all’infanzia bensì all’adolescenza, ma in realtà i nostri autori operano su entrambe quel processo di rimozione della loro specificità, operata (come ci insegna Postman) proprio dallo schermo: adultizzare il bambino, sottraendolo al suo processo graduale di divenire adulto.
ONLIFE: RAPPRESENTAZIONE O ESPERIENZA?
La seconda critica che si può rivolgere è che l’assunto (ipotesi da dimostrare), che non ci sia più distinzione tra l’esperienza dal vivo e quella di fronte a uno schermo non si basa su prove empiriche ed è teoreticamente abbastanza contraddittoria. Gli autori di Oltre la Tecnofobia si riferiscono molto al filosofo Walter Benjamin. Egli, infatti, designò fotografia e cinema come media che avevano modificato l’inconscio ottico: zoom, rallenty o slow motion, replay, etc., rendevano visibili cose che l’occhio nudo non poteva mettere a fuoco cambiando l’intera percezione del mondo. La stessa capacità di attenzione e di esperienza ne venivano modificate ma non per questo Benjamin teorizzò l’indifferenza ontologica tra i due tipi di percezione. Il nostro corpo-cervello elabora in modo simile ma non identico digitale e reale, altrimenti – come ammettono gli stessi autori – non saremmo in grado “di distinguere tra presenza fisica e digitale” (p.41). Il problema dei bambini di oggi è però che l’esposizione precoce e prolungata agli schermi riduce le capacità di questa distinzione. Il punto fondamentale è che gli autori insistono sul fatto che il corpo-cervello elabora rappresentazioni simili nel mondo virtuale e nel mondo reale. Teniamo in sospeso la domanda se questo sia vero o meno. Il filosofo ebreo-tedesco Benjamin non insistette solo sui diversi modi di percepire il mondo (decisamente molto meno sulla rappresentazione) bensì sui modi di viverlo: proprio l’esperienza (Erfahrung) narrabile e condivisibile è qualcosa di molto prezioso che nella modernità rischierebbe di essere annullato dall’esperienza vissuta (Erlebnis) che caratterizza invece il mondo caotico e veloce della società dominata da pubblicità e merci (Benjamin del resto non pensava che il capitalismo fosse la fine della storia).
Gli autori di Oltre la Tecnofobia riducono la differenza tra reale e virtuale a quella tra 3D e 2D, senza considerare la multi-sensorialità. Riducendole a rappresentazioni simili, disconoscono le differenze specifiche delle due esperienze. Dal punto di vista del bambino (che per altro quando nasce ci vede ben poco) ciò che differenzia l’esperienza dal vivo e quella tramite schermo non è solo la rappresentazione ma l’esperienza, che si fa con i cinque sensi del corpo (sporcandosi le mani e saltando nelle pozzanghere). Prendiamo un kiwi: il modo con cui il bambino vive e conosce un kiwi per la prima volta passa molto meno dalla rappresentazione, che dalla mano e dalla bocca. La multi-sensorialità è ciò che distingue il mondo come rappresentazione (quello dello schermo) dal mondo reale. Inoltre, mentre del mondo ti fai una rappresentazione, nello schermo la rappresentazione è già preparata da registi o algoritmi. Scambiare l’esperienza per la rappresentazione è un doppio errore: significa deprivare l’esperienza della multi-sensorialità lasciando lavorare prevalentemente la vista e offrire una rappresentazione di mondo già selezionata, ridotta e uniformata.
Se si sposta il focus dalla rappresentazione all’esperienza le differenze tra mondo reale e mondo virtuale sono notevoli per ciò che più conta per chi deve ancora divenire adulto. L’apprendimento infantile, a partire dall’apprendimento della lingua-madre, è molto migliore quando avviene senza gli schermi, e almeno fino a sei anni l’apprendimento è migliore dal vivo anziché tramite schermi, effetto noto come video deficit o transfer deficit, proprio perché il baby-talking – cioè, la modalità universale di insegnamento-apprendimento linguistico è multisensoriale, ha bisogno della sintonizzazione emotiva, della relazione tra corpi, dell’attenzione condivisa, cioè della condivisione delle intenzionalità. Mentre nella mente di un bambino di cinque anni, la rappresentazione del kiwi in uno schermo potrebbe confondersi con quella della mela (e non potremmo certo dargli torto), nel mondo reale sono due esperienze conoscitive assai diverse: basta mettere in bocca per capire. Un bambino diventa adulto in relazione con umani non in isolamento dagli altri umani.
Per questo motivo in tutto il mondo desta molte preoccupazioni l’esposizione precoce agli schermi, questione su cui gli autori non spendono mezza parola in tutto il libro. Insistono invece sul concetto di onlife che, pur essendo molto sexy, applicato all’infanzia è terribilmente fuorviante. Tale concetto coniato da Luciano Floridi (e usato da Lancini) indica l’esperienza quotidiana sempre più frequente di una costante connessione online, che implica un’interazione continua tra reale e virtuale. Il concetto di onlife si riferisce quindi alle esperienze quotidiane di connessione e interazione continua, caratterizzata da una indistinzione tra reale e virtuale. Il termine vuole mettere in risalto il fatto che stando in rete non si è fuori dal mondo, perché anche la rete è parte della vita e ha effetti sulla vita reale. Tutto ciò che si fa nel virtuale ha conseguenze sul mondo reale.
Un concetto semplice, ma che rischia di trasformarsi in arma ideologica: incoraggiare l’indistinzione di questo flusso continuo di tempo schermo con la realtà come qualcosa di positivo e/o ineluttabile, significa non stabilire una chiara priorità ontologica del reale sul virtuale e contribuire alla confusione. Si può vivere senza essere connessi ogni minuto, ogni ora, ogni giorno, anche oggi nel 2025, ma non si può usare il digitale senza vivere nel mondo reale: Floridi presenta la onlife come l’ultima frontiera di un’avanzata storica di un progresso tecnologico lineare, che non è né buono né cattivo, ma un destino ineluttabile, non deciso né voluto dagli umani, sul quale pertanto gli umani non possono decidere nulla. Onlife è il condensato dell’ideologia digitale attuale, ma è un concetto che, se applicato a un bambino, diventa estremamente fuorviante. Il caso estremo di un bambino che cresce circondato solo da robot era già stato descritto da Daniel Stern come esperienza psicotica che rende vana la funzione più umana propria della rappresentazione: la distinzione tra realtà e immaginazione.
Le tecnologie, come ci insegnano gli apporti più recenti della storia e dell’antropologia, sono sempre state decise dagli esseri umani e non sono disponibili su una linea retta che necessariamente avanza e progredisce verso le magnifiche sorti e progressive. Anche oggi le tecnologie digitali sono selezionate, decise e regolamentate da esseri umani: il problema è che sono nelle mani di pochissime persone che, pur regolando l’uso degli schermi per i loro figli, hanno tratto enormi profitti dall’assenza di regole per l’esposizione agli schermi della popolazione da 0 a 18 anni.
---
Nel continuare la recensione del libro dovremo cercare di capire la vera ossessione ovvero l’intolleranza verso ogni tipo di regolamentazione del digitale, che, alla luce persino dei tentativi di regolamentazione blanda delle Big Tech, appare oggi come totalmente anacronistico: nel 2026 la questione non sarà infatti se darsi delle regole ma chi scriverà le regole, e quali regole darà per l’uso delle tecnologie digitali, anche ai comuni mortali.
APPROFONDIMENTI:
- https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/smartphone-social-figli-capi-web-li-vietano-motivi/ec8b3ea6-f177-11ec-82b6-14b9a59f244e-va.shtml
Recensione di Oltre la tecnofobia, il digitale dalle neuroscienze all’educazione - Prima parte
A maggio di quest’anno è uscito un libro, Oltre la tecnofobia, Il digitale dalle neuroscienze all’educazione di Vittorio Gallese, Stefano Moriggi, Pier Cesare Rivoltella, che – dichiaratamente, fin dal titolo – intende proporre una visione in controtendenza rispetto alla tecnofobia che sta dilagando tra media, common sense, e riflessioni accademiche.
Abbiamo accolto con grande interesse la riflessione critica, acuta e articolata, di Simone Lanza che, con il pretesto di confrontarsi con le tesi degli autori, costruisce un ragionamento parallelo su tematiche quali la metafora del cervello come computer, l’identità di rappresentazione dei mondi analogico e digitale, e il presunto autoritarismo celato da divieti e restrizioni dell’uso delle tecnologie digitali a bambini e ragazzi.
In questo primo articolo presentiamo la sintesi della recensione del libro; nei successivi tre seguiremo il ragionamento analitico di Simone Lanza.
-----
Il saggio di Vittorio Gallese, Stefano Moriggi, Pier Cesare Rivoltella si scaglia contro la tecnofobia, figlia di una lunga tradizione storica che ha visto demonizzare ogni rivoluzione tecnologica “dall’invenzione del fuoco agli smartphone” (p.22), dalla scrittura alfabetica alla fotografia, dal cinema alla televisione, fino all’attuale panico morale. Gli autori si adoperano a smontare con vigore le tesi di Jonathan Haidt (La generazione ansiosa), secondo cui i giovani sarebbero vittime passive di tecnologie portatrici di ansie sociali; a loro avviso, il vero problema non è il digitale ma la paura culturalmente costruita che lo circonda, una nostalgia reazionaria per un passato idealizzato, sostenuta da divieti inefficaci e da un’autorappresentazione sociale che colpevolizza le nuove generazioni.
Il limite più rilevante del saggio è che, credendo di criticare la diffusione della tecnofobia, non analizza il mondo odierno, ben plasmato in profondità dalle piattaforme digitali, che invece mettono a valore le paure sociali, che sono la leva e non la resistenza alla diffusione di massa di queste tecnologie. Il libro, soprattutto, fa un pessimo uso delle sue tre fonti principali chiamate a corroborare l’impostazione teorica: Walter Benjamin, Bernard Stiegler, Paulo Freire. Se quindi in questa recensione si darà eccessivo spazio a questi testi non è tanto per restituire alle tre fonti la loro forza critica, completamente rimossa nel libro in questione, quanto perché questa operazione consolida, con il linguaggio scientifico, una serie di luoghi comuni, che qui si intendono invece sottoporre a critica. Presenterò subito i contenuti.
Nella prima parte (gnoseologica), ispirata alle ricerche delle neuroscienze, gli autori demoliscono la metafora del cervello come computer. L’essere umano è dotato di intersoggettività corporea e i neuroni motori si attivano anche nella percezione di stimoli visivi o tattili senza produrre movimento effettivo. Questa simulazione motoria dimostrerebbe che “i meccanismi cervello-corpo che consentono la nostra relazione fisica e diretta con il mondo (…) e quelli che intervengono nel mondo – analogico e digitale – con cui rappresentiamo il mondo con storie e immagini, sono molto simili” (p.37). Non esiste così una differenza qualitativa o ontologica nel modo in cui “rappresentiamo” (p.41) il mondo perché il primo medium sarebbe il corpo (p.21). Il riferimento principe della prima parte è al filosofo Walter Benjamin, primo critico ad avere compreso che i media trasformano la stessa percezione dell’esperienza del mondo reale. Ne L’opera d’arte al tempo della sua riproducibilità tecnica sostiene che i media (essenzialmente fotografia e cinema) hanno cambiato il modo di percepire il reale.[1] Sulla confusione tra esperienza di mondo di Benjamin con la rappresentazione del mondo si tornerà più avanti, perché questa confusione permette di sovrapporre la rappresentazione del mondo analogico a quella digitale, perdendo di vista la dimensione esperienziale del mondo reale, di cui il virtuale è solo una parte.
Nella seconda parte (ontologica) si sostiene la tesi che l’indistinzione percettiva sia anche costitutiva del reale, cioè che virtuale e reale siano sovrapponibili. Un’idea dura a morire per la resistenza del buon senso umanista a cui i nostri autori contrappongono le tesi del filosofo Bernard Stiegler, per il quale la tecnologia non è esterna all’umano, perché l’evoluzione umana è “tecnologico-umana” (p.23). A ulteriore conferma portano una tesi di Debord riproposta in modo forse impreciso: “tutto ciò che un tempo veniva vissuto direttamente è ora semplicemente rappresentato a distanza (sic).” (p.43). Secondo me, la traduzione corretta è “tutto ciò che era direttamente vissuto si è allontanato in una rappresentazione”. Che poi è proprio ciò che i nostri autori non vogliono capire: lo schermo trasforma (e allontana) il vissuto in rappresentazione, come si vedrà più avanti.[2] In ogni caso la loro argomentazione è che la contrapposizione tra umano e tecnologia sia sterile, storicamente infondata e filosoficamente inadeguata, seguendo le tesi del filosofo francese Bernard Stiegler, in Italia sicuramente non abbastanza riconosciuto. Stiegler elabora da Derrida la nozione di tecnica come pharmakon (veleno e farmaco insieme): come la scrittura per Platone così anche il digitale è intrinsecamente ambiguo potendo avvelenare o curare a seconda della dose.
Questa prospettiva smaschererebbe la tecnofobia umanista, radicata al contrario in una nostalgia metafisica che contrappone artificiosamente l’uomo alla macchina, il naturale al tecnologico. Da questa prospettiva teorica, per altro assolutamente condivisibile, anche alla luce del dibattito filosofico in corso sul post-umano (dibattito non menzionato), si passa però velocemente a polemizzare con le soluzioni di "buon senso" derivate da questa visione semplicista: ecco che il concetto di "benessere digitale" è una trappola che scarica sulle macchine responsabilità umane, mentre i divieti (come gli smartphone vietati sotto i 14 anni, le circolari del Ministero, etc...) ignorano la complessità del rapporto coevolutivo tra essere umano e tecnica. Qui gli autori si buttano nelle braccia dello psicologo Matteo Lancini: per gli adolescenti in ritiro sociale (hikikomori), i media digitali non sarebbero la causa del male, ma il farmaco che evita esiti psicotici, permettendo loro di restare agganciati al mondo. Viviamo ormai in una realtà onlife, dove ogni distinzione tra on line e off line sarebbe obsoleta. Gli autori ci invitano ad "abitare farmacologicamente (e dunque consapevolmente) la catastrofe" (p.107): riconoscere le tossicità del digitale senza rinunciare alle sue potenzialità curative. Questa parte teorizza l’inseparabilità di umano e tecnologico deducendone la polemica contro il buon senso umanista sulle misure da prendere per gli abusi degli smartphone in età adolescenziale. Da un lato polemizzano contro le misure di buon senso dall’altro si limitano a segnalare solo alcune storture delle tecnologie informatiche nominando essenzialmente i rischi dei deepfake e della disinformazione delle fake news che viaggiano più veloci delle notizie vere. Gli autori sono fermamente convinti che “l’avvento dei media digitali ha democratizzato l’accesso alle informazioni” (p. 56) e che “l’ascesa delle piattaforme sociali ha permesso ai politici di interagire direttamente [sic] con gli elettori” (p.57): convinzione quest’ultima che forse alla fine del XX secolo poteva essere anche condivisibile, ma che dopo la Brexit e il ruolo di Cambridge Analytica, per non parlare della fine di ogni regolamentazione avanzata da Trump, suona quanto meno goffa, se non persino collusa.
La critica si fa totalmente pedagogica nella terza parte, dove ogni suggerimento pratico volto a limitare l’uso delle tecnologie è definito autoritario. Per questa operazione si scomoda il pedagogista Paulo Freire citandolo in esergo e avvalendosene nell’argomentazione: secondo gli autori i divieti inibiscono la capacità critica e deresponsabilizzano gli adulti e chi si vuole educare. Portano l’esempio di genitori cattivi che negano le carte Pokémon ai propri figli, i quali finiscono però per riceverle dai loro pari per una sorta di giustizia compensativa, traendo questa conclusione: “i divieti non reggono all’urto dei gruppi di pari” (p.144). L’ansia di controllo – già evidente in Platone con la sua diffidenza verso la scrittura – sarebbe il vero male: vietare informazioni ai minori è un modello fallimentare, poiché il gruppo dei pari compensa sempre le privazioni. Qui proprio gli autori abbracciano una posizione molto netta: “ogni scelta di protezione [sic] o di divieto, in senso proprio, non è educativa” (p.147). Anche qui mi sia lecito approfondire la questione per capire come Freire la pensasse davvero, ma soprattutto se l’antiautoritarismo non sia oggi qualcosa che potremmo ritenere inadeguato nonché anche abbondantemente superato dai dibattiti pedagogici contemporanei sulla crisi dell’autorità genitoriale.
Questo libro ci dà l’occasione per criticare sette luoghi comuni di cui questo manifesto “tecno-ottimista” sarebbe la versione “scientifica”. Lo sforzo dei nostri autori consiste nel convincere che ciò che viene vissuto sia sostanzialmente identico a ciò che viene rappresentato a distanza: stare tutto il giorno davanti a uno schermo sarebbe la stessa cosa che fare esperienze nel mondo reale, a due anni come a novanta, senza curarsi di dire qualcosa di critico sul fatto che ciò che passa oggi attraverso lo schermo è selezionato e personalizzato da algoritmi progettati da un pugno di miliardari che stanno aumentando le loro ricchezze e che non hanno alcuna finalità pedagogica se non quella di modellare i comportamenti di miliardi di persone.
NOTE
[1] Gallese aveva già ampiamente sviluppato queste tesi con M. Guerra in Lo Schermo Empatico. Cinema e Neuroscienze, Milano 2015. Su Walter Benjamin cf. anche: V. Gallese, Digital visions: the experience of self and others in the age of the digital revolution, in “International Review of Psychiatry”, n. 36, 2024, pp. 656–666. Per una ricostruzione analitica di Benjamin mi sia consentito rimandare a: S. Lanza, L’educazione nell’epoca della riproducibilità tecnica. note su Walter Benjamin, in “Quaderni Materialistici”, n. 23, 2024, pp. 155-176
[2] La traduzione della Società dello spettacolo proposta autonomamente dai nostri autori è quanto meno discutibile: meglio sarebbe stato conservare la traduzione dal francese di Stanziale “Tutto ciò che era direttamente vissuto si è allontanato in una rappresentazione [c’est éloigné dans une raprésentation]”. La traduzione di questo passaggio diventa pertanto proprio il tradimento proprio di ciò che Debord denuncia: con la società capitalistica l’esperienza vissuta viene mercificata e sostituita da una rappresentazione, spettacolo è quindi “il movimento autonomo del non-vivente”, etc.… proprio perché Debord auspicava una società diversa capace di usare in modo migliore le tecnologie.
Negare l’evidenza. Un clima di disinformazione
Quando la realtà ci sfugge di mano, il nostro cervello si rifugia in un’antica strategia di sopravvivenza: trovare un colpevole. È più rassicurante immaginare un “volto tra le nuvole”, che accettare l’idea che il mondo sia, talvolta, caotico, privo di intenzione e difficile da controllare. È il cosiddetto modulo di rilevazione dell’agente: un dispositivo cognitivo descritto dalle scienze cognitive evoluzionistiche che ci spinge, per prudenza, a vedere intenzionalità dove non ce n’è. Meglio sospettare un predatore inesistente, che ignorarne uno reale.
Lo storico delle religioni Stewart Guthrie, nel suo Faces in the Clouds (Oxford University Press, 1993), chiama questo meccanismo “antropomorfismo cognitivo”: attribuire caratteristiche umane a entità o eventi naturali, come tuoni, terremoti o carestie. Un’ipotesi evoluzionista che spiega la nascita di molte religioni come estensione dell’animismo primitivo: ci dev’essere qualcuno dietro, anche se non si vede.
Non è un caso se lo stesso schema mentale viene riattivato oggi di fronte al cambiamento climatico, alla pandemia, all’instabilità globale. Come spiega la psicologa sociale Karen Douglas in “The Psychology of Conspiracy Theories” (Current Directions in Psychological Science, 2017), le teorie del complotto proliferano in situazioni di incertezza, ansia, senso di esclusione. Non servono a spiegare il mondo, ma a renderlo psicologicamente tollerabile. Dietro un virus? Un laboratorio. Dietro il riscaldamento globale? Un piano delle élite per controllare le masse.
Nel Medioevo, per spiegare carestie e pestilenze si cercavano streghe. Oggi, si cercano burattinai: Bill Gates, Klaus Schwab, George Soros e ovviamente Greta Thunberg. Cambiano i nomi, non lo schema. I roghi si sono trasformati in commenti sotto i post, meme, video virali. Ma la logica è la stessa: trovare un capro espiatorio e scaricare su di lui l’angoscia collettiva.
Il pensiero complottista offre un doppio vantaggio narcisistico: ci fa sentire sia speciali (“io so la verità”) sia perseguitati (“gli altri non capiscono”). È un rifugio identitario: se il cambiamento climatico fosse reale e causato da noi, dovremmo cambiare. Ma se è tutto un inganno, possiamo restare come siamo. E magari sentirci anche eroi per averlo smascherato.
Ogni smentita, poi, diventa una conferma. Se i dati scientifici contraddicono la teoria, è solo perché “loro” ci stanno mentendo. Una trappola mentale chiusa dall’interno, a doppia mandata.
Ma non c’è solo psicologia. Il negazionismo climatico è una strategia deliberata e ben orchestrata. A documentarlo in modo puntuale sono Naomi Oreskes e Erik Conway in Merchants of Doubt (Bloomsbury Press, 2012). Una vera radiografia del sistema: think tank finanziati dall’industria dei combustibili fossili, “esperti” compiacenti, studi isolati, messaggi ambigui. Non per negare apertamente il cambiamento climatico – oggi sarebbe insostenibile – ma per seminare dubbi. Perché se non puoi smentire la scienza, puoi almeno confondere il pubblico.
È la stessa tecnica usata, decenni fa, dall’industria del tabacco. Quando ormai era evidente il legame tra fumo e cancro, non restava che un’arma: chiedere “ulteriori studi”. Creare l’illusione di un dibattito aperto. Come dichiarò con cinismo S. J. Green, direttore della ricerca della British American Tobacco: «La richiesta di nuove prove scientifiche è sempre stata un espediente per giustificare l’inazione o il rinvio. Di solito è la prima reazione di chi è colpevole.»
Lo stesso copione, aggiornato, è stato messo in campo da ExxonMobil. Già negli anni ’70 e ’80 i loro scienziati interni producevano modelli previsionali molto accurati sugli effetti della CO₂. Ma la direzione aziendale scelse un’altra strada: finanziare il dubbio. Tra il 1998 e il 2004, la compagnia ha speso oltre 16 milioni di dollari per sostenere think tank negazionisti, come il Competitive Enterprise Institute. Celebre la loro campagna del 2006: «CO₂: They call it pollution. We call it life». Nessun dato. Solo retorica.
La disinformazione funziona anche perché sfrutta un altro meccanismo psicologico: la truthiness, termine coniato dal comico Stephen Colbert per indicare ciò che “suona vero”, anche se non lo è. Un effetto verità che prende scorciatoie emotive, bypassa il pensiero analitico e colpisce direttamente l’istinto.
Uno studio pubblicato su Science da Soroush Vosoughi, Deb Roy e Sinan Aral (“The Spread of True and False News Online”, 2018) ha mostrato che le fake news si diffondono più rapidamente, più lontano e più in profondità rispetto a quelle vere. Non sono i bot i principali responsabili, ma noi: indignati, frettolosi, disattenti. Le bufale provocano emozioni forti – rabbia, paura, disgusto – che attivano il cervello più rapidamente della riflessione razionale.
È il cosiddetto bullshit asymmetry principle (Brandolini’s law): per smontare una sciocchezza servono almeno dieci volte le risorse necessarie per produrla. La scienza richiede tempo, verifiche, cautele. Il complotto no. Viaggia leggero, virale, immune alla smentita. E mentre la politica si divide, la transizione ecologica si arena. Perché, intanto, il tempo corre.
Le teorie del complotto e la disinformazione scientifica sono la conseguenza, prevedibile, di come funziona il nostro cervello e di come funzionano – in modo non meno prevedibile – gli interessi economici organizzati. Comprenderlo è il primo passo per difenderci. Perché mentre la scienza avanza a passi lenti e incerti tra ipotesi, verifiche, margini d’errore e formule prudenti (“altamente probabile”, “coerente con i modelli”, “correlazione significativa”), la disinformazione finanziata dalle lobby del carbone, del petrolio e del gas corre – rapida ed emozionale – sul tapis roulant della truthiness. Non deve dimostrare nulla. Solo dirci quello che desideriamo sentire.
NOTA
Su questo tema Matteo Motterlini ha appena pubblicato, per Solferino Libri, Scongeliamo i cervelli, non i ghiacciai
L’Effetto Proteo: Quando l’Avatar cambia chi siamo
Nell’era digitale, l’identità personale non è più confinata al corpo fisico: sempre più spesso si estende ai nostri avatar, quei corpi virtuali che abitiamo nei social network, nei videogiochi, negli ambienti digitali in generale. Ma cosa succede quando l’aspetto di questi avatar inizia a influenzare profondamente il nostro comportamento reale? Questo è il cuore dell’“Effetto Proteo”, un fenomeno psicologico che mette in luce il potere trasformativo dell’identità digitale.
DALLA MASCHERA ALL’AVATAR: LE ORIGINI DELL’EFFETTO PROTEO
Coniato nel 2007 da Nick Yee 1 e Jeremy Bailenson 2, il termine “Effetto Proteo” richiama la figura mitologica greca di Proteo, capace di cambiare forma a piacimento. L’idea alla base è semplice ma potentissima: quando adottiamo un avatar in un ambiente digitale, tendiamo inconsciamente a comportarci in modo coerente con il suo aspetto. Se l’avatar è alto e attraente, potremmo mostrarci più sicuri di noi; se appare debole, potremmo essere più remissivi.
Già Oscar Wilde, ben prima del digitale, scriveva: “Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth”. La maschera, oggi, è l’avatar, e funziona da catalizzatore per l’esplorazione dell’identità.
Nell’affrontare l’identificazione tra avatar ed essere umano si analizzeranno, in prima battuta, i meccanismi psicologici e cognitivi che sono alla base dell’esistenza dell’Effetto Proteo; successivamente, verranno valutati gli effetti di stereotipi e bias su comportamento e identità; infine, si tenterà una sintesi di quanto analizzato, vagliando come e quanto l’identificazione nel proprio avatar conduca a delle modifiche nella percezione di sé, tanto nei mondi virtuali quanto in quello reale.
INQUADRAMENTO PSICOLOGICO
Numerosi studi hanno indagato i fondamenti teorici dell’Effetto Proteo. Uno dei principali è la “self-perception theory” di Daryl Bem 3. Secondo questa teoria non sempre conosciamo i nostri stati interiori in modo immediato: spesso ci osserviamo dall’esterno, proprio come farebbe un osservatore qualsiasi, e traiamo conclusioni su cosa proviamo in base al nostro comportamento visibile. Questo meccanismo diventa particolarmente evidente quando mancano segnali interni chiari o quando ci troviamo in contesti ambigui. Negli ambienti virtuali ciò significa che, quando “indossiamo” un avatar, tendiamo a comportarci secondo le caratteristiche estetiche e simboliche che gli abbiamo attribuito, e da tali comportamenti inferiamo i nostri stati d’animo. L’avatar, quindi, non è solo una maschera, ma anche uno specchio che riflette (e crea) il nostro Sé.
Un’altra teoria rilevante è la “deindividuation theory” di Philip Zimbardo 4, sviluppata a partire dagli anni Sessanta. Secondo Zimbardo, in situazioni di anonimato o di forte immersione in un gruppo, l’individuo tende a perdere il senso della propria individualità, diminuendo l’autocontrollo e mostrando comportamenti che normalmente inibirebbe. L’anonimato riduce la paura del giudizio altrui e attenua il senso di responsabilità personale: in un ambiente digitale queste condizioni si verificano con facilità. Secondo Zimbardo, l’effetto della de-individuazione è tendenzialmente negativo, e conduce a comportamenti antisociali; tuttavia, altri autori hanno evidenziato che individui in condizione di de-individuazione, temendo meno il giudizio sociale, possono esibire anche espressioni di empatia, solidarietà o affetto.
Questa visione è stata successivamente affinata da Tom Postmes 5, Russell Spears 6 e Martin Lea 7 attraverso il modello SIDE (Social Identity Model of Deindividuation Effects). Gli autori sostengono che l’anonimato non elimina l’identità personale, ma favorisce il passaggio a un’identità sociale condivisa. Quando un individuo si sente parte di un gruppo tende a interiorizzarne norme e valori, comportandosi in maniera coerente con le aspettative collettive. Ciò significa che, in un contesto digitale, l’utente può sviluppare un forte senso di appartenenza a una comunità online assumendo atteggiamenti e comportamenti che riflettono la cultura del gruppo stesso. Come osservano gli autori, il bisogno di sentirsi accettati nella cerchia sociale di riferimento supera qualsiasi considerazione etica riguardo il comportamento adottato. In questo senso, l’avatar non è solo uno strumento di espressione individuale, ma anche di conformità sociale. L’interazione tra anonimato, immersione e identità condivisa crea una cornice psicologica che amplifica le norme del gruppo. In positivo, questo può rafforzare la cooperazione, il supporto reciproco e l’inclusività; in negativo, può alimentare polarizzazioni, intolleranze e comportamenti aggressivi.
STEREOTIPI E IDENTITÀ DIGITALI
Gli stereotipi giocano un ruolo centrale nell’Effetto Proteo. Già nel 1977, Mark Snyder 8 dimostrava che le aspettative proiettate sull’interlocutore influenzano profondamente l’interazione. Tre fenomeni descrivono l’impatto degli stereotipi:
- Stereotype threat: la paura di confermare uno stereotipo negativo conduce a prestazioni peggiori.
- Stereotype lift: l’identificazione con un gruppo visto positivamente migliora fiducia e risultati.
- Stereotype boost: l’appartenenza a gruppi stereotipicamente forti conduce a benefici in prestazioni e autostima 9.
Nei videogiochi è stato osservato che avatar maschili e femminili esibiscono comportamenti diversi quando utilizzati da persone del sesso opposto: tale fenomeno è noto come “gender swapping”. Gli uomini tendono a usare avatar femminili per ottenere vantaggi sociali, mentre le donne lo fanno per evitare attenzioni indesiderate. Uno studio condotto su World of Warcraft (Yee, Bailenson, & Ducheneaut, 2009) ha rilevato che avatar più attraenti o più alti generano atteggiamenti più estroversi, mentre avatar meno imponenti portano a comportamenti più schivi. In uno studio parallelo, condotto su giocatrici e giocatori di EverQuest II (Huh & Williams, 2010), è stato evidenziato che personaggi maschili controllati da donne sono più attivi in combattimento, mentre personaggi femminili controllati da uomini si dedicano maggiormente alla socializzazione: in entrambi i casi si assiste alla messa in atto di comportamenti stereotipici, aderenti a ciò che un determinato individuo si aspetta da persone identificate in un genere altro.
IDENTITÀ DESIDERATA E OVERCOMPENSATION
Il fenomeno dell’identificazione desiderata, o “wishful identification”, si manifesta quando l’individuo si immedesima in personaggi con qualità che vorrebbe possedere. Nel 1975 Cecilia von Feilitzen 10 e Olga Linné 11 teorizzavano che gli spettatori più giovani dei programmi televisivi tendessero a proiettarsi nei protagonisti delle storie che consumavano per sentirsi più intelligenti, forti o valorosi. Questo desiderio di immedesimazione non richiede necessariamente una somiglianza fisica tra soggetto e personaggio: l’importante è che il personaggio incarni qualità desiderabili, e assenti nella vita reale dell’osservatore. Nei mondi virtuali, tale meccanismo assume una dimensione interattiva: non ci si limita più a osservare un eroe sullo schermo, ma lo si diventa, scegliendo avatar che riflettono i nostri desideri più profondi e agendo attraverso di essi.
Una manifestazione concreta di questo processo si osserva nel fenomeno dell’overcompensation. In uno studio condotto da Roselyn Lee-Won 12 e colleghi, a un gruppo di giovani uomini è stato chiesto di sottoporsi a una serie di test stereotipicamente associati alla mascolinità (forza fisica, cultura generale “virile”, autovalutazioni). Coloro che ottenevano risultati deludenti tendevano poi a creare avatar in The Sims 3 con tratti fisici accentuatamente maschili: muscoli pronunciati, lineamenti decisi, capelli corti. Questa costruzione ipermaschile del proprio alter ego virtuale rappresenta una forma di riaffermazione identitaria, un tentativo inconscio di compensare una percezione negativa del proprio Sé fisico o sociale. Non solo: quando questi stessi individui ripetevano i test dopo aver interagito con l’avatar, i loro risultati miglioravano. Questo suggerisce che l’identificazione con un corpo virtuale desiderato possa rafforzare l’autoefficacia anche nel mondo reale. Il Sé digitale, in questo senso, non è solo uno strumento di espressione, ma anche un vero e proprio alleato nella costruzione di fiducia e autostima.
Questa dinamica di retroazione è una delle più affascinanti implicazioni dell’Effetto Proteo: non è solo l’avatar a essere influenzato dall’utente, ma anche l’utente a essere modificato dal suo avatar. L’identità digitale, quindi, diventa non solo espressione, ma anche motore di trasformazione del Sé.
ETICA E DESIGN DELL’IDENTITÀ DIGITALE
L’Effetto Proteo non è un semplice artificio sperimentale: è una dinamica concreta con ripercussioni reali su comportamento, percezione di sé e relazioni sociali.
Come vogliamo che ci vedano gli altri? E quanto siamo pronti ad accettare che il nostro comportamento possa cambiare, anche profondamente, in base al corpo digitale che abitiamo? La progettazione di avatar non può essere considerata solo una questione estetica: è un atto di modellazione identitaria. Costruire un corpo digitale significa anche dare forma a una possibile versione di sé, con tutto il potere trasformativo che questo comporta.
NOTE:
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Bem, D. (1972). Self-Perception Theory. In L. Berkovitz (ed.), Advances in Experimental Social Psychology, vol. 6. New York: Academic Press.
Gergen, K. J., Gergen, M. M., & Barton, W. H. (1976). Deviance in the Dark. In Psychology Today, vol. 7, no. 5. New York: Sussex Publishers.
Huh, S., & Williams, D. (2010). “Dude Looks like a Lady: Gender Swapping in an Online Game”. In W. S. Bainbridge (ed.), Online Worlds: Convergence of the Real and the Virtual. Londra: Springer.
Hussain, Z., & Griffiths, M. D. (2008). Gender Swapping and Socializing in Cyberspace: An Exploratory Study. In CyberPsychology & Behavior, vol. 11, no. 1. Larchmont: Mary Ann Liebert, Inc.
Lee-Won, R. J., Tang, W. Y., & Kibbe, M. R. (2017). When Virtual Muscularity Enhances Physical Endurance: Masculinity Threat and Compensatory Avatar Customization Among Young Male Adults. In Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, vol. 20, no. 1. Larchmont: Mary Ann Liebert, Inc.
Postmes, T., Spears, R., & Lea, M. (1998). Breaching or Building Social Boundaries?: SIDE-Effects of Computer-Mediated Communication. In Communication Research, vol. 25, no. 6. Thousand Oaks: SAGE Publishing.
Shih, M., Pittinsky, T. L., & Ambady, N. (1999). Stereotype Susceptibility: Identity Salience and Shifts in Quantitative Performance. In Psychological Science, vol. 10, no. 1. New York: SAGE Publishing.
Snyder, M., Tanke, E. D., & Berscheid, E. (1977). Social Perception and Interpersonal Behavior: On the Self-Fulfilling Nature of Social Stereotypes. In Journal of Personality and Social Psychology, vol. 35, no. 9. Washington, D.C.: American Psychological Association.
Steele, C. M., & Aronson, J. (1995). Stereotype Threat and the Intellectual Test Performance of African Americans. In Journal of Personality and Social Psychology, vol. 69, no. 5. Washington, D.C.: American Psychological Association.
Walton, G. M., & Cohen, G. L. (2003). Stereotype Lift. In Journal of Experimental Social Psychology, vol. 39, no. 5. Amsterdam: Elsevier.
Yee, N., & Bailenson, J. (2007). The Proteus Effect: The Effect of Transformed Self-Representation on Behavior. In Human Communication Research, vol. 33, no. 3. Oxford: Oxford University Press.
Yee, N., Bailenson, J., & Ducheneaut, N. (2009). The Proteus Effect. Implications of Transformed Digital Self-Representation on Online and Offline Behavior. In Communication Research, vol. 36, no. 2. New York: SAGE Publishing.
Zimbardo, P. G. (1969). The Human Choice: Individuation, Reason, and Order versus Deindividuation, Impulse, and Chaos. In W. J. Arnold, & D. Levine (eds.), Nebraska Symposium on Motivation, vol. 17. Lincoln: University of Nebraska Press.
Prodotti da forno intelligenti? – Una nuova forma di ibridazione
Di recente, un’azienda di comunicazione ha reso nota un’esperienza di uso ibrido tra intuizione umana e capacità dell’intelligenza artificiale. L’azienda è stata incaricata da un cliente di sviluppare un nuovo prodotto nella linea dei prodotti da forno salati.
Va ricordato che nel marketing, quando si parla di prodotto si intende – come minimo - la combinazione tra prodotto fisico (in questo caso, quello che si mangia), prezzo, posizionamento, packaging e immagine visuale.
Per realizzare questa operazione, l’agenzia ha avviato una ricerca sensoriale con giudici umani professionisti, coinvolgendo anche consumatori e community online di potenziali consumatori, che hanno definito le caratteristiche di sapore, consistenza e dimensioni, del prodotto fisico.
Poi, utilizzando le informazioni raccolte, ha chiesto a un sistema di Intelligenza Artificiale di generare dei visual evocativi che rappresentassero le caratteristiche desiderate del prodotto. Queste immagini hanno dato input a designer e addetti al marketing per sviluppare la dimensione di immagine e packaging del prodotto, da proporre al cliente.
Il risultato, il prodotto che sarà proposto sul mercato, costituito dalle diverse componenti, sembra essere, quindi, un ibrido tra creatività umana e lavoro di analisi e di sintesi svolto da una macchina.
Questo processo sinergico uomo-macchina sembra aver amplificato la creatività umana e pone la consueta domanda: il ruolo dell’ingegno umano è insostituibile? La IA può concepire modi di pensare differenti – magari non migliori ma sicuramente alieni - da quelli possibili per un umano? Grazie alle macchine intelligenti, può estendere il concetto stesso di creatività?
Proviamo a fare una prima razionalizzazione di questo tipo di approccio ibrido:
- In un processo di brainstorming, ogni partecipante espone la sua personale idea dell’argomento. Quando le idee sono esaurite, si fa un compendio delle possibili soluzioni reali. Al termine, si sceglie una o più di una per essere approfondite e una per essere sviluppata.
- Se Inseriamo la I.A. nel processo, questa può essere ennesimo partecipante che avanza una sua proposta, nata – evidentemente dai dettagli o dalle omissioni delle altre.
- Al termine del processo, la I.A. può fare il compendio di tutte le proposte e restituirlo all’umano, che lo rielaborerà con il suo pensiero e stile personale.
Se intensifichiamo l’ibridazione, possiamo immaginare che la I.A. generi – sulla base della conoscenza acquisita – anche un compendio completo di esempi, fatti e contraddittorio, mantenendo un “tono di voce” nello stesso tempo riflessivo e inclusivo. L’umano potrà, poi, personalizzare questo compendio secondo la propria sensibilità e stile.
Questo modello di approccio unirebbe la velocità della I.A. alla profondità della riflessione umana, favorendo la naturale tendenza umana a risparmiare energia come strategia di sopravvivenza. Alla IA si può affidare il compito più gravoso, tenere traccia e organizzare i contenuti, che svolgerà velocemente. L’uomo può ri-elaborare i contenuti con il proprio tocco personale.
Il risultato finale si può considerare una soluzione accettabile? Potremmo chiederlo all’umano e alla macchina, reiterando il processo fino a quando l’umano risponde positivamente.
Come può essere definita la forma intellettuale del risultato? Ci sarebbe arrivato comunque l’uomo? Ci sarebbe arrivata la macchina tra i suoi scenari possibili attingendo allo scibile a sua disposizione?
Di fatto, sembra assodato che l’ingegno umano sia caratterizzato dalla capacità di pensare in modo critico, di immaginare nuove possibilità e di trovare soluzioni non convenzionali ai problemi.
Queste qualità sono difficili da replicare completamente con la tecnologia, anche con i progressi dell’intelligenza artificiale. Questa può analizzare grandi quantità di dati e identificare modelli, ma – per ora - manca di intuizione e di pensiero laterale.
Inoltre, l’ingegno umano è spesso guidato da emozioni, esperienze personali e valori culturali, elementi che la tecnologia non può replicare completamente.
Un prodotto sviluppato congiuntamente da umano e I.A. può essere considerato – a nostro parere - una nuova tipologia di prodotto, poiché rappresenta una fusione delle capacità uniche di entrambi, e neutralizzare felicemente la tensione tra le visioni apocalittica e integrata di queste nuove tecnologie.
Eco-ansia - La crisi ecologica tra medicalizzazione e politicizzazione
ECO-ANSIA: TRA DISAGIO PSICHICO E SINTOMO POLITICO
Negli ultimi anni, la crisi ecologica ha prodotto un'ondata di emozioni collettive che ridefiniscono il modo in cui le persone vivono il proprio rapporto con il mondo. Tra queste emozioni, l’eco-ansia si impone come una delle più diffuse e significative. Spesso descritta come una “paura cronica della fine del mondo” o come uno stato di angoscia legato al futuro del pianeta, l’eco-ansia è rapidamente entrata nel lessico della psicologia e dei media, fino a essere talvolta trattata come una vera e propria patologia da gestire individualmente[1].
Tuttavia, ridurre l’eco-ansia a un disturbo mentale rischia di oscurare il suo significato più profondo. Il pericolo non è solo quello di medicalizzare un’emozione condivisa, ma anche di depoliticizzarla - trasformando una risposta motivata dalla consapevolezza di una crisi reale in un problema personale da contenere. In questo senso, parlare di eco-ansia significa entrare nel cuore della tensione culturale, politica ed esistenziale verso la crisi climatica.
UN’EMOZIONE RADICATA IN UN’EPOCA
L’eco-ansia non nasce nel vuoto. È il frutto di un’epoca segnata da disastri ambientali, disuguaglianze globali e una crescente percezione dell’irreversibilità della crisi climatica. In molti casi, questa ansia non è legata a esperienze dirette di catastrofe, ma alla consapevolezza della loro imminenza, che si traduce in un senso di incertezza paralizzante. Si tratta, in altri termini, di una forma di disagio che nasce dalla difficoltà di immaginare un futuro vivibile.
A questo proposito, il pensiero dell’antropologo Ernesto De Martino offre una chiave di lettura particolarmente illuminante. De Martino parlava di “crisi della presenza” per indicare quei momenti in cui un individuo o una collettività perdono la capacità di situarsi nel mondo con continuità, agire con intenzionalità, e proiettarsi nel futuro. Ne La fine del mondo (1977), De Martino indaga la percezione dell’apocalisse come forma radicale di crisi della presenza, in cui il mondo perde senso e coerenza. L’apocalisse, per l’antropologo italiano, non era solo la fine materiale del mondo, ma un’esperienza culturale e simbolica di disintegrazione: è la perdita di senso, il collasso dei riferimenti storici, etici e affettivi che permettono agli individui di “esserci” nel mondo. L’apocalisse, in questa prospettiva, è una minaccia interna alla cultura: accade quando la struttura simbolica che tiene insieme l’esperienza umana viene meno, lasciando spazio all’angoscia, alla paralisi, alla perdita di futuro.
Questa riflessione è sorprendentemente attuale nel contesto dell’eco-ansia. Molti giovani oggi vivono una forma di apocalisse simbolica: la percezione che il futuro sia compromesso dal collasso ecologico genera sentimenti di impotenza, paura e smarrimento. Come nella crisi della presenza descritta da De Martino, anche l’eco-ansia è segnata da un’interruzione del senso e della fiducia nella continuità del mondo. Rileggere De Martino alla luce della crisi ecologica significa dunque riconoscere che la posta in gioco non è solo ambientale, ma profondamente culturale e antropologica: è la possibilità stessa di abitare il mondo che viene messa in questione. L’eco-ansia, in questa prospettiva, è molto più di uno stato mentale: è il sintomo di una frattura storica, culturale ed esistenziale che mette in discussione il legame tra persone, ambiente e futuro.
IL RISCHIO DELLA MEDICALIZZAZIONE
Negli ultimi anni, l’eco-ansia è stata sempre più spesso affrontata come una condizione psicologica da trattare clinicamente: terapie, tecniche di mindfulness, strategie di coping individuale. Sebbene tali risposte siano necessarie e possano offrire sollievo, concentrarsi esclusivamente sulla loro promozione rischia di generare un duplice effetto negativo. Da un lato, individualizzano un problema collettivo, attribuendolo alla sensibilità o fragilità della singola persona. Dall’altro, distolgono l’attenzione dalle cause strutturali della crisi climatica, alimentando l’idea che l’unica risposta possibile sia l’adattamento psicologico e non la trasformazione sociale.
Questo processo di medicalizzazione non è nuovo. Come mostrano le critiche mosse da studiosi e studiose della sociologia critica, la tendenza a psichiatrizzare forme di disagio legate a condizioni sociali ingiuste è un tratto ricorrente della modernità. In questo caso, però, l’effetto è ancora più pericoloso: nel trattare l’eco-ansia come un disturbo da curare, si contribuisce a rendere “normale” l’anomalia ecologica, neutralizzando la sua carica potenzialmente sovversiva.
UN’EMOZIONE POLITICA
L’eco-ansia, al contrario, può essere interpretata come una forma di sensibilità ecologica e politica. Si tratta di un’emozione che nasce dall’inconciliabilità tra la gravità della crisi ecologica e la lentezza - o l’inazione - delle risposte istituzionali. Non è un caso che molti giovani dichiarino di sentirsi traditi dalla politica e impotenti di fronte a un sistema economico che continua a produrre disastri ambientali pur conoscendone gli effetti[2]. L’eco-ansia è, in questo senso, una reazione ragionevole, persino lucida, a un contesto che oscilla tra apocalisse annunciata e immobilismo strutturale.
Movimenti come Fridays for Future, Ultima Generazione o Extinction Rebellion hanno fatto di questa emozione un motore di mobilitazione. Le loro azioni performative—come i blocchi stradali o le proteste simboliche—possono essere lette come rituali collettivi per rielaborare la crisi della presenza. Invece di fuggire dall’eco-ansia, questi movimenti la mettono in scena, la condividono e la trasformano in linguaggio politico. Così facendo, restituiscono all’ansia la sua dimensione culturale e collettiva, sottraendola alla sfera dell’intimo e del patologico.
CURA, SPERANZA, APPARTENENZA
Se l’eco-ansia è il segnale di una frattura nel rapporto con il mondo, la risposta non può che passare attraverso una forma di “cura del legame”. Non si tratta solo di proteggere gli ecosistemi, ma di rigenerare i significati condivisi, di ricostruire le condizioni per sentirsi parte di un mondo abitabile. In questo senso, le comunità ecologiche, le reti di mutualismo climatico e le esperienze di resistenza ambientale rappresentano tentativi di produrre nuove forme di appartenenza, nuove narrazioni, nuove temporalità.
L’eco-ansia non va repressa né semplicemente gestita. Va ascoltata come un sintomo, sì, ma non di un disagio mentale: di una crisi epocale. È un’emozione che ci obbliga a interrogarci su cosa significa “stare al mondo” oggi, su quali futuri siano ancora immaginabili, e su come ricostruire un senso di presenza che non escluda la speranza.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Clayton, S. D., Pihkala, P., Wray, B., & Marks, E. (2023). Psychological and emotional responses to climate change among young people worldwide: Differences associated with gender, age, and country. Sustainability, 15(4), Article 3540. 10.3390/su15043540
De Martino, E. (1977). La fine del mondo, Einaudi, Torino.
Kałwak, W., & Weihgold, V. (2022). The relationality of ecological emotions: An interdisciplinary critique of individual resilience as psychology’s response to the climate crisis. Frontiers in psychology, 13, 823620. 10.3389/fpsyg.2022.823620
[1] Per un approfondimento su questa controversia vedi Kałwak e Weihgold (2022).
[2] Vedi la ricerca di Clayton e colleghi (2023).
Sanare una controversia - Il dissidio tra Basaglia e Tobino
Tra le pubblicazioni dello speciale Basaglia pubblicate su questa rivista, risalta l’articolo di Gianluca Fuser che ha saputo fare controversia nella controversia parlando di Mario Tobino, grazie a un’approfondita lettura degli archivi della Fondazione Tobino. Vorrei con questo articolo porre in risalto una questione che sposta il focus della controversia, cercando di suggerire un modo per ricomporla prendendo in considerazioni elementi diversi storici e sociali.
Centrale nell’articolo di Fuser è l’impossibilità di conciliare la controversia nei seguenti punti:
«Tobino, seppure non escluda del tutto l’origine sociale, ha una visione organica, fisiologica della follia, e accusa Basaglia di credere che la chiusura dei manicomi cancelli ogni traccia della follia. Basaglia, infatti, la nega e nello stesso tempo, ne attribuisce la creazione alla società malata, al potere, per rinchiudere i disallineati, i disturbatori dell’ordine e dello sfruttamento.»[1]
«Altro punto di dissidio insanabile è il tema della presenza e della forma delle strutture di cura, che coinvolge anche la visione politica delle due posizioni: Tobino non prescinde dalla necessità di un luogo dove i matti possano trovare – per periodi lunghi o brevi, più o meno volontariamente, in modo comunque aperto – riparo, protezione, cura e tranquillità; e sottolinea l’assenza di preparazione dei territori, della popolazione e delle famiglie per la trasformazione dalle strutture accentrate a quelle diffuse; Basaglia, al contrario, non transige, insiste sulla necessità di distruggere l’istituzione manicomiale e ribadisce la necessità della riforma, da farsi subito, in nome della «crescita politica, e quindi civile e culturale del paese».»[2]
Ora, mi chiedo se davvero questi punti siano insanabili. Non è mia intenzione conciliare due persone che chiaramente non andavano d’accordo in quel momento e su quell’argomento. La controversia c’è stata. Se la differenza evidenziata da Fuser può essere sanata, significa soltanto che l’oggetto del contendere è da cercare altrove.
Riguardo alla forma e alla presenza delle struttura di cura, Tobino parla di un luogo dove la persona possa avere riparo, protezione, cura e tranquillità, e non vedo come questo luogo possa essere associato al manicomio basagliano, luogo di repressione, controllo e emarginazione. Se penso a Gorizia, ma anche alle diverse applicazioni della legge 180 – alcune raccontate nello stesso speciale su Controversie[3] – è innegabile la presenza di un punto di raccolta del malato, punto in cui la società lo raccoglie e egli stesso si raccoglie. Un luogo in cui ripararsi dopo una crisi sopravvenuta e cercare una normalità.
Tobino ribadisce,[4] giustamente, che Lucca era già un posto così ma non può dire lo stesso del resto d’Italia. Così, anche Basaglia ha realizzato l’esperimento di Gorizia prima e senza la legge 180 e continua nondimeno a ritenere necessaria l’abolizione del manicomio. Siamo di fronte ad una ambiguità del manicomio? Da un lato, c’è la pretesa oggettività della struttura manicomio come un certo luogo costruito in un certo definito modo con l’obiettivo di una determinata funzione. Dall’altro, invece, troviamo il significato sociale che ognuna di queste strutture porta con sé, in termini di violenza o di carità delle istituzioni. Significati e strutture che formano i luoghi, a partire dalla scelta di come disporre stanze, corridoi, finestre, fino alla formazione degli stessi operatori sanitari.
Sembra che sia Tobino che Basaglia siano ben consapevoli di questo ed entrambi hanno lavorato per contrastare strutture e pratiche che conservano il segno della storia di violenza dell’istituzione manicomiale. La frattura avviene sulla legge e, fino a qui, nulla di nuovo. Ci torno a breve, vorrei, prima, coinvolgere nel discorso anche il primo dei punti inconciliabili indicati da Fuser.
Che cosa si intende con il fatto che Tobino abbia una visione organica, fisiologica e Basaglia no? Che Tobino non consideri il ruolo dei determinanti sociali nella malattia – per quanto non li escluda – e invece Basaglia riconduca la malattia solo a quelli?
Tobino sembrerebbe distinguersi per una visione realista della malattia. “Dolorosa follia, ho udito la tua voce” è il racconto di una follia che esiste per sé stessa. Non è questione di quanto sia organica, perché proprio i racconti di Tobino sono descrizioni di comportamenti che risultano patologici proprio per la sofferenza a stare in un contesto sociale che diremmo normale. L’uomo che graffia i volti degli altri pazienti, nel racconto di Tobino, non dice esplicitamente “sto soffrendo”, ma noi comprendiamo la sua impossibilità di vivere, appunto, nel mondo normale. Tobino con coraggio risponde alla prima questione pratica della cura: il fatto è che le cose sono andate così, adesso sono malato e in qualche modo è da qui che si deve partire.
Basaglia allora è diverso? Non molto a mio parere. Egli non nega la realtà della malattia, ma si concentra sulla diversità, sul fatto che ogni variazione dalla norma è una diversa norma possibile. Non credo che si possa vedere - nel tentativo di modificare l’ambiente del malato (distruggere i muri) - un’omissione della realtà della malattia. Basaglia aveva visto una possibilità. Quella che alcune condizioni di sofferenza trovassero un nuovo senso.
Non sbaglia, Basaglia, quando afferma questa possibilità. Lo abbiamo visto nei tanti tentativi che hanno avuto successo. Sbaglia, invece, quando nega il significato pratico della «carità continua», pratica della quale Tobino spiega per bene il significato: «se il malato pulito, vestito, lì seduto, di nuovo si risporca, perde le urine, scendono le feci, noi si ricomincia da capo, per riportarlo al suo precedente aspetto». Penso sia innegabile che la speranza data da Basaglia, di una vita diversa nella società con gli altri, sia anche di nuovo possibilità di fallimento e in alcuni casi si trasformi nella falsa speranza che noi o quel nostro parente non sia quello che è.
Sono, quindi, due facce dello stesso discorso su salute e malattia. Se le guardiamo dal lato della persona che viene curata, Basaglia è la speranza di guarire ancora,Tobino la forza di salvarsi ancora un giorno. Abolito il manicomio, la persona malata trova un nuovo senso e prospera. Nel manicomio, la persona malata vive al riparo da un mondo che lo ferisce. Abolito il manicomio il malato che non trova una strada muore. Nel manicomio che lo cura, il malato vive costretto in un’unica vita possibile.
A produrre la nostra salute sono i rapporti tra organismo e ambiente, dove il primo comprende la sua personale storia non solo come determinanti, ma anche come biografia e autobiografia, mentre il secondo comprende l’inscindibile nesso tra la disposizione “materiale” dell’ambiente e i valori che lo costruiscono e strutturano. Il primo e il secondo punto di questa controversia rispondono a quella divisione tra interno e esterno, tra soggetto e mondo. Quell’ambiguità della salute che da un lato si descrive oggettivamente e dall’altro non può fare a meno di riferirsi a un soggetto che dice di se stesso di essere in salute, o in malattia.[5]
Eppure, la controversia c’è stata! Vedo due possibilità (e sicuro ce ne sono altre) per ricomporre la controversia come tale. La prima è che la morale che sottende le antropologie di Basaglia e Tobino sia in realtà molto diversa e che si rifletta nella realtà pratica delle scelte. La seconda (ed è quella che personalmente più mi interessa) è che questi Basaglia e Tobino simbolici fossero strumenti del discorso politico e culturale che faceva leva (allora come oggi) sull’autorità dei due scienziati. Consapevoli nella misura in cui era dato loro modo di ribadire la possibilità di una vita diversa, fosse essa segnata dalla quotidiana carità continua o dall’aiuto per tornare nel mondo degli altri. Inconsapevoli però del fatto che a parlare per il loro tramite sia stata ancora la voce della normalizzazione, la violenza dell’istituzione che schiaccia nella malattia (Tobino) o che distrugge nell’afflato positivista di ricondurre ogni diversità a alla norma (Basaglia). La stessa verità dei discorsi dei due scienziati è poco importante se non comprendiamo come queste verità siano state tradotte dalle forze sociali del tempo e quali elementi effettivamente abbiano concorso a comporre questa controversia.
NOTE
[1]Fuser, G., 2024, Controcanto, https://www.controversie.blog/controcanto-tobino/
[2]Fuser, G., 2024, Controcanto, https://www.controversie.blog/controcanto-tobino/\
[3]Si veda l’intervista di L. Pentimalli alla dott.sa Bricchetti [https://www.controversie.blog/raffaella-bricchetti/] così come la mia intervista al dott. Iraci [https://www.controversie.blog/rete-psichiatrica-sul-territorio-intervista-a-uno-psichiatra-che-attuava-la-legge-180/]
[4]M. Tobino, Dolorosa follia, ho udito la tua voce, La Nazione 7 maggio 1978.
[5]Su questo si veda G. Canguilhem, “La salute: concetto volgare” in G. Canguilhem, Sulla medicina. Scritti 1955-1989, tr. it. di D. Tarizzo, Einaudi, Torino 2007.